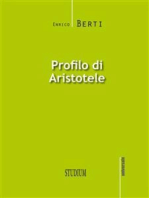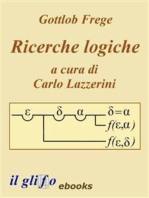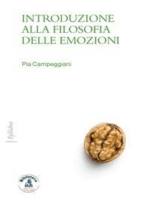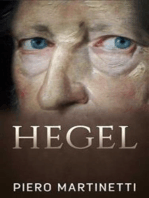Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Jaeger W, Aristotele. Prime Linee Di Una Storia Della Sua Evoluzione Spirituale NN
Transféré par
Valentina MurrocuTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Jaeger W, Aristotele. Prime Linee Di Una Storia Della Sua Evoluzione Spirituale NN
Transféré par
Valentina MurrocuDroits d'auteur :
Formats disponibles
WERNER JAEGER
ARISTOTELE
PRIME LINEE DI UNA STORIA
DELLA SUA EVOLUZIONE SPIRITUALE
LA NUOVA ITALIA EDITRICE
FIRENZE
PROPRIET LETTERARIA RISERVATA
l1edizione : luglio 1935
3= ristampa: novembre 1964
Titolo originale dell' opera
Aristoteles. Grundlegung eirter Geschichte seiner Enlwicklung
Berlin, Weidmann, 1923
Versione autorizzata di Guido
Calogero
con aggiunte c appendice dell'Autore
STAMPATO IN ITALIA
PRINTED IN ITALY
H TAP NOY ENEPrEIA ZQH
Aust. ATelaph.
PREFAZIONE DELL'AUTORE
ALL'EDIZIONE ORIGINALE
Il carattere di questo libro, che ad un tempo
ri
cerca e quadro d' insieme, esige un breve cenno di accom
pagnamento.
Esso non intende di
offrire
un esposizione
sistematica,
bens un' analisi, che procede dagli scritti di Aristotele e
in essi persegue le tracce obliterate della sua
formazione
interiore. Lacornice biografica ha ilsolo scopo di rendere
perspicuo lo scindersi del complesso,
finora
indistinto,
degli scritti in tre diverse
fasi
di sviluppo. Data la po
vert del materiale, il quadro che in tal maniera si ot
tiene resta certo
frammentario.
Fa per risaltare, nei
suoi contorni, una visione d' insieme intrinsecamente pi
chiara della figura spirituale di Aristotele e dei motivi
dominanti del suo pensiero, che torna a vantaggio della
ricerca storica dei problemi e dei principi
filosofici.
L'autore non ha tuttavia avuto Fintento di
fornire
un
contributo alla costruzione sistematica della filosofia,
bens d' illuminare ilperiodo di storia dello spirito greco,
che porta ilnome di Aristotele.
Irisultati di queste ricerche sono stati da me esposti
ripetutamente, in corsi alle universit di Kiel e di Ber
lino,
fin
dal J916: e da allora data, nella sostanza, anche
la
forma
delF esposizione, eccettuato il capitolo conciti'
sivo. Della letteratura critica apparsa inseguito, che del
resto non
offre
molto quanto ad Aristotele, ho tenuto
confo soltanto per le novit che ne ho appreso o per le
X PREFAZIONI
tesi da cui debbo dissentire. Esi cercheranno invano an
che risultati di ricerche pi antiche, quando esse concer
nevano solo
infruttuosi
cambiamenti di opinioni o di
forme
espositive di Aristotele: cose che non hanno niente
che vedere con la sua evoluzione. Anche meno, poi, s
poneva P esigenza di un' analisi di tutti gli scritti di Ari
stotele, che
fosse
scopo a se stessa, e di una riceraa micro
scopica di tutte le loro stratificazioni, quando si trattava
soltanto di chiarire, con esempi perspicui, il
fenomeno
spirituale della sua evoluzione, nel suo
effettivo
signi
ficato.
Esprimo
infine
il pi profondo senso di gratitudine
alla Casa Editrice, che con coraggiosa
fiducia
ha assunto
inpieno, nonostante lo
sfavore
dei tempi, ilrischio della
pubblicazione di questo libro.
Berlino, Pasqua del 1923. W. J.
PREFAZIONE DELL'AUTORE
A
QUESTA
TRADUZIONE
Che del mio Aristotele appaia un'edizione italiana
*
non molto
tempo dopo quella inglese pubblicata dalla Cla
rendon Press, per me causa di viva
soddisfazione,
in
quanto io mi sento,
fin
dalla giovinezza, legato da stretti
vincoli alla scienza italiana, e specialmente in quanto
saluto con sincera ammirazione e simpatia il rifiorire,
che in essa si
manifesta, degli studi sulla
filosofia
antica.
Sono
grato anzitutto alla Casa editrice, che ha il merito
di aver reso possibile, con la sua iniziativa, questa
ver
sione, e non meno al traduttore, che ha sottratto ai suoi
lavori personali di storia della
filosofia
greca il tempo e
lo
sforzo
dedicati a questa fatica, al
fine
di rendere il
mio libro accessibile a unapi vasta cerchia di suoi con
nazionali.
Ho approfittato volentieri di questa occasione per cor
reggere sviste e inserire aggiunte, atte a
fornire
ulteriori
conferme
particolari alle tesi da me sostenute. Cos,p. es.,
PREFAZIONI
mi stato possibile aggiungere alcune testimonianze anti
che, in genere trascurate nonostante la loro importanza,
deli' idea di uno sviluppo delle intuizioni
filosofiche
di
Aristotele. Non
potevo
invece naturalmente propormi, per
una traduzione, il compito di discutere tutta la vasta let
teratura critica che la pubblicazione del mio libro ha
fatto
venire in luce. Per una simile discussione ci vorrebbe un
libro, clw io non ho iltempo di scrivere, avendo da dieci
anni orientato le mie indagini verso altri campi di studio.
Ad Aristotele
fio
torner bens, ma solo investe di editore,
quando l'edizione delle versioni latine medievali d'Aristo
tele, che stata intrapresa dall' Unione internazionale
delie Accademie e che sar pubblicata in Italia, avrpro
ceduto tanto innanzi da
far
s che l'Accademia di Berlino
possa adempiere a quello che per essa uno storico impe
gno d'onore :possa cio sostituire quella sua vecchia edizione
delle opere dello Stagirita, che un secolo
fafece
epoca, con
un'edizione nuova e
conforme
al livello critico dei nostri
tempi, qual' divenuta possibile specialmente dacch
compiuta la pubblicazione dei ventolto volumi in cui essa
medesima ha edito icommentatori greci di Aristotele. Ma
so lene :vita brevis, ars longa.
W. J.
Berlino, 1" marzo 1934.
IL PROBLEMA
Aristotele c ilprimo pensatore che abbia, nello stesso
tempo, fondato la
gua
filosofia e l'inquadramento storico
della propria personalit speculativa, e con ci inaugu
rato una nuova, interiormente complessa e pi responsa
bile, forma di consapevolezza filosofica. Il creatore deb
l'idea dello sviluppo storico dello spirito concepisce an-
che~la~p"ropria opera come il risultato di una evoluzione
dipendente solo dalla legge intrinseca alla cosa, e anzi
fa apparire dappertutto, nella sua esposizione, ipropri
pensieri come il frutto immediato della critica dei suoi
predecessori, inparticolare di Platone e della 6ua scuola.
stato quindi un concetto filosofico e aristotelico quello
a cui si obbedito quando lo si seguito in tale intento,
e si cercato di comprenderlo storicamente in funzione
di quegli stessi presupposti, su cui egli costru ilsuo edi
ficio scientifico.
Ilfilologo, il quale abituato a valersi del giudizio
che una personalit storica porta su se stessa come d
fonte non del tutto obiettiva, e a non trarre da esso
il suo criterio di misura, non pu meravigliarsi del fatto
che tutti questi tentativi non abbiano condotto a una
viva penetrazione del carattere filosofico di Aristotele,
tanto pi in quanto si cominci col giudicarlo in fun-
zione dal suo modo d'intendere i predecessori: come
1.
W. Jaeger,
Aristotele.
o IL PHOIU.EMA
se mai un filosofo potesse, in questo
senso, comprendere
isuoi predecessori. Tuttavia ci pu essere un solo cri
terio positivo per valutare Findividua creazione di Ari-
stotele: e questo
non nel modo
in.
cui egli critica_Plfo_
ton, bens nel"modo in cui egli stesso piaionizza (per-
che ci significa, per lui, filosofare).
A spiegare perch
egli abbia fatto procedere la scienza in quella determi
nata
direzione, non basta.
la",
storia precedente
della
scienza,""ima~occorre anzitutto la sua propria evoluzione
filosofica; per lo stesso motivo
onde_aneb)_egli_non_ de
duce soltanto dai predecessori
la posizione
di Platone
nella storia del pensiero greco,
ma .
Ia_spiega come pro-
dotto dell'Incontro della sua originalit creatrice con
qugTTnjfiussi
storici. Se vero che nella considerazione
del divenire spirituale l'elemento creativo ed originale
non deve avere, nelle grandi
individualit, troppo
breve
parte,
vero di conseguenza che la complessiva
evolu
zione storica ha bisogno di essere integrata
con l'evolu
zione organica della singola personalit.
Lo stesso Ari
stotele
segnala lo stretto nesso di evoluzione e forma:
forma impressa, che vvendo si sviluppa , il con
cetto fondamentale della sua filosofia. Scopo ultimo
per lui quello di conoscere la forma e
]a entelechia at
traverso gli stadi del suo accrescimento. Solamente cos
l'elemento normativo di una struttura spirituale viene
in immediata
evidenza, come ancora Aristotele gi dice,
al principio
del suo corso di lezioni sulle forme primitive
della vita
statale; Allo stesso modo die in ogni altro
campo, anche qui la retta considerazione 8..o.t.Uene.
'sol
tanto quando si scorgano le cose nel loro svolgersi dalle
prime origini.
uno dei quasi inconcepibili paradossi,
di cui pur
ricca la storia della conoscenza
umana, il fatto che sino
ad oggi (quando si prescinda da qualche singola
mani
festazione, non priva
di merito ma affatto parziale e
IL I-IOBLEMa 3
perci rimasta inefficace) non si sia mai applicato ilprin
cipio dello
sviluppo organico allo stesso autore di tale
principio. Si pu senza esagerazione dire che in un'et,
in cui stata messa insieme un'intera letteratura circa
il_ processo evolutivo di Platone,
dell'evoluzione di Ari
stotele non parla che qualcuno, e
comunque quasi nes
suno sa nulla.
Questa tenace trascuratezza per uno dei
problemi pi vitali della storia dello spirito antico ha
conclusivamente esercitato tanta suggestione, che nella
non applicazione della considerazione storica ad Aristo
tele si persino veduta una specie di simbolo della sua
ideale differenza rispetto a Platone. E mentre la storia
dell' evoluzione platonica
minaccia di rendere a poco a
poco gli
osservatori insensibili per l'impeto costruttivo,
che costituisce una delle forze fondamentali del pensiero
di Platone e lo distingue da tutti ifilosofi precedenti, ci
si all' incontro abituati a considerare la questione della
cronologia e
dello sviluppo della dottrina
aristotelica e
delle sue fonti quasi come un segno d' inintelligenza filo
sofica. La monade infatti, che al di
fuori del tempo reca
in s il germe di ogni particolarit, sarebbe,
appunto,
il sistema.
La ragione
fondamentale,
per la quale finora man
cato il tentativo di una storia dell' evoluzione aristote- _
..........
lica, e stata, in una parola, la concezione scolastica della
Ya filosofia come rigido
schematismo concettuale, il cui
apparato dialettico dominavano
abilmente icommenta
tori, senza
tuttavia aver sempre un'
idea e un' esperienza
personale
delle forze motrici della ricerca aristotelica,
del singolare
concorso di
penetrante, astratta apodittica
e d' intuitivo, organico senso della forma. Lo spirituali
smo di Aristotele saturo di intuizione e realt: ilsuo
faticoso rigore
dimostrativo solo il vincolo salutare,
che la
sanguigna vitalit del quarto secolo h3 imposto
a se stessa per ascesi
pedagogica. II
principio dell' incora-
4 IL PROBLEMA
prensione era gi implicito nella separazione delle parti
in stretto senso filosofiche della dottrina
aristotelica, e
cio della logica e della metafisica, dall'indagine empi
rica della realt quale si venne compiendo nel Peripato
fin dalla terza generazione.
E per quanto grande sia stato
pi tardi il merito della scuola dei commentatori inau
gurata da Andronico (1sec. a. C'.), alla quale anzitutto
dobbiamo la salvezza degli scritti dottrinali, e per quanto
superiore, per rigore di concezione filosofica, fosse illoro
tradizionalismo fedele alla lettera a paragone dei miseri
seguaci di Teofrasto e di Stratone, neppure questo moto
di ritorno ad Aristotele arrec una rinascita dello spirito
originario. Mancava ad esso la feconda base di una scienza
della natura e dello spirito in costante progresso,
e con
ci quella fruttuosa azione reciproca di esperienza ed
elaborazione
concettuale, dalla quale le idee speculative
di Aristotele avevano attinto la loro malleabile e pieghe
vole forza. D' allora in poi, nella comprensione di Ari
stotele, non vi pi soluzione di continuit: alla tradi
zione dei commentatori si connette l'aristotelismo
orien
tale, e ad esso quello occidentale, senza lacune. Ilpecu
liare carattere di entrambi, la cui efficacia educativa bu!
loro tempo non pu del resto esser mai valutata abba
stanza, inquella stessa scolastica puramente
concettuale,
che gi al mondo antico aveva sbarrato il passo per una
viva comprensione di Aristotele. Non si era in condizione
di comprendere la sua filosofia come il prodotto del suo
singolare genio e dello stato dei problemi, storicamente
dati, del suo tempo, e ci si atteneva perci solo alla
forma impressa , senza sospettare come la sua vita si
fosse svolta.
Frattanto, e solo per colpa del tradiziona
lismo, era intervenuta la perdita di una delle fonti prin
cipali per la conoscenza dell' evoluzione d Aristotele,
cio dei dialoghi e delle lettere; e con ci err anche
l
ostruito 1' accesso al mondo della sua umana personalit.
IL PROBLEMA 5
Cos accadde che il ridesto amore per 1' antichit, provo
cato dall' Umanesimo, non port quanto ad Aristotele ad
alcun cambiamento, tanto pi in quanto egli appariva
come il principe di quella scolastica medievale, che da
un lato Lutero e dall' altro gli umanisti disprezzavano
con pari energia. Fra tutte le grandi figure della filosofia
e letteratura classica, ilsolo Aristotele non ha goduto di
alcuna rinascita. Ognuno, certo, sapeva che egli era una
grande forza, una delle basi del mondo moderno: ma
egli rimaneva un elemento di tradizione, e proprio per
il fatto che si aveva ancora troppo bisogno della sua
scienza, pur dopo 1' et dell' Umanesimo e della Riforma.
Tanto Melantone quanto iGesuiti hanno costruito la
loro teologia sulla sua metafisica; Machiavelli ha estratto
le sue tegole dalla politica, icritici e ipoeti francesi
dalla poetica. Alla logica hanno attinto tutti ifilosofi,
anche molto dopo Kant; all'etica, moralisti e giuristi.
Quanto
ai filologi, non era tanto un troppo forte in
teresse per ilcontenuto a impedir loro di penetrare sino
all' interna forma del suo pensiero, quanto ilgretto e for
malistico concetto dell'antica prosa d'arte, quale gli uma
nisti avevano nuovamente messo in onore. Essi hanno,
certo, studiato acutamente gli scritti superstiti di Aristo
tele, e cercato di stabilirne il testo; ma il nuovo senso
stilistico era esteticamente urtato dallo stato di incompiu
tezza in cui essi sono tramandati. Si applicava ad essi un
criterio di stile letterario, contro le cui norme essi urta
vano continuamente e che era loro del tutto estraneo.
Si confrontava ingenuamente lo stile degli scritti dot
trinali coi dialoghi di Platone, e ci si entusiasmava della
meravigliosa arte di questi, mentre si tentava di trasfor
mare violentemente le trattazioni aristoteliche in ma
nuali leggibili mediante ogni sorta di interventi razio
nalistici, atetesi di parti incomode e trasposizioni di libri
interi o di singole frasi.
Questa
specie di crtica nacque
6 IL PROBLEMA
dal misconoscimento di quella forma provvisoria, che
cos significativa per lo spirito della filosofia aristotelica
e dalla quale deve muovere ogni suo intendimento slo-
rico. Anche inPlatone, certo, l' importanza del problema
della forma per la conoscenza del suo peculiare spirito
stata a lungo, ed sempre di nuovo, misconosciuta;
particolarmente la filosofia degli specialisti e la filologia
dei letterati sono sempre inclini a considerare la forma
come qualcosa di letterario, che non ha alcun significato
per il contenuto del pensiero platonico, per quanto la
connessione di quel pensiero con quella forma sia un
fenomeno unico nella storia della filosofa. Tuttavia la
maggior parte dei critici sa ormai he lo sviluppo for
male una delle principali chiavi dell'intendimento
filosofico di Platone; mentre, nel caso d Aristotele, si
vorrebbe aderire tanto pi esclusivamente al contenuto,
in quanto,
si dice, esso non ha affatto forma. Ma se
togliamo di mezzo la gretta idea della forma letteraria,
propria della retorica ellenistica (alla quale per poco
non dobbiamo ascrivere la perdita delle opere dottrinali
di Aristotele, come dobbiamo attribuirle quella della let
teratura stoica ed epicurea) ecco che il problema del
l'evoluzione storica si pone da se. Impossibile infatti
spiegare Io stato caratteristico dell' opera lasciata da Ari
stotele, senza ammettere che essa rechi in s le tracce di
diverse fasi del suo sviluppo. L' analisi degli scritti dot
trinali porta da s a tali concezioni, e iresti dei perduti
scritti letterari la confermano. Primo e inevitabile com
pito di questo libro sar dunque quello di segnalare anzi
tutto, in base ai resti delle opere perdute e attraverso
1' analisi degli scritti pi importanti, come stia a loro
fondamento un' evoluzione : conforme, del resto, all' ori
gine stessa del presente lavoro, nato dall' interpretazione
degli scritti e dei frammenti a proposito d un'edizione
IL PROBLEMA 7
della Metafisica.
La critica filologica entra in ogni modo
immediatamente
in servigio della posizione filosofica dei
problemi, perch si tratta di chiarire non soltanto lo
stato esteriore degli scritti come tali, ma anche il modo
in cui in esso si manifesta 1' energia propulsiva del pen
siero aristotelico.
PARTE PRIMA
IL PERIODO ACCADEMICO
L
L'ACCADEMIA
QUANDO
VI ENTR ARISTOTELE
Secondo l'attestazione, degna di fede, dei biografi,
Aristotele scrisse al re Filippo di Macedonia di essere ri
masto vent' anni presso Platone. Avendo egli appartenuto
all'Accademia fino alla morte di Platone (348/7), vi en
tr, dunque, nell'anno
368/7.
Inquel tempo egli era nella
giovanile et di circa 17 anni1).
Quando
lasci la scuola,
;i avvicinava gi ai quaranta. Di questi indiscussi dati di
fatto si rimasti troppo poco sorpresi. Certo, nella storia
dei grandi pensatori, e forse addirittura in ogni evolu
zione spirituale di indipendenti nature creatrici, non si
trova altro esempio di un uomo dotato di originalit pa
rimenti profonda, che sia rimasto cos tenacemente sotto
l'influsso di un genio di tutt' altra natura e di prepo
tente forza, e sia cresciuto del tutto alla sua ombra. Ora,
difficile trovare un pi esatto criterio di misura per
la interiore ricettivit, e insieme anche per la sicurezza
ed energia della capacit creatrice, della relazione, che
') Della lettera parla la Vita Marciana, p. 427, 18 Rose (Pa.
Ammon., p. 438, 13 ; Traimi, lat., p. 443, 12). La notizia dell'et
di 17 anni non deriva dalla stessa fonte, ina si trovava combinata
con la notizia tratta dalla lettera gi presso ibiografi alessandrini:
cfr. per ci Dionys. HaLic., ad Amiti* 5 >(728 R.).
12 IL PERIODO ACCADEMICO
lega le forze e per ci stesso le chiama alla luce, con un
grande maestro e con la forza spirituale che attraverso
di lui obiettivamente agisce, e a cui il giovane consacra
l'amore della sua giovent e la sua prima dedizione,
fino al tempo in cui, fattosi maturo al contatto con essa,
se ne separa. questo il tema dell' interiore evoluzione
di Aristotele. All' esperienza del mondo platonico, e alla
crisi ond' egli pass da quella a se stesso, egli deve la
straordinaria tensione dell' intelletto, la cui elastica ra
pidit pone il~suo pensiero a un grado pi avanzato ri
spetto a quello dTTlatone, nonostante la differenza spe
cfica tra
ljiua genialit limitata e quella illimitata del
maestro. E, d' allora in poi, discendere da quel grado
vale quanto girare all' indietro la ruota della Necessit.
Non lecito considerare la relazione filosofica di Ari
stotele con Platone, secondo quanto fino ad oggi si pur
"smpre" ftcttocome~n' adesione intellettuale a certi prin
cipi del maestro e un dissenso da certe altre parli della
sua dottrina, all stesso modo incui si pu concepire la re-
lazione di uno'dTerno pffessoT di fil'Mfia''cn Knt. In
vero, proprio il rilievo del carattere incomparabile della
natura di Platone e del suo plastico filosofare ha fatto
sorgere dubbi circa la comprensione di Aristotele per il
suo modello. Appunto ci che in Platone forma, appa
rizione, mito, deve (secondo questa opinione) essere stato
trascurato da Aristotele. La sua critica sembra quasi 11011
colpire Platone, in quanto non tocca per nulla questi lati,
pure essenziali alla sua natura. Nella sua astrattezza, essa
sembra una [iev<4J3acris
et?
XXo og. Ma quanto miope,
anzi scolastica, una simile accusa'. Inpi di un luogo
Aristotele fa comprendere che egli prima di passare alla
critica stato chiaramente consapevole proprio di que
sta natura dello spirito platonico. N altrimenti avrebbe
potuto essere, in un uomo in cui onoriamo il creatore
della psicologia e della sua applicazione a fenomeni spi-
l'accademia QUANDO
VI ENTR ARISTOTELE
13
rituali
ed artistici. Proprio
lui stato quello che ha
coniato
per primo
brevi e calzanti parole per
designare
in
Platone quell' elemento
poetico, che icritici moderni
credono
di aver scoperto.
L'essenza artistica del dialogo
platonico stata dajui definita
piesattamente
chjlalla
maggior parte
dijquellu
Egli nonhamai creduto di esau
rire, con la sua critica_.dellg-j
MS
Ita logiche ed ontolo
giche della dottnna.
platonica,.il.suo..sigreificato.
8torico._e...
-
il suo universale contenuto.
Tutto ci evidente, e non
ha bisogno dell' attestazine
delle sue stesse parole, per
chiunque sa come Aristotele non si avvicin affatto, ini
zialmente, con fredda intelligenza critica al mondo
della
filosofia platonica, ma anzi rest per lunghi anni domi-
nato dall'enorme
suggestln~dil
sua figura.
Ma altro
comprndere nella sua natura un mondo
.cos
complesso, ..
composto delle pi varie_forze spirituali
e affatto
singo
lare nella sua individua irwnfestazionecqme.q(ie]lo1.pla-...
tonico, altro volerlo imitare e.
proseguire come. sistema..
In_questo_punto
il Invio tra l planismo
fecondo e
il platonismo sterile. Sterile
l'estetizzante
mendace,
scimmiesca contraffazione dell' unit spirituale
di Pla
tone, il verboso culto dei
simboli e termini a lui
cari-, fe-
eondo illavoro intorno
ai suoi problemi, al quale Pla
ton?"stesso aUribTace' il
vatre"7massirno'
Ed esso con
duce necessariamente oltre di lui. Fecondo anche 'di
ventar consapevoli, insieme con Aristotele, merc la con
siderazione dell'antitesi
tra la scienza moderna
e la non
pi
riconquistabile unit
spirituale di Platone,
del carat
tere
unilaterale, se anche tanto necessario, del nostro pen
siero. In tempi diversi, Aristotele ba assunto rispetto a
questo
problema una posizione
diversa. A iniziali
tenta
tivi d' ingenua imitazione
e continuazione del modello
platonico segue un periodo in cui egli ha imparato
a
distinguere tra l'essenza eterna dell' eredit platonica
e
gli elementi temporali,
individuali e perci irripetihir
14 il periodo
accademico
della Bua formulazione, che egli cerca di eliminare, pur
sforzandosi di conservare fedelmente quell'essenza. La
filosofia di Platone diviene ora per lui, da compiuta for
ma, materia
pe7"qurcs'dihuqvo_ pi alto. La presa di
posizione
.risnetto-a-n
che,
con tutta l'animargli ha t-
tinto da Platone,
si__estende attraverso l'intera opera"
dlia sua vita, il filo conduttore della sua stessa evo-
I luzione. Essa fascia inlravvederc un progressivo sviluppo,"
: attravrso icui diversi stadi dato seguire chiaramente
I
il processo onde il nocciolo essenziale del suo pensiero
si libera dalla corteccia. Anche le ultime creazioni re
cano in s, in certo modo, la traccia e il sigillo dello
spirito platonico, ma in grado pi esiguo che quelle di
pi antica et. concetto aristotelico dell'evoluzione
pu esaere applicato a lui stesso: la nuova forma, che
vuol realizzarsi nel divenire, si afferma vittoriosamente
contro l'opposizione di una materia, per quanto grande
sia il valore intrinseco a questa. Essa cresce e trasforma
quella dall'interno secondo la sua legge, imponendole la
propria figura. Come la tragedia si sviluppa dal diti
rambo facendogli subire varie modificazioni, finch essa
raggiunge la 6ua pi propria natura
(loe xijv iauzijc
cpoLv), cos Aristotele giunto dall' elaborazione della
filosofa platonica alla formazione di se stesso. La storia
della sua evoluzione presenta, coi suoi documenti esatta
mente determinabili, addirittura una scala del graduale
processo in tale direzione, anche se egli non riusc, in
molti punti, ad andare al di l del compromesso. Intali
puntici suoi scolari lo hanno spesso capito, pi tardi,
meglio di quanto si fosse capito egli stesso, cio hanno
cancellato 1' elemento platonico e cercato di conservare
quello puramente aristotelico. Ma ci che specifica-
niente aristotelico proprio soltanto lajmetjji Aristo
tele. Gli scolari non capirono questo: egli ne rimase
sempre consapevole.
l'accademia QUANDO
VI ENTR ARISTOTELE 15
L' Accademia, in cui Aristotele entr nel 367, non era
pi quella dei tempi del Simposio, attorno alla cui tavola
Platone, nel tumulto dell' entusiasmo, poteva pensar radu
nati iprincipi delle arti e delle scienze e irappresentanti
della giovent ellenica, per udire dalla Locca della veg
gente
il grande mistero della nascita dello spirito da Eros.
L' essenza_del pensiero di Platone,non coincideva pi, gi
da lungo tempo, col simbolo_
che_e380__gi jera .creato-nelle
opere della giovinezza, nella centrale figura filosofica, di
Socrate. Ilsuo contenuto e il suo metodo oltrepassavano
ampiamente la cerchia dei problemi socratici. Ci che_So;....
crSe era stt"per"PItri' " per la primitiva scuola.pla:,,
tonica, ArBtotIe"pvT"sentirlo ormai solo attraverso Ia__
lettura, e non pi per l viv'presenza vitale dello spirito
socratico, nell' "Accademia del decennio tra il e. iL?50
Testimoninz'gi' clssiche di un'ormai conclusa stagione
del maestro, il Fedone e il Gorgia, la Repubblica e il
Simposio sovrastavano come calme divinit alla realt
operoga della scuola. Chi fosse stato, da lungi, allettato da
esse a godere la personale presenza di Platone, restava
certo meravigliato che in seno a quella Bcuola filosofica
non si celebrassero misteri. Da quelle opere emanava,
e splendeva lontano, una forza trasformatrice, una se
riet nuova.
Questa
trov Aristotele anche nell'Accade
mia. Ma le classiche dottrine platoniche delle idee, del-
l'unit e della molteplicit, del piacerete del dolore,
dello Btato, dell' anima e della virt, non erano affatto
reliquie intangibili per le~"discussion.iIlegli-SColrL--ma.
venivano senza tregua esaminate,
difese.e, modificate, con
acuta distinzione dei concetti e minuziosa indagine della
loro logica capacit. Decisivo era poi ilfatto che a questa
comune opera di pensiero partecipassero anche gli sco
lari." Le figure e imiti dei dialoghi erano, e rimasero, la
pi peculiare "e Irripetibile creazione di Platone; all'in
contro, la discussione dei concetti divenne il principio che
16 IL PERIODO ACCADEMICO
pi tipicamente determin il carattere dell'Accademia
accanto al suo motivo religioso, giacche soltanto questi
due elementi dello spirito platonico potevano esser tra
smessi a una tradizione.,,
Quanto maggiore fu il numero
dglscoIaxT che egli attir a s, tanto pi forte divenne
la preponderanza di quella rispetto al Iato artistico della
sua natura. La compressione _che_ il dialettico esercit
sul poeta aveva certo, in Platonej un fondamento pro-
prio nell'affettiva compresenza di tali forze contrastanti,
ma fu
soprattutto la_scuola a condurlo irresistibilmente
in quella direzione.
Per T orientamento spirituale di Aristotele decisivo
fu il fatto che proprio al tempo del suo ingresso nel-
l'Accademia cominciasse a svolgersi quella trasforma
zione cos grave di conseguenze, con 1' elaborazione della
.pi tarda dialettica platonica. Grazie ai progressi della
pi moderna indagine platonica possiamo seguire anche
con precisione cronologica questo processo nei grandi
dialoghi metodologici, che Platone scrisse in quegli anni:
_il, Teeteto, Sofista, ilPqlijico,.i)arinenUle,q il
Filebo,
Il dialogo principale di questo gruppo, il Teeteto, fu
scritto poco dopo la morte (369) del famoso matematico
di cui esso onora la memoria1). Esso tanto pi carat-
') Per gl'indizi cronologici esterni cfr. gli argomenti deri=ivi
di Eva Sachs, De Theaeieto Atheniensi mathematica (Diss., Berlino
1914), p. 18 segg. 'La prova di maggiore evidenza naturalmente
fornita dalle analisi stilistica e filosofica, entrambe confermami
g' indizi esterni di tarda composizione. Non e' ormai pi nessuno
che voglia porre al principio dell'evoluzione
platonica, quale dia
logo elementare, (come pur faceva ancora lo Zeller) il Sofista,
che approfondisce in senso positivo il problema del Teeteto e che,
come ilPolitico egualmente connesso a questo ciclo, conserva anche
la medesima cornice scenica. Le fondamentali ricerche del Campbell
sono state accolte in Germania soltanto tardi, ma sono state in
compenso confermate in ogni lato dalle indagini pi recenti. Deci
siva per ci la storia dello sviluppo della dialettica platonica, che
d'allora in poi si fece strada: cfr. soprattutto le Studicn zur
Entwicklung der platonischen Dialektik (Breslavia 1917 [2" ed. am-
pliata, Lipsia 19311) di J, Stcnzcl, a cui devo non poco:
L'ACCADEMIA QUANDO VI ENTR ARISTOTELE 17
teristico per lo spirito dell' Accademia nel tempo in cui
vi entr Aristotele, in quanto in esso e nei dialoghi se
guenti
(
Sofista
, Politico) il paziente lavoro della scuola,
che nelle opere del periodo classico appariva quasi com
pletamente superato, comincia a costringere al proprio
servizio l' intera opera letteraria di Platone, lasciando
cos un quadro della sua fatica, in cui non manca alcun
tratto importante. Essenziale per la comprensione_di Ari
stotele e della sua relazione con Platone che non si
parta dalia vaga idea complessiva
di Platone e si
pnga al suo luogo il ben definito concetto dell' astratto.,
e metdlgccf prodo ultimo della filosofia platonica,
iniziatosi nel 369. Con essa era indicato cT'Aristotele un
orientamento" preciso, ed aperto alla sua speciale pre
disposizione un campo di fecondo lavoro originale.
L' attitudine del puro ricercatore, che distingue Art-
stotele'dH'praLi'co'empirismo'dlia socratica dallo
spi
rito riformatre' del primo Platone, e ilcarattere astratto
"dT"suo
pensiero,
che lo mette in contrasto con la pla
sticit artistica di quelloj non sono tratti che fossero pro
pri soltanto
alla, sua personalit._.Vi si manifest la ge
nerale tendenza dell'Accademia nel"tempo
in cui egli le
appartenne, neetoj.
l'apoteosi,di,..questo,
.non
socra
tico ideale di filosofo del tardo periodo platonico.
N.ella
rappresentazione
del
filosofesche
1' episodio, del dialogo
pone in bocca a Socrate, il filosofo non appare
simile a
quest'
ultimo
quale
con storica fedelt era stato caratte
rizzato nell' Apologia,
bens al tipo del matematico so
litario, icui tratti hanno palesemente contribuito a de
terminare il nuovo ideale teoretico.
Nondi
ci che sta
iu cielo o sotto la terra, ma solo dell'.uomo
si era dato
penser Scrate. IlTeeteto chiama invece 1' anima filo
sofica "YlofpsTpca e arpovojiouaa *)". La. realt pros-
') Theaet., 173 E-174A.
2.
W. Jaeodi;, iim/olel.
IS IL PERIODO ACCADEMICO
sima le appare indifferente: essa disprezza il pratico
tendere ed operare, cio proprio la vita di quegli uo
mini tra cui Socrate aveva cercato .diVpreferenza i.auoi
ascoltatori, ed erra in lontananze sublimi, secondo la so
lenne espressione attinta a Pindaro.
Nel Teeteto si accenna gi, con ciliare parole, anche
alla prossima apparizione del Parmenide, che con molta
probabilit stato scritto prima ancora della continua
zione del Teeteto, cio del
Sofista
e del Politico, ed era
quindi forse gi pronto quando Aristotele entr nella
scuola : in ogni caso, non venne alla luce molto pi tardi.
Non verosimile che, in cos giovane et, Aristotele ab
bia senz' altro preso, nella nuova cerchia, l'iniziativa di
un sovvertimento capitale, quale gli attribuiscono coloro
che fanno risalire a lui le obiezioni di questo dialogo
contro la i.ottrina delle idee. II dialogo attesta quanto
l'Accademia, gi primardi .Aristotele, avesse proceduto
nella critica.delle.ibride propriet ontologiche ed astratte
"3eIIe*'idee: la distinzione delle ime dalle altre non po
teva "essere a lungo evitata. Platone credeva, certo, di
\
| poter "dominare"le difficolt, ma riconobbe come giusti-
\
I
(
beata, in linea di principio, la faticosa indagine logica
1 1
ij
ed ontologica delle idee quale compiuta in questo
dialogo e nei seguenti, e apr con ci egli stesso la via
alla successiva evoluzione. Difficilmente, invece, si po-
ijtrebbe riconnettere la speculazione aristotelica al Fe- 1
( done o alla Repubblica e alla loro dottrina delle idee.
La relazione di Platone con segnalati matematici del
suo tempo, come con Teeteto e Teodoro, opposti rappre
sentanti della generazione giovane e fornita d' interesse
filosofico e di quella vecchia, capacissima nel suo campo
ma intollerante di filosofia, ha non senza ragione lasciato
le sue tracce proprio in un',opera, che apparve, in...quel
tempo. Circa il 367 anche Eudosso di Cizico venne ad
Atene con la Bua scuola, per discutere con Platone e coi
L'ACCADEMIA QUANDO VI ENTR ARISTOTELE 19
suoi discepoli problemi che agitavano gli uni e gli altri 1).
Fu quello un avvenimento sensazionale, e d'allora in poi
vediamo costantemente in relazione con l' Accademia
membri di quella scuola di matematica e di aslronmiaV_
.
come
Eicone7~~Ateneo
ed altri. Gi nella Repubblica
dato osservare l'efficacia della nuova scoperta
Jella
ste-
remetri'Sp'operata tla Teeteto._Dai tempi del soggiorno
di Eudosso l'interesse per inuovi tentativi della scuola
cizicena, diretti a spiegare imovimenti irregolari dei
pianeti con semplici presupposti matematici, occupa un
posto dominante nel pensiero di Platone e nei suoi se- .
guaei. Ma anche altri impulsi spirituali provennero da
\\
Eudosso: l'orizzonte geografico e storico-culturale si
ampli enormemente. Eudosso rec con s ima pi esatta
conoscenza dell'Asia e dell' Egitto e rifer, per personale
esperienza di molti anni, circa lo stato della scienza astro
nomica di quelle regioni. Anche per_i.problemi..etici, gli
si era debitori: la questione, pi tardi cos decisiva per
1' etica aristotelica, dell' essenza e
del.
significatp_del pia
cere e del dispiacere, port negli ultimi anni della vita
di Platone a un grande "dibattito accademico, a cui_prc-
sero parte Senocrate, Speusippo e
Aristotele. .con.scritti
Ttspl ijSoviic, e To stesso Platone col Filebo. Aristotele,
che conobBiTEudosso~fin-daT pfincipi~(ll suo soggiorno
all'Accademia, tratteggia la sua impressione personale,
ancora molto tempo dopo, con schietto calore, quando
ricorda l'influsso che da lui gli deriv. Eudosso discusse
') La congetiura del Tannery {Histoire
de l'astronome, p. 296,
n. 4) confermala dalla Vita (p. 429, 1 Rose), secondo la quale
Aristotele enlr nell'Accademia al tempo di Eudosso. Qualche com
pilatore lia, cio, frainteso l'indicazione cronologica e preso Eudosso
per un arconte. Nella fonte era soltanto rilevata la coincidenza tem
porale dell' ingresso di Aristotele con la presenza di Eudosso. Cfr.,
sulle tracco di J. Jacoby, E. Sachs, op. cit., p. 17, n. 2.
20 IL PERIODO ACCADEMICO
.lanche
la dottrina delle idee e propose una modificazione
'
del loro concetto 1).
E, in generale, la scuola platonica prese sempre pi
ad attirare personalit straniere, e delle pi diverse atti
tudini spirituali. Iviaggi avevano condotto Platone in
stretto contatto con ipitagorici della cerchia tarentina
di Archita, il cui influsso si estendeva fino alla Sicilia.
Col fioriva allora la scuola medica di Filistione, la cui
efficacia oltrepassava anche iconfini dell' isole, onde de-
v'esserne fatto idealmente dipendere p. es. uno scrittore
e medico come Diocle di Caristo d' Eubea. Con FilBtione
Platone dev' essere etato in rapporto.
L' autore della co
siddetta seconda lettera platonica sembra abbia avuto
notizia della Bua relazione con lui, e probabilmente an
che di un invito di Filistione ad Atene. In ogni modo
dietro iltarp? SixsX?
arc y;, non altrimenti desi
gnato, della cui annoiata presenza alle sottilizzazioni con
cettuali degli Accademici parla un comico contempora
neo, si cela, se non Filistione stesso, una reale persona
lit della sua scuola 2).
Questo
racconto pu del resto mo
strare come Platone curasse s d' intrattenersi con dotti
di ogni disciplina, ma il risultato si restringesse sovente
solo alla scoperta dell' abiss invalicabile che separava
la scienza ionico-siciliana da ci che per scienza inten
deva Platone. L' ampiezza con cui il Timeo fa uso dei
J) Per le opinioni di Aristotele circa ilcarattere e la teoria edo
nistica di Eudosso v, Etilica Nicorn., K 2; circa la sua proposta di
trasformazione della dottrina delle idee Metaphys., A 9, 991 a 17 e
il secondo- libro del IIspl (fr. 189 Rose), dove la trattazione
era pi ampia ed erano contenuti gli argomenti in contrario, poi
conservati -da Alessandro nel commento al luogo citato della Me
tafisica. Eudosso voleva concepire la methexis come immanenza
Ielle idee nelle cose, ed era in ci combattuto aspramente da Ari
stotele. 'Che essa costituisse allora il problema pi dibattuto risulta
del resto anche dai dialoghi platonici pi tardi.
s) Epicre.te, fr. 287 Kock. Cfr. M. Wcllmann,
Fralmente
der
sikelischen Ante (Berlino 1981), p. 68, e ilmio articolo Dos
Pneump
im Lykeion (in Hermes, XLVIII). p. 51. n. 3.
l'accademia QUANDO VI ENTR ARISTOTELE 21
risultati della pirecente medicina, matematica ed astro
nomia, non deve nascondere la sovrana libert con la
quale Platonesi comporta rispetto alla materia onde crea
poeticamente la sua cosmogonia.
Comunque, nella scuola dell' ultimo Platone fu sotto
posto
a riflessione e discussine
incassai
ricco materiale,
e un Aristotele poteva bene, in' tale ambiente, imparare
a valutare da. s_il_smfica_to jelle realtmgoler_che
pi tardi divennero tanto essenziali per ilsuo metodo di
ricerea.~Tuttavia non si dovrebbe parlare,"" coin"ggi si
fa comunemente 1), di un' organizzazione delle scienze
nell' Accademia. Le moderne accademie e universit non
possono far risalire la loro tradizione a Platone, da cui
era lontanissimo il pensiero di un' unit sistematica di
tutte le scienze, e ancor pilontano quello di una realiz
zazione pratica di tale unit in un' organizzazione enci
clopedica delle discipline scolastiche ai fini dell' inda
gine dottrinale. Le scienze della medicina, della mate'
malica, dell' astronomia, della geografia e dell' etnologia.
igrandi complessi dell' archeologia e della storia, delle
arti retoriche e dialettiche, per ricordare soltanto itipi
pi notevoli dell' indagine greca, si sono sviluppate cia
scuna per s, nonostante che in certe occasioni si trovas
sero riunite in singole personalit, e anche allora con-
ducevano indisturbate una vita autonoma. L' idea di ve
der connessa in un universale sistema delle scienze la
loro matematica con la ricerca, condotta da alcuni sofisti,
dell' archeologia o della storia della cultura greca, sa
rebbe apparsa molto singolare a un Teodoro o a un Tee-
teto. Anche imedici restano affatto indipendenti. Una
figura d' eccezione Democrito, e pi tardi Eudosso, che
in certa misura anticipa il tipo aristotelico.
Quest'
ul-
*) Sin dal tempo dell'articolo, divenuto celebre, di H. Usener
in Preussische Jahrbiicher, LIII (1884), ristampato in Vortr'ge und
Auh'ize,
n. 69. ...... ...
22 IL PERIODO ACCADEMICO
timo fu un prodigio di versatilit e un matematica e
astronomia con geografia ed etnologia e con studi me
dici e filosofici, conducendo ricerche originali nei primi
quattro campi di indagine.
Quanto
a Platone, tutto il suo sforzo era esclusiva
mente orientato verso 1' ente . Se si vuole inserirlo
neir_ft3n"d"6l"*pehsiro greco, egli prende posto
tra
irappresentanti dell' indagine__crca 1' oola, a cui
.
egli
diede un nuovo orientamento con la dottrina delle idee,
e che anzi risuscit senz' altro a vita nuova. Dalla teoria
delle idee non si pu dire che egli discenda alla molte
plicit, al mondo empirico, perch la sua ricerca mira
soltanto all'unit e al soprasensibile. E direzione della
sua indagine parte dal mondo dell' apparenza e procede
verso l'alto. Solo per le esigenze della speculazione
concettuale egli giunge_all'_elaborazione.deljnietodo della
divisione logica, che pi tardi acquista in Aristotele cos
enorme importanza per" il dominio empirico tanto del
regno animale e vegetale quanto
del mond dello spirito.
Vr"p'r~Platone non si tratta ancora dell' ordinamento
' sistematico delle realt singole, che per lui giacciono al
di sotto della sfera dell' eidos e sono assolutamente
! rceipov, e quindi inconoscibili. Per Platone il concetto
!
dell'individuo (ttojiov) quello dell' eidos pi basso e
|
non ulteriormente divisibile, che per lui designa illimite
l tanto della scienza quanto del concetto d realt, nella
direzione del mondo apparente. Le molte divisioni lo
giche di piante e di altre cose, di cui parla il comico
Epicrate e che apparivano agli estranei come l'elemento
pi caratteristico e straordinario nell' attivit degli Ac
cademici (anche la grande opera di Speusippo, intito
lata Le somiglianze, sembra non avesse per argomento
che quelle) non erano compiute per interesse alle coso
in s, ma per conoscere le relazioni logiche dei concetti;
e fu in tal senso che allora apparvero
nell' Accademia
l'accademia QUANDO VI ENTR ARISTOTELE 23
anche libri di ogni sorta col titolo di Divisioni. Nella
divisione delle piante si mirava a una positiva botanica
tanto poco quanto Platone, nel Sofista, intendeva di stu
diare isofisti nella loro realt storica J).
La via, che da queste divisioni della realt esistente
conduceva al progetto di una scienza unitaria, e pur di
visa in tante scienze particolari per quante parti si da
vano della realt (5v), non era pi molto lunga; ma a
tale conclusione si giunse solo quando il concetto ari
stotelico della realt ebbe soppiantato il concetto tra
scendente dell' essere platonico2). Degno di riflessione
comunque il fatto che solo merc la filosofia concettuale
degli Attici e il loro gusto per le divisioni logiche l'idea
di una superiore connessione sia stata importata nelle
singole scienze, che si erano gi sviluppate indipenden
temente. ormai quasi impossibile calcolare, caso per
caso, ivantaggi e idanni arrecati dalla realizzazione di
quell' idea. Certo sono stati, gli uni e gli altri, notevol
mente grandi. Una completa compenetrazione di tutte le
scienze, ciascuna delle quali conserva pure in s una sua
anima e un proprio principio informatore, merc lo spi-
*) Nel frammento sopra citato Epicrate non dice che iPlato
nici si occupassero effettivamente di argomenti botanici: ci su cui
scherza la mania di divisione logica, che d maggiore importanza
alle relazioni concettuali che alle cose stesse:
uspl y.p cpasiug epopipevoi
8isxiPt0V
tj>u>v ts p(ov
SivSpojv ts cpoiv Xadvcuv "ts fvi;,
xSt* il
TOTOIS
Xijt XoXoXVTIjV
ipy;ra?ov
tivoc
iati yivoog.
Qui (Slog non ila Sicura degli animali, bens sinonimo di cpOoij
e di yV0S e termini di schietta dialettica platonica sono anche
quelli del definire, dividere, esaminare iconcetti. Ifram
menti degli "Opoia di Speusippo si trovano ora raccolti in P. Lang,
De Speusippi Academici scriptis (Dissect., Bonn 1911). Gi il titolo
mostra a che si mirasse in quest' opera.
*) Arist., Metaph., I" 2, 1004 a 2: looaOta pipi] cptXoaocpEag
istlv Soamsp al oatat.
i
!
1
24 IL PERIODO ACCADEMICO
rito universale di una determinata filosofia, non si mai
tradotta in realt in periodi di vivace sviluppo dell'in
dagine scientifica. Una parziale compenetrazione si ebbe
soltanto quando la filosofia pass al comando di grandi
indagatori, che la permearono dello spirito di singoli e
determinati rami della ricerca scientifica, o per l'inter
vento di nature spirituali di duplice attitudine. Aristo
tele, Leibniz, Hegel sono gli esempi pi significativi, e
tra loro assai diversi, di questo tipo spirituale.
Anche Platone possedeva una particolare compren
sione scientifica per questioni matematiche, in modo da
|
poter seguire gl' importanti progressi che quella scienza
l'i
allora compiva. E lo interessava anche l'astronomia,
per
!
!
quanto in essa era allora accessibile al pensiero mate
matico. Della fisica degli elementi egli si occup seria
mente pitardi, nella speranza di trovare una deduzione
matematica delle differenze qualitative dei cosiddetti eie-
menti di Empedocle, che egli voleva concepire come
meri stati di aggregazione. Per quel che riguarda il
! mondo fenomenico, egli rivolse altrimenti la sua atten-
zione solo al campo della medicina e a quello etico-
politico, in cui, specialmente per la composizione delle
Leggi, mise insieme un ampio materiale concernente il
diritto penale e la storia della cultura. La tendenza allo
studio delle realt singole cade..qu.in.di nel periodo,incui
Aristotele era membro, della scuola. L'impulso spirituale,
ebe questi trasse da quelle nuove fonti di storia della
politica, s' intrawede nelle numerose coincidenze della
sua Politica con le Leggi di Platone. Per gli studi mate
matici, particolarmente esercitali nell'Accademia, gli
mancavano disposizione e inclinazione, appena si uscisse
dall' elementare. Per il dominio della natura organica,
in cui doveva poi manifestarsi la sua peculiare genialit,
egli non trovava invece nell'Accademia alcun impulso
spirituale.
L'ACCADEMIA QUANDO VI ENTR ARISTOTELE 25
Per quanto
fruttuoso e duraturo per la sua filosofia
sia stato l'influsso che sul giovane Aristotele esercit il
contatto con il rigoroso e metodico procedimento delle ;
diverse scienze, e per quanto quel procedimento debba :
essere stato congeniale alla sua natura, pi forte di tutti
questi influssi fu tuttavia per lui quello della personalit
di Platone, il cui spirito introspettivo e plastico sovra
stava a quei fecondi campi di ricerca. Esso attrasse, d'al
lora in poi, tutto il suo operoso interesse.
Non abbiamo intenzione d'illustrar qui gl'influssi
che la personalit di Platone esercit sui contemporanei,
o di restringere in ima breve formula la sua posizione
nella storia della scienza. Per uno spirito predisposto
come quello di Aristotele, quest' ultimo problema do
veva costituire il perno di tutto il suo ulteriore atteggia
mento nei riguardi del maestro. Tenendo conto della sua
lontananza da tutta la scienza d' allora e di oggi, si
dato a Platne ilnome'di mstico, e lo si
perci espunto
dal vero e proprio processo
evolutivo dei problemi scien
tifici. Se questa
soluzione sbrigativa dell' enigma fosse
esatta, difficilmente si capirebbe perch egli abbia in
fluito cos profondamente sulle sorti della scienza. Certo, !
gli elementi da cui si svolta 1' opera di Platone ap-
partengono ad altre sfere che a quelle della laxoplct, ionica .
o dell'intellettualismo illuminato dei sofisti, le quali]
nonostante la grande lontananza che le separava, appa
rivano allora senz' altro come le forme della scienza.
Ilprimo di quegli elementi, la <ppivrjot; di Socrate, era
solo esteriormente simile al razionalismo dei sofisti, e
aveva la sua intima radice nel dominio, sin allora igno
rato dalla scienza e dalla filosofia greca, dell' assoluta
consapevolezza morale. Essa esigeva un nuovo, metem
pirico concetto dell' intuizione interiore.
Quando
Pla
tone poneva ad oggetto
della socratica cpevTjats
un es
sere soprasensibile e concepiva questo come forma ,
26 IL PERIODO ACCADEMICO
introduceva nel mondo del pensiero socratico due ulte
riori elementi, che erano estranei alla scienza d' allora.
L' uno era 1' eidos, il risultato di una lunga evoluzione
artistica e visiva dello spirito greco; l'altro era la specu
lazione concettuale circa l'ocfa, che da lungo tempo era
stata messa in tacere e a cui egli diede nuovo nutrimento
col problema dell' uno e dei molti e vivace contenuto in
tuitivo con la concezione delle idee. Se consideriamo poi
come quarta forza il dualismo del mito orfico dell'anima,
a cui Platone era incline per innata vocazione e che
piantava forti radici nel terreno del nuovo e soprasen
sibile concetto dell' essere, e vi aggiungiamo l'energia
creatrice di miti della fantasia platonica, non difficile
farsi un' idea del modo in cui Platone doveva influire
sui comuni uomini di scienza del suo tempo come una
mescolanza di noeta, maestro di virt, critico e profeta,
alla quale non apportava essenziale modificazione nean
che ilrigore con cui egli si legava ai ceppi del suo nuovo
metodo. Ma se vero che, con tutto ci, sulla personalit
platonica facevano perno quelle di Teeteto, di Eudosso
e di Aristotele, cio dei pi geniali pionieri della ricerca
scientifica che abbia prodotto il quarto secolo, ecco che
condannata la prudenza di chi, per insufficiente idea
della complessit delle vie dello spirito, vorrebbe can
cellare dalla storia della scienza il pi fecondo rivolu
zionario del pensiero filosofico, solo perch egli non ha
messo innanzi nuovi fatti e risultati, ma scoperto affatto
nuove dimensioni dello spirito.
Tanto a un Aristotele quanto a un Eudosso non po
teva restar celato come nell' opera filosofica di
Platone
fossero fuse insieme la scoperta di oscure regioni del
l' anima, nelle quali non era ancora penetrato l'occhio
di alcuna conoscenza oggettiva, e specifici
ritrovati
scien
tifici ed elementi mitologici. La necessit di questa fu
sione non era affatto dipendente dalla sola inclinazione
L'ACCADEMIA QUANDO VI ENTR ARISTOTELE 27
soggettiva di creatore, bens era una formazione stori
camente determinata, icui momenti furono designati pi
tardi da Aristotele con comprensione egualmente pro
fonda Bia nel senso prammatico che in quello personale.
In un primo tempo,
tuttavia, egli s' immerse con tutta
l'anima nelle totalit di quel mondo incomparabile, come
dimostrano i resti dei suoi primi scritti; e proprio
;
gli elementi non scientifici della filosofia platonica, quello
metafisico e quello religioso, segnarono nel suo spirito
'
1' orma pi profonda e duratura.
Questi
influssi dovet
tero incontrarsi, in lui, con una capacit ricettiva parti
colarmente acuta. L' ulteriore complesso dei suoi pro
blemi si svilupp, per la massima parte, dal contrasto in
cui quelli lo posero pitardi con la sua disposizione me
todica e scientifica, e la loro forza dimostrata nel
modo migliore dal fatto che egli non ne fece mai getto,
pure avendo proceduto, in ogni campo scientifico, oltre
ilimiti platonici. II giovane Aristotele cerc e trov in
Platone la guida per ima nuova vita, proprio come quel
buon contadino
corinzio, di cui egli, nel suo dilogo
Nernto, racconta come ..dalla lettura del Gorgia'-di Pla
tone fosse stato spinto ad abbandonare I' aratro e a cer
care e seguire il maestro.
Platone ha chiarito, nella settima lettera, come l'eser
cizio del bene sia strettamente connesso con la sua cono
scenza. La conoscenza, a cui Socrate attribuiva la capa
cit di render buoni gli uomini, diversa da ci che di
solito ha quel nome nella scienza. Essa un sapere crea
tivo e accessibile soltanto all' anima, che abbia affinit
1
di natura con ci che dev' essere conosciuto, il buono, il
giusto, il bello. Nulla negato con tanto appassionata
energia da Platone, anche nella sua pi tarda et, quanto
il principio che 1' anima possa conoscere ci che giusto
senza essere essa stessa giusta1). In ci, e non nel-
')
Plat- *D.. VU. 3U A-
IL PERIODO ACCADEMICO
l'organizzazione delle scienze, era il significato della fon
dazione dell'Accademia platonica. Tale significato si man
tenne vivo fino all'ultimo, come dimostra la lettera della
vecchiaia di Platone: lo scopo quel3o della convivenza
(auffjv) delle persone elette, le
quali, allevata la loro
anima nel bene, possono per la loro superiore attitudine
spirituale divenir partecipi di quella conoscenza con
clusivamente illuminante, della quale Platone dice che
il commercio con essa non gli sembrava alcun bene per
la massa degli uomini, ma solo per quei pochi che, con
piccolo avviamento, erano capaci di trovarla da s3).
') Plat., epist. VII, 341 C-.
IL
LE OPERE GIOVANILI
Aristotele ha scritto una serie di opere dialogiche, ai
cui resti purtroppo non si pensa come si dovrebbe. Ci
accade nonsoltanto perch in genere si preferiscelasciare
ai filologi la noia dello studio dei frammenti, ma anche
per la persuasione, saldamente stabilitasi fin dalla tradi
zione della scuola peripatetica, che ilvero e proprio Ari
stotele sia quello dei grandi trattati dottrinali. Eppure
anche per 1' esatta comprensione di questi ultimi e della
loro posizione c' molto da imparare dai resti dei dia
loghi perduti. Sarebbe gi una notizia della pi alta im
portanza,
se in virt di quelli potessimo stabilire, circa
la relazione delle due specie di scritti, il solo fatto che i
dialoghi composti secondo il modello platonico cadano
quasi tutti nella giovinezza di Aristotele, e che nella pi
tarda et egli si sa di conseguenza astenuto quasi del
tutto dall' attivit letteraria. Icosiddetti scritti dottrinali
non sono infatti che il sostrato scritto di una vasta atti
vit didattica e scolastica. Certo, anche questa regola ha
le sue eccezioni. L'Alessandro o Sulla colonizzazione de
v'essere, stando al titolo, un dialogo, la cui data cade nel
tempo in cui la politica asiatica del Re, non condivisa
30 IL PERIODO ACCADEMICO
da Aristotele, gli faceva sembrare desiderabile una pub
blica scissione da Alessandro in cospetto al mondo elle
nizzato.
Questo ritardatario dunque venuto in luce per
una particolare occasione giornalistica. Lo stesso pu
direi, mutatis mutandis, della silloge delle 158 costitu
zioni, la quale, come ha mostrato la Costituzione degli
Ateniesi, era di proposito destinata al pubblico e scritta
instile chiaro e vivace. Nonostante queste eccezioni, re
sta valida la regola che Aristotele, nel corso della sua
evoluzione, modific in maniera decisiva la sua opinione
circa ilbisogno che la scienza avesse di esposizione lette
raria, e circa la relazione dell' attivit letteraria con
quella della vera e propria produzione scientifica.
In Platone elemento primario, in origine, l'intento
costruttivo e plastico. Egli non scrive per esporre il con
tenuto della sua dottrina.
Quel
che l'attrae il compito
di rappresentare 1' uomo filosofico nel momento dram
maticamente fecondo della ricerca e della scoperta, del
l'aporia e del conflitto. E ci non inun' esercitazione me
ramente intellettuale ma inlotta con tutte le forze, della
pseudoscienza, del potere politico, della societ, delle
proprie tendenze, con le quali lo sprito della filosofia
platonica doveva necessariamente venire inurto. Secondo
l'originaria
intuizione platonica, la filosofia non un
campo di
scoperte teoretiche, ma una riforma di tutti
ifondamentali elementi della vita. Si pensi, per esem
pio, al duello del Gorgia fra Socrate e Callide, rappre
sentante della concezione politica e sociale fondata sulla
forza egoistica, o alla paradossale raffigurazione del fai >.
sofo contenuta nel Teeteto. Coi dotti colloqui di Gior
dano Bruno, di Hume o di Schopenhauer questi dialoghi
hanno in comune soltanto il nome. Platone compone la
tragedia del filosofo. Innessun caso egli espone sotto ma
schera stilistica semplici modificazioni delle sue opinioni
teoriche, come poi fanno isuoi imitatori.
LE OPERE GIOVANILI 31
Nello sviluppo della forma platonica, il gruppo di
dialoghi che inaugurato dal Teeteto, contemporaneo
all' ingresso di Aristotele nell'Accademia, diviso dai
precedenti da un abisso, nello etesso modo in cui, dal
punto di vista del contenuto, annuncia uno spostamento
dell' interesse centrale della sua filosofia nel senso della
metodologia e dell'astrazione analitica1). L'equilibrio
armonico degli elementi artstico e filosofico in queste
tarde opere perturbato a favore del contenuto scientifico.
Nel Teeteto appaiono per la prima volta disarmonie, che
orecchi raffinati avrebbero potuto
chiaramente percepire.
Esse non derivano tanto da un' esteriore disuguaglianza
in fatto di elaborazione formale, quanto dal trionfo del
l'astratto interesse metodologico sull' impeto drammatico,
e dal conseguente svolgimento di nn tema, che procede
per la sua piana e diritta via. Chi capace di avvertire
la peripezia e il groviglio del nodo drammatico anche
nel campo della metodologia e dell' elaborazione di con
cetti astratti, ritrover certo anche qui il Platone co
struttore di drammi. Ma, nonostante ogni acume della
costruzione logica, pur sospetto
il fatto che proprio il
Teeteto sia apparso per lo pi ai filosofi moderni come
il capolavoro scientifico di Platone. Esso si avvicina
molto, nel fatto, a un'opera di critica dottrinale; e non
un caso che proprio nell'introduzione del Teeteto Pla
tone parli del metodo di composizione dialogica da lui
fino allora seguito, per annunciar semplificazioni fondate
')
Il problema della forma stalo posto per la prima volta
in profonda relazione genetica con 1* evoluzione filosofica di Pla
tone da J. StenzeI nella conferenza1 Literarische Form und philoso-
pkischer Gehdll des platonischen Dialoges, pubblicato in Jahresber.,
d. Schlesischen Gesellschajt
fiir vaterl.
Kultur, 1916, e ristampato
nelleStudien zia Enlwicklungsgeschichte dcr platonischen Dialektik,
Breslavia 1917, p. 123 segg. [2* ed., Lipsia 1931, ibidem]. Per idia
loghi pi tardi cfr. il capitolo Die nette Dialoglorm und die neue
Methode, ibid., p. 45 segg.
32 IL PERIODO ACCADEMICO
sul suo intento di dar maggior adito alla chiarezza scien
tifica e all' immediatezza dell'espressione1).
Nel
Sofista
e nel Politico diventano anche pi evi
denti le difficolt in cui la forma dialogica fa ora incor
rere Platone. L'applicazione a un dato concetto del
metodo della divisione, discendente grado a grado dal
l'universale al particolare, in se cos poco drammatica
e cosi monotona, che ilprotagonista del dialogo, nel prin
cipio del Sofista, deve porre isuoi interlocutori di fronte
alla scelta tra ilnon interromperlo troppo spesso o l'ascol
tare una sua esposizione continuata2). Con ci chiara
mente abbandonato il tipo socratico del dialogo maieu-
tico, e riconosciuto che il dialogo si ormai abbassato a
mera elaborazione stilistica e ad ornamento inorganico.
IlTimeo e ilFilebo non fanno eccezioni a questa regola.
Ci che al lettore appare esteriormente come dialogo
qui solo un trasparente velo stilistico, gettato sopra a un
contenuto puramente dottrinale. IlTimeo attinge la sua
possente efficacia a tutt' altre fonti che alla vivacit del
dialogo, e il Filebo i potrebbe tradurre senza difficolt
in un' unitaria e metodica trattazione, gi prossima al
l'Etica aristotelica. Nelle Leggi scompare anche l'ultima
traccia di figurazione drammatica. Si rinuncia consape-
l) Theaet 143 B. Nel Teeteto ancora mantenuta la forma
esteriore del dialogo socratico, e alla maieutica si allude esplicita
mente pi d' una volta. Ma proprio l' insistente riflessione circa la
natura e ilimiti del metodo socratico mostra come Platone si serva
ormai, di proposito, di quell' antica forma solo per la preliminare
elaborazione confutatoria del problema concernente la definizione
della scienza. Lo Stenzel ha giustamente segnalato Io stretto nesso
del Teeteto col Sofista, in cui quei problemi trovano la loro prima
soluzione; e nel Sofista la forma maieutica senz'altro- messa da
parte. Cfr. le conclusive parole di Socrate nel Teeteto (210 C):
-rooorov yp (vov
f/ jir(
txv1
Svarai, 7tXov 8" oSv.
") Soph., 217 D. Certo, si deve ancora parlare, qui, Sitos npg
Irtog.ma a patto che l'interlocutore risponda sempre di si: e quindi
ci non ha pi nulla che fare col dialogo maieutico %atit kiovv
xal nxpiovv, in cui l'interrogante si astiene dall'esporre la pro
pria opinione e soltanto induce l'interrogato a manifestare la sua.
LE OPERE GIOVANILI 33
volmente alla rappresentazione dei caratteri, e il com
plesso non che una conferenza in tono di proclama
zione solenne, tenuta non da Socrate ma da Platone stesso,
lo straniero ateniese *). Gi dal tempo del
Sofista
la figu
ra di Socrate era stata confinata in parti secondarie:
nelle Leggi viene logicamente lasciata del tutto da parte.
Nel Filebo essa affiora ancora per l'ultima volta. Vi sono
infatti discussi problemi che gi aveva proposto il So
crate storico : ma s' intende che essi sono trattati in tut-
t'altro senso. Platone li risolve con nuovi mezzi meto
dici, di cui Socrate non aveva ancora la minima idea.
La distinzione del Socrate storico e della filosofia propria
in quest' ultimo periodo compiuta pienamente da Pla
tone. Anch' essa un intomo del fatto che 1' elemento
scientifico e la generale tendenza al dottrinale e al logico
portano Platone alla crisi. Ilmetodo della classificazione
e dell' astrazione, ultimo frutto della dottrina delle idee,
al quale Platone negli scritti seriori d ilnome specifico
di dialettica, ha intrinsecamente trasformato il dialogo
polemico sviluppatosi dall'arte confutatoria di Socrate,
lo ha svuotato di contenuto psicologico e lo ha confinato
al limite della trattazione scientifica. Su questa via, un'ul
teriore elaborazione non era possibile. La morte della
grande arte del dialogo drammatico, nel suo classico tipo
platonico, era soltanto una questione di tempo: la sua
radice non era pi vitale. Fu questo il momento in cui
intervenne il giovane Aristotele 2).
') L'autore dell' Epinomide ha, in questo senso, una visiono
esalta dello stato delle -cose quando fa (980 D) che 1* Ateniese ri
chiami idue altri personaggi del dialogo a un famoso passo delie
Leggi con le parole, esulanti da ogni illusione scenica, se ve n
rammentate, giacch ile prendeste certo appunti v6nopv}paTa)
.
Qui
siamo senz'altro in piena lezione accademica.
3) Finora non stato compiuto alcun tentativo di riconnettere
il dialogo aristotelico all'evoluzione formale di Platone. R. Hirzel
(Der Dialog, p. 275) non giunge neppure a porre il problema, in
quanto procede adoperando come .criterio un ideal tipo
jedio
del
8. \V. Jaeoek, luUilele.
34 IL PERIODO ACCADEMICO
Tutti gli Accademici scrissero dialoghi, ma nessuno
in cos gran numero e di tanta importanza come Ari
stotele. Hfatto in B significativo per 1' atteggiamento
della generazione
nuova rispetto a Platone. Tutti si son
serviti del dialogo come di ima forma data, senza preoc
cuparsi dei limiti entro i quali una simile imitazione
fosse possibile. Che il dialogo platonico, nel suo classico
fiore, fosse qualcosa di assolutamente irriproducibile, una
creatura nata da un concorso, quale non avrebbe potuto
pi rinnovarsi, di personale energia formatrice, obbiet
tiva necessit di cose ed esperienza individuale, non ap
pariva ancora chiaro ad essi, tanto pi in quanto
iGreci
erano in genere tratti all'imitazione di ci che una volta
si fosse scoperto
. Per gli scolari il dialogo divenne
ora la forma, nella quale la filosofia esoterica acquistava
vita e figura, e per ci ciascuno desiderava di veder poe
ticamente concretata in tali simboli la forza suggestiva
che ad esso veniva dal maestro. Certo, quanto pi si fece
strada l'idea che Platone, nella sua fusione intima di
personalit, vita ed azione, era una grandezza indivisibile,
che non si poteva immediatamente tramandare nella sua
totalit senza incorrere nella rigiditscolastica o nella su
perficialitletteraria, tanto maggiore fu la consapevolezza
con cui si cercarono forme affatto nuove per ilcontenuto
scientifico, che da quel complesso appariva separabile e
quindi tramandabile alla tradizione. Ma questi tentativi,
logicamente, non si riallacciarono ai dialoghi, bens alla
orale attivit didattica. Caratteristico per l'interiore vi
cinanza, e assenza di distanziamento critico, del giovane
Aristotele rispetto a Platone il fatto che egli non si
dialogo platonico e vedendo 11 tipo aristotelico solo' nella sua anti
tesi rispetto a quello. Idue generi di dialogo nascon per lui solo
dalla diversa natura spirituale degli autori, senza che sia tenuto il
debito conto delle condizioni di fatto che contribuiscono a quella
Senesi.
LE OPERE GIOVANILI 35
mise subito per questa via, ma anzitutto prosegu la
tradizione della forma dialogica. Evidentemente, la spe
cifica essenza platonica viveva per lui pi energica ed
oggettiva nel dialogo che in qualsiasi altra forma. Dai
frammenti superstiti dei suoi dialoghi, dalle imitazioni
dei posteri (tra cui particolarmente da ricordare Cice
rone, che a lui si riconnette vivacemente) e dalle infor
mazioni degli antichi possiamo trarre la conclusione che
Aristotele fu il creatore di un nuovo genere di dialogo
letterario, cio del dialogo di discussione scientifica. Con
giusta veduta, vi si poneva fine al giuoco maieutico della
domanda e della risposta, che ormai sussisteva soltanto iti
apparenza, avendo perduto il suo significato organico fin
dal tempo incui dietro ad esso nonsi celavano che
< lun
ghi discorsi . Ma mentre nel vecchio Platone tutto lo
sforzo si concentrava nel porre al luogo del dialogo la
singola esposizione dogmatica, Aristotele manteneva l'an
titesi dei vari discorsi, secondo quanto accadeva di fatto
nella vita scientifica della pi tarda Accademia. Uno de-
gl' interlocutori doveva assumere la direzione del dibat
tito, porre iltema e riassumere infine irisultati. Con ci
eran posti, certo, stretti limiti alla possibilit di carat
terizzare ipersonaggi. L' arte della composizione dei di
scorsi divenne di dominio della retorica e fu elaborata se
condo le esigenze del Fedro platonico. Maggiore efficacia
che la descrizione dei caratteri aveva ora lo spirito com
plessivo del dialogo: e questo aveva piuttosto acquistato
che perduto in fatto di unitaria tonalit suggestiva, pur
avendo sacrificato, in compenso, la sua oggettivit arti
stica. Era quindi soltanto una logica conseguenza quella
che traeva Aristotele quando, nei suoi dialoghi, finiva
per condurre egli stesso la discussione.
Con questa trasformazione non fu certo restituito
al dialogo il suo originario significato socratico, ormai
tramontato per sempre, ma gli fu ridato, come ai suoi
36 Il PERIODO ACCADEMICO
primordi,
un nuovo senso oggettivo, corrispondente
alla
mutazione dei colloqui nei quali esso continuava
ad
avere la sua viva radice. La scherma drammatica delle
battaglie eristiche, la palestra dei Xyoi, avevano ceduto
il luogo alle lunghe disquisizioni e dimostrazioni teo
retiche, procedenti per definite vie metodologiche. Si
pu lamentare questo mutamento, ma esso rispondeva a
un' esigenza obiettiva. Anche Platone aveva riconosciuto
questa
necessit quando aveva abbandonato il dialogo
maieutico e la caratterizzazione dei personaggi. Aristotele
non condusse alla decadenza del dialogo, come crede di
aver accertato la storia letteraria, che non considera le
interiori forze motrici, ma gli fece compiere soltanto
un inevitabile trapasso a un diverso grado di sviluppo.
D dialogo di discussione scientifica soltanto 1' espres
sione del fatto che l'elemento scientifico spezz conclu
sivamente, in Platone, la sua forma, e la ridusse al pro
prio servizio. Non si tratta di un semplice fenomeno
estetico, ma di un processo dello spirito filosofico, che si
crea dall' intimo la propria forma.
Si soliti di riferire le occasionali espressioni dei
posteri circa la differenza specifica del dialogo aristote
lico a lutti isuoi dialoghi: ma ci impossibile, anche
stando soltanto al titolo. L'Eudemo o sulFanima e ilGril
lo o sulla retorica devono essere stati ancora prossimi
al tipo dell' antico dialogo platonico, quale ilFedone e il
Gorgia. Tra iframmenti dell'Eudemo se ne trova uno,
che mostra ancora la tecnica socratica della domanda e
della risposta1). Che Aristotele intervenisse anche inque-
') Arist.,
(ramai.
44 Rose (cito secondo 1* edizione teubneriana,
la cui numerazione dei frammenti diverge da quella precedente
dell' Accademia di Berlino). Non si tratta tuttavia di un metodo
maieutico di domanda e risposta, ma di un procedimento scola
stico in cui chi dev'essere istruito interviene interpellando, e l'altro
LE OPERE GIOVANILI 37
sti dialoghi eome protagonista cosa che va messa in
dubbio. Idialoghi Politico e Sulla filosofia, che occupa
vano due o tre volumi e pei quali ci attestato che Ari
stotele stesso appariva come direttore della discussione '),
si avvicinavano invece evidentemente al tipo della trat
tazione dottrinale, ed erano quindi totalmente diversi.
L'esempio di Platone dovrebbe costituire una sufficiente
avvertenza per non ascrivere ad Aristotele ima forma
rigida e stabilita una volta per sempre. L' evoluzione della
sua opera dialogica fa intravvedere tutti igradi intercor
renti tra il dialogo maieutico e la pura trattazione dot
trinale. Essa si svolge parallelamente alla sua evoluzione
filosofica, o meglio ne l'organica manifestazione.
Altri chiari esempi della relazione che intercorr-e fra
singoli dialoghi aristotelici e platonici possono esser dati
tenendo particolarmente conto del loro contenuto. L'Eu
demo infatti si riconnette al Fedone, ilGrillo al Gorgia,
ilibri Sulla giustizia alla Repubblicaa). Parimenti, il
l) Per Aristotele come interlocutore principale v. iframm. 8,
9 e 78 Rose.
Quest'ultimo
passo (Cicer., ep. ad Quntum
jr.. Ili,
5, I) sembra si riferisca non soltanto al Politico {de praestante
viro) tna anche ai libri ilepi 8ixauo<jvtJs (de republica:dr. la nota
seguente) che Cicerone eertamente conosceva. Gli sforzi di elimi
nare la contraddizione nei luoghi in cui Cicerone parla del
mot Arislotetnis si rivelano privi di ragion d'essere a un esame
non prevenuto dei luoghi stessi. Inad Att., XIII, 19, 4, egli chiama
aristotelico il metodo di far dirigere il dialogo dall'autore stesso;
io ad jam., L, 9, 23, desipia come aristotelico Iostile dialogico
dei
libri De aratore, per quanto egli stesso non vi appaia come pro
tagonista del colloquio. Entrambe le cose sono giuste. Aristotele
stesso non aveva avuto-! principatus intutti idialoghi: nel Grillo
e neli' Eudemo, anzi, non compariva affatto. Aristotelico l'alter
narsi di lunghi discorsi, il metodo di fornire ciascun libro di un
dialogo di un proemio particolare, e anche l'use della .prima per
sona. Ma in nessun luogo sta scritto che un dialogo non possa
essere aristotelico quando non riunisca in s tutte e tre queste
particolarit. Non lecito forzare le testimonianze per costruire
un tipo unitario. La stessa situazione si ripete a proposito della
notizia, che Aristotele abbia combattuto nei dialoghi la dottrina
delle idee.
') Ci pu sicuramente esser dedotto tanto dalla corrispon-
denz. interna di ciascuna coppia dei dialoghi quanto dal fatto che
38) IL PERIODO ACCADEMICO
Sofista, ilPolitico, ilSimposio e il Menesseno dipendono
naturalmente dagli omonimi dialoghi di Platone. NelPro-
treptico, che non era un dialogo, ei pu rintracciare fino
a risonanze verbali l'influsso del protreptico che Platone
diede nel suo Eutidemo. Platone appariva forse anche
come interlocutore nei dialoghi aristotelici. Dipendenza
fortissima si mostra pure nello stile. Sembra infatti che
Aristotele conquisti presto un suo proprio linguaggio,
uno stile che vuol soltanto essere schietto e chiaro, come
naturalmente sgorga dallo spirito di un puro ricerca*
tore a). Ma nel'Eudemo, p. es., venivano narrati dei miti,
e anche altrove non mancavano ornamenti vivaci: nu
merose, e famose nell' antichit pi tarda, erano le com
parazioni, che in parte si ricollegavano a noti modelli
platonici. Nella comparazione degli uomini sotterranei,
che salgono alla luce e contemplano il cosmo, la lingua
di un' energia trascinante. Nel mito di Mida
dell'jEfide-
mo riecheggia lo stile apocalittico delle parole clic pro
nunciano le Parche nell' ultimo libro della Repubblica.
Cicerone celebra 1' aureo fluire della prosa dei dialoghi
aristotelici, mentre in nessun luogo vi si trovano abbel
limenti retorici. Precisi e chiari nel pensiero, alti e vi-
Cicerone si vale insieme, nel De republica, del dialogo aristotelico
e della Repubblica di Platone. E in quest'ultima proprio dal
problema della giustizia he nasce la filosofia dello Sialo. Gi allora
essa doveva avere, come secondo ttolo, quello di lepl Sixaicovsjg:
e ci importante per la genesi dei sottotitoli dei dialoghi pia-
tonici.
')
Delle condizioni del bello stile, stabilite dall'antica relorica,
la dottrina aristotelica riconosce soltanto la chiarezza (Rhct , i",
1404 b 1; 1414 a 19; Poet., 1458 a 18; e cfr. J. Stroux, De Theo
phrasti virlulibm dicendi, Lipsia 1912, p. 30), considerando com
prese in essa tutte le altre. Questo ideale, che non mirava tanto
alla prassi retorica quanto alla creazione di uno stile schietto e
scientificamente evoluto, fu per abbandonato gi da Tcofrasto e
poi da tutta la retorica posteriore. Essi ei accordavano col gusto
del tempo, mentre Aristotele pensava che la scienza fosse una
forza, che non avrebbe lasciata senza modificazioni nemmeno la
lingua.
LE OPERE CIOVANII.I 39
branti nel tono, questi scritti hanno esercitato influsso
sulle personalit pi raffinate della tarda antichit. Della
loro apertura
spirituale documento il fatto che il cal
zolaio Filisco e il cinico Cratete leggano insieme, nella
bottega, il Protreptico, che Zenone, Crisippo, Cleante,
Posidonio, Cicerone e Filone abbiano subito fortemente,
nella loro filosofia religiosa, l'influsso di queste opere gio
vanili di Aristotele, e che Agostino, il quale conobbe il
Protreptico attraverso l'Ortensio di Cicerone, sia stato
condotto da esso alla religione e al cristianesimo 1). Ineo-
platonici vivono nei dialoghi di Aristotele come in quelli
di Platone, e la Consolatio di Boezio fa risuoDare attra
verso ilMedioevo I'ultima eco della primitiva intuizione
religiosa di Aristotele. Dal punto
di vista del valore arti
stico, 1' antichit, pur pregiandoli altamente, non mise i
dialoghi aristotelici senz'altro alla stessa altezza di quelli
platonici. Ma nel movimento religioso dell' ellenismo essi
hanno avuto importanza quasi maggiore di quelli pla
tonici, la cui arte affatto oggettiva non accostava n edi
ficava.
Ma qual' era, in
queste opere, la posizione filosofica
di Aristotele rispetto a Platone? Sarebbe strano che l'in
fluenza del modello si fosse estesa solo al tema e a par
ticolarit dello stile e del contenuto, e nel resto fosse
stato assunto un punto di vista antitetico a quello pla
tonico, come accade nelle opere posteriori. IlSimposio,
il Menesseno, il Sofista, il Politico, sono stati davvero
scritti allo scopo di superare gli omonimi dialoghi pla
tonici e contrapporre ad essi un esempio del modo incui
') Per la lettura del Protreptico nella calzoleria v. il framm. 50
Rose. Per la conversione di Agostino merc l'Ortensio, v. Confess.,
IIJ, 4, 7: ille vero liber mutarit affectum
meum et ad te ipsum, do
mine, mutarit prcces meas et vola ac desideria mea fecit
alia, viluil
mihi repente omnis vana spes et immortalitatem sapientiae concu-
piscebam aestu cordis incredibili et surgere coeperam, ut ad te
redirem (cfr. anche Vili, 7, 17).
40 IL PERIODO ACCADEMICO
si sarebbero dovute trattare le questioni che vi erano
discusse? Si sarebbe, il discepolo, attaccato alle calcagna
del maestro con ostinata e pedante tenacia, per disgre
gare criticamente isuoi lavori uno dopo 1' altro? Prima
di attribuirgli una simile aberrazione nel senso del gusto
e della convenienza, si sarebbe dovuto considerare pi
seriamente 1' altra possibilit, che anche dal punto di
vista filosofico egli non pensasse, in quelle opere, a nien-
t'altro che a continuare l'opera platonica.
La comprensione dei dialoghi ha avuto cattiva sorte
fin dal tempo in cui, per opera di Andronico e nell' et
di Siila, tornarono in luce gli scritti dottrinali. In quel
tempo ancora altamente pregiati e assai letti, essi pas
sarono presto in seconda linea, fin da quando i dotti
peripatetici si accinsero all'esatta interpretazione degli
altri scritti, da troppo tempo trascurati, e scrissero a tal
fine commentari su commentari. Ineoplatonici pregia
rono idialoghi come documenti di un platonismo auten
tico, in opposizione agli scritti dottrinali, mentre un
esegeta di stretta tendenza peripatetica quale l'acuto
Alessandro di Afrodisia, che doveva averli ancora potuti
leggere nella massima parte, restava imbarazzato di fronte
ad essi. Egli, che dal punto di vista critico-filologico era
certo pi ingenuo di quanto di solito si fosse ai suoi
tempi, ha cercato di spiegarsi la relazione tra dialoghi e
scritti dottrinali come se solo questi ultimi contenessero
la vera opinione di Aristotele, e idialoghi invece rife
rissero false opinioni altrui1). Fin d'allora si riconosce-
*) Elias, in Arist. coteg., 24 b 33 & 8 "AXjavSpoj fiXXijv 5ia-
cpopv
XifS'.
Tfflv xpoapcmy.jv spg x BiaXofOi, ri iv [lv
cotj xpoapaxixotg x SoxoOvxa afcctji Xiyei xal x Xj]9rj , iy
8 xotg Siaoyixotc; x SJJ.oij 8oxovxa x
isuSrJ.
Nonostante- l'in-
genua forma espressiva il commentatore riferisce certo con sostan
ziale esattezza1 l'opinione di Alessandro. Contraddizioni fra le due
specie di scritti erano gi note a Cicerone (de fin., V, 5, 12). Allora
esse si facevano dipendere da esigenze formali della letteratura di
carattere popolare.
LE OPERE GIOVANILI
41
vano dunque contraddizioni fra le due specie di opere.
Ilvano sforzo che itardi peripatetici compirono per ren
dersi conto di questo enigmatico stato di cose si mani
festa anche nella famigerata tradizione circa la diffe
renza tra scritti essoterici e scritti esoterici. Natural
mente si cerc negli scritti dottrinali un punto in cui
Aristotele si esprimesse circa idialoghi, e lo si trov
nella frequente denominazione tjwtspixot Xiyot, che in
alcuni luoghi poteva
esser riferita senza sforzo ai dialo
ghi, pubblicati con intento letterario. A questi
Xofot
essoterici, destinati al pubblico, si contrapposero
allora
gli scritti dottrinali come segreta
dottrina esoterica, per
quanto
inAristotele non si trovasse alcuna traccia di una
simile espressione concezione. Apparentemente, quindi,
il contenuto dei dialoghi stava a quello degli scritti dot
trinali come la SEa all'Wj&sia. Aristotele doveva averli
scritti, in parte,
addirittura con consapevole allontana
mento dalla verit, non ritenendo che questa
fosse ac
cessibile alla moltitudine. Perfino le difficolt della ter
minologia scolastica dei trattati, che fece molto dispe
rare itardi commentatori, furono sfruttate a vantaggio
di questa
misteriosa interpretazione, e si cre ima falsa
lettera di Aristotele ad Alessandro, in cui l'oscurit dei
termini era presentata come mezzo previsto per turlu
pinare inon iniziati.
La critica moderna, che non ha creduto a questa misti
ficazione, di cui era facile scorgere la tarda provenienza
dello spirito del neopitagorismo'),nonsi liberatainvece
') La rinascita dello studio dei trattati operata -da Andronico
(con la quale soltanto cominci a porsi ilproblema della relazione
degli scritti essoterici, quasi esclusivamente letti fino allora, con
queste intatte fonti della pura
>
dottrina aristotelica) cade nei-
1' et di massimo fiore del ncopitagorismo, il quale, in conformit
della sua natura, cercava in ogni pensatore precedente una speciale
dottrina segreta. Si comprende quindi come tali categorie venissero
allora applicate agli scritti aristotelici.
42 JL PERIODO ACCADEMICO
dall'antico pregiudizio concernente idialoghi1}, Certo,
non disponendo essa che di frammenti, la sua situazione
era pi difficile che quella degli antichi. Cos, invece di
credere a quei pochi ma preziosi reBti, si prefer ricorrere
alle testimonianze , e soprattutto a due espressioni di
Plutarco e di Proclo, che provenivano dalla stessa fonte
e parlavano della critica diretta da Aristotele contro la
dottrina platonica delle idee nell' Etica, nella Fisica,
nella
Metafisica
e nei suoi dialoghi essoterici 2).
Qui
si trovava irrefutabilmente accertato che Aristotele avesse
assunto, gi nei dialoghi, la stessa posizione dei poste
riori scritti critici. Non restava allora che o far risalire
1' apostasia di Aristotele da Platone a un momento
assai precoce del suo periodo accademico, o attribuire i
dialoghi a un' et pi tarda. In favore della prima opi
nione si trov con la stessa facilit una testimonianza
in Diogene Laerzio, asserente che la defezione aristote
lica era avvenuta ancor vivo Platone, il quale aveva al
lora
detto;
Aristotele mi ha calpestato come i puledri
calpestano la loro madre, quando liha messi alla luce 3).
*) Solo in et recentissima sono apparsi due studi, che rico
noscono il contenuto platonico dei dialoghi. Ad. Dyroff (Ueber
Aristotele*' ErUtvicklung, nella Festgabe
fiir
Georg v. Herding, Fri
burgo 1913) raccoglie brevemente, dai frammenti, molte remini
scenze platoniche, piuttosto da un punto di vista sistematico e
senza esaminare particolarmente le singole opere, come non sa
rebbe del resto stato possibile nell'ambito del suo lavoro. Il quale
mi venuto sott'occhio solo dopo la stesura delle presenti ricerche,
e ini lia confermato nelle mie convinzioni, per quanto il problema
esiga ora maggiore accuratezza d'interpretazione, come mostra l'opi
nione del Dyroff sul ITe.i'. cptAoaoetscg. La dissertazione viennese di
A. Keil (Diss. Phil. Vindob., XI, 67), che pure ho conosciuto dopo
il compimento del mio lavoro, tratta solo dell' Eudemo e del Jlapl
9iXooocp(ac, da esatti punti di vista (del von Arnim) e con buoni
risultati singoli, nonostante la mancanza di approfondimento filo
sofico. Estranea a entrambi ilavori ancora l'idea di riconnettere
il problema a quello pi vasto dell'evoluzione storica intrinseca ai
grandi trattati.
3i Arisi., franvm. 8 Rose.
') Diog. Lacrt., V, 2,
LE OPERE GIOVANILI 43
Sotto l'influsso di queste
testimonianze il Bernays, nel
suo vivace libro sui dialoghi di Aristotele, si sforz logi
camente di mutar significato a ogni espressione platonica
dei frammenti, interpretandola come ornamento lirico.
All'incontro, Valentino Rose le scov avidamente, per
valersi (secondo la sua fantastica idea del carattere apo
crifo di tutti idialoghi perduti) di ogni traccia di plato
nismo che in essi s trovasse come d'indizio della loro
non autenticit1). Comune a entrambi icritici solo la
persuasione sentimentale, che a un cervello cosi sistema
tico e rigoroso come quello di Aristotele non si poBsa at
tribuire una deviazione da vedute una volta accolte. Fiu
da principio essi lo pensano rivolto contro Platone in
acuti ed indipendenti scritti critici, e trovano nell' idea
di un periodo platonico di Aristotele un' insanabile con
traddizione con la sua fredda e critica natura intellet
tuale.
Ora, evidente: se questa complessiva concezione, in
s coerente, insostenibile, e se Aristotele nei suoi pri
mordi ha vissuto per decenni un periodo platonico, se
ha scritto nello spirito di Platone e ha professato la Bua
dottrina del mondo, cade con ci tutta la comune opi
nione circa la natura dell' uomo e si pone 1' esigenza di
una nuova concezione tanto della sua personalit e della
sua sorte interiore quanto delle forze motrici della sua
filosofia. Nel fatto, quella favola del rigido, immutabile,
freddo, privo d' illusioni e di esperienze, povero di fatali
avventure, soltanto critico Aristotele cede sotto il peso
dei fatti, che sua merc sono stati fin ora artificiosamente
svalutati. davvero sorprendente che gli antichi aristo
telici, iquali avevano ancora interesse a segnar netta-
*)
J. Bernays, Die Di'togf des Aristoleles in ihrevi Verhiillnis
za seineri iihrigea IFcrken (Berlino 1863); Valentini Ro;e Arislc
44 IL PERIODO ACCADEMICO
mente il limite tra Platone e Aristotele e a concepir la
dottrina di quest' ultimo nel modo pi semplice ed uni
tario possibile, non sapessero che fare dei dialoghi? Essi
stavano innanzi al complesso dei trattati come di fronte
ad un' unit sistematica e non articolata cronologica
mente. Alla storia di una filosofia o di un'individualit
umana non sapevano ancora applicare quel concetto del
l'evoluzione, che avrebbe potuto fornir loro proprio Ari
stotele. Cos non potevano far altro che svalutare ilcon
tenuto dei dialoghi come espressioni di vedute non ari
stoteliche e dichiararli una compilazione letteraria e po
polare. In ogni caso, dunque, l'eterodossia di questi
scritti un dato di fatto indiscutibile, che va premesso
a qualsiasi interpretazione. In quale direzione essa si
manifestasse, indicato dall' interesse che ineoplatonici
ed altri religiosi e filosofici adoratori di Platone ebbero
per questi scritti, e l'equiparazione che ne fecero alle
opere stesse di Platone. Esempi di ci saranno recati pi
oltre. Resta solo l'attestazione di Plutarco e di Proclo,
a causa della quale il Bemays considerava a priori ne
cessario di negar nei dialoghi ogni traccia di filosofa
platonica.
Ma anche questo argomento, non regge, appena Io si
esamini pi accuratamente. Anzitutto non si tratta di
una doppia attestazione, giacch la coincidenza verbale
accerta che entrambi gli autori hanno utilizzato ima
fonte comune, non sembrando che Proclo abbia attinto
a Plutarco. L' attestazione in s dice che Aristotele non
combatt la dottrina platonica delle idee soltanto nel
l'Etica, nella Fisica e nella Metafisica, ma anche nei dia
loghi essoterici. A documento di ci viene arrecato, tanto
inPlutarco quanto inProclo, dalla stessa fonte, un'espres
sione di uno dei dialoghi, appartenente
allo stesso Ari
stotele come interlocutore: egli non poteva aver simpa
tia per la dottrina delle idee, anche se per ci egli fosse
LE OPERE GIOVANILI 45
dovuto cadere in sospetto di litigiosit1). Si tratta dun
que di una concreta situazione storica in uno scritto de
terminato (secondo ogni verosimiglianza, il dialogoHe.pl
epiXoGoeptas,
incui Aristotele combatteva anche altrimenti,
com' attestato, la metafisica platonica) a cui si riferisce
l'indicazione di entrambe quelle testimonianze. Non
lecito quindi generalizzarla a tutti idialoghi, ma solo di
concluderne quel che gi prima sapevamo, e cio che tra
i dialoghi ce n' era qualcuno, in cui Aristotele veniva
in contrasto con Platone.
Questo
dato di fatto non ci
autorizza peraltro innessun modo a dare interpretazioni
pi evolute a concetti platonici che si trovino in altri
dialoghi. Dobbiamo piuttosto riconoscere un'evoluzione
') Arist., framm. 8 Rose: Proclo (nella sua lictoxfcjn; xfiv
pgn xv l'IXxrovog Tijicuov Bit' ApioxoxXou? vrsipi)t.ivtuv,
presso Joannes
Pliilopon., de aet. mundi, II, 2, p. 31, 17 Rabe):
xal xivBovssi (ii|8sv oQxceg 6 ivrjp xsivog (seri. Aristotele) no-
itoii)3ac$ou tW IlXcittovog ; v x5>v tSev inrifl-soiv, 06 jivev
v Xoyixoig xtpsxEapaxa x etSyj xaXcov, XX xal v fythxotg itpig
t a&Toayav Biapaxpsvog xal v cpuaixolg ox iwv
xg yev-
otig stg xg ISiag vacfpetv, &g v x(p rcapt ysvosuig Xyei xal
rp&oos xal v x (isx x tpocix 7toXX<jj nXiov Sxe rcspl xrSv
py.fflv itpayiiaxeo[isvog xal xaxaxeEvmv paxpg xanjyoplag xffiv
ISsv v xotg itpixoig, v xotg pcoig, v xotg xeXsoxaEoig xijg
icpaypaxsEag xsEvvjg xal v xotg 8 1aX y o ig aaepoxaxa xsxpa-
y<bg [ivj Bvaaat tip 8yp.axt xoxqi cufuia&stv, xv xig a&xv
otrjxai Bi iXo ve ix av v xiX ysi v .
Plut-, adv. Colot., 14 (1115 B) : xg ye jvijv ESag, spi 5>v
yxaXst -ctj HXxum, jcavxax0 xivSv 8 'Apt0T0TXi)g xal redoav
_
nyuiv noplav a-xalg v xotg S-txotg Orcopvijpaoiv, v xotg (jisx x
cpooix, v xotg) cpocixotg, 8t xfiv 5<oxsptxffiv SiaXyrav,
ipiXovsixxepov
ivtoig ISogsv 1) tpaoaoywxapov x.... xv
Soyfixiov
xo8x(Dv,tbgitpo8ipsvog xrjvIIXTuivcc CrtiepsErcatvcpiXoooipCav.
L'antica fonte, che entrambi seguono e che lo scrittore pi lardo,
Proclo, riferisce nella forma pi precisa, elencava singolarmente
tutti iluoghi delle opere aristoteliche, in cui era combattuta
la dottrina delle idee: cos sono ricordati tre luoghi della Meta
fisica
(libri A, Z e MN), sono itati con reminiscenze verbali i
passi dei Secondi analitici (A 22, 83 a 33) e deli Etica Nicotnacliea
(A 4), e cos quello sopra spaziato (del Hept cpiXooo(ag), l'unico
che avesse potuto trovar nei dialoghi l'autore di
quella raccolta di
passi, evidentemente assai accurata e completa. Questo elenco
quindi una prova diretta del fatto che la polemica antiplatonica
compariva solo in un punto dei dialoghi.
46 II. PI:R!0!iO Af.CAI)i;51H'0
interna dei dialoghi anche dal punto di vista filosofico,
per la stessa ragione onde riconoscemmo necessario di
ammetterla riguardo alla loro forma.
Einrealt lo stesso Plutarco, per quanto secondo Popi-
mone finora corrente egli denoa aver trovato dappertutto,
anche nei dialoghi di Aristotele, un'antitesi di quest'ul
timo a Platone, ci offre una prova esplicita e inequivo
cabile del fatto dell'evoluzione filosofica dello Stagirita.
In un passo, che finora stato totalmente trascurato T),
egli cita Aristotele come esempio illustre del fatto che
il vero filosofo sappia modificare le sue vedute senza
rammarico, anzi addirittura con gioia, appena abbia ri
conosciuto il suo errore. Aristotele, Democrito e Cri-
sippo mutarono in tal modo le loro precedenti opinioni
filosofiche: e la parola che Plutarco usa per designare que
sta mutazione { peratf'ssd'ac ) mostra come egli non possa
affatto alludere a questioni di valore soltanto secondario,
perch nella filosofia ellenistica essa era il termine tec
nico per indicare iltrapasso da una scuola all' altra. Egli
deve anzi aver saputo che le opinioni precedenti (t
Ttpod-ev artfp pav.ovxa) in questione si trovavano espres
se nei dialoghi di Aristotele. Ci diviene evidente se si
torna ad osservare ancora una volta 1' altro passo, e lo
esamina accuratamente. Aristotele attacc Platone non
soltanto nei trattati didattici, ma anche nei dialoghi,
come risulta da questo e da quest'altro passo. T.a con
trapposizione implica evidentemente il tacito presuppo-
'} Plut., de virt. mar., cap. 7, p. 417 segg.: Infatti perch
nella ricerca filosofica non spiacevole il lasciarsi guidare dagli
altri e il modificare pi volte la propria opinione, ed anzi gli
stessi Aristotele, Democrito e Crisippo hanno abbandonato tran
quillamente, senza resistenza e con gioia, alcune delle loro teorie
precedenti?... perci il pensiero si volge volentieri verso la verit,
quando essa viene in luce, e dice addio all'errore. Ho richiamato
per la prima volta 1' attenzione su questo passo in Hermes, LXIV
(1929), p. 22.
LE OPERE GIOVANILI 47
sto che qui s' incontri qualcosa di
notevole
e di contra
stante alla regola. Plutarco, cio, deve aver considerato
come regola che idialoghi di Aristotele fossero scritti
da un punto di vista platonico. Ci reso ovvio anche
dal fatto che egli parla occasionalmente di essi come
delle opere platoniche di Aristotele1).
Come sopra s' visto, nella tarda antichit queste cose
non erano chiare ad ognuno come a Plutarco: il che
dimostrato anche da un' importante attestazione di Eu
sebio circa la grande opera polemica che lo scolaro di
Isocrate, Cefisodoro, aveva scritto contro Aristotele
").
Quest'
opera dev' essere stata un prodotto della concor-
')
Plut., adv. Colot., 20: Come diceva Aristotele nelle sue
opere platoniche (v
toff
IIXatu>Yutots).
Questa allusione vien di
solito riferita al dialogo Sulla filosofia.
Vero che una tradizione
sicura c'informa che questo dialogo conteneva un attacco a Pla
tone: ma se, com' verosimile, l'espressione le opere plato
niche era diventata un concetto fisso per indicare l'intero gruppo
degli scritti dialogici, nulla ostava a che fosse designato in tal
modo anche illlspt ptXooocpCa;. Nel fatto, la maggioranza di questi
scritti era platonica, non solo nella forma ma anche nel contenuto
doUrinale.
'I Eusch-, praep. evang., XIV 6 (che qui segue, coin egli stesso
racconta, Numenio):
Questo
Cefisodoro, quando vide che il suo
maestro Isocrate veniva attaccato da Aristotele, non sapeva invero
nulla di Aristotele stesso n aveva alcuna conoscenza di lui: ma,
vedendo che la filosofia di Platone era celebre, credette che Ari
stotele fosse un suo seguace, e cos polemizz contro Aristotele, ma
in realt colpi e vituper Platone, cominciando con la dottrina
delle idee e terminando col resto, per quanto egli non ne avesse
nessuna conoscenza personale e si basasse solo su congetture, cor
rispondenti alle opinioni correnti a tale proposilo . Alla fine di
questo capitolo un altro passo, di contenuto simile: Questo
Cefisodoro non combatt colui contro il quale polemizzava, ma com
batt colui contro il quale non intendeva polemizzare. Per quel
che concerne la spiegazione qui data del fatto che Cefisodoro nella
sua polemica contro Aristotele non attaccasse la dottrina di que
st'ultimo ma quella di Platone, essa un escogitazione ad hoc
abbastanza stolta per non meritare di esser presa sul serio neppure
un istante. Dire che Cefisodoro non aveva bastevole conoscenza
della filosofia di Aristotele e attacc in sua vece quella di Platone
perch era pi
famosa
cosa che poteva venire in mente solo
a clii non possedesse la pi lontana idea dell' effettiva situazione
storica deli' et incui Aristotele era ancora membro dell'Accademia.
48 IL PERIODO ACCADEMICO
renza tra l'Accademia e la scuola d' Isocrate, e risalire al
tempo in cui Aristotele, che allora era un giovane mem
bro della scuola di Platone, v' introdusse lo studio della
retorica e port cos ad aperta rottura la latente rivalit
delle due istituzioni. Eusebio ci racconta che Cefisodoro
scese in campo contro la dottrina platonica delle idee e
contro tutte le altre sue teorie, e manifesta la sua
sorpresa per il fatto che egli avesse posto Aristotele
in connessione con queste concezioni. Inconformit del*
. 1' opinione popolare corrente, Eusebio si rappresentava
Aristotele come il naturale antipodo di Platone. Egli
(o la sua fonte, Numenio) non sapeva, e difficilmente
:
poteva sapere in quella tarda et, che quello che Cefiso
doro aveva avuto dinanzi agli occhi era un Aristotele
totalmente diverso da quello dei trattati didattici, iquali
furono pubblicati solo secoli pitardi ed erano f amilic
ai lettori dell'et imperiale. Cefisodoro conosceva A
stotele esclusivamente attraverso le sue pubblicazioni h
. terarie, cio attraverso idialoghi che egli scriveva nel
tempo incai era ancora membro dell'Accademia. Ilfatfn
che egli scrivesse un libro contro Aristotele e in esso
assalisse le teoria delle idee non pu quindi insegnarci
se non che fino a quel momento tutti gli scritti di Ari
stotele si basavano totalmente sulla filosofia di Platone.
La nostra interpretazione dei frammenti superstiti
dei dialoghi deve giustificare questa
tesi nei casi parti
colari; e le questioni da porre debbono con ci risultare
dai frammenti e non possono semplicemente mirare a
una conclusione generale. Occorre partire dalle pi salde
basi cronologiche e filosofiche, che si possano ricavare
dai frammenti. Anche della genesi giovanile dei dialoghi
la dimostrazione pi calzante pu esser data soltanto at
traverso l'interpretazione singola.
in.
L'EUDEMO
TJ et di questo dialogo, che prende ilnome dall'amico
di Aristotele Eudemo di Cipro, determinata dal suo
stesso motivo occasionale, che possiamo ricostruire Benza
difficolt in base a un racconto di Cicerone circa il so
gno d Eudemo1).
Durante unviaggio inTessaglia questo scolaro di Pla
tone, esule dalla sua patria, era stato colpito da una grave
malattia. Imedici di Fere, dove egli giaceva ammalato,
avevano abbandonato ogni speranza. Ma ecco che gli ap
parve insogno un giovine di leggiadro aspetto, e gli pro
mise che sarebbe guarito inbreve tempo, che pochi giorni
dopo il tiranno Alessandro di Fere sarebbe morto e che
lui stesso sarebbe ritornato dopo cinque anni nella sua
patria. Aristotele raccontava, evidentemente nell' intro
duzione, come la prima e la seconda promessa si realiz
zassero subito: Eudemo guar e il tiranno fu poco dopo
assassinato dai fratelli della moglie (359). Tanto mag-
') Arisi., framm. 37 R. (Cicer., de div., I, 25, 53). 11 dialogo
era evidentemente ancora molto letto nell' et imperiale. In un
catalogo di libri del sec. Ili d. C, conservato- in un papiro edito
da Medea Norsa in Aegyptus, II (1921), p. 16, il libro appare tra
idesiderata.
4.
W. Jaeger, Aristotele.
50 IL PERIODO ACCADEMICO
giore divenne allora, nell' esule, la speranza di veder com
piuta cinque anni dopo anche la terza promessa e di
poter cos tornare a Cipro. In questo periodo di tempo
si trovava ad Atene Dione, bandito da Siracusa. Con
l'aiuto finanziario dell'Accademia egli arruol una banda
di volontari coraggiosi, pronti a rischiare la vita per la
liberazione della patria di Dione. Anche qualche giovine
filosofo, e tra questi Eudemo, si un all' impresa, entu
siasta degl'ideali politici d Platone, che Dione avrebbe
ora dovuto tradurre in atto. Ma nei combattimenti in
nanzi a Siracusa Eudemo trov la morte, proprio cinque
anni dopo quel sogno (354).
Questo
inaspettato compi
mento della predizione fu interpretato nell'Accademia
nel sengo
che la divinit avesse predetto ilritorno nella
patria eterna dell'anima, e non in quella terrena.
Nell'introduzione del dialogo, con cui egli eternava la
memoria del caro amico e cercava di consolare ilproprio
dolore, Aristotele raccontava la storia del sogno di Eude
mo, per mostrare come, nella sua conclusione, la divinit
stessa confermasse la verit della dottrina platonica del
l'origine ultraterrena dell'anima e del suo futuro ritorno
nell'aldil. Ci offriva l'appiglio per un dialogo meta
fisico aull' anima , al centro del quale stava il pro
blema dell' immortalit. L'ambiente ideale del Fedone,
abbandono del mondo e preparazione alla morte, rivive
nello scritto del giovane Aristotele. La vita terrena del
l'anima nei ceppi della corporeit, che il Fedone pari-
gona a un carcere, divien per lui un' et d' esilio del
l' anima dalla sua patria eterna.
Quale
ardore di nostal
gia per la sicurezza e la pace dei campi ultraterreni
nell' immagine del profugo, che in terra straniera con
templa la patria dalla quale stato espulso! UEudemo
era una consolatio, uno scritto consolatorio. Della sin
golare insensibilit dei critici, che non sapevano scor
gervi altro che una gelida esercitazione stilistica nella
T.'cEUDKjUO
51
maniera del Fedone, non mette conto di parlare. Solo la
viva fede nell' inversione dei valori della vita e della
morte, compiuta dal Fedone platonico, poteva avere
un' autentica virt di consolazione. L' autore delI'Eudento
era radicato con tutto il suo spirito in questa fede nel-
l'aldil, e nell' intuizione del mondo e dell' anima che
ad essa si collegava. Ineoplatonici si valsero perci del-
YEudemo e del Fedone come di fonti equivalenti della
dottrina platonica dell' immortalit, ed alla stregua di
questa noi vogliamo ora esaminare iresti del libro ari
stotelico.
Come Platone nel Fedone, Aristotele combatteva nel-
YEudcmo la concezione materialistica contraria all'idea
dell' immortalit, e proprio nella stessa formulazione che
gi in Platone assumeva quella dottrina: l'anima non
altro clie 1' armonia del corpo, cio quell' entit, diversa
dalla somma degli elementi materiali ma risultante come
prodotto della loro esatta connessione, a cui anche
l'odierno materialismo d il nome di anima. Della cri
tica, che neWEudemo era rivolta contro questa conce
zione, si sono conservati due argomenti. Il primo dice:
l'armonia ha qualcosa che le si contrappone, la disarmo
nia. Dunque 1' anima non armonia I).
La non identit dei due concetti qui dimostrata
merc la prova della non identit di ima loro nota: pre
supposta quindi l'importante nozione che l'identit
degli attributi condiziona l'identit degli oggetti. L' at
tributo che gli serve di nota comparativa quello della
possibilit logico-formale di costituire un' antitesi di con
trariet rispetto ai concetti in questione, anima e armo
nia. La cosa si dimostra possibile soltanto nel caso del
l' armonia, l'anima non ammettendo alcun contrario di
tale specie. Come Aristotele, che definisce il sillogismo in
') Arist., frairmi. 45 R.
52 li PERIODO ACCADEMICO
forma cobi breve e tagliente, con palese soddisfazione
per la sua serrata necessit logica, sia giunto a dimo
strare la non identit dei due concetti e del loro con
tenuto proprio dal loro diverso comportamento quanto
alla possibilit di applicare 1' antitesi di contrariet, non
appare immediatamente chiaro. Chiaro diventa subito,
invece, appena si faccia ricorso al seguente principio
della dottrina aristotelica delle categorie : la sostanza
(oata) non ammette alcun contrario, cio non pen
sabile alcuna opposizione di contrariet di cui essa sia
elemento1). Nel fatto, dunque, ilsillogismo non contiene
soltanto la prova che 1' anima non sia armonia, ma pre
suppone implicitamente
ci che molto importante
per ilpunto di vista filosofico del dialogo
che l'anima
sia una sostanza. Non certo strano, allora, che un pen
satore che considerava indiscusso questo presupposto po
tesse giungere a colpire la tesi materialistica con 1' ap
plicazione di quel principio della logica formale, che
senza dubbio coglieva il punto debole dell' avversario.
Ora, interessante la relazione dell' argomento aristo
telico con quello platonico del Fedone (93 C segg.).
Que
sto pi complesso. Secondo Platone, l'anima o mo
rale, razionale e buona, o immorale, irrazionale e cat
tiva.
Queste
opposte condizioni o costituzioni sono da lui
spiegate come una sorta di ordine e di armonia, e rispet
tivamente di disordine e di disarmonia, dell' anima. Di
tali propriet possono darsi, nell' anima, diversi gradi.
Dunque anche l'armonia, e rispettivamente il suo con
trario, pu essere armonica in maggiore o minor grado.
Ora, se la tesi dell' avversario fosse giusta, e Be 1' anima
non fosse che un' armonia di certe condizioni, si po
trebbe senz' altro sostituire al concetto di armonia quello
di anima e ne deriverebbe 1' assurdo cbe 1' anima po-
') [Arist.], categ., 3 b 21 segg.
L' EUDEMO 53
Irebbe essere pi o meno anima 1). L' armonia pu dun
que essere soltanto una propriet dell'anima, e non l'ani
ma stessa. La forma modificata, nella quale questa dimo
strazione si presenta in Aristotele
giacch il suo ar
gomento non che ima trasformazione di quello plato
nico
, mostra chiaro 1' ostacolo che la sua logica in
contr nel modello del maestro. Anche la prova del
Fedone ha per base un principio logico, che la dottrina
aristotelica delle categorie formula nel modo seguente:
considerata in generale, la sostanza (cuoia) non ammette
ins alcuna distinzione di grado (t jiXXov -/.ai txov),
cio io non dico che una sostanza non possa essere pi
o meno sostanza di un' altra, ma che ogni sostanza non
possa essere in grado maggiore o minore ci che essa .
P. es., che un uomo sa ora uomo in grado maggiore di
prima impossibile, mentre possibile che sia ora pi
pallido di prima. La categoria della qualit ammette per
sua natura unpie un meno, quella della sostanza no").
Da questa legge deriva, per chi, come Platone, consideri
1' anima come una sostanza, che 1' anima non ammette
(come invece ammettono 1' armonia e la disarmonia, la
virt e il vizio, la scienza e l'ignoranza, e in genere ci
che relativo) una distinzione di grado 3). Anche Pla
tone, dunque, deduce la non identit di anima ed ar
monia gi dall'impossibilit di applicare ad entrambi
iconcetti unmedesimo principiologico, ossia, esprimendo
la cosa in termini aristotelici, dalla loro pertinenza a
categorie diverse.
J) Plat., Phaed., 93 B-D.
*) [Arist.], categ., 3 b 33-4 a 9.
') [Arist.l, categ., 6 b 15: Cmpxet. S xal ivavTiriig lv toTg
xpig ti otov peTTj
xaxtif
IvccvtCov, ixTspov Sv Tfflv np6( ti, xal
irooT|ir; voia. Da ci segue che (6 b 20) SoxstSxal t pSXXov
xal t ttov 7ud"/,sa0ai T xptj ti, allo 6tesso modo in cui
l'incompatibilit del (iSXXov xal )5ttov con l'oola deriva dal
l'incompatibilit di questa con l'vavTtiTiij. Che non ogni en-
tit relativa ammetta una diversit di grado dotto in 6 b 24.
54 II. PERIODO ACCADEMICO
II motivo della modificazione arrecata da Aristotele
alla prova del Fedone con ci chiarito pienamente. Se
condo la concezione platonica un pi e un meno, ima
distinzione di grado, non pu mai sussistere nella realt
assolutamente determinata (itpas) ma solo in quella
indeterminata (impov). Dov' possibile un' antitesi di
contrariet, possibile anche 1' esistenza di un medio tra
idue estremi, e quindi una scala di differenze graduali,
un pi e un meno. Il principio adoperato nel Fedone,
che la sostanza non ammette un pi e un meno, vien
cosi ricondotto nell' Eudemo al principio che ne costi
tuisce la base: la sostanza non ammette alcuna antitesi
di contrariet. Di qui la semplificazione della prova in
un solo sillogismo, col quale Aristotele raggiunge lo stesso
scopo.
Contemporaneamente, egli ottiene anche un secondo
argomento contro la tesi materialistica da ci che gli
resta dopo aver liberato dalla sua corteccia il nocciolo
della dimostrazione platonica. Egli lo espone nel modo
seguente: all' armonia del corpo opposta la disarmonia
del corpo; ma disarmonia del corpo vivente malattia,
debolezza, bruttezza. La prima di queste,
la malattia,
deriva da un' asimmetria degli elementi, l'altra, la de
bolezza, da un' asimmetria delle parti omogenee dell' or
ganismo (pocoEpi}), la terza, la bruttezza, da uu' asim
metria delle parti del corpo. Ora, se la disarmonia
malattia, debolezza e bruttezza, 1' armonia salute, forza
e bellezza. Ma 1' anima non alcuna di queste cose : n
salute, n forza, n bellezza. Un'anima l'aveva infatti
anche Tersile, nonostante tutta la sua bruttezza. Dunque
1' anima non armonia ').
Questa dimostrazione deriva immediatamente dal
l' antropologia platonica. Platone distingue psTaC
del-
') Arist., framm. 45 (p. 50, 13 JR.).
l'EUDEMO 55
l'anima e del corpo. Quelle
dell' anima sono sapienza,
coraggio, giustizia e temperanza, quelle del corpo salute,
forza e bellezza. Di fronte ad esse sta la serie delle qua
lit opposte, delle xaxtca del corpo e dell' anima. Le
Ccpeta<
dipendono dall' armonia (simmetria), le
tcay.fat
dalla disarmonia (asimmetria) rispettivamente dell'anima
e del corpo. La spiegazione della malattia, della debo
lezza e della bruttezza come derivanti dall' asimmetria
del corpo e di sue parti o relazioni fu attinta da Platone
alla medicina del suo tempo, alla quale egli ricolleg in
generale la sua scienza etica come terapia dell' anima,
vedendovi un modello di vera scienza e di metodo rigo
roso. La dottrina platonica della virt una teoria della
buona e della cattiva salute dell' anima, costruita secondo
il modello della medicina, e suo principio il concetto
della misura (pitpov) e della simmetria o armonia. Ma
se certo, a priori, che 1' armonia del corpo il prin
cipio delle petal aupato?,
salute, forza e bellezza, non
possibile interpretare nello stesso tempo anche l'anima
come armonia del corpo.
Questo
argomento ha il van
taggio di sconfiggere 1' avversario materialista sul suo
stesso terreno. L' interpretazione della malattia come
asimmetria e della salute come simmetria del corpo po
teva pretendere accoglienza anche presso irappresen
tanti della scienza naturale, mentre non poteva contar
su di essa quella della virt come simmetria dell' anima,
da cui partiva il Fedone. La dottrina platonica delle
virt dell' anima e del corpo, che Aristotele qui segue
ed elabora nei particolari, del tutto estranea ai grandi
trattati. In essa vive uno spirito pitagorico-matematico;
la retta costituzione morale dell' anima, al pari della
normale e regolare costituzione del corpo, per Platone
soltanto un caso particolare della legge universale di sim
metria cosmica, secondo la dottrina svolta nel Filebo
56 IL PERIODO ACCADEMICO
in connessione con la sua pi larda concezione del.
mondo J).
L' analisi delle due dimostrazioni ha prodotto un du
plice risultato. Da un lato essa mostra la piena dipen
denza da Platone, nel campo metafisico, nella quale si
trova ancora l'Aristotele dell' Eudemo. E non solo nel
rifiuto del materialismo, ma anche nel lato positivo della
dottrina. Solo alla mancanza di un'interpretazione ap
profondita da ascrivere il fatto che finora non si sia
riconosciuto come gli argomenti dell' Eudemo siano ba
sati sullo stesso fondamento che sostiene la metafisica e
la teoria dell'immortalit del Fedone-,
sul concetto pla
tonico della sostanza e dell' anima. Che per Aristotele
l'anima sia qui ancora assolutamente sostanza confer
mato anche dai tardi imitatori, p. es. Olimpiodoro
(Arist., framm. 45), che riferisce 'la prima argomenta-
J) Per la dottrina delle tre psxal
ocufiatos
cfr. Plat.,
591 B; Leges, I,<31 C; Phil., 25 D segg. (e specialmente 26 B), ecc.
Esse vengono volentieri messe in parallelo con le virt dell'anima.
Se in Phil., 26 B esse sono fatte dipendere da un determinato rap
porto numerico di certe antitesi, chiara, come ora pu vedersi,
la derivazione di questa teoria dall' Eudemo. Ivi si pu anche
vedere come l'etica del |Utpov si basi sulla diretta trasposizione
nel campo spirituale di vedute proprie della medicina e della ma
tematica contemporanea. La usctijc aristotelica torna a connettersi
consapevolmente a questo punto di partenza, e sviluppa l'analogia
in forma anche pi rigorosa; anche il [lxpov delia medicina un
giusto mezzo soggettivamente determinato e ha' bisogno
dello croxASscff-a'., come gi insegnava la medicina ippocratica.
Le petal oipatogtornano ad apparire solo nella giovanile Topica
(116 b 17; 139 b 21; 1-15 b 8) e nel VII libiti della Fisica (246 b 4),
la cui composizione appartiene, com' noto, a un'et o prossima
o addirittura coincidente col periodo accademico (cfr. E. Hoffmann,
De Aristotelis Physicorum l. VII, Dissert., Berlino 1905),
Questo
quadro completato dalla dottrina delle quattro Sparai
the
esposta nel Prolreplico e che parimenti ancora del tutto pla
tonica. Fra la definizione della salute come simmetria degli
cior/sEa,
data nell* Eudemo, e quella della stessa come simmetria del caldo
e del freddo, data nella Topica, non c' del resto alcuna differenza,
perch gli axovzXn. sono derivati dalle supreme antitesi del caldo
e del freddo, dell'umido e dell'arido, ed anche nei trattati Ari
stotele chiama spesso queste ultime col nome di elementi,
l'eudemo >
57
zione nella forma seguente: l'armonia ha qualcosa di
contrapposto,
l'anima no, perch una sostanza. La
petitio principii, che a ragione si scorta in questa for
mulazione, non minore nella sua forma originaria, in
cui essa tacitamente presupposta
1j. Come si mo
strato, essa risale a Platone stesso, che nel Fedone parte
dallo stesso presupposto. Ilcarattere dogmatico della di
mostrazione mostrato anche pi chiaramente da Plo
tino, quando si limita a dire: 1' anima una oaia, 1' ar
monia no 2),.
La dottrina posteriore di Aristotele occupa una po
sizione intermedia tra la concezione materialistica, che
l'anima sia armonia del corpo, e quella platonica del
l'Eudemo, che sia una sostanza indipendente. L'anima
sostanza solo come
ivteXIx61*
ojj-axoc; tpuctxo ouvip-et
a>f)v
!xoVT0S
3)- Essa non pu separarsi dal corpo, e per
ci non immortale; ma, legata ad esso, il principio
informatore dell' organismo. Con la concezione che ne
offre l'Eudemo quadra invece ancora ci che Plotino,
dal punto di vista platonico, obietta contro la dottrina
aristotelica dell'anima come entelechia: Essa non ha
esistenza per il fatto di essere forma di alcunch (sISo?
icv{), ma senz' altro realt (ooCa). Non trae il suo
essere dalla circostanza di abitare in un corpo, ma esiste
prima ancora di appartenere
ad esso 4). E siccome
') Bernays, I. ., p. 145, n. 15.
') Piotili., Firn., IV, 7, 8 (133, 19-134, 18 Volkmimn). Che Plo
tino attinga all' Eudemo e non al Fedone, dimostrato dalla scis
sione dell' unico argomento del Fedone (93 B segg.) nei due argo
menti che ne ricav Aristotele. Questi son da lui sostituiti tacita
mente a quello platonico, mentre son riportati senza modificazioni
idue primi argomenti del Fedone (92 A-C e 93 A).
')
De anima, B 1, 412 a 19 segg. Neil' intero capitolo Aristo
tele discute la sua precedente concezione dell'anima come sostanza,
e la limita in modo, che essa non appar pi separabile dal corpo,
ma solo 4j oa'~ f, tiv Jyov (412 b 10) .
') Plotin., Enn., IV, 7, 8 (134, 19 V., e specialmente 135, 31
segg.).
58 IT. PERIODO ACCADEMICO
V Eudemo sostiene proprio la preesistenza, gi dimo
strato anche da ci che l'anima c in s oofa. Possiamo
perci non meravigliarci del fatto che lo stesso Plotino,
che combatte il concetto aristotelico dell' anima, si ap
propri totalmente 1' argomento dell' Eudemo. Viceversa,
si volgono contro il sillogismo dell' Eudemo idifensori
dell'Aristotele autentico , Alessandro di Afrodisia e,
dopo di lui, ilsuo seguace Filopono. Secondo essi l'anima
ha un
opposto, la privazione, e ci infirma l'argomento.
Questa concezione presuppone il concetto di entelechia
e ne coerente conseguenza. Alessandro respinge 1' argo
mento mettendolo insieme con quello del Fedone da cui
si svolto 1). Di fatto, l'elemento caratteristico nel pri
mitivo concetto aristotelico dell' anima che questa non
ancora eT8o$ xivs, ma e!8$ -ti, un'idea o entit
ideale. Ci esplicitamente riferito dalla tradizione, e
solo ora pu essere pienamente compreso 2). Ma Aristo
tele stesso ha lasciato un' importante testimonianza, che
illumina il fatto della sua evoluzione. Nel luogo del De
anima in cui combatte la dottrina dell' armonia, egli
cita il suo scritto precedente e ne ricava la seconda, na
turalistica obiezione, che ancora elabora in qualche
aspetto, mentre passa senz' altro sotto silenzio l' argo
mento tratto dal carattere sostanziale dell'anima a).
Il secondo frutto dell' analisi nell' accertamento
')
Alex-, in Arisi, de on., apud Fhilop., comm. in
Arisi,
de an.,
p. 144, 25 segg. (Hayduck). L' eidos e la privazione costituiscono la
ivavcCwotg, il cui sostrato la 5Xrj (cfr. Metaph., A 2, 1069 b 3
segg., e speciali, b 32-34 e 1070 lj 18; ecc.). L'anima come eidos
aristotelico ha dunque un ivavztov, esattamente come l'armonia.
8)
Arist., framm. 46 (52, 19 R.) xal v -cip EiSijptp.... elBg t;
itocpaivctai
crjv stvai. Essenziale la mancanza di un ge
nitivo come otpatog o ttvj, che non pu essere supplito col
Bernays (1. c., p. 25), per spiegare cos l'espressione come equivoco
mascheramento di una celata antitesi rispetto a Platone. Quella
espressione era sentita da Simplicio come qualcosa che divergeva
dalla normale concezione aristotelica.
'l Arisi., De anima, A 4, 408 a Isegg.
L' EUDEMO
59
della piena indipendenza del giovane Aristotele rispetto
a Platone nel campo logico-metodologico, in cui egli, no
nostante la sua dipendenza in tema di generale conce
zione del mondo, gli sta di fronte con libert assoluta,
e forse con un lieve senso di superiorit. La riduzione
dell' argomento platonico ai suoi elementi e la netta
costruzione tecnica delle due argomentazioni che egli ne
ricava tradiscono una lunga esperienza in queste cose,
cosi come isuoi mutamenti presuppongono
le nozioni
della dottrina delle categorie. Che il superstite scritto
sulle categorie non possa esser nato prima dei tempi del
liceo e anzi non sia neppure stato scritto da Aristotele
(esso caratteristico del periodo di naturalismo ed em
pirismo, che s' inizi nella scuola dopo la morte del
maestro) cosa senza importanza: l'impostazione fon
damentale e iprincipali elementi della dottrina delle
categorie erano gi realt, prima ancora che Aristotele
osasse scuotere ifondamenti metafisici della filosofia pla
tonica 3). Vediamo da ci quando debole fosse origina-
l) Le Categorie non possono essere uno scritto giovanile di
Aristotele, dal momento che come esempio per la categoria del
dove vi nominato il Liceo, e cio senza dubbio la scuola ari
stotelica, dalla quale sono tratti volentieri anche in altri casi gli
esempi per 1concetti logici. Basta pensare a Cori6co; il frequente
uso che di tal nome vien fatto nelle esemplificazioni scolastiche
acquista sapore solo quando si pensi alle lezioni di Asso a cui egli
era presente. L'inversione nominalistica della dottrina aristotelica
della prima e della seconda oticla quale appare nelle Categorie
non ammette eliminazioni interpretazioni conciliatorie: anche la
sna forma non c aristotelica. Non bisogna negare la giusta impor-
tanza a questi spontanei e poco appariscenti indizi linguistici. Inol
tre, l'autore presuppone come gi nota la dottrina delle Categorie
e ne sceglie ed espone soltanto pochi problemi. Tutto ci non im
pedisce di riconoscere che la maggior parte degli elementi singoli
sono, nel loro contenuto, aristotelici. Quanto
precoce sia stata la
loro genesi nell'evoluzione spirituale di Aristotele mostrato dal
l'Eudemo. Ernst Hamhruch {Logische Regeln der plat. Schule in
der arist. Topik, in IPiss. Beil. z. Jahresb. d. Askan. Gymn. (Ber
lino 1901), ha dimostrato che una gran quantit di importanti
nozioni logiche della Topica ebbero origine nell'et accademica.
60 It PERIODO ACCADEMICO
riamente in Aristotele, a differenza di Platone, il nesso
tra logica e metafisica. Egli non consider mai la logica,
a cui dedic acute attenzioni e della quale fu il vero
padre, come una parte della filosofia oggettiva, ma sem
pre solo come un' arte o capacit (Svapi;) retta dalle
sue particolari regole formali, all' incirca come la reto
rica. Era gi ilprimo specialista intema di logica, prima
ancora di trarre dalla sua nuova dottrina dell' astrazione
conseguenze che contraddicessero alla dottrina delle idee.
L'influsso degli studi logici si mostra anche in altri
frammenti dell' Eudemo, pertinenti alla dimostrazione
dell' immortalit, e particolarmente nella predilezione
per la cosiddetta dialettica. In antitesi con l'uso lin
guistico di Platone, Aristotele d questo nome al metodo
dimostrativo basato su premesse meramente verosimili,
cio di evidenza soltanto soggettiva. Di dimostrazioni di
tal genere fanno gi largo uso idialoghi platonici. Nel
conflitto dell' argomentazione (il lato artistico della lo
gica non deve essere mai perduto di vista in Platone e
in Aristotele) esse adempiono all' ufficio d' integrare,
quali peltasti accanto agli opliti, le deduzioni rigorosa
mente apodittiche. Non possiedono piena esattezza scien
tifica (-/. pJ3eia) : ma chi potrebbe disprezzare il peso
degli argomenti x) che Aristotele attinge, per la dimostra
zione della sopravvivenza dell' anima, alle intuizioni re
ligiose del popolo, alle costumanze del culto, alle narra
zioni di miti antichissimi? Anche nei trattati Aristotele
muove, nella maggior parte dei casi, dall' opinione co
mune o da giudizi di personalit segnalate, e cerca di
fondere la nozione propriamente filosofica e razionale
col motivo di verit intrinseco a quelli. Dagli innamorati
dell'estremismo radicale, che dal tempo del romanti
cismo sono da noi considerati, almeno nel campo dello
')
Arist., framm. 44 (48, 11-22 R.).
L' t EUDEMO! 61
spirito, come icervelli pi profondi, egli stato perci
accusato di inclinazione verso il senso comune . Inve
rit, dietro a questa
dialettica, che accanto alla propria
ragione riconosce un certo diritto di parola anche al
fatto storico, all' esperienza collettiva, alle idee di grandi
personalit, si cela una singolare teoria dell' esperienza
(nel senso concretamente storico della parola), che deriva
piuttosto dalla consapevolezza dei limiti propri di ogni
riflessione puramente
intellettuale su tali questioni, che
da un pigro affidamento a ci che par giusto a tutti.
Nelle profondit metafisiche dell' Eudemo conduce
il mito di Mida e Sileno. Interrogato dal re circa il pi
alto dei beni (-co itvtwv atprriirccctov), Sileno svela ri
luttante l'infelicit angosciosa del destino umano. Nello
stile si scorge l'influsso del discorso della vergine Lachesi,
figlia di Ananke, nel decimo libro della Repubblica (617
D segg.). Nella figura e nel linguaggio di Sileno spira
l'umore malinconico di un temperamento cupo, con
dannato ad un esilio nella natura terrestre. Con abil
mente velata terminologia platonica vien proclamata la
dottrina fondamentale della filosofa dualistica. asso
lutamente impossibile che ilfiglio dell'uomo acquisti il
sommo bene: egli non riuscir mai a partecipare della
natura dell' ottimo (jj.exaoy_sv rfjs xo eXxfoxou tpuoeuts).
Giacch il sommo bene , per tutti, il non esser nati
(x pi) YevaO-ai). Se poi sia nato, ilmeglio che 1' uomo
possa ottenere d morire il pi presto possibile 3).
Hparticolare fascino delle solenni parole, illoro vero
e proprio valore di oracolo, nella loro studiata ambi
guit. La saggezza popolare era intonata a tale cupa ras
segnazione: il meglio morire. A questo ingenuo pessi
mismo manca ogni intuizione di un altro e perfetto
mondo, di ima pi alta esistenza che si inizi dopo la
morte. Aristotele immette invece nelle parole di Sileno
') Arist., framm. 44 (48. 2349, 11R.).
bl IL PERIODO ACCADEMICO
iconcetti fondamentali della metafisica platonica: l
|ri] nou soltanto non esser nati , ma anche
non entrare nel divenire . Al mondo della genesi
ilFilebo (53 C segg.) contrappone infatti, quale ultimo
fine e insieme quale compiuta antitesi, il puro essere del
mondo ideale. Ogni valore, ogni perfezione, ogni assolu
tezza dal lato dell'essere, ogni disvalore, ogni man
canza, ogni dipendenza dal lato del divenire. La pitarda
etica aristotelica si distingue da quella platonica in
quanto non si pone il problema di un bene assoluto, ma
di ci che tale per la vita delTuomofv-EipojTUVGV yafl'v)
Qui
invece Aristotele ancora del tutto su terreno pla
tonico. Concependo la realt di valore supremo, gli viene
ancora fatto di pensare all' essere trascendente del bene
assoluto, e non a ci che il Greco chiama eudemonia.
Dal bene assoluto esclusa ogni attivit terrena. Ilpro
blema quindi soltanto quello di ritornare il pi rapi
damente possibile, dal regno del divenire e dell'imper
fezione, a quello dell' invisibile essere.
Pi chiaro che mai si rivela poi il platonismo nel
nocciolo sostanziale del dialogo, la teoria dell'immor
talit. Aristotele consider pi tardi la connessione del
l'anima con l'organismo corporeo come ilvero problema
della psicologia, e si arrog ilmerito di aver riconosciuto
per primo la natura psicofisica dei fenomeni psichici. La
scoperta dei nessi psicofisici doveva anzitutto scuotere la
fede platonica nell'immortalit dell'anima individua, e
Aristotele non pot serbare, delle sue opinioni di una
volta, altro che quella dell' indipendenza del puro vo;
dal corpo. Tutte le altre funzioni dell' anima (riflessione,
amore e odio, timore, ira e memoria) presuppongono
come base ilcomplesso psicofisico e periscono con esso 1).
*) Sull' inseparabilit delle funzioni psichiche dal corpo v, de
anima, A 1, 404 a 16 e altrove; sulla distinzione del vos
dalle funzioni psicofisiche A 4, 408 b 18-30.
t' EUDEMO 63
Precoci sono, in Aristotele, idubbi circa l'immortaliti.
dell' anima intera (che l'unica espressione storica
mente ammissibile per ci che imoderni chiamano spesso,
anacronisticamente, immortalit individuale). Tra gli
scritti dottrinali, il libro A della Metafisica, composto
subito dopo la morte di Platone, tende gi a limitare la
sopravvivenza al voj 1). Anche in un estratto di Giam-
blico dal Protreptico di Aristotele detto: nulla di
divino o di beato appartiene all' uomo, salvo quel tanto
che inessi d' intelletto e di ragione, e che solo degno
di serio interessamento.
Questa
sola infatti, di tutte le
nostre cose, sembra essere immortale e divina
3). que
sta limitazione che poi lo conduce a dare tanto maggior
valore al voOj: esso per lui addirittura una divinit
presente in noi, conforme alla dottrina del V0O5
ftupafrev
zierwbv. La dottrina etica dell' eudemonia e quella teo
logica della noesis noeseos sono fondate su questa
intui
zione. Si comprende quindi come gi ineoplatonici
vo
lessero riferire al solo vo?
gli argomenti in favore del
l'immortalit contenuti nell' Eudemo. Temistio connette
questo difficile problema con l'aporia concernente 1* in
terpretazione del concetto dell' anima quale risulta dal
Fedone, in cui Bono parimenti implicite alcune ambi
guit.
Certo, quando Temistio (o la sua fonte) ascrive al
Fedone il celato intento di dimostrare l'immortalit sol
tanto del vos, scambia l'intenzione degli argomenti pla
tonici con le loro conseguenze2). Imiti del premio e del
castigo delle anime nell' aldil presuppongono necessa
riamente la sopravvivenza dell' intera anima . Riferite
al voO; aristotelico, perdono ogni significato. Tuttavia
') Arisi., Metaph., A 3, J070 a 2
") Arisi., framm. 61 R.
') Arisi., framm. 38 R.
64 IL PERIODO ACCADEMICO
non si pu negare che ipi seri argomenti del Fedone
(secondo
l'espressione dello stesso Temistio), come quello
tratto dalla reminiscenza e dall'affinit dell'anima con
Dio, possono dimostrare soltanto l'eternit dello spirito.
Platone stesso non ha distinto nettamente, nei suoi
dialoghi, idue problemi, clti nella loro differenza solo
dalle discussioni accademiche. Mentre da queste deriva
la posteriore e cauta formula di Aristotele, nel Fedone
possono ancora distinguersi chiaramente le originarie
correnti di pensiero, che si unificano nella religione pla
tonica dell'immortalit. Una corrente proviene dalla
speculazione anassagorca circa il puro vo, che si basava
stilla divinizzazione dell'intelletto scientifico e costituiva
il culmine del razionalismo filosofico del quinto secolo.
L'altra di provenienza opposta : discende dall'aspet
tativa orfica dell'aldil e dalla religione catartica, che
predicava la penitenza e la purificazione affinch- l'anima
non dovesse soffrire nell'aldil le pene pi terri
bili. Essa un'esperienza non speculativa, bens etico-
religiosa, dell'indistruttibilit e indipendenza dell'intima
sostanza psichica. InPlatone idue clementi si sono fusi
in
apparente unit. Ma
questa unit non si fonda sul
l'affinit dei motivi, ma sulla mirabile sintesi di chiarezza
razionale e ardente esigenza religiosa propria dell'anima
platonica. Sotto l'indagine analitica dell'intelletto, la
sua creazione si scinde di nuovo negli elementi originari.
Dopo tutto ci, non pu ormai pi sorprendere che
Aristotele, noli'Eudemo, si accosti al punto di vista del
Fedone anche in quanto attribuisce l'immortalit al-
l'anima intera ]). 11 sentimento pu attingere conso
lazione religiosa solo a
questa intuizionerealistica2 l'eter-
') Ci risulta chiaro dalle parole di Temistio :anche ncll'lTu-
cfcmo occorreva l'interpretazione , per riferire gli argomenti per
la sopravvivenza dell'anima al solo vw?.
L' EUDEMO 65
nit dell' impersonale spirito pensante,
senz' amore e
senza ricordo dell' aldiqu, non ha per esso importanza.
Egli ha per lottato con dubbi, di cui rimasta la traccia
nella sua interpretazione dell' anamnesi platonica. Com'
noto, Aristotele rigetta nella sua psicologia, insieme con
la dottrina delle idee e con la sopravvivenza dell'anima
intera, anche la reminiscenza 1). Neil' Eudemo egli si
basa invece ancora su quest'ultima teoria. Ma fin d'al
lora egli si posto,
e ha cercato di risolvere con mezzi
platonici, quello stesso problema psicologico della con
tinuit della coscienza nell' esistenza successiva alla
morte, che pi tardi gli fa apparire insostenibile 1' im
mortalit nel senso del Fedone. La continuit della co
scienza connessa con la memoria. Mentre pi tardi egli
nega la memoria al vou;, nell' Eudemo egli cerca di
conservarla per l' anima ritornata nell' aldil, trasfor
mando la dottrina platonica dell' anamnesi in una teoria
della continuit della coscienza in tutte e tre le fasi del
l' esistenza dell' anima, preesistenza, vita terrena e vita
successiva alla morte. All'intuizione platonica della re
miniscenza dell' anima rispetto all' aldil egli contrap
pone la sua tesi del ricordo dell' anima rispetto all'ai-
(Iiqu. Egli la fonda mediante un' analogia. Come coloro
ebe passano dalla salute alla malattia perdono spesso la
memoria, in modo da disimparare perfino a leggere e a
scrivere, e invece quelli che ritornano dalla malattia alla
salute si ricordano di ci che hanno sofferto durante la
malattia, cos l' anima che discende nel corpo dimen
tica le impressioni ricevute nel periodo della sua preesi
stenza, e invece l'anima ritornata per la morte Dell'al
dil si ricorda delle sue esperienze e sofferenze (fta
para) dell'aldiqu "') La vita senza corpo la condizione
') De anima, T 5, 430 a 23; Metaph.,A' 9, 993 a 1.
') Arist,, framm. 41 R.
5.
W, Jaeger, Aritlotele.
66 IL PERIODO ACCADEMICO
normale (xa:x cpoiv) per 1' anima, il soggiorno nel corpo
una grave malattia. L' oblio di ci che le apparve nel-
1' antevita solo una transitoria interruzione e oblitera
zione della continuit di coscienza e della memoria. E
giacch per il risanamento, cio per la liberazione del
l'anima dal corpo, non c' da temer nulla di simile,
l'immortalit dell' anima intera sembra, con questa
concezione, assicurata. L' argomento dipende dall' esat
tezza del suo presupposto, che il sapere dell'uomo sia
una reminiscenza di ci che egli contempl laggi (x
luti -9'tz[i-ca). Con la sorte di questo dogma platonico
necessariamente connessa quella dell' immortalit perso
nale, professata dall' Eudemo. Platone aveva fondato, col
mito psichico dell' anamnesi, la sua grande scoperta lo
gica dell' a priori. Ilgiovane Aristotele comincia col pro
cedere sulla via di questo mito, senza autorizzarci a con
siderare in lui come pura metafora questa forma rap
presentativa, che incontriamo come dogma fondamentale
nel Menone e nel Fedone. Nel momento in cui egli vide
chiaro il carattere specificamente logico del pensiero
puro, e interpret la reminiscenza come fenomeno psico
fisico, neg all' intelletto la capacit dell' anamnesi e la
sci cadere le idee della preesistenza e dell' immortalit.
Ma
questo momento, in cui il realistico mito platonico
doveva scindersi per lui nei due suoi elementi, poetico
e concettuale, non era ancora arrivato al tempo del
l'Eudemo.
Nel cerchio chiuso della concezione platonica, che Del
l'Eudemo conclude in s la vicenda dell' anima, manca
ancora solo I'ultimo elemento, le idee. Una critica senza
inclinazioni preconcette non pu dubitare dell'incoerenza
in cui si incorrerebbe quando si volesse espungere dal
l' esposizione di Proclo, da lui designata come autentica
dottrina aristotelica, o si volesse spiegare come semplice
aggiunta del relatore, proprio quell'elemento dell'intero
l'EUDEMO 67
sistema concettuale che solo d senso e nesso logico al
tutto.
Questo
elemento appunto quello delle idee. Sotto
gli l%il S-sipata non si celano che le idee del Fedone.
Prescindendo dalla terminologia, che puramente pla
tonica, Aristotele non avrebbe mai potuto esprimersi cos
sulla base della sua posteriore psicologia e dottrina della
conoscenza. E se la presenza della dottrina delle idee
nell' Eudemo non fosse esplicitamente assicurata dalla
citazione di Proclo, l' ammissione della preesistenza e
della reminiscenza dovrebbe gi bastare da s a esigerla.
Si possono affermare o negare le idee, dice Platone nel
Fedone, ma non si pu separare la teoria dell' anamnesi
e della preesistenza da quella delle idee. Unica la sorte,
e la logica necessit, di entrambe le dottrine '). Quando,
pi tardi, Aristotele abbandon la dottrina delle idee,
cess insieme, necessariamente, di aver valore per lui
anche quella dell' anamnesi.
Questa
dunque la posizione che rispetto a Platone
occupava Aristotele intorno all' anno 354/3, dopo almeno
tredici anni di discepolato. 12 suo periodo platonico si
estende quasi fino alla morte del maestro. Nei limiti in
cui 1' opera giovanile ha significato per la natura di un
uomo, si possono dedurre molto bene, dall' Eudemo, al
cuni tratti caratteristici della personalit aristotelica. Ti
pico che egli, nel campo della tecnica logica e meto
dologica, fosse gi maestro in un' et, in cui dal punto
di vista metafsico dipendeva ancora pienamente da Pla
tone.
Questa dipendenza aveva evidentemente la sua ra
dice nelle profondit irrazionali del suo sentimento per
sonale e religioso. Le correzioni al modello platonico, che
') Plat, Phaed., 76 D. Il principale argomento, con cui il Ber-
nays (1. c, p. 25) nega che la dottrina delle idee possa stare a fon
damento dell' intuizione del mondo espressa nell' Eudemo, ancora
l'attestazione di Proclo e di Plutarco, che Aristotele abbia combat
tuto le idee anche nei dialoghi (contro cui cfr. sopra, p. 44 segg.).
68 IL PERIODO ACCADEMICO
intraprendeva, erano prudenti e conservative. Tentava
perfino di tener dietro a Platone nel suo campo pi
proprio, nel regno del mito dell' anima.
Qui
aveva ra
dice la forza pi energica del pensiero platonico, quella
che determinava la sua intuizione del mondo. In Aristo
tele, per grande che fosse la sua interiore tendenza anche
a tale regno dello spirito, essa non si mostrava, gi qui,
cos originale e sviluppata come la genialit in stretto
senso scientifica.
IV.
IL PROTREPTICO
1. Forma ed intento.
Dopo l'Eudemo, 1' opera pi importante del periodo
che precede la morte di Platone per noi, per il suo
stato di conservazione e anche per il suo effettivo signi
ficato, il Protreptico. Certo, bisogna prima dimostrare
che esso appartenga
a questo periodo, perch finora non
si mai data neanche 1' ombra di una simile dimostra
zione. Perfino la questione della forma letteraria dello
scritto, che fino a poco tempo fa stata in prima linea,
non ancora del tutto chiarita. Di rilevarne ilsignificato
filosofico non si mai fatto nemmeno il tentativo.
Tra gli scritti giovanili di Aristotele il Protreptico
occupa una posizione singolare. diretto a un principe
di Cipro, Temisone. Per quanto non sappiamo nulla di
preciso di costui e della sua vita, possiamo farci assai
bene un'idea del tono di vita di questo piccolo despota
illuminato dell' incipiente ellenismo. Attraverso l'enco
mio di Isocrate a Evagora e il suo messaggio a Nicocle
noi conosciamo questi due personaggi, che erano pure
principi di Cipro, padre e figlio. Il discorso a Nicocle
un protreptico, che prescrive al giovane signore imigliori
principi di un retto e intelligente governo. Cosi, nel
70 IL PERIODO ACCADEMICO
quarto aecolo, le Bcuole gareggiano nell' attirare 1' atten
zione delle potenze mondane e nel procacciarsi con ci
influenza politica. Non sappiamo se Aristotele avesse co
nosciuto Temisone per mezzo del suo amico Eudemo di
Cipro. Ma senza dubbio dobbiamo inquadrare la mis
sione, cui egli adempie col suo scritto, nell'attivit poli
tica dell'Accademia, cbe era allora vastissima. Ilproemio
si rivolgeva a Temisone. Se vi si diceva che per la sua
ricchezza e reputazione egli aveva come pochi la voca
zione per la filosofia, non da credere che in bocca ad
Aristotele questa fosse, come parrebbe a primavista, una
frase di adulazione a). Va rammentata che, secondo la
concezione platonica, solo filosofi che giungano al
potere
politico, o re che si diano seriamente alla filosofia, pos
sono presumere di svolgere nello stato V attivit pi alta
e di venire in aiuto dell' umanit sofferente. Anche Pla
tone, cio, considera la ricchezza e la
potenza come in
dispensabili
strumenti dell'idea'). Temisone deve aiu
tare
l'Accademia a metterein atto la sua dottrina dello
stato.
Con tale
scopo strettamente connessa 'la forma dello
scritto (giusta
nemesi, anche questa, del fatto che si sia
quasi sempre tenuta distinta la questione della forma
da quella del contenuto). L'origine del protreptico come
forma letteraria nel nuovo metodo pedagogico
dei so
fisti. Non Un genere che la socratica abbia prodotto dal
suo intimo: laveste dialogica, che si spesso considerala
peculiare degli scritti essoterici di Aristotele, non ad
esso
connaturata di necessit 5).
Quando Cicerone dialo-
*)
Arist., framm. 50 R.
Il concetto in s assolutamente platonico,
come si vede
dalla seconda lettera (310 EJ, il cui autore lo formula nel modo
seguente: Jtfcpuxs
otmvai stj ta-tv qspivijols vs xal Svafiij
v.al T0t' SXArjXct Sicixsi xal Slte xal oUYYiy":-
')
Nei cataloghi delle opere di Aristotele
conservatisi Vanto in
Diogene quanto in Esichio e Tulemco il Protreptico posto tra gli
IL PROTREPTICO
71
gizz nell' Ortensio le idee del Protreptico aristotelico,
ritenne necessario di segnalare anche nel titolo questa
trasformazione dell' opera. Anche la forma dei protre-
ptici superstiti,
che non risalgono certo oltre 1' et del
l'impero, ci permette
di concludere che il protreptico
era un discorso di propaganda, di tipo simile a quello,
che gli si riconnette nella forma e nello spirito, della
predica ellenstica d'invito alla conversione, passato
poi
nella chiesa cristiana. Pu darsi che spesso concetti pro-
treptici siano stati trasferiti in forma dialogica, come
nella cosiddetta Tavola di Cebete.
Quanto
al Protreptico
di Antistene la cosa, certo, non sicura: ma, com' noto,
Platone si comportato intal modo, nell' Eutidemo, con
argomenti socratici.
In questo
dialogo Socrate d ai so
fisti, che prendono parte alla conversazione, saggi di un
colloquio protreptico con uno scolaro, nella forma a lui
peculiare della domanda e della risposta: e ci con
sono al modo in cui egli spesso giuoca ironicamente con
forme d' arte proprie della sofistica. A questo modello
classico di protreptica platonica Aristotele si ricollegato
in forma addirittura esplicita, ma soltanto per ci che
riguarda iconcetti. Quanto
alla forma, egli non segui
questa volta le traccie di Platone, bens ilmodello d' Iso
crate.
Com' evidentemente
attinta da lui la forma della
missiva personale, cos la parenesi appartiene al conte
nuto stabile del sistema pedagogico
d' Isocrate. L' allo
cuzione a ima determinala persona un mezzo
stilistico,
ins assai vecchio, di ogni sorta di esortazioni e orazioni
didascaliche. Neil' et in cui il verso era ancora lo stru-
scritti essoterici raccolti a capo dell'elenco, il che per non implica
nulla circa la sua forma, perch Don detto che dovessero essere
essoterici soltanto gli scritti
dialogici- Intale gruppo esso poteva
esser compreso anche se aveva la forma di un discorso o di un
messaggio.
72 IL PERIODO ACCADEMICO
mento obbligato con cui si influiva spiritualmente sugli
uomini, possiamo seguire lo sviluppo della forma allo
cutiva dagli avvertimenti di Esiodo a Perse fino al poema
didascalico di Empedocle e alle sentenze dedicate a Cimo
da Teognide, che ancora al tempo di Socrate e dei sofisti
servivano nella scuola per l'istruzione morale dei fan
ciulli. A questa poesia sentenziosa, di vecchio stile, la
sofistica sostituisce una nuova forma prosastica, che ga
reggia con successo con quella antica 1). L'immagine
ideale del principe, che Isocrate presenta in Nicoele,
corrisponde sul nuovo piano sofistico all' ideale cavalle
resco di Teognide. Appartengono entrambi a un unico
tipo. IlProtreptico di Aristotele tuttavia piche un'im
magine filosofica di principe. Esso proclama il nuovo
ideale della vita puramente filosofica, quale Platone esige
anche dall' uomo d' azione. Platonico infatti, e non con
sono allo spirito del pi tardo Aristotele, il fatto che
egli diriga a un uomo impegnato nella prassi politica
un discorso d' invito al [Lo; O'swpTjircx;. E il libro non
stato da lui, come si usa dire, dedicato al principe
suo amico (la dedica di dialoghi o di trattazioni unuso
della cortesia letteraria ellenistica, mentre 1' et classica
non conosce affatto questo costume libresco), ma gli
stalo diretto come viva espressione del suo intento di
energica esortazione pedagogica. In questo senso, Ja de
dica un elemento costitutivo dello stesso stile pro
treptico.
Anche altre traccie segnalano l'imitazione della pa-
renesi isocratea. La forma peculiare, che stampa il suo
sigillo su tutto ci che di mano aristotelica, e cio il
predominio dell' organizzazione concettuale apodittico-
') Lo sviluppo della forma prosastica del protreptico dalla poe
sia gnomica delle
'jtccS
Sj-'ott stato esattamente segnalato da P. Veri-
dland, Anaximenes von Lampsahos, Berlino 1905, p. 81 sgg. Cfr,
Isocr.,
ad A'icccl., 3,
IL PROTREPTICO
73
sillogistica, doveva certo trionfare anche nel Protreptico,
e qui, anzi, in modo pi facile e brillante che altrove. Si
deve filosofare? Ecco la domanda che stava a capo di
tutte le esortazioni all' esercizio della filosofia. Aristotele
rispondeva prontamente: o si deve filosofare o non si
deve filosofare. Nel primo caso, si deve senz' altro filoso
fare. Nel secondo caso, bisogna
tuttavia filosofare, per
dimostrare che non si deve filosofare. Dunque bisogna
inogni caso filosofare 1). Analoga forma sillogistica hala
maggior parte dei brani superstiti. Ma al di l di questo
velo dialettico compaiono spesso i concetti dell' antica
parenesi. Inun frammento pi ampio, che giunto sino
alle antologie bizantine ed anche tornato da poco alla
luce, nella sua integrit originaria, inun papiro di Ossi-
rinco, si osserva in maniera particolarmente chiara que
st' alternativa di vecchio pensiero e di nuova e penetrante
formai dimostrativa2). Bisogna persuadersi che la feli
cit dell' uomo non. consiste nel posseder molto, ma nel-
l' essere ben disposto nel proprio spirito. Neppure il
corpo, infatti, b stima felice perch adorno di splendidi
abiti, ma solo perch sano e ben costituito, anche se
mancante di quell' ornamento. Allo stesso modo bisogna
chiamar felice l'anima solo quando moralmente edu
cata, e l'uomo quando si trova nella medesima condi
zione: e non chiamar tale un uomo che sia splendida
mente adorno di beni esterni, quando in s stesso non
valga nulla. Neauche un cavallo, che abbia morso d'oro
e finimenti preziosi e in s sia di scarso valore, oggetto
di stima, mentre Io quando sia di buona costitu
zione . Oppure: Come chi fosse spiritualmente infe
riore ai suoi schiavi sarebbe ima figura spregevole, cosi
occorre stimar miseri quegli uomini icui possessi hanno
') Fraram. 51 R.
) Frainm. 57 R. Cfr. I'ap. Oxyrh., IV, p. 83 sgg.
74 IL PERIODO ACCADEMICO
maggior valore che la loro stessa persona,... Saziet genera
intemperanza, dice il proverbio. E mancanza di educa
zione spirituale, accoppiata con forza e ricchezza, pro
duce follia .
Queste
idee si trovano anche in massime
non platoniche di saggezza pratica, ma nuova la forma
apodittica della loro esposizione. Anche il frequente si
dev' essere persuasi un mezzo stilistico della parenesi
sofistica. Sii convinto l'inizio, ripetuto non meno di
quindici volte, delle massime rivolte a Nicocle da Isocrate
e a Demonico dall' autore del protreptico che da lui s' in
titola. L' analisi filosofica mostrer come Aristotele tra
sformi efficacemente, oltre al tesoro inesauribile dell' an
tica saggezza gnomica greca, anche l'etica e la metafisica
platonica. Egli fonde il contenuto esortativo del Gorgia
e del Fedone con la forma del protreptico isocrateo e col
passo simmetrico della sua prosa.
Questa
sintesi ilfrutto
degli sforzi compiuti dal giovane platonico per intro
durre come materia d'insegnamento nell'Accademia, e
per elevare a disciplina scientifica, la retorica nel senso
tecnico della parola.
IlProtreptico acquista cos ilsignificato di uno scritto
di propaganda per la scuola platonica e per il suo ideale
pratico e pedagogico. Gli ambienti dominati da Isocrate,
ilquale fino allora aveva connesso 1' esercitazione formale
dello spirito merc la stilistica e 1' oratoria con l'inse
gnamento dei principi della morale e della politica pra
tica, si videro di fronte ad una nuova ed aperta concor
renza. HProtreptico dimostrava coi fatti la parit di di
ritto dell'Accademia nel campo retorico. Ma anche dal
punto di vista del contenuto esso doveva apparire agli
isocratei come un attacco aperto all'ideale educativo
della loro scuola. Gli sdegnosi accenni polemici di Iso
crate all' ideale platonico di un' educazione puramente
filosofica della giovent, la sua esaltazione, misurata sulla
psicologia del mediocre filisteo, del criterio banale del-
IL PItOTREPirCO 75
l'utilit nel campo pedagogico, provocavano certo, da
lungo tempo, l'Accademia a rispondere. Nel Protre
ptico, Aristotele confut la tesi triviale che ilvalore della
scienza potesse misurarsi dalla sua utilit per la vita
pratica. Ma pi convincente che 1' acutezza dei suoi sillo
gismi fu, per la sua vittoria contro quella grettezza
men
tale, la dimostrazione della sua spirituale superiorit,
quale si rinnovava in ogni linea del suo scritto. Egli mo
strava come n un buono stile n una sana organizza
zione di vita n tuia feconda scienza politica (gli scopi
stessi a cui Isocrate pretendeva di condurre gli
uomini)
fossero possibili senza un saldo fondamento ultimo di
convinzione umana.
Sembra che la scuola di Isocrate non rimanesse in de
bito della risposta, e per combinazione essa ci stata con
servata dalla tradizione fra idiscorsi di Isocrate. l'ano
nimo discorso A Demonico, compilazione di un cervello
inferiore, tra le righe della quale balena ilbieco astio del
concorrente. L'autore si manifesta scolaro d'Isocrate nel
l'armamentario spirituale di cui b vale nella polemica.
Molto pi tardi lo scritto non pu esser stato composto,
stando al suo contenuto e alla sua disposizione, e quasi
certamente esso si conservato soltanto per ilfatto che era
stato scritto per incarico della scuola. Nell'introduzione1)
1' autore manifesta le sue intenzioni nel modo seguente:
Le persone che scrivono per iloro amici idiscorsi pro-
treptici si accingono a una bella impresa, ma tuttavia
non si occupano della parte piimportante della filosofia.
Chi invece indirizza la giovent non all' esercitazione
puramente intellettuale del suo spirito2), ma alla solida
') [Isocr.], ad Demon,3.
!) Il concetto della iXooocpia , per questo autore, quello iso
crateo, clie si avvicina di pi alla nostra idea di cultura generale .
La 5etvT7)g 4v tot; Xyoij e la in essa, da lui rifiutata,
non , secondo la giusta osservazione gi fatta dal Wendland, quella
76 IL PERIODO ACCADEMICO
formazione del suo carattere morale, arreca vantaggi as
sai pi grandi ai suoi
ascoltatori.
Quelli li educano sol
tanto all' abilit dialettica, questi correggono e formano
la loro indole morale .
Quale
altro protreptico, se non
quello di Aristotele, poteva esser questo che, diretto da
unfilosofo a unsuo amico, e consapevolmente intonato in
senso teoretico e invitante allo studio della dialettica,
aveva acquistato tanta fama da costituire un incipiente
pericolo per 1' ambiente isocrateo? Al Protreptico aristo
telico conviene anzitutto ci che l'isocrateo dice dell'o
rientamento, alieno dalla vita pratica, dell' ideale peda
gogico difeso dall' avversario. Esso era il primo protre
ptico filosofico e, per quel che sappiamo, l'unico che
ponesse la fondamentale questione di principio circa la
reale necessit di educare l'uomo soltanto per la vita ,
e che mettesse ilmondo piccolo-borghese d' Isocrate di
fronte all' audace esigenza del fl-ewpijitxis. Ma non
abbiamo bisogno di limitarci ad argomenti di carattere
generale, perch la dipendenza dello scritto da quello di
Aristotele pu essere stabilita in forma anche pi evi
dente 1).
del retore; egli non combatte contro un xpoxpercxix; np;
y]"coj5ixi5v, ma contro la filosofia logico-dialettica: cfr. Isocr-, Pel., 2,
dove queste cose sono parimenti definite come itepispyia lv
xo; Xyoi;. Il Ilspl vtiSivsu); (258 segg.) mette insieme dialettica,
geometria e astronomia come costituenti il corso di studi caratte
ristico dell'avversario, e le dice, come l'autore del discorso a De
monico, vantaggiosissime por l'esercitazione spirituale (265) ma
prive di utilit per le grandi
azioni e idee.
') P, Wendland (1, c., p. 92 segg.) ha segnalato, nella sua ec
cellente trattazione del discorso a Demonico, anche le sue relazioni
col Proireplico aristotelico, tra le quali anche la concordanza te
stuale sopra trascritta. Che la Demonicea si diriga
essenzialmente
contro il Protreptico, e sia stata anzi scritta proprio nell'intento
di contrapporre al suo un altro ideale, sembra a me la conseguenza
inevitabile (per quanto non tratta dal Wendland) di queste osser
vazioni. Certo, non necessario che Io scritto sia stato un'eco cro
nologicamente immediata dell'opera aristotelica: ma senza dubbio
l'autore l'ha composto quando ancora era vivo Aristotele. L'influenza
del Protreptico fu sempre crescente, durante tutto il secolo che se
ll, PROTREPTICO
77
Ad Dem., 19: pi)
xaxxYgt
paxpiv 65v nopessat 7tpi$
xo; SiSioxtiv ti XP1)01!10'' rcay-
yeXXogivou;- ataxpv yp xo;
p.v ifindpoog xijXixaxa
JteXyij
Siccnepv ivexaxo JtXstco feorijoal
xij
y Sjtpxoocav ootav, xo; 84
Ystoxipou; prj84 T; xax yf(Y
to
paia;xojjysiv ini ify gsXtCut xa-
xaoxijoai xv ax&Y Sivotav.
Cfr. |19 init.: Y;yo5 xiov
cUouopTiov noXX
jwXX<3v gtvac
XpJ)pT(ov xpetxxur x piv yp
Taxing noXeCitsi, x 8 nana.
xv xpivov jiapapiYsi* aoyja yp
jivov xfflv
xxviixxtov
frvaxov.
Ar., fr. 52 (p. 62,7 R.): o
tri
8sT ysuyeiv yiXooeyEav, stnsp
ioxlv pv yiXoGoyta xaMnsp
otipeS-a xxvjolg xs xal x.pt?01?
ooyCa;, -fj 84 coy
[a xby (leylaxuiY
yafl-ffiv O84 8at xxrjpxuiv psv
Ivsxb 7tXtv y' "HpaxXioug axrj-
Xa; xctl itoXXixi; xtvSuvseiv,
Sii
Si ypdviyciv fnjSiv
reovefy
fi?;il
8anav2v.
?J |vqv
v8pano5(584g ys
xo ijv, XX p xo ijv e
yXixsoat, xal xat?
xiy
itoXXtv
axv xoXouS-stY 86ca;, XX
pij xo; noXXo; tov
xat; a-
xoB, xal x pv xptjpaxa ?7jxstv,
xiv 84
xaXjv
pvjSEptav
ittijx-
Xsiav xoietaS-ai x Tiapnav.
La coincidenza fra idue luoghi non pu esser casuale,
perch mentre in Aristotele l'immagine dei navigatori
voraci, sprezzanti di ogni pericolo, conviene assai bene
all' altro termine del paragone, l'uomo che deve sacri
ficarsi per la cura dei pi alti beni, l'isocrateo l'ha sem
plicemente inserita nel suo testo, nel tipico modo in cui
un retore adopera all' occasione ifiori stilistici raccolti
nelle sue letture. Ma non ha combinato con essa nulla
di buono, e la sua antitesi fredda e sforzata: all' imma
gine aristotelica dei mercanti che traversano ilmare egli
contrappone quella dello studente che senza pericolo com
pie il suo viaggio per andare ad Atene all' universit.
La sua sorprendente
ammonizione, che molte lezioni
valgano pi che molto denaro , non del resto priva
di ogni originalit, perch alla scuola d' Isocrate la tassa
di frequenza era cara,
gi alla sua pubblicazione (cfr. framm. 50 R.) : si comprende quindi
benissimo come nascesse 1'csiger.za di prender posizione di fronte
ad esso.
78
IL PERIODO ACCADEMICO
2. Sopravvivenza
e
ricostruzione del Protreptico
.
L' acuto libro del Bernays sui dialoghi di Aristotele
aveva richiamato l'
attenzione dei
filologi sulle opere dei
neoplatonici,
mostrando con alcuni
esempi la loro pre
dilezione per quegli
scritti.
Eottimo fu il
risultato che ottenne nel 1869 l'inglese
Ingram Bywater,
quando
scoperse ampi brani del Pro
treptico
aristotelico nell'
omonimo libro di
Giamblico, in
cui essi giacevano
seppelliti tra
numerosi estratti da dia
loghi platonici 5).
Il destino volle che il Bernays,
in
quel
tempo, avesse gi
concluso le sue ricerche e si fosse,
con la sua
conclusiva negazione di un periodo platonico
di
Aristotele, preclusa
la via all' interpretazione
della
nuova scoperta. E lo stesso
scopritore, il
Bywater,
era
rimasto del tutto sotto l'
influsso della
dimostrazione del
Bernays. La gioia
della
scoperta lo spinse a farla subito
di
dominio pubblico,
senza tentare una pi
accurata de
limitazione dei nuovi
frammenti e un
accertamento di
ci che con essi si fosse acquisito.
IlProtreptico di
Giamblico un libro di letture filo
sofiche per
principianti,
compilato sulle opere dei pensa
tori la cui dottrina
appariva
schiettamente
pitagorica ai
neoplatonici
dell'et
posteriore a
Porfirio. Tra questi
filosofi (oltre
a quegli
stessi neoplatonici
e agli
scritti,
per la maggior parte
falsificati, dei pitagorici
pi
antichi,
citati da essi) stavano
in prima linea
Platone e
l'Aristo
tele delle
opere giovanili,
che da essi
erano considerali
come veri e
propri scrittori
esoterici. La
venerazione dei
loro scritti come cose sacre un esempio
della stessa
enorme forza della
tradizione scolastica e libresca, che si
riscontra anche nel
contemporaneo
cristianesimo e gu-
*)
Journal
of Philology,
II, p. 55 segg.
IL PROTREPTICO 79
daismo e pi iardi nell' islamismo. Neil' opera di Giam
blico dato un variopinto mosaico di brani, per lo pi
famosi, e eemplicemente giustapposti, di dialoghi plato
nici. Meschini trapassi, costituiti di formule stereotipe,
tradiscono dappertutto, al primo sguardo, le suture.
Ipassi dialogici delle opere platoniche sono trascritti in
prosa corrente, e da ci derivano, qua e l, grossolane
inesattezze. Per quanto
Platone e Aristotele non vengano
esplicitamente citati, non si pu affatto parlare di unten
tativo di plagio, perch ogni scolaro conosceva quei passi.
Questo
centone comunque un pietoso documento del
tramonto irrimediabile a cui era andata incontro ogni
cultura letteraria e ogni originalit scientifica. Gli estratti
del Protreptico aristotelico, che Giamblico considera
come primo esempio di quel genere letterario, derivano
dalla sua personale lettura. L' intonazione religiosa e
ascetica del libro attirava ineoplatonici, che vedevano
in esso un documento del preteso platonismo di Aristo
tele, o almeno un mezzo per conciliare il contrasto tra
la dottrina platonica e quella peripatetica. Si pu addi
rittura parlare di una rinascita neoplatonica del Pro
treptico, perch non e' quasi rappresentante di quella
scuola che non mostri di averlo letto1).
Veniamo, ora, a determinare I' estensione degli estratti
di Giamblico: lavoro gi tentato, dopo il Bywater e lo
Hirzel, dallo Hartlich2). La parte principale del libro
di Giamblico (capp. V-XIX)
composta di estratti di dia
loghi platonici. Nel centro (capp. VI-XII) la serie in
terrotta da estratti aristotelici.
Questi
ultimi derivano
tatti da un solo scritto perduto, in cui gi il Bywater ha
) Un altro esempio sar segnalato in seguito, in altra occa
sione.
') Hirzel, inHermes, X, p. 83 segg.; P. Hartlich, De exkortalio.
num a Graecis Romanisque scriptarum historia et indole (in Le.ipz.
Studien, XI, fase. 2, Lipsia 1889), p. 241 segg.
80 re,
PERIODO ACCADEMICO
esattamente riconosciuto il Protreptico.
Ne l' identifica
zione era difficile, perch brani d questi captoli si tro
vavano citati, alla lettera o quasi, in Cicerone, Agostino,
Proclo e Boezio, o col nome di Aristotele o in luoghi
di carattere esplicitamente
protreptico e in scritti pel
quali era
dimostrata la dipendenza
dal Protreptico di
Aristotele. Sotto l'influsso del
disordine regnante inque
sti estratti, lo Hirzel e lo Hartlieh
ritennero che Giam-
blico dovesse essersi valso, oltre che del Protreptico, an
che di altri scritti di Aristotele:
senza, peraltro, che po
tessero propriamente
dimostrarlo. Nel cap. "V adope
rato, oltre a
Platone e ad
Aristotele, un terzo autore, a
cui si ascrivono le parti del capitolo che non si possono
far risalire a
Platone.La conclusione di tale capitolo, che
si considera gi facente parte della serie di estratti ari
stotelici segnalabili
dal cap. seguente in poi (come
ac
cade anche nella
pirecente edizione, del Pistelli)
deriva-
come spero di
dimostrare altrove, da Porfirio, il quale
perci probabilmente
anche l'autore degli altri tre,
non ancora
identificati, paragrafi del cap. V, essendo essi
di
evidente origine
neoplatonica.
L'inizio dell'
antologia
aristotelica costituita da al
cuni argomenti, tra loro giustapposti, in sostegno del va
lore della filosofia, che si
riconnettono, con sensibili riso
nanze verbali, all'
Eutidemo di
Platone. Essi sono attinti
dal dialogo
protreptico di Socrate (
Euthyd 278 E segg.).
Ancora piimportante di questo fatto, finora non osser
vato, quello che anche a capo della serie degli
estratti
platonici
(p. 24, 22 segg.)
Giamblico abbia
posto lo
stesso brano. Non verosimile che egli si sia qui ripetuto
per distrazione, e giacch le sue parole non sono una
semplice
citazione dall'
Eutidemoma riassumono l'
espo
sizione platonica in una lunga serie di sillogismi,
com
prendente
termini aristotelici, evidente come egli non
abbia qui attinto
direttamente a Platone, bens a una
li, PROJREPTICO 81
fonte intermedia. Questa
il Protreptico di Aristotele.
Come Aristotele nell'Eudemo prendeva a modello il Fe
done, cos nel Protreptico si riconnetteva pi volte al
l' opera in cui Platone prendeva posizione contro la
protreptica sofstica, l'Eutidemo.
Questa
conclusione ci fa compiere un nuovo passo in
nanzi. Il Bywater aveva paragonato tra loro iseguenti
luoghi:
Cic., Hort., fr. 26 Bait. 36 MuelL: Jambl., Protr., p. 24, 22 Pist.:
beali certe omnes esse volumus revtag ivftpomoi (ouWpeS-a
sO jipvmv.
Che Cicerone, nel suo dialogo protreptico, abbia sfruttato
ilProtreptico di Aristotele accertato in modo cos si
curo da altre prove che non ci sarebbe stato neppur bi
sogno di un argomento come quello offerto da questa
congruenza verbale fra idue tardi autori valsisi del libro
aristotelico. IlBywater ne ha dedotto che anche in que
sto caso la fonte comune eia Aristotele. D'altronde, il
passo di Giamblico con tutto ilsuo contesto (pp. 24, 22
27, 10) costituisce un estratto dall' Eutidemo di Platone.
La conclusione del Bywater non regge, quindi, per ci
che riguarda la fonte di Giamblico. Viceversa, quando
si pensato che anche Cicerone si sia direttamente valso
dell' Eutidemo, si attribuito a Cicerone un metodo di
lavoro troppo frammentario. molto pi probabile che
egli abbia tratto realmente la sua frase, che formava il
punto di partenza del sillogismo, dal Protreptico di Ari
stotele, e che Aristotele stesso, e non Cicerone, 1' abbia
attinta, insieme con ibrani di cui si sopra parlato,
all' Eutidemo. Ad Aristotele non era quindi sfuggita la
famosa frase iniziale del colloquio protreptico contenuto
inquel dialogo. Giamblico, invece, non ha trascritto que
ste parole nel suo estratto aristotelico, perch le aveva
trascritte alcune pagine prima direttamente dall' Euti-
6.
W. Jaeger, Aristotele.
82 IL PERIODO ACCADEMICO
demo. La conseguenza di questo
metodo di scelta la
totale mancanza di connessione della prima serie degli
argomenti (p. 37, 3-22) da lui attinti al Protreptico.
Ancora pi decisiva per la conoscenza del metodo di
Giamblico la parte clie segue (framm. 52 R.).
Si tratta di una serrata dimostrazione, che si estende
per varie pagine (37, 22i41, 5). A prima vista pare tutta
di un getto. Siccome il brano a p. 40, 15-24 citato anche
da Proclo e con esplicita attribuzione ad Aristotele, se ne
concluse che non solo questo brano ma tutta quanta
1' argomentazione fosse stata tratta dal Protreptico aristo
telico. Senza dubbio vi si doveva trattare della possibilit
della filosofia come scienza, della sua importanza nella
vita e della rapidit dei suoi progressi. Si aggiungeva
poi anche il fatto che tutta questa argomentazione si
trovava anche in un altro libro di Giamblico, adoperata,
in forma invero incongrua, per un1apologia della mate
matica.
Questo
punto preceduto da una critica della
filosofia operata dai suoi oppositori, inemici dichiarati
di ogni pura teoria. Anche questa parte presenta ogni
indizio di provenienza aristotelica. Di conseguenza idue
brani sono connessi insieme dal Rose (framm. 52).
L'interna evidenza della cosa non lascia alcun dub
bio circa l'esattezza di questa attribuzione: discutibile
soltanto se Giamblico abbia trascritto la dimostrazione
nella sua integrit o l'abbia messa insieme da s con ma
teriali aristotelici. Anzitutto da notare che isuoi estratti
platonici sono semplicemente giustapposti l'uno all' al
tro, mentre quelli aristotelici mostrano un nesso inte
riore. Nel libro aristotelico Giamblico aveva dunque di
fronte una serrata argomentazione protreptica, che na
turalmente doveva allettarlo ad appropriarsene. Ma la
speranza di ritrovare intatte in lui intere dimostrazioni
del Protreptico aristotelico si svela purtroppo fallace.
Giamblico attinge invero alla sua fonte 1' impulso di pro-
IL PROTREPTICO
83
varsi da s in un' organica dimostrazione del valore in
dipendente della filosofia, in conformit del suo modello.
Ma icapitoli, esteriormente
armonizzati, in cui egli ha
articolato questo processo di pensiero, sono compilati con
materiale aristotelico informa assai rozza. Dalla sua este
riore concatenazione non possibile dedurre la sua in
tegrit e organicit interna.
Ci dimostrato proprio dall' esempio del frammento
52. Le parole che tengono insieme, al principio alla fine
e al centro, il triplice complesso di questa
difesa della
filosofia, richiamano certo alla memoria la simile maniera
usata da Aristotele nei trattati. Ma in realt derivano,
come mostrano le analogie, da Giamblico. Per ci que
sti, nella ripetizione dell' estratto nel terzo libro, le tra
lascia del tutto all' inizio e le modifica alla fine. La strut
tura generale dell' argomento dunque di Giamblico.
Egli ha soltanto inserito iconcetti aristotelici, come ma
teriali grezzi, nella propria misera compilazione. Del
l' originaria architettura aristotelica non rimasta trac
cia. Ci confermato anche dalle parole che concludono
il frammento, e che si sono conservate tanto in Proclo
quanto in Giamblico. La loro coincidenza cos stretta e
particolare, che si vede com' esse siano dappertutto le
originali parole di Aristotele: diverso solo il punto di
vista da cui vengono citate dai due autori. Proclo dimo
stra con esse che la filosofia un fine in s (8t' aut
a(pSTv) tema, questo, che ilProtreptico trattava am
piamente ;Giamblico se ne serve per provare che la
filosofa non pu essere una scienza troppo difficile: e
questo non poteva certo essere il significato del passo
aristotelico. Ma con ci il sospetto di non arislotelicit
si estende anche a tutta la restante struttura dell' argo
mento di Giamblico. Dobbiamo guardarci dal dividere in
capitoli la materia dell' estratto giamblicheo, con super
ficialit pari a quella che constatiamo nella sua interna
84 IL PERIODO ACCADEMICO
disposizione, e attribuirla senz' altro a scritti diversi di
Aristotele. Per affermare che Giamblico si sia valso di
pi scritti aristotelici manca ogni argomento. N sono
plausibili le deduzioni con cui si neghi la provenienza
di un capitolo dal Protreptico perch in esso si presen
tano argomenti gi trattati in parte inun altro capitolo.
Icapitoli sono costruzioni fittizie, che si sbriciolano
appena si batta sulla fragile calce che tiene insieme gli
elementi dell' edificio. Solo imateriali che risultano da
tale dissoluzione reggono alla prova e non possono esser
fatti in pezzi. Illoro cemento, pi tenace della pietra,
la logica dei sillogismi aristotelici.
Citazioni parallele di Cicerone o di Agostino o di Boe
zio 1) assicurano la qualit di estratti dal Protreptico an
che ai luoghi seguenti: cap. Vili, p. 47,5
48, 21 (framm.
59; 60; 61 Rose), cap. IX, p. 52, 16
54, 5 (framm. 58),
oltre all' inizio del capitolo VIII, p. 45, 6
47, 4 (framm.
55).
Questa parte di provenienza unitaria. caratte
rizzata dall' uso dei sillogismi dialettici (iit ttSv Ivapyfij?
nioi cpaivopvwv) adottati da Aristotele con particolare
preferenza nelle opere letterarie, e dall' uso speciale del
concetto di tfpvtjais, su cui dovremo tornare. Di estratti
ce ne sono, peraltro, ancora molti. Comincio col capi
tolo VII, finora non fatto dipendere dal Protreptico ari
stotelico e invece di particolare importanza.
Le parole iniziali (p. 41, 6-15) sono state aggiunte
da Giamhlico. Egli vuol dimostrare tre cose. Prima, che
il cppovsv (qui, in senso schiettamente platonico, con
cetto universale della pura filosofia) ha per gli uomini
') La speranza dell'Usener (v. Rheinisch. Museum, XXVIII, p.
400) che da Boezio si potessero ricavare pi ampi brani dell'Orten
sio, non ha avuto conferma: anzi non si pu allatto parlare di un
nso che Boezio abbia fatto dell'Ortensio, come pi tardi dovette
rinmettere lo stesso Usener {Anecd.Holdcri, p. 52). Agostino fu in
vece un fervente lettore del dialogo ciceroniano.
IL PnOTREPIJCO 85
valore in s. Seconda, che esso utile per la vita, perch
senza pensare ed argomentare l'uomo non riesce a pro
cacciarsi nessun vantaggio. Terza, che la filosofa neces
saria per la conquista dell' eudemonia, a qualunque in
tuizione della vita si aderisca e comunque s' intenda
1' eudemonia, o come massimo di piaceri (5ov-fj)
o come
perfetta educazione ed attivit etica (ptvtj) o come pura
vita dello spirito {tppVT)ot?). Questi
tre punti corrispon
dono esattamente alla serie dei capitoli di Giamhlico:
ilprimo trattato nei capp. VII-IX, ilsecondo nel cap. X,
il terzo nei capp. XI-XII. Ora, si potr certo esaminare
in qual misura siano stati trascritti dal libro aristotelico
(e che di fatto essi siano, per intero, estratti dal Protre
ptico sar dimostrato in seguito) : ma nessuno comunque
vorr credere che essi formino un unico ed organico
frammento nell' ordine che presentano
in Giamhlico. Da
ci deriva che le parole introduttive, annuncianti questa
disposizione dei sei capitoli, sono di Giamhlico. La cor
nice di questo quadro, la cui tripartizione stata certo
imitata dal modello, da lui riempita con singoli passi
scelti, attinti alla stessa fonte. Ci risulta gi dall' inizio:
subito dopo l'annuncio del contenuto egli comincia, senza
neppur tentare un adeguato trapasso
stilistico al lette
rale estratto aristotelico che segue, con lo schematico Iti
co(vyv (41, 15). L'argomentazione che cos s'inizia, e che
in s sostanzialmente unitaria, arriva fino a p. 43, 25,
ma senza dubbio abbreviata a p. 42, 5. A p. 43, 25
cominciano di nuovo itagli: tuttavia gi la conclusione
della parte precedente (43, 22-25) mostra la stretta con
nessione originaria con la dimostrazione seguente
(43, 27
fino alla fine del cap. VII). Evidentemente, si tratta qui
di una serie slegata di estratti da un autore antico, in
ogni passo del quale facile riconoscere Io stile e il pen
siero di Aristotele. Non si pu certo dire che fosse rigore
metodico il voler escludere, per la mancanza di attesta-
86 IL PERIODO ACCADEMICO
zioiie esterna, queste pagine da un contesto di brani di
arBtotelicit chiaramente dimostrata.
Specificamente aristotelico il concetto fondamentale
e l'elaborazione metodica del primo capitolo (41, 15
43, 25). Per determinare ci che promuove lo sviluppo
e ilvantaggio di un dato essere, l'autore parte dal con
cetto del tXo$. Il fine di un essere pu venir ricer
cato solo in un' intelligente attivit, in una vivente rea
lizzazione della sua natura: dalla massa delle sue azioni
o funzioni (Ipyov) si distingue quella che gli essenziale
e che costituisce il suo tsXo;, come la potenza che pro
pria a lui piuttosto che ad ogni altro individuo o genere
(oSxsta pSTfj). In tale forza innata il compito di ogni
essere. La gerarchia delle funzioni invista del loro valore
data dalla natura, perch le funzioni servili sono in
sieme sempre quelle biologicamente inferiori, mentre le
dominanti sono le superiori. In tale relazione si trovano,
p. cs., le funzioni corporee rispetto a quelle psichiche.
L' ipyov delle facolt psichiche ha, inquesto senso, mag
gior pregio che quello delle facolt corporee. H grado
supremo occupato da quella facolt dell' anima che
non serve soltanto, come le altre, a produrre un Ipyov
diverso dalla sua vpyeta, e che quindi non ha il buo
fine in un oggetto esterno, da essa creato, essendo per
lei unica ed identica cosa l'vspyeta
e l'
Ipyov.
Questa
la cppvijac; (approssimativamente traducibile col ter
mine di ragion pura ) che ha ad oggetto e scopo sol
tanto s stessa, e non crea altro che s etessa. Essa pura
contemplazione (frswpfa); e nel concetto della contem
plazione sono risolti inunit quelli dell' essere, dell'agire
e del creare. La pi alta forma di vita non n la pro
duttivit n 1' attivit intese nel comune significato dei
termini, bens l'intuizione conoscitiva dello spirito, pro
duttivo ed attivo in senso superiore. Si vede subito come
qui non manchino gli elementi di contenuto aristotelico:
il
pnOIREPIICO 87
e cio la comparazione della gioia contemplativa con
quella dell' attivit disinteressata della vista; ilsignificato
dei termini designanti la funzione e il suo risultato
(ivlpysia, ipyov). la distinzione di Ipya che sono im
pliciti nella stessa ivpyeta da Ipya che sono invece
creati da essa; la discriminazione delle tre attivit poie-
tica, pratica e teoretica; la coincidenza del soggetto e
dell' oggetto nell' atto dello spirito 1). Nella dottrina del
l' ordinamento gerarchico, che sta a fondamento della
trattazione e alla quale poco pi oltre si accenna anche
esplicitamente, troviamo il principio basilare della teleo
logia aristotelica, secondo il quale in ogni campo della
realt igradi inferiori vengono superati e risolti nei su
periori. Infine corrente inAristotele la tripartizione dei
tipi di vita e di filosofia secondo ipunti di vista dell'in
teresse edonistico, di quello morale e di quello spirituale.
A questi argomenti riguardanti il contenuto si ag
giunge una decisiva conferma esteriore. Nel capitolo con
cernente la forma originaria dell' etica aristotelica sar
dimostrato che ampie parti, in s coerenti, dell' Elica
Eudemea coincidono esattamente, tanto nel contenuto
quanto nella espressione verbale, cogli estratti conservati
inGiamblico: e questi brani sono inparte quelli che l'au
tore dell'Etica dice esplicitamente di aver tratto dagli ljio-
TSpixol Xyot. Siccome il confronto di questi luoghi con
gli estratti di Giamblico mostra che questi ultimi sono
stati di modello agli altri, dobbiamo senz' altro ricono
scere nello scritto su cui Giamblico ha esercitato la sua
scelta una di quelle opere perdute di Aristotele, la cui
designazione come scritti essoterici stata oggetto di cos
lunghe controversie, mentre ora pu essere sottratta a
')
Il concetto di ipyov, uno degli clementi pi essenziali della
dottrina aristotelica dei valori, manifesta la sua influenza dapper
tutto e appare esplicito nei seguenti luoghi: 42, 5, 13, 39, 20, 22:
43, *>, 9, 18, 21.
88 IL PERIODO ACCADEMICO
ogni ulteriore dubbio. Ora, proprio le dimostrazioni del
VII capitolo di Giamblico si ritrovano nelle parti del
l'Etica Eudemea desunte da uno scritto essoterico. La
loro natura aristotelica quindi senz'altro accertata;
che poi essi appartengano propriamente al Protreptico
pu essere considerato come egualmente certo, perch
anche gli altri passi che nell' Etica si dimostrano desunti
da un' opera aristotelica sono tratti da esso, e perch il
loro contenuto concettuale di natura pienamente pro-
treptica.
Pi tardi, nelle sue lezioni, Aristotele ha non di rado
posto il problema delle diverse forme di vita, e messo i
suoi ascoltatori dinanzi alla scelta. In questi casi la vita
tendente alla soddisfazione e al guadagno sempre messa
accanto a quella dell' uomo d' azione e a quella dell' in
dagatore e del filosofo. Tanto questa impostazione del
problema quanto la risposta che la vita dedicata al puro
sapere meriti preferenza, anche dal punto di vista inorale,
rispetto a ogni altra specie di esistenza umana, derivano
dal Protreptico.
Con ci non tuttavia ancora esaurito il significato
dell' estratto contenuto nel VII capitolo di Giamblico.
Ogni lettore della
Metafisica
aristotelica ha certo spe
rimentato, ogni volta che tornato a quel libro, l'effetto
suggestivo delle prime pagine, in cui con vittoriosa ener
gia si sviluppa il concetto clie 1' occupazione teoretica
e scientifica non contraddice alla natura dell' uomo, ma
che anzi la gioia del vedere, del concepire e del cono
scere profondamente radicata nel suo spirito, e si ma
nifesta Bolo in diversi modi a seconda dei differenti gradi
della sua consapevolezza e cultura. Cos essa viene ad
adempiere addirittura alla pi alta esigenza dell' uomo,
e da semplice mezzo di soddisfazione degli accresciuti
bisogni della vita civile diviene massimo valore in s e
culmine della cultura; e la scienza la forma pi alta
IL PROTREPTICO
89
e pi
desiderabile
di questa
attivit
contemplativa,
in
quanto
realizza
nella forma
pi netta la visione disinte
ressata
della
pura scienza
e produce
il sapere pi
perfetto.
Chiunque
abbia sentito
come valore
supremo
la
scienza
esercitata
seuz'
altro scopo che s stessa, avver
tir l'energia protreptca
di questi
concetti.
Inmodo pi
puro,
serio ed elevato la scienza
non stata mai conce
pita
e
vissuta, ed essa resta anche
oggi lettera morta per
chi non sa intenderne
in tal modo l'esercizio.
A inten
derla
in tale profondo
senso aveva insegnato
Aristotele
nel
Protreptico.
Che il famoso inizio della Metafisica
sia
nella
sostanza solo
una replica abbreviata
della classica
esposizione
del
Protreptico, dimostrato
dal
confronto
col VII cap. di Giamblico
(p. 43, 20), che se ne distingue
solo in quanto
tratta
gli stessi concetti
con pi ampio
respiro
e con pi particolare
approfondimento
logico.
Risulta
anzi, da tale
confronto,
che
capitoli introdut
tivi della Metafisica
sono stati composti
per l'immediato
scopo didattico
con materiale raccolto
dall' opera gi
esi
stente, e non sono stati mai neppur
concatenati
in un
saldo
organismo.
Metaph.,
Al, 980 a 21:
Anteo, vO-ptoicot to5 el5i-
vai pyo-Jxai
cpset". o'jieCov
S' fj tiv
alothssioy
yr.j?crif .
al rp X<Dpl T?!SXPt-aS
&Ya-
uffivxai 8 1
*
Sauva;, xal
[Xtota
i(jjv 'kXvii 8i
z(Si
cftfitfliv.
"<>
p&vev Iva np&z.
TWjisv, XX
kccI gv] 8 v n
SX-
Xo vi e? it p 4tt eiv T 6p2v
alpo&psfra
&vtI nvitov
siicstv tiv
&\7,av. alz'.sv
8'
gii
fiXioTa
tvist yvto-
pletv jjiiS?
aOTi)
t)v al-
oOijascov
xal noXX?
8v]-
Protr., 43, 20:
T Cfpovstv &ptt -Atti T Oe-uv
pstv.... ndvtiDV
SotIv
alpe-
tdjTatov Totj vOpebnoi?,
)5itsp otp.cn
v.al t toT{ gppaoiv
ipv,
8 xal sXoni
Tip fiv &xeiv,
slv.at
pij ti pSXXol f'"
yvsoOai
Si' aT itap* 0-
zijV Tv
Stspov.
Iti si t 8pv &-j-a-iT&!j.sv
8c"Sut,
IxavSp fiapTupst
TOTO STI TtvTBp t cfpovstv
al t YlYviuoxeiv
laxTiu; 4y a-
it&aiv
.... 4XX4 prjv t ys
icp aiaO-vEoS-ai
8iaplveTai toO
90
IL PERIODO ACCADEMICO
Iti)
55v
xal
-taTtc
jtapooai? xa!
Suvjisi x ijv 8i)p'.axai ... xij5
8 ataS-ijosioj fj it)s 5'
sui?
Stampai SBvafUg
x#
oa-
tpsoxxij slvai xal St
TOSTO Xal [liXlOTB ctlpo-
ptK aJtijv. .. oxoBv st ti
\iiv
ioxtv a'.psxv Sta vrjv
afafajoiv, 8* aX c9-r] si j y v 0-
aie ti; xal 8i t yvu>-
piljeiv
aur?) Svaaa-cu. ri|v $o-
Xv alpojiea, rcXai 8
eliro|i8V 5xi [tx e p] Suotv
del jiSXXov atpexv
$ ftSX-
Xov Onipxsi. xa&xv, xfflv
[lv atoftrjsstuv
xi/v
5<{jiv vyx7]
jiXtoxa
atpexrjv slvat xal xt-
p'.tti, taxfjj 54 xa\ ibv SXXur*
4to3(5v
atpcxojtpa xal xo 5)v
laxlv
fi
tppvsis, xuptioxpa
(oBoa) xc
&Xii5-sac. Soxs
Ttdvxc 4v8-pouwt. x4 <ppovetv jii-
Xtoxa Bttbxouoi* xd y&p ?i}v
f
aitflvxsg xi tppovetv xal x
yvtaplttv
iyaxffioi.
Xot 8 1atpo pj . cpasi [lv eBv
ala5-r((;iv
ixovxa
yiyvsxat l
t$a....
Ci che nella prima frase della
Metafisica
concen
trato nella semplice parola ynrjci;, l'amore per un'at
tivit sentita come fine a s
stessa, molto pi chiara
mente espresso nelle parole corrispondenti dell'estratto
del Protreptico, secondo quanto era necessario per l'espo
sizione essoterica. Non c' parola che non tradisca subito
il suo carattere aristotelico. Soltanto, Giamblico ha qui
fuso insieme, in forma assai rozza, vari brani del Pro
treptico, die erano stati messi insieme per la
somiglianza
del loro contenuto : da ci l'effetto tautologico del com
plesso. Non si tratta invece affatto di una mera parafrasi
del testo della
Metafsica.
L' ambito di questi brani
essenzialmente pi vasto di quello
dell'introduzione della
IL PROTREPTICO 91
Metafsica.
Anzitutto, l'energica tendenza a una forma
nudamente
logica d' argomentazione corrisponde all'im
magine che in base all'Eiulemo ci siamo formata del
l'attitudine mentale del primo Aristotele. Cos della de
duzione dal principio topico,
che di due oggetti ha mag
gior
valore quello che possiede inmaggior grado la qua
lit pregiata r) ; e dell' inferenza, condotta per via defi
nitoria, del valore della cppvyjocj
dal concetto della vita.
Etanto nel Protreptico quanto
nella
Metafsica
la dimo
strazione dialettica, in conformit, parimenti, con le
osservazioni fatte a proposito dell' Eudemo.
Ora, lo stesso carattere manifestano dappertutto i
due primi capitoli, e giacch essi espongono gli stessi
concetti fondamentali del Protreptico, concernenti l'au
tarchia della pura scienza teoretica, spontanea nasce
l'idea che siano stati desunti da quell'opera, o per in
tero o nella massima parte.
L' esame dei particolari d-
mostra agevolmente V esattezza di questa
idea. In en
trambe le opere si espone il concetto della pura scienza
contrapponendolo a quello dell' attivit pratica dipen
dente da mera esperienza o abitudine. Non il pratico
e
l'empirico, ma il conoscitore e il teorico ha dignit su
periore, perch l'empiria non giunge mai a comprendere
le cause e ifondamenti dei fenomeni, come fa invece il
teorico merc il suo dominio dell' universale.
Quanto
pi
emprica, quanto pibisognosa dell' aiuto dell' intuizione
(jtpoffsms), tanto meno esatta la conoscenza. Vera
mente esatta solo la conoscenza di ci che massima
mente conoscibile, e tali sono i principi pi generali
(-r xp&zx), che costituiscono l'oggetto della pi alta
") Per confutare il principio elle l'anima fosse un'armonia del
corpo si faceva uso, nell'Eudemo, della nozione logica che l'iden
tit
degli attributi determina l'identit degli oggetti. Simile procedi-
mento seguito qui da Aristotele, quando riferisce la pluralit
di valoci
dell'oggetto all'esistenza fundpxslv) di proprietdi diversi
gridi di valore.
92 IL PERIODO ACCADEMICO
scienza teoretica. Pu darsi, certo, che il
puro empirico
abbia nella vita pi successo del
teorico, mancante d
esperienza pratica, ma esso non giunge mai a un' azione
che derivi effettivamente dall'
intendimento della neces
sit della cosa, e si conformi a saldi
principi. Egli resta
un jv&uao;, un pedestre
meccanico. La
continua, per
quanto celata, polemica contro lo spirito banausico e
contro ilsuo dispregio della teoria, che permea iprimi
capitoli della
Metafisica, ha il suo
modello nel Prolre-
ptico, incui Aristotele aveva
minutamente
controbattuto
gli attacchi degli empirici. Un brano in cui sono pi
ampiamente riferiti gli argomenti degli oppositori si
fortunatamente conservato (framm. 52 :p. 59, 17 segg. R.).
Che la filosofia non abbia utilit per la vita pratica,
facile capirlo da quel che segue. L'
esempio migliore
ci dato dalle scienze teoretiche o pure
(7Tt(JT?j[ii)
e dalle
discipline dipendenti
({i7T0Xeqievat o?ai). Ve
diamo infatti che igeometri non sono
capaci di appli
care praticamente nulla di ci che
dimostrano in teoria.
Misurare una superficie e compiere tutte le altre opera
zioni concernenti le grandezze e gli spazi son cose che
sanno
benissimo fare igeodeti per la loro pratica, men
tre imatematici e i
conoscitori delle ragioni ideali di
questi procedimenti
sanno tutt' al pi come si deve
fare, ma non sanno, essi stessi, fare . Nel Protreptico
si insiste anche molto sull'
esigenza, per ilsapere scien
tifico, dell'
esattezza (v.plt'.a)
'
esigenza che vien con
nessa con la definizione della scienza come conoscenza
dei supremi principi e
fondamenti. Conoscenza esatta
pu esserci infatti soltanto dell'
universale, dei
principi.
La coincidenza si estende talora fino alle singole parole.
Anche nella deduzione dei gradi superiori e supremi
della conoscenza da quelli
inferiori ed ingenui i due
scritti presentano un completo parallelismo,
per quanto
non ci si possa
naturalmente aspettare da Aristotele che
IL PROTREPTICO
93
egli si ripeta meccanicamente
per pagine
intere. La coin
cidenza verbale resta, com' facile intendere, un caso
d'eccezione.
L'argomento pi decisivo che questi con
cetti appartengono,
nellalorooriginaria
tendenza, al Pro
treptico per cui sono stati pensati,
mentre nella Meta
fisica
essi sono soltanto stati ripresi per le esigenze
del
proemio, e ristretti secondo la necessit dei nuovi limiti.
Subito dopo il grande estratto assegnato dal Rose i
Protreptico segue, nel terzo libro di Giamblico, una de
scrizione, proveniente
dalla stessa fonte, del progressivo
sviluppo della filosofia dalle altre Riconnetten-
dosi alla dottrina platonica delle catastrofi cosmiche il
Protreptico
(framm. 53 R.) narrava come dopo il gran
diluvio e dopo le devastazioni da esso arrecate gli uo
mini fossero etati costretti a escogitare anzitutto iritro
vati pi necessari per assicurarsi il vitto e 1' esistenza
(-c raspi tTjv Tporjv
j)v irpStov vccfKcvxo
cptXoao'-pelv)
;come poi, migliorate
le loro condizioni, in
ventassero le arti dedicate al loro diletto, quali la mu
sica e via dicendo; e solo in terza linea, dopo avere del
tutto soddisfatto ilbisogno delle cose necessarie alla vita
(t vayxat
a) si volgessero alla libera scienza, alla pura
filosofia. Aristotele pensa specialmente
alle discipline ma
tematiche, quando parla dei rapidi progressi delle pure
scienze negli ultimi tempi, e cio nella generazione
di
Platone. Nella Metafisica
(A 1, 981 b 13
982 a 2) lo
stesso concetto riesce singolarmente
inaspettato, mentre
nel Protreptico esso serviva a dimostrare che gli studi
filosofici, quando si siano prodotte le coudizioni che in
citano ad essi, esercitano sugli uomini un'attrattiva
irre
sistbile. Che a questo punto
Aristotele pensasse princi
palmente alla matematica
cosa che si pu ancora rile
vare nella stessa
Metafisica.
Egli designa qui come inizio
della terza fase di sviluppolericerche matematiche della
casta sacerdotale egiziana. Anche la distinzione delle
94 IL PERIODO ACCADEMICO
Tvat vayxatac dalle Xeufrspat deriva dal Protreplico.
Dal quale proviene, dunque, tutto il contenuto dei due
primi capitoli: e Io etesso si deve supporre del brano
982 b 28
983 a 11, di singolare carattere platonico-teo-
logioo, anclie se la povert dei documenti non ci permetta
in questo caso una sicura conclusione1).
Del IX capitolo di Giamblico considerata come de
rivante certo dal Protreptco la parte finale (p. 52, 16
54, 5
framm. 58 R.). Per ci che riguarda ilcontenuto,
essa fa parte della risposta all'obiezione che la filosofia
non abbia utilit pratica. La provenienza aristotelica
della divisione dei beni in validi per l'uso che se ne fa
e validi per se stessi (vayxata e Si' at faittopeva o
Xsufrepa) assicurata da Cicerone: e cosi la bella im
magine delle isole dei beati, icui abitanti vivono senza
bisogni terreni, dediti soltanto alla pura contemplazio
ne2). Nell'estratto di Giamblico il passo per molto
abbreviato. Aristotele non vi tratteggiava soltanto una
bella immagine, ma mirava con esBa al fine metodico di
') In due luoghi famosi, in cui esalta la divinit e beatitudine
della pura Ectopia del filosofo, Aristotele esorta gli uomini a non
temere di aver pensieri immortali e divini (in antitesi all'antica
esortazione ellenica): v. Metaph., A 2, 982 b 28; Etti. Nic., K 7,
1177 b 31. Tanto l'inizio della
Metafisica quanto la parte citata del
libro conclusivo dell'Etica traggono notoriamente dal Protreplico
(cfr. p. 95 n.
1) una serie di concetti e di formulazioni caratteri
stiche, e protreptica in misura estrema anche l'inversione aristo
telica dell'antica parcnesi.
Ora, l'autore del protreplico a Demo
nico, che, come si mostrato, si vale in pi luoghi polemicamente
di quello aristotelico, scrive al % 32; Sbavata pv tppvsi
tip
[isyaW-liuxoS stva'., {tvrjTi Ss iqj oufip.Tpto{ viv furapxvTcov ~o-
Xk6siv.Cos egli d, certo, un senso non speculativo, e semplicemente
morale, all' tt-vata eppovetv, ma in quanto riconosce comunque
una ragion d'essere all'&dotvKTa
9
povetv mostra di subire l'influsso
aristotelico nella correzione dell'antica parenesi, che di cos alti
9Pvij|iaTa non voleva assolutamente sapere. E allora pu conside
rarsi come certa la congettura che l'esortazione famosa all'48-ova-
q>' 6oov IvSxsta; [E
ih. Nic., 1177b 33) si trovasse origina
riamente nel Protreptco e di i sia stata trasferita nell'Etica e nel
proemio della Metafisica.
*) Framm. 58 R.
il
protreptco
>
95
mostrar l'uomo in certo modo isolato dalla necessit
(xpeias) della vita.
Questo
metodo intuitivo ha il suo mo
dello nella favola dell'anello di Gige, narrata nella Re
pubblica platonica allo scopo di farvi osservare il com
portamento di una persona che, libera da ogni esterno
riguardo per ilgiudizio degli uomini, pu agire come gli
piace. Per lo pi si considera l'estratto di Giamblico
come pi fedele di quello di Cicerone: ma a torto. Ci
cerone dice: se ci immaginiamo trasferiti nelle isole dei
beati, che bisogno abbiamo pi di eloquenza,
visto che
l non vi alcun processo, che bisogno di virt, come
di quelle della giustizia, dell'eroismo, del dominio di
s e perfino della capacit di scelta morale (pruAentia)1
Solo la conoscenza e la pura contemplazione resta an
cora, laggi, degna di essere desiderata. Noi l'amiamo,
dunque, non perch ci rechi vantaggio o perch ne ab
biamo necessit, ma in virt della sua stessa natura.
Giamblico tralascia tutto ci, e rende di conseguenza
oscuro il fine metodico della comparazione. Cicerone
ha conservato abbastanza fedelmente, nel complesso,
l'espressione originale: solo, ha aggiunto alle quattro
virt cardinali di Platone, nominate da Aristotele nel
Protreptco, 'eloquenlia, evidentemente in relazione al
contenuto del suo dialogo, in cui Ortensio contrapponeva
appunto Veloquentia, come sommo bene, alla filosofa.
Ci dimostrato dal X libro dell'Urico Nicomachea.
Anche qui, dove egli egualmente parla di quel puro con
templare, che era argomento del Protreptco, Aristotele
non sfugge a una reminiscenza della sua opera giova
nile1). Egli confronta il contemplante con l'uomo che,
immerso nella vita attiva, ha bisogno di molti mezzi per
recare in atto la sua volont morale (-fj -/optifia
7) Per esser liberali necessario denaro, e cosi
') Elh. Nic., K 4, 1178 a 24-35.
96 IL PERIODO ACCADEMICO
per esser giusti, se veramente si vuol compensare secondo
ilprincipio della parit; per esser valorosi necessaria la
forza, per controllareilpropriodominio dis occorre l'oc
casione che induca a smarrirlo. Altrimenti, come pu
mai la buona intenzione tradursi in atto, senza di che,
d'altronde, essa non raggiunge la sua perfezione? Solo
chi conosce non ha bisogno di questi mezzi esteriori per
esercitare attivamente la sua ptvf] ; anzi essi non po
trebbero costituire che impedimenti sul suo cammino.
Anche qui Aristotele rappresenta la fl-ewpfa come isolata
0 indipendente dalle necessit della vita. Certo, il con
cetto orientato alquanto diversamente, la tetrade pla
tonica delle virt consapevolmente messa da parte, e
il nuovo esempio della liberalit compensa, con la sua
energica efficacia, la perdita in calore entusiastico, che
l'intero brano subisce per l'eliminazione dell'immagine
delle isole dei beati. Ma nonostante questa rielabora
zione si riconoscono itratti originari, essendo stato con
servato il fine dimostrativo del concetto. Elemento
essenziale qui, come in Cicerone, il venir meno delle
Tj'9%v.ai p&xat nello stato di pura beatitudine dell'intui
zione intellettuale. con ci dimostrato che l'esposizione
ciceroniana , delle due, la pi completa.
Ma dal Protreplico deriva anche la prima parte del
capitolo IX. Ci provato con pari evidenza tanto dal
contenuto quanto dallo stile. Aristotele muove dalla tri
partizione delle cause del divenire in natura, arte e
caso, la quale s'incontra anche altrove inlui, per quanto
non esposta con la stessa energia che in questo luogo1).
') La stessa tripartizione delle cause del divenire si incontrer
nel dialogo Scoi tfiieoayistj, in cui essa s torto ha fatto nascer
dubbi. In realt, essa un elemento peculiare della fisica meccani-
stica prepl3tonica. Ma gi Platone ne fa uso nelle Leggi (X, 888 E),
e proprio nello stesso modo che il Protreptico aristotelico, per mo
strare che la ocig non inferiore, incontenuto spirituale e capacit
artistica, alla txvr] e per svilupparne di conseguenza il suo nuovo
il
pi\OTHEt"irco 97
Aristotelica l'idea che non soltanto l'arte ma anche (ed
anzi in maggior grado) la natura sia teleologicamente
orientata verso il raggiungimento di uno scopo, e che la
finalit dominante nell'opera
manuale, nella tecnica e
nell'arte nonsia altro che un'imitazione della finalit na
turale.
Questa
veduta circa la relazione dell'arte con la
natura da lui espressa pi volte, brevemente, anche
nel secondo libro della Fisica, che fa patte
della pi
antica sua produzione
letteraria; e anche altrove, all'oc
casione, se ne risente l'eco. Ma in nessun luogo essa
dedotta con cos vigorosa coerenza come qui, e d' in
confondibile originalit una frase come la seguente
(p. 49, 28): p'-jisl-cat yp o x-qv xe'xvy]v V) epuatg J)
W. aiTj x9)v ipuatv, xa cxtv rti xu> ftoTjftelv xal x na-
paXeuxpsva X?/$ cpuuet?
vattXxjpouv. Anche la dimostra
zione indubbiamente di spirito aristotelico. Gli esempi
son tratti dall'agricoltura e dalle cure di cui hanno bi
sogno gli organismi superiori prima e dopo la nascita. Il
principio dell'universale finalit della natura organica
documentato con esempi tratti dalla meccanica del
corpo umano e dei suoi organi di difesa2). Tutto di
concetto dellacpoig. La forma realistica in cui questa idea trattata
nel Protreplico mostra quanto strettamente Aristotele si riconnetta
alla pi tarda fase del pensiero platonico anche nella sua filosofia
della natura.
') Ci era stato' gi affermato dalla dottrina, permeala di spi
rito razionalistico, di alcuni sofisti presocratici circa la finalit tec
nica della natura, e specialmente dell'organismo umano. Tracce di
un simile sistema scientifico si sono conservate in Senofonte, Me
ntor., I,4, 6 segg., a cui corrisponde Arist-, part, anirti., B 15, Da un
orientamento spirituale affatto diverso invece nata la teleolo
gia della filosofia aristotelica della natura,
giusta l'affermazione
che in questo stesso punto fa il suo autore. Secondo
Aristotele, non
la natura a manifestare disposizioni che si avvicinino alla mec
canica in abilit di artificio: ma, anzi, ogni arte non che un ten
tativo dello spirito umano di gareggiare con la creatrice ed organica
natura, per quanto in un mezzo diverso, cio in quello della costru
zione tecnica, in cui non si pu mai parlare di un tsXo; nel pi
alto ed organico significato.
') J. Bcrnays (Gesamm. Abhandl., I, p. 23) consider eracliteo
7. XV. Jaeger, Aristotele.
95 IL PERIODO ACCADEMICO
viene in vista di un fine. E tale c ci che ogni volta
si produce come risultato finale del processo genetico,
continuamente dominato dalla legge naturale, e che co
stituisce il perfetto compimento di questo medesimo pro
cesso. Cos lo psichico posteriore al fisico nel processo
del divenire, e nel campo dello psichico posteriore, a
sua volta, l'intellettuale, nella sua forma pura. Pitagora
ha quindi giustamente designato la pura Ustopia. come
scopo ultimo dell'uomo, cio come perfezione della na
tura umana. Alla domanda circa lo scopo per cui noi
fossimo nati egli ha infatti risposto: per contemplare
l'edificio celeste. Ed anche Anassagora ha manifestato
la stessa opinione.
L'apoftegma di Anassagora si ritrova nell' Etica Eu~
demea, e con cos precisa coincidenza verbale, che Giam-
blico o lo ha tratto di l o ci ha conservato il testo a
cui attinge YEtica Eudemea. Delle due ipotesi la seconda
la vera, come sar mostrato pi tardi dall'analisi di
tutto il procedimento di pensiero contenuto nell'Etica.
Anche in questo caso nell' Etica Eudemea ripetuto il
il principio che l'arte fosse imitazione della natura, perch l'autore
del Ilest
xofioo
(5, 396b 7 segg.) spiega il divenire della ',-oic
come unificazione armonica di opposti, e ne d la prova con
l'esempio delle arti, considerate come semplici imitazioni della na
tura. Ma il molto eracliteo aD|tpip|iBVov taeppsvov, auvejiov
SiSov citato in tale contesto dall'autore del IIspl nspoli non
contiene alcun accenno a una simile concezione, la quale, per ci
che concerne l'inferenza dalla tyrr) alla tpio'.c come modello del
l'imitazione, peripatetica e non ha niente a che fare col filosofo
di Efeso. Una dottrina analoga, per quanto diversa nel contenuto,
si trova in Democrito (framm. 154), che chiama gli uomini scolari
degli animali: del ragno nel tessere e nel rammendare, della ron
dine nel costruire, degli uccelli canori nel cantare (cfr.per l'ultimo
esempio
Lucrezio, V, 1379, che ai vv. 1102 e 1361 deduce anche
l'arte culinaria e quella della semina e dell'innesto dall'imitazione
della natura: il che gli certamente provenuto da Democrito attra
verso Epicurei. In Aristotele si tratta di qualcosa di affatto nuovo.
TI principio che l'arte sia imitazione della natura da lui riferito
iti carattere finalistico di ogni produzione umana e fondato 6ulla
concezione teleologica della natura.
IL <MOT*EPTICO 99
Protreptico, ed con ci dimostrato che ad esso stato
attinto noti solo l'apoftegma anassagoreo ma tutta la di
mostrazione a cui esso appartiene.
Ci ancora confermato indirettamente da un altro
fatto. La teoria dell'arte come imitazione della natura
si trova ulteriormente elaborata nella dottrina di Posi-
donio circa l'origine della civilt, di cui abbiamo som
maria notizia attraverso la 90 lettera di Seneca. Posido-
nio ha con essa molto contribuito alla diffusione, nella
pitarda antichit, della dottrina aristotelica concernente
il graduale progresso delle arti, procedenti dalle esigenze
della vita a quelle del piacere e culminanti infine nella
purafrewpia. Si congetturato, con buonfondamento, che
questa concezione di Posidonio si trovasse esposta
nel
suo Protreptico1). Se questa ipotesi giusta, egli si
allora ricollegato anche in questo punto alla dottrina
del Protreptico aristotelico. La particolare sfumatura,
che egli aggiunge alla dottrina aristotelica, non ha qui
importanza: maggior peso ha il fatto che il riferimento
della teoria del progresso come risultato della filosofia al
Protreptico di Posidonio trovi nel modello aristotelico
un appoggio importante.
Pi rapida pu essere la dimostrazione del fatto che
anche il resto degli estratti giamblichei di Aristotele
(capp. X-XII) attinto al Protreptico. Il cap. X muove
dal principio, gi dimostrato proveniente dal Protrep
tico, che la tvt] sia imitazione della cpat?. Anche la
scienza dell'uomo politico esige, cos, un fondamento
filosofico, perch eBsa ha bisogno, ancor pi che p. es.
quella del medico, di muovere dallacpuati; nel vero Senso
della parola, e cio dal vero essere. Solo questa cono
scenza pu procurargli la comprensione delle supreme
') Cfr. Gerhausser, Der
Protreptikos des Poseidoitios, Diss.
Heidelberg (-Monaco 1912), p- 18 segg.
100 IL PERIODO ACCADEMICO
norme (Spot), sulle quali egli deve regolare la sua azione. I
La politica pu diventare una ~y_vrj esatta solo tradu-
cendosi per intero in filosofia.
Questo
passo concernente I
l'ideale di esattezza della pura scienza , come si mo- I
strato sopra (p. 91 sgg.), riprodotto insieme con altre parti I
del Protreptico nella introduzione del primo libro della I
Metafisica.
IItono platonizzante della concezione, quale I
appare in Giamblico, volutamente attenualo nella Me
-
I
tafisica, ma conviene appunto al Protreptico, come mo
strer nel particolare l'interpretazione filosofica dei
frammenti (p. 118). Ohe tale accento platonico non
possa valere come argomento per attribuire questa parte
al compilatore neoplatonico riconosciuto anche dallo
Hirzel e dal Diels. Iconcetti sono troppo originali per
ch ci sia possibile. Particolarmente adatto per un'o
pera diretta a un pratico della politica l'accenno che
quest'ultima possa essere riscattata dalla sua presente
infecondit e inconsistenza solo se esercitata su fonda
mento scientifico e concepita come disciplina normativa. (
Quest'
argomentazione culmina nella prova del suo ca
rattere essenzialmente teoretico. Non la mera analogia
derivante dall'esperienza, ma la conoscenza teoretica
delle norme supreme il fondamento di una politica fe-
j
couda. Motivo dominante anche qui la polemica con
tro ipuri empirici, la cui conoscenza non va al di l
'
delle cosiddette costituzioni ideali (eftvopfai) di Sparla e
'
di Creta (e con ci sembra si alluda a Isocrate e alla
dottrina sofistica dello stato). Essa ci fa vedere, cos, che
la discussione critica circa le tre costituzioni ideali (Spar
ta, Creta, Cartagine), che ora occupa il secondo libro
della Politica aristotelica, risale nella sostanza gi al pe
riodo accademico. L'interessantissimo frammento di pri
mitiva politica aristotelica, di cui cos entriamo in pos
sesso e che nonostante isuoi presupposti platonici non
avrebbe tuttavia potuto esser scritto, per la prevalenza
IL PROTREPTICO 101
del suo interesse metodologico, da nessun altro platonico,
mostra che ilProtreptico aveva immediata relazione con
gli scopi politici dell'Accademia. Superficiale era quindi
il voler dedurre, dal contenuto politico del cap. X,
che esso dovesse derivare da uno scritto puramente poli
tico di Aristotele. Decisivo non il contenuto, bens il
punto di vista da cui esso vien considerato. E proprio
questo punto di vista
l'accentuazione del carattere
teoretico della politica normativa inquadra il fram
mento nella esaltazione della pura D-eaipta contenuta nel
Protreptico.
Il cap. XI tratta della relazione della qipvTjois col
piacere. Si osservato che il capitolo non conveniva a
un protreptico, non trovandosi questo tnof
nei pro-
treptici posteriori. Ma questo
metodo in s erroneo.
Non si pu dedurre meccanicamente dai luoghi comuni
dei pi tardi protreptici dell'et imperiale ci che fosse
conveniente a un protreptico della scuola platonica. Que
sto metodo, usato con troppo zelo nell'indagine lette
raria, non reca ad alcun risultato quando si tratti di una
forma individuale, organicamente prodotta da esigenze
obiettive, come quella propria degli scritti platonici e
aristotelici. Che ad un protreptico mirante a dimostrare
l'identit della conoscenza (cppvTjm?) platonica con la
vera beatitudine convenisse la discussione, consueta nel
l'Accademia, circa la relazione della cppV7jou; con la
fjSovVj assolutamente naturale, perch la tesi non po
teva essere dimostrata in alcun altro modo. Aristotele
non poteva immaginare una felicit priva di piacere, e
doveva quindi indagare quale sorta di piacere potesse
fornire la fppvrjais.
Questo
problema, gi trattato am
piamente da Platone nella Repubblica') e poi nel Filebo,
non poteva
esser tralasciato nella difesa di ini ideale di
') Plat, Resp., VI, 596 B.
102 IL PERIODO ACCADEMICO
vita puramente contemplativo. Anche l'Etica Nicoma-
chea, dimostrando nel X libro che la vera eudemonia
assicurata dal 9'ewpTjxtv.? j3tos, indaga la relazione della
perfetta attivit col piacere e particolarmente la pura
sensazione di piacere che accompagna il conoscere. Ab
biamo gi dimostrato che questa parte del X libro di
pende in certa misura, nel contenuto, dal Protreptico,
con cui ha comune l'argomento.
Ilpiacere della 9-ewpia
era dunque senz'altro uno degli argomenti propri del
Protreptico. Infine, anche la dimostrazione della dipen
denza dell'Etica Eudemca dal Protreptico viene a pro
vare la logica necessit del capitolo sul piacere. Tanto
nell'Etica quanto nel Protreptico cppvqatj, Sov, pexq
sono giustapposte come le tre specie possibili dell'eude
monia. La dimostrazione del Protreptico culmina nella
tesi che la vita puramente contemplativa soddisfa nella
maniera pi perfetta alle esigenze di ciascuno di quei
tre ideali. La contemplazione, di cui parla ilProtreptico,
non soltanto il culmine della conoscenza filosofica, ma
anche il compimento dell' evoluzione morale dell* umo
e la pura beatitudine di un'ininterrotta gioia spirituale.
impossibile sottrarre un elemento a questo edificio
concettuale senza distruggerne il complesso. Risulta di
mostrato con ci che anche la prima parte
del XII cap.
un estratto dall'opera aristotelica.
Non si fa certo una congettura troppo audace im
maginando che il Protreptico aristotelico, come iposte
riori esemp dello stesso genere letterario, culminasse
nella rappresentazione della vita beata.
Questa
archi
tettura determinata da una necessit oggettiva e sti
listica, che toglie ogni carattere pericoloso alla dedu
zione procedente dal posteriore all' anteriore, dal con
dizionato alla sua condizione. Che mai non si darebbe per
poter leggere questo epilogo, in cui Aristotele attingeva
l'estremo vertice della sua fede! Ma per quanto b eian
ilrsoTRErrico 103
volute attribuire ad Aristotele le parole conclusive, che
seguono inGiamblico (pp. 60,7
61,4), bisogna pur dire
che il desiderio ha vinto in tal caso la riflessione cr
tica J). Impetuose, anche entusiastiche, possono ben es
sere queste frasi, ma non qui l'impeto dominato di
Aristotele, che non rinuncia mai all' austero ritmo della
progressione apodittica, perch per lui il rigore meto
dico sta pi in alto di quel pi alto entusiasmo, di cui
tuttavia traboccano sensibilmente molte delle sue dimo
strazioni. La maggior parte degli elementi singoli del
brano di Giamblico potrebbe certo, in s, essere slata
presa dal Protreptico, e forse lo : p. es., la natura con
traddittoria della nostra esistenza terrena e corporea; la
meschinit di ogni nostra conoscenza e sapienza; il con
trasto tra le malsicure nostre dimore presenti e il luogo
da cui proveniamo e in cui tendiamo a ritornare; la
sproporzione tra il lavoro che dobbiamo compiere per
conquistare le cose pi necessarie alla vita eeterna e la
fatica spesa per ci che solo prezioso ed eterno. Ma
la fiacca connessione di queste idee con lo scopo del
l'esortazione edificante; la tendenza irrazionalistica, di
cui si scorgono le traccie; l'unzione chiesastica, con la
quale vengono gettate al vento solenni parole platoni
che; alcune espressioni chiaramente neoplatoniche come
la via celeste e il regno degli Dei; infine, la ver
bosa prolissit della conclusione, che non arriva a tro
vare un fine, tradiscono la rielaborazione giamblichca.
Poi seguono estratti da Platone.
3. La filosofia del protreptico
IlProtreptico non tratta alcun problema particolare:
la sua importanza, varcante i limiti della specifica
scienza filosofica, piuttosto nell' universalit della que-
') Hartlich, I. e., p. 254 segg.
104 IL PERIODO ACCADEMICO
stione vitale da esso posta, quella cio del senso della
filosofia, del suo diritto all' esistenza e della sua posi
zione nel complesso della vita umana 1). Ci non si
gnifica che la filosofia platonica avesse messo per la
prima volta gli uomini di fronte a questo problema,
che si ripresenta tenace nelle leggendarie biografie di
Talete, Anassagora, Pitagora e Democrito. Ma ogni ri
torno storico del tipo umano schiettamente scientifico
lo fa rivivere in una nuova ed appassionata presa di po
sizione rispetto all' ambiente. Nella sua forma pi de
cisa, infatti, il
fi
loq resta un postulato del
l'innata attitudine scientifica, che certo rinasce sempre,
ma non mai veramente giustificata di fronte al senso
comune. necessario, per ci, un grande impeto di fede
nella capacit della conoscenza ad elevare colui che la
scopre pi in alto di quanto altrimenti non sia concesso
agli uomini. Da questo entusiasmo, dal quale nulla
tanto lontano quanto l'intellettuale alterigia dei dotti
di professione, nato Io scritto. Ebso attesta come Ari
stotele non sognasse soltanto il pacifico idillio di una
consueta vita scientifica, ma esaltasse la beatitudine di
chi ha imparato a guardare ilmondo con gli occhi di Pia-
') Nell'interpretazione della filosofia del Protreptico debbo op
pormi, oltre che alla concezione armonizzante del Bernays, anche
al Diels, che in rchiv
fiir Gesch. d. Philos., I, p. 493, cercava di
attenuare, nei frammenti, le visibili tracce di pensiero platonico,
riducendoli a puri ornamenti stilistici. La verit era stata invece,
se anche molto timidamente, sospettata da R. Hirzcl (in Hermes,
X, p. 98): ma egli non os opporsi, come esigeva la coerenza, al
preconcetto dominante, e fu ridotto al silenzio dal Diels. Il poste
riore cambiamento di opinione del Diels riguardo all'evoluzione
di Aristotele si manifesta chiaramente in Zeitschr. jiir vcrgleich.
Sprachjorschung, XLVII, p. 2-01, n. 4, dove, in base ai risultati delle
mie ricerche sulla genesi della
Metafisica
(Studien zur Entstehungs-
geschchte der Melaph. des At., Berlino 1912), egli riconosce l'esi
stenza di un periodo platonico di Aristotele. Gli scritti essoterici ci
fanno in ogni modo risalire, in parte, in un'et ancora anteriore, e
costituiscono, anche dal punto di vista del contenuto, un momento
preliminare rispetto alla revisione critica del platonismo quale si
manifesta negli strati pi antichi dei trattati.
II, PBOTREPTICO 105
tone. Cos esso diventa un proclama della vita platonica
e della filosofia che ad essa conduce. Per noi essa ha
il pregio di costituire quell' autentica professione di fede
di Aristotele, che andiamo cercando.
Non un caso che proprio un rappresentante
della
pi giovane generazione accademica si assumesse ilcom
pito di giustificare l' ideale della vita scientifica di fronte
al mondo dei profani. Questa
generazione ha sperimen
tato con rinnovata intensit il vecchio conflitto tra in
dagine scientifica e prassi. Platone stesso non smentisce
mai, neppure nei suoi periodi pi teoretici, la sua na
tura di scolaro di Socrate, ilquale dall'esperienza e dalla
necessit della vita era spinto a rivolgere al prossimo le
sue meticolose domande. Lafilosofia di Platone radicata
nelle stesse esigenze dell'epoca e della vita pratica: solo
il suo vertice, la conoscenza delle idee, appartiene alla
supcriore sfera della pura conoscenza teoretica. Dall'esi
genza socratica della conoscenza della virt nasce il pri
mato dell' intelletto creatore, che contempla il puro es
sere e trasforma la vita secondo la norma di quello.
A ogni altra forma di vita vien contestato il diritto stesso
di assumere questo nome. Nonsi tratta soltanto di dimo
strare all' uomo, tenacemente attaccato al suo pratici
smo, come anche 1' attitudine teoretica abbia una
certa ragion d' essere e possa scamparla perch non
fa male a nessuno: si tratta dell'ardita fede, che una
vita degna del nome possa esser fondata solo sulla co
noscenza della suprema verit. A questa esigenza Platone
tien fermo anche quando,
rivoltosi, esclusivamente alla
ricerca scientifica, non interviene pi, coi suoi intenti
di riforma, nella realt. Ma tuttavia la giovane genera
zione, allevata esclusivamente in questa
solitudine scien
tifica, deve porsi di nuovo il problema del valore del
{Ho?. Quel
valore essa deve trovarlo essenzial
mente nel suo intimo, nella pura felicit della fieajpfa
106 IL PERIODO ACCADEMICO
e nel!' unificazione dello spirito con l'eterno. L'ideale
platonico, in origine tanto incline all' attivit riforma
trice, tende cos ad assumere un atteggiamento contem
plativo-religioso.
Il concetto designante quell'unit di vita pratica e
conoscenza teoretica, che sola pu giustificare questo en
tusiastico ideale scientifico, quello della ppvrjci,?. Esso
costituisce il pernio di tutta la trattazione, che verte
circa la possibilit, l'oggetto, l'utilit, lo
sviluppo, la
felicit di tale forma di conoscenza. La si pu definire
come conoscenza creatrice del puro bene merc inte
riore intuizione dell' anima, e insieme come conoscenza
del puro essere: quindi anche come deduzione dell'a
zione buona e della conoscenza vera dalla stessa fonda
mentale energia dello spirito.
Questo concetto, una delle
ideae irmatae dell' anima greca, ha avuto tin lungo svi
luppo, ma nessuna et l'ha avvicinato alla sua perfe
zione pi di quella che si
apre con Socrate e si chiude
con Aristotele. Ilsenso che esso ha nel Protreplico pu
ramente platonico. Da lungo tempo scisso in due motivi,
uno economico-pratico e uno morale-religioso, egBo di
viene proprio per ci il
punto di cristallizzazione del
pensiero socratico. Da questo passa a Platone, che ela
bora in esso intensamente il momento intellettuale del
sapere e indaga la particolare natura di quest'ultimo.
La tppivYjcc; contrappone ora a s, come suo
oggetto,
l'idea, il tipo normativo. Ne nasce cos l'intuizione intel
lettuale del Buono e del bello in s. Ed estendendo
l' idea sempre piilsuo dominio oltre ilimiti della fera
morale, incui si era originariamente
presentata a Platone
impegnato nei problemi
della socratica, fino a diventare
1' assoluto principio della realt, la (ppvr/ei$ si
riempie
di
sempre nuovo contenuto. Diventa scienza eleatica del
l'essere, Spirito anassagoreo, in una parola il con
trario di ci che essa era
stata nella sfera pratica della
IL FROTIIEPTICO
socratica, e cio pura ragione teoretica. La teoria
pla
tonica si distingue ora in
dialettica, etica, fisica. D' ora
in poi esistono pi eppovy/csc?:
la parola,
cos, finisce
spesso per assumere ilsignificato pi superficiale
di sin
gola materia scientifica . Ginnastica, medicina, tutte le
altre discipline sono ppovaeig.
Questa
evoluzione
com
prensibile quando si pensi alla linea di sviluppo per
corsa dalla filosofia platonica e alla sua conclusiva divi
sione in tre filosofie. Nella dottrina dei principi si com
pienello stesso tempo un' evoluzione, per la quale l'idea
viene matematizzata
e conduce a una teologia e mona
dologia. Tale il significato che il termine di cppvTjm?
ha, quasi
esclusivamente, nel Prolreptico: essa il voO?,
ci che propriamente
divino in noi, forza del tutto
diversa dalle altre facolt dell' anima, pensiero meta
fisico-speculativo,
come nel Timeo e nel
Filebo, nelle
Leggi e neir Epinomide.
Mentre il Prolreptico concepisce la tppvyjois come
la conoscenza filosofica in assoluto, in enso del tutto
platonico,
la
Metafisica
non conosce pi questo
concetto.
Del tutto diversa anche
l'immagine offerta dall'Etica
Nicomachea. Con la tppvjjotg del Protreptico essa non
ha pi niente in comune. Nel VI libro dell'Etica
dedicato largo spazio al problema della posizione della
cppvTjais nel sistema delle virt dianoetiche dell'anima.
Dappertutto, fra le righe, traspare la polemica. Aristo
tele riconduce la ypvrjat? al suo comune significato, cio
alla fase preplatonica del suo sviluppo terminologico.
Le toglie ogni valore teoretico e delimita nettamente
il suo dominio rispetto a quelli della aoqsfa e del voOg l).
Secondo ilcomune uso linguistico essa una facolt pra
tica, che mira tanto al giusto calcolo del vantaggio per-
') Eth. Nic., Z 5 segg.: in tale uso linguistico s'insiste in 1140
a 25, 29, b 8, 10, 11, 1141 a 25, 27, b 5.
108 IL PKMODO ACCADEMICO
sonale quanto alla scelta di ci che conviene moralmente.
Ci coincide con la pitarda terminologia di Aristotele :
quando egli concede la
ippvYjcis anche agli animali,
ormai alla massima distanza dal punto di vista della sua
giovinezza '). Nel sistema dell'etica essa un'attitu
dine abituale dello spirito, concernente l'esperienza pra
tica di ci che costituisce il
bene e il male dell' uomo !)
(i'ct;
rcpaxTtxfj). Aristotele insste ora nell'
osservare che
essa non un pensiero ma una riflessione, che non ha
rapporto con l'universale bens con le irripetibili singo
larit della vita, e che quindi non ha per oggetto ci che
nell' universo pi prezioso e alto, non essendo insomma
una scienza4). Tutto ci significa l'aperta
ritrattazione
delle vedute platoniche professate nel Protreptico.
E mentre in quest' opera egli designa la metafisica come
Tfj?
TcaauTY]? XqD'sfas ofav of te nepl 'Av!*a-
ypav xa IIap|iev{Yjv qui insiste esplicita
mente nel chiarire che uomini come Anassagora e Talete
si chiamano oocpol e non cppvipot, perch essi non s'in
tendevano del loro vantaggio, ma indagavano le eterne
leggi dell'universo1).
Dietro questa vicenda
terminologica si cela il mu
tamento della concezione metafisica ed etica di Ari
stotele. Per Socrate la
ypvrjoig era la razionale facolt
etica, in conformit di quel comune uso linguistico,
che
l'Etica Nicomaehea rimette iu onore. Platone,
analiz
zando pi accuratamente la natura di questa
conoscenza
morale e deducendola dalla 9-Ecopfa delle norme
eteme,
e in conclusione dell'
iyafiiv,la trasform di
fatto in
ima
conoscenza scientfica di realt concepite come og
gettive;
tuttavia aveva
diritto di conservare per questo
') Elfi. Nic., Z 7, 1141 a 27.
") Et!i. Nic., ZS, IMO b 20, b 4.
'I Elh. Nic., Z 8, 1141 b 9, 14; 1141 a 21, 33 sgg.; 1142 a 24.
')
i'rnmm. 52 (p. 59, 3 R.);
Elh. Nic., Z 7, 1143 b 3-5).
IL PROTREPTICO 109
sapere teoretico il nome di tppvijo15, in quanto la co
noscenza del vero essere era nello stesso tempo una co
noscenza delle pure norme, invista delle quali si doveva
vivere. Nella contemplazione delle idee coincidono l'eB-
sere e ildover
essere, la teoria e la pratica. Con l'abban
dono della dottrina delle idee la dialettica
perde quel-
1* immediata importanza per la vita umana che le era
essenziale in
Platone;
essere e dover essere si separano
infatti, ora, l'uno dall' altro. Metafisica ed etica si di
stinguono molto pi nettamente di prima
*). Alla con
siderazione
retrospettiva il costante riferimento plato
nico dell' azione morale alla conoscenza dell' essere ap
pare ora intellettualistico.
Tra 1' una e l'altra Ari
stotele segna una distinzione precisa. Scopre le radici
psicologiche dell' azione e della valutazione morale nel-
l'ij&o;, l'indagine del quale vien cos in primo piano
in quel pensiero che d' ora in poi si dice etico, e caccia
in ombra la tppovTjtn?
trascendente.
Si compie cos la
separazione,
feconda di conseguenze,
della ragion teo
retica dalla ragion pratica,
ancora strette nella ppvTjot?
in unit indistinta.
Da questo
quadro evolutivo deriva necessariamente
come
Aristotele, nel Protreptico, debba trovarsi ancora
sul terreno
di una diversa metafisica.
Se il rifiuto della
giustificazione
unilateralmente teoretica della vita morale
e quello del primato
della tppovYjat?
platonica, compiuto
') Ci vale per ogni specifico valore umano, ma non per il
valore o bene assoluto. Nel concetto di Dio coincidono anche per
Aristotele
_
e in ci egli rimane per tutta la vita platonico
l'es
sere e il valore nel senso assoluto della parola; il sommo essere
e nello stesso tempo il sommo bene. Nel punto di massima lonta
nanza dalla sfera umana la metafisica coincide ancora con l'etica
e l'etica con la metafisica. Ma la prospettiva completamente
spostata, e solo inremota lontananza l'immobile
polo, segnalante la
direzione ultima, affiora sull'orizzonte dell'esistenza. Il nesso di
questa metafisica con la singola np&St? troppo debole per giusti
ficare ancora la sua
designazione col termine di <ppvY]oi.
110 II, PEIUODO ACCADEMICO
dall' Etica Nieomachea, una conseguenza dell' abban
dono della dottrina delle idee, il Prolreplico, che c an
cora completamente dominato dall'antico concetto della
<ppv7]ocs, deve avere ancora le sue radici nella metafisica
morale di Platone, nella sua unit di essere e dover es
sere. Di fatto, qui ogni elemento essenziale platonico,
e non solo nell' uso linguistico ma anche nel contenuto.
In nessun altro luogo Aristotele accetta la divisione ac
cademica della filosofia in dialettica, fisica ed etica, a
cui accenna occasionalmente soltanto nella Topica,
opera che probabilmente da annoverare tra isuoi pi
giovanili tentativi ]). Della dottrina, costruita su fon
damento psicologico, delle virt, contenuta nell'Etica e
costituente la prima vera fenomenologia della morale,
non b trova ancora alcuna traccia; e invece s'incontra
la dottrina platonica, elaborata su fondamento sistema
tico, delle quattro virt2). Decisivo poi ci che il Pro-
treptico dice circa il metodo dell'elica e della politica.
Gli avversari della filosofia che appaiono in quest'o
pera usano il nome di etica, come se ci fosse naturale,
nel senso platonico di scienza del giusto e dell' ingiusto,
del bene e del male, al pari della geometria e delle altre
') Nel framm. 52 (p. 60, 17 R.) vengono distinte nettamente,
nella dimostrazione della possibilit di raggiungere un effettivo
sapere: 1) ntotpi) nspl tjv
Sixaiiov
y.at tjv
au|icfspvxcuv ; 2) itspt
cpiiasiog ; 3) itspl t-SJg SXX-r) SXr)ikCa{. Manca ancora ad Aristotele una
denominazione per la prima filosofia: cfr. p. 59, 1-4 R., dove, ac
canto alla scienza del giusto e dell'ingiusto e a quella della natura,
si accenna ad essa, ma se ne designa il concetto con una perifrasi.
D'altronde, la designazione platonica di
< dialettica non per
lui abbastanza caratteristica, perch non distingue l'ontologia dal
l'elica e dallo politica n implica in s alcun riferimento a un og
getto, e vien quindi ristretta nei limiti della pura logica formale.
Alla tripartizione corrisponde la dimostrazione: 1) nepi ootej p. 60,
21-61, 1 R. 2) aspi 'jio/ijp ipsxcv p. 61, 2-8 R. 3) aspi tposuij
p. 61, 8-17 R_ In Top,, A 14, 105 b 20 segg. Aristotele distingue
rtpoTcioaig tfooixai, XoytxaC (neanche qui detto 6iaXe*n-
xaC: cfr. Senocrate, framm. 1Heinze).
5) Per le quattro virt platoniche v. framm. 52 (p. 62, 1 R.)
e 58 (p. 68, 6-9).
il
pnoiREPiico 111
discipline ad essa affini 1). Aristotele richiama con ci
l'attenzione su un punto che evidentemente doveva aver
pi colpito e suscitato critiche, e cio sulla concezione
dell' etica come scienza esatta. In un altro luogo egli
designa la politica, che non pu essere distinta dall'etica,
come una scienza che ricerca norme assolute (8poi). Egli
contrappone
la politica filosofica alle la cui
scienza soltanto derivata. Tra queste egli annovera
anche la solita politica empirica, che giudica
solo se
condo le analogie dell' esperienza e non pu perci mai
dar luogo a un' attivit feconda. La politica
filosofica
ha per oggetto l'esatto in s : una scienza pura
mente teoretica2).
Questo
ideale di esattezza matematica contraddice a
tutto ci che Aristotele, nella sua Ecica e nella sua Po
litica, professa a proposito del metodo di queste due
scienze. Neil' Etica Nieomachea egli combatte esplicita
mente, come inconciliabile con la"natura del suo oggetto,
1' esigenza di un' esattezza di metodo. In questo senso
egli avvicina l'etica e la politica piuttosto alla retorica
che alla matematica3). Essa pu raggiungere
un'uni
versalit soltanto generica: le sue deduzioni non esclu
dono ogni eccezione, per lo meno di regola. Tanto mag
giore l'universalit, tanto minore il contenuto e l'effi
cacia: ecco il giudizio della pi tarda etica aristotelica
sull' ideale metodico sostenuto ancora dal Protreptico4).
Non c' quasi parola, dedicata daITEtica Nieomachea
a questo argomento, che non abbia anche un intento
polemico: dobbiamo quindi imparare a leggerla facendo
attenzione a ci. (Nel Protreptico si diceva che il poli
tico filosofico si distingueva dal politico di stampo con-
') Framm. 52 (p. 58,
23).
") Jambl., Protr., p. 55, 1e 55, 6 segg. (Pistelli)
') Etk. JVic., A 1, 1094b 11-27; A 13, 1102 a 23
i-vii Nw\. r 7. nnt
'12 IL PERIODO ACCADEMICO
sueto per l'esattezza della sua conoscenza normativa,
essendo abituato a considerare le cose in s e a non con
tentarsi delle varie immagini offerte dalla realt empi
rica. A questo luogo ai riconnette quasi verbalmente, e
con determinata intenzione, un passo dell' Etica Nico-
machea, nel quale questa concezione si trova esattamente
capovolta. necessario, si dice qui, distinguere tra il
modo incui un geometra misura l'angolo retto e ilmodo
incui lo misura ilfalegname (cio
l'empirico). Ilprimo
considera la verit in se, 1' altro si occupa della natura
di quella realt solo per ci che necessario invista dei
suoi scopi pratici. E proprio quest' ultimo, non il geo
metra,
paragonato da Aristotele alla scienza etico-po
litica! L'ideale metodologico di un'etica more geome
trico, seguito da Platone, qui nettamente respinto, men
tre domina ancora incontrastato nel Protreptico J). Pa
rimenti, Aristotele polemizza contro la sua precedente
concezione platonica nei passi dell'Etica in cui insiste
sull'assai maggioreimportanza che, a paragone della cul
tura teoretica, possiede l'esperienza pratica per ilpolitico
e perfino per l'ascoltatore di lezioni di etica 2). Cosi, di
et posteriore anche la sentenza che per un re ilfilo
sofare non sia una necessit, anzi piuttosto un impedi
mento, ma che per egli debba prestare orecchio a con
siglieri veramente filosofici. Essa deriva probabilmente
da un memoriale inviato ad Alessandro, e sembra rife
rirsi a una determinata situazione storica, da assegnare
Edi. /Vic., A 7, 1098 a 26 pspvvjc&ai 5 xal-cSv Kpostpfisvwv
XP) xal fijv SxpijUiav &poto tv Sreaeiv Ireivj-tsrv, XX' tv
ixexoij v.at t;v &reoxeipiv)v BXijv "/.al liti togotov,
'f'
fioov
olxstov T-g ps9-s5qi, "/al yp xxxwv /al ytu>fiixp]S
5iaf
spvxiog
iixitytoCoi
vff*
6 pi- yp
l'P
&3ov rep'j tpyo-,
5 8i ti iotlv ) Jtstv ti. {Ssarijs yp tXr;8-o5s.
v6v atv 5 xpreov
/al tv totf XXots
reoiijxov,
8reu>?
ji t recipspya tcBv Ipyuiv reXeiio
yivrjtai. Cfr. Jambl., Protr., p. 55, 1-14.
1Elfi. Nic., K 10, 1131 a 1e 10; A 13, 1102 a 19 segg.
tt PROTBF.PTICO
113
al tempo della spedizione d'Asia '). Tra questo consi
glio e quello contenuto nello scritto che, dirigendosi
a
Temisone, vuol farne unpolitico teorico, obbediente alle
idee, sta tutta una trasformazione dei fondamenti del
pensiero aristotelico.
L' ideale di nn' etica geometrica era concepibile solo
sul piano della pi tarda dottrina delle idee. Per Pla
tone, sapere scieniifeamente equivale a misurare. Per
scienza esatta egli intende una scienza che misuri le cose
merc un criterio assoluto e perfettamente determinato.
L'illimitato (fiitetpov), la molteplicit
del mondo sen
sibile non perci mai oggetto di una pura scienza.
Il Fihbo mostra come il vecchio Platone cerchi di ren
dere 1' etica oggetto di una scienza esatta di tipo mate
matico merc il principio del lmite (Ttpa;) e della mi
sura (|iypov). Il concetto del misurare vi riappare ad
ogni passo: il distintivo dello stadio matematico della
dottrina delle idee. Essendo ogni bene misurabile e li
mitato, e ogni male incommensurabile e illimitato, tanto
nel cosmo come nell'anima, la politica e l'etica del tardo
Platone in senso vero e proprio una scienza teoretica
della misura e della norma. Nel secondo libro del per
duto Politico Aristotele scriveva: il bene la misura
pi esatta fra tutte2).
Questo
principio allegato pro
prio contro di lui dal platonico Siriano, che vuol dimo
strare con esso come Aristotele avesse avuto in altri
tempi una miglior comprensione della dottrina plato
nica. Non diversa da questa,
infatti, quella professata
da Aristotele nel Protreptico, quando pone 1' esigenza
dell' esattezza e designa la politica come pura scienza
*)
Pramm. 617 R.
*) Fi-amm. 79 R. Il contesto di Siriano, non compreso dal
Rose nella sua trascrizione, importante perch mostra come egli
avvertisse chiaramente l'antitesi di questo principio rispetto alla
posteriore dottrina di Aristotele.
8.
W.
Jaigee,
Aristotele.
'14 u, PERIODO ACCADEMICO
normativa. Tale la filosofia del Filebo, che nella tavola
dei valori d il primo posto alla misura (pixpov), il
secondo a ci che comunque commensurabile (auppe-
xpov), il terzo alla ragione che ne ha conoscenza (tppvTj-
O'.j). L'idea del bene
era, nella Repubblica, fonda
mento di esistenza e di conoscibilit per tutto ilmondo
reale. Secondo ilFilebo, e secondo il Politico di Aristo
tele, essa tale in
quanto il pi alto e universale cri
terio di misura, e cio la pura unit mediante la quale
il mondo delle idee limitato e simmetrico , e con
ci esistente, buono e conoscibile. Ogni illimitatezza
esclusa dal suo
cospetto.
Quanta parte abbia avuto in
questa dottrina la tarda concezione platonica delle idee
come numeri, non pu qui essere indagato. Aristotele,
nel Protreptico, ne fa spesso menzione. La sua etica po
steriore, che non riconosce alcuna norma valida univer
salmente e neppure ammette criterio di misura al di
fuori di quello, vivente ed individuale, che risiede nel
l'autonoma personalit morale e la cui cppvTjoi? non con-
cerne l'universale (xaffXou) ma il particolare (xecfKexa*
<3~ov ), costituisce la consapevole antitesi della conce
zione sostenuta nel
Protreptico e nel Politico*). Ilprin-
') Phileb., 66 A.
!) Elk. A'ic., r 6, 1113 e 29 5 OTtouSaCoj fp ixaaxa xpivei
pD-j; xal v ix4cco:j tAijfi-; aT$ aatvEtau... xal Siatfpst -?.sr.
o-uov tou>{ 6 onot)5ato{ tip t iXijfrig Iv 1x4otoij 6pSv, Giajtsp
xavv xal ptpov attv
(v. A 14, 1128 a 31 6 Si] xapieig xal
Ao8-pto{
o6tu>s
l{;si, olov vpo; & v
aux$. K 1176 a 18
xal Iotiv Sxotou
fit
pov
$ pez-ij xal 6 -raS-g g to io -o
j,
xal giovai eUv Sv al toOttp cjaivipsvat xal gSa 0X5 oto; /aipst.
Queste mirabili frasi dimostrano del resto di nuovo, considerate
alla luce delle espressioni del Protreptico,
che l'indagine etica d
Aristotele era in origine completamente dominata dal problema
platonico della commensurabilit, e del criterio di misura, dei fe
nomeni morali: soltanto, egli rigetta pi lardi le norme universali
e non riconosce altro criterio di misura al di fuori della coscienza
autonoma (certo niente affatto esatta in senso gnoseologico)
della
personalit moralmente educata 1 6
onouSatosi. Con ci egli rinvia
ciascuno al giudizio di s medesimo, e fa luogo alle individuali
IL PROTREPTICO 115
cipio che il bene sia la misura pi esatta di tutte coin
cide esattamente con la sentenza, enunciata dal vecchio
Platone nelle Leggi, che Dio sia la misura di tutte le
cose : sentenza che, involuta antitesi rispetto al principio
di Protagora, che l'uomo sia la misura di tutte le cose,
innalza la norma assoluta sul trono del mondo a).
Questa
Dio platonico infatti ilbene in s, la pura monade, la
misura delle misure.
Qui
la politica e l'etica diventa teo
logia, e si asside sul culmine della filosofia teoretica: es
sere e dover essere sono insenso assoluto identici, e l'at
tivit umana si manifesta inimmediata connessione finale
col massimo valore esignificato del mondo. UEticaNico-
machea2) combatte coerentemente anche questa posizio
ne dominante della politica, che pu esser tanto poco la
somma sapienza, quanto poco gli scopi della vita umana
attingono quel bene etemo, che solo ilsaggio scorge nella
contemplazione della divinit.
L'esigenza del Filebo, d'innalzare lafilosofia a scienza
matematicamente esatta 8), non manifesta la sua efficacia
soltanto sull'etica e sulla politica del Protreptico. Essa
sta a fondamento anche della descrizione dei rapporti che
intercorrono fra la scienza empirica e la scienza pura.
Come l'ideale dell'esattezza e il concetto della misura,
cos anche il problema della delimitazione delle scienze
determinazioni e condizioni dell'attivit morale nella loro moltepli
cit inesauribile, senza tuttavia scuotere l'inviolabilit della norma
interiore. Anche ilfamoso concetto della bpz-.r, come giusto mezzo
tra VbntpOAij e 1' iJ.Asf.jHj trattato sotto l'aspetto del problema
della misurazione di quantit continue (B 5, 1106 a 26) e trac il
suo significato metodologico solo da questa impostazione del pro
blema: cosa alla quale d solito non si bada affatto, in quanto non
si tien presente il contesto storico che coiu'-'ziona, in Aristotele, la
genesi di tale questione.
*) Plat.
Leg., IV, 716 C 4 Si] <H6s ptv itv-tiav xprj[iTBiv p-tpov .
Sv sii] [lAio-ta, xal noX pAAov ?) no6 tig, Si; tfasiv,
SvOpioitoj.
1Eth. Vic., Z 7, 1141 a 20 segg.
*) Per l'esattezza (xplpsia) come criterio di misura del carat
tere scientifico di una disciplina v. Phil., 56 B-C, 57 C-E, 58 C,
59 A, 59 D ecc.
116 IL PERIODO ACCADEMICO
pure rispetto a quelle applicate passato
nella tarda dot
trina platonica dalla matematica. Nel Prolrcptico, gli av
versari 1) della pura filosofia e della pura scienza istitui
scono ibinomi di geometria e geodesia, dottrina dell'ar
monia e musica, astronomia ed esperienza nautica del
cielo e dell'atmosfera, per dimostrare che in ogni campo
la teoria addirittura d'impaccio per l'attivit pratica
in quanto allontana lo studioso dall'esercizio e spesso pa
ralizza la stessa naturale sicurezza dell'istinto. Saremmo
curiosi di conoscere ci che Aristotele opponeva a tali
osservazioni. Purtroppo, la sua risposta a tali critiche
andata perduta. Il motivo del giustapporre, in coppie
parallele, le scienze empiriche c quelle pure non na
turalmente stato inventato dagli avversari, essendo usato
inizialmente dallo stesso Platone. Nel Filebo2) si distin
gue un' aritmetica dei filosofi dall' aritmetica della co
mune umanit; e a seconda che essa opera con unit
uguali o disuguali, essa scienza in grado maggiore o
minore. Cos esiste anche una duplice tecnica del calcolo
e della misura, anzi tale dualismo 3) sussiste in molte
ilyya.: anche senza che esse mostrino nel nome tale di
stinzione. Tra esse sovrastano incomparabilmente alle al
tre, per l'esattezza e la verit quanto
alla misura e al
numero, quelle di cui si occupano iveri filosofi. La ri
sposta di Aristotele agli empirici sar stata simile a
quella data da Platone nel Filebo: non si tratta di sta
bilire quale arte giovi di pi all'azione e quale procacci
maggiori vantaggi, bens di sapere quale tra esse miri
alla massima esattezza, chiarezza e verit. Un po' di
bianco veramente puro pi bianco, pibello e pivero
') Fratnm. 52 (p. 59, 18 segg. R.).
') Phil., 56 D.
') Phil., 57 D. De confrontare anche Epin., 990 A, dove l'astro
nomo procedente con metodo matematico contrapposto al cono
scitore empirico dei fenomeni celesti e meteorologici.
IL PHCTREPTICO 117
di una quantit anche grandissima di bianco mescolato
con altro colore . Esso sar quindi senz'altro preferito
dall'amatore di colori puria).
Questo
ideale dell'esattezza
del sapere a scapito della sua utilit, che deriva dallo
spirito di costruzione matematica della pi tarda dot
trina platonica delle idee, chiaramente riconosciuto an
che dal Protreptico. Non si pu concepire Aristotele sen
za questo sentimento costruttivo, artistico della meto
dologia.
In ogni modo, la dottrina delle idee appare chiara
mente professata, nel Protreptico 2), anche nella sua
parte sostanziale. Come nelle arti manuali gli uomini
hanno costruito imitando la natura imigliori strumenti,
coi quali si misura e controlla la perfezione lineare o
superficiale degli oggetti sensibili, cos sussistono per Ari
stotele anche per ilpolitico determinate norme (Spot) che
egli attinge alla autentica realt e verit (it r/]$ cpuasio?
xa zfji Xp&eta?) e secondo le quali egli giudica
ci che retto, onorevole, buono e salutare. E come in
quel caso i pi perfetti strumenti sono quelli imitati
dalla natura, cos anche la legge migliore quella con
forme alla natura in grado massimo. Ma questa legge
non pu esser prodotta senza che sia stata conosciuta,
merc la filosofia, l'essenza e la verit stessa delle cose.
Gli strumenti delle altre arti e iloro pi esatti calcoli
non si ricavano immediatamente dai supremi principi
(ox n'atfflv t<Bv rcp&tov) bens da fonti di secondo,
terzo, e anche pi basso ordine, e le loro regole vengono
acquisite per mera esperienza. Solo il filosofo dirige la
Sua imitazione (jrijAijcis) immediatamente verso l'esatto in
s (ie' aifv
T(I)v
xptjfv), Egli infatti un contem-
') l'Ini., 53 A.
') Jamb!., l'rnir., p. 54, 22 segg., e spec. 55, 1e 55, 7 segg. {manca
nel Rose).
113 IL PERIODO ACCADEMICO
platore (3-saxj) delle cose in s (aura) e non delle loro
copie ([ttpvjpaTa).
Tanto la lingua quanto il contenuto filosofico del
passo sono puramente platonici. Ci ha richiamato l'at
tenzione gi in un'et in cui non si poteva ancora con
cepire l'idea di un periodo platonico di Aristotele1). Fin
che si considerava ilpasso isolatamente, si poteva pensar
forse di spiegarlo ammettendo un'imitazione stilistica di
Platone, dietro la quale si celasse, riservata e cauta, la
concezione propria dello scolaro. Ma ilsignificato di que
ste parole pu essere veramente compreso solo nella sua
organica connessione con tutta la filosofia del Protreptico,
ed esso esige necessariamente, come fondamento teoretico
della gi veduta dottrina dei valori, la metafisica duali
stica delle idee. Ircpxa della
Metafisica
e dell'analitica
di Aristotele son qualcosa di diverso da quelli di cui si
parla qui. Certo, anche nella Metafisica'2) detto che
il filosofo conosce iprincipi supremi, quelli in massimo
grado universali (jtpffixa). Si mostrato come la formula
zione dei due primi capitoli della
Metafisica
si riconnetta
strettamente e di continuo al Protreptico. Tanto pi im
portante ilfatto che Aristotele vi eviti, a ragion veduta,
la formula platonica ax x Jtpixa cancellando l'axd,
c cio proprio la parola che nel Protreptico fornisce al
l'espressione x rcpixa il senso specifico che esso ha nella
terminologia platonica. Quest'ultimo, d'altronde, non pu
significare l'universale astratto, gi per il motivo che i
concetti generali nel senso aristotelico non costituiscono
) V. R. Hirzel (in Hermes, X, p. 99), che ha giustamente pa
ragonato la necessit della filosofia pel dinasta e per l'uomo di
stato, affermata dal precedente frammento, con l'esigenza platonica
che ire debbano filosofare o che solo ifilosofi debbano essere re.
Errava invece lo Hirzel, per le ragioni gi dette, quando voleva
ascrivere il cap. X di Giainblico non al Protreptico ma a un altro
scritto giovanile, puramente politico, di Aristotele.
!) Metaph., A 2, 982 a 25.
IL PROTREPTICO 119
alcuna antitesi rispetto alle copie (fnpVjpaxa), ter
mine, questo, anch'esso specificamente platonico, il cui
uso ha senso solo in connessione con la dottrina plato
nica delle idee come esemplari e della partecipazione
delle cose sensibili ad esse. Interpretare il termine [itjiVj-
paxa nel significato pi generico di cose sensibili
assolutamente escluso, data l'estrema nettezza, stilistica
e logica, propria di Aristotele1).
Questo
disperato tentativo di trovare una via d'uscita
dalle contraddizioni in cui necessariamente s'impiglia
ogni interpretazione aristotelizzante del passo del resto
dimostrato vano anche dall'equazione terminologica di
quelle
espressioni platoniche con la formula la natura
in s e la verit (puais axj xal X&sia). Non si pu
qui pensare al concetto aristotelico della natura. Non sa
rebbe infatti giustificata, per essa, l'aggiunta dell' axVj,
n essa quella fonte di assolute ed esatte norme poli
tiche e morali, di cui qui si parla s), n infine si potrebbe
l) Il termine deve porre in rilievo il maggior valore esisten
ziale del modello, e non pu quindi esser pi usato dal momento
in cui le idee sono soltanto ti [lXtoxa xa&Xou e non pi eota.
Tanto meno si pu dire che le singole realt della natura visibile,
costituite, secondo la concezione aristotelica, di materia e forma,
siano imitazioni delle entelechie, o forme, operanti in esse. Pre
messa necessaria del concetto delle imitazioni ila trascendenza
platonica, il di
esemplare ed esemplato. Decisivo poi
il fatto che anche pi tardi Aristotele, criticando la dottrina delle
idee, designa spesso queste, con platonico terminus tecknicus, come
ax assolutamente, senza alcun'altra aggiunta, allo stesso modo
che qui (Jamhl., 55, 13 Pistelli): axtv fp Jori Ssaxr;g, XX'o
(itpri[icixoiv. Ilpronome qui non si riferisce ad altro, ma ha valore
assoluto. Ilche possibile, linguisticamente, in quanto tale suo uso
accade soltanto in antitesi alla designazione delle corrispondenti
apparenze o copie sensibili: cfr. Metaph., 991 a 5 ini x' axrjs xal
tvj; xtvg (scil. 8o5oc), a $0 oO (lvov ttv atoS-rjxSv ... SXX xal
attv, b 30 |isxa xiv SeOpo x' loxal xal axtv, 997 b 14 nap'
ax?
xal
x&c
alaOijxg, b 24 (isxa axffiv xe xal xSv yOapxW.
Evidentemente non si fatta attenzione a questo particolare uso
platonico del termine.
J) La designazione della politica, che non sviluppa la sua ener
gia creatrice in funzione della norma eterna ma procede secondo
modelli terreni e inconformit a costituzioni e leggi scritte, col ter-
120 IL PERIODO ACCADEMICO
dire del filosofo, il quale indaga la natura aristotelica,
che egli indaga l'originario inso , mentre le altre arti,
che traggono iloro strumenti e le loro regole dalla stessa
natura sensibile, hanno a che fare soltanto con copie di
seconda, terza e anche pi tarda mano. Se infatti tanto
l'uno quanto le altre avessero ad oggetto della propria
imitazione la stessa natura, quale posizione di privilegio
spetterebbe al filosofo rispetto alle altre
x'/va: quanto al
rapporto con quella? Invece, proprio quest'antitesi della
filosofia, che contempla la realt ins delle cose, rispetto
alle arti, che imitano soltanto copie di copie ci permette
di procedere pi oltre'). Essa deriva dalla teoria delle
idee
esposta nel decimo libro della Repubblica.
Iltertium eomprationis sta nel fatto che tanto l'una
quanto le altre si modellano su una realt oggettiva, esi
stente al di fuori di esse, alla quale incerta misura attin
gono le loro leggi: per le arti tecniche modello la
natura sensibile, per ilfilosofo invece la natura ins ,
appercepibile solo nel puro pensiero: il vero essere, al
trimenti designato con la formula di ax x ixpGvta 2).
dunque impossibile che questa espressione significhi
la massima universalit, perch pi tardi Aristotele, defi
nendo tale universalit, le negala realt oggettiva: men
tre proprio tale realt attribuita ai np&xx dalla desi
gnazione la natura ins . Nonsi puconcluderne altro
che in questo luogo ci che inmassimo grado univer
sale e logicamente esatto ancora identico con ci che
essenzialmente reale: e
questa identit conviene sol-
mine di |J.C]fj]o"g o di
infilinola
Xi]Jetag risale al Politico di
Platone (297 C; 300 C segg.), in cui occotre pi volte, al pari del
confronto del vero uomo di stato col timoniere (cfr. 297 E). Di qui
deriva, del resto, il problema medesimo. In 308 C la politica ideale
di Platone detta 7) xax rpOoiv o5ca
fffitv woXt-twii.
*)
Plat., Resp. X, 599 A; 600 E; 602 C; 603 A; 605 B.
*0 l'iat., Parm., 132 'D x.... sSi] xa3xa (oitsp rcapaSsiffiaxa
lavava', iv tf; <paei. L'equiparazione di tp6ai?, 5v,
XrJt-eia pla
tonica.
IL PROTREPTICO
121
(1 tanto all' idea platonica. Solo di essa si poteva dire che
fosse la natura in s, il divino, l' immutabilmente
saldo,
costante ed eterno, verso cui il politico filosoficamente
consapevole orienta la bub vita, e in cui si ncora come
un bravo pilota1).
Se nel Protreptico le idee si presentano
anzitutto
come fondamenti della gnoseologia, in quanto preciso
oggetto di un puro sapere, e solo in secondo luogo come
norme etiche, ci corrisponde alla direzione ideale se
guita da Platone in quella pi tarda fase del suo svi
luppo, a cui appunto
b riconnette Aristotele. Essa con
duce all'accentuazione del momento metodologico e alla
repressione, se non all' eliminazione, del carattere onto
logico dell'idea. Lo stesso argomento per la reale esi
stenza delle idee viene ora essenzialmente tratto dalle
esigenze e premesse necessarie della conoscenza concet
tuale. Se ifenomeni sensibili fossero isoli oggetti reali,
il pensiero
concettuale, che solo esatto, sarebbe senza
reale oggetto,
e quindi, per il Greco di quell' et, non
sarebbe affatto una conoscenza. Ilcarattere di esattezza
del puro sapere diventa con ci la vera e propria pietra
angolare del tardo pensiero platonico. L'idea il puro
oggetto, che si deve inferire come esistente per il pen
siero esatto.
Questo
argomento capitale dell' Accademia
stato riferito da Aristotele nel suo scritto perdutollep
ISefv, dal quale lo ha tratto Alessandro di Afrodisia,
che ce lo ha conservato2). Si spiega con ci come il
Protreptico chiami le idee 1' esatto in s . Ma anche
il termine, che appariva nell1argomento accademico,
torna qui ad essere espresso
8) : quello di assoluta
mente determinato (x (bptapva).
') Jambl., Protr., 55, 21 segg. (Pistelli).
'1 Framni. 187 R.
l) Frainm. 52 (p, CO, 21 R.) : cfr. Ihpl JSswv, fraumi. 187 (p. 149,
22 R.).
122 IL PERIODO ACCADEMICO
Mentre pi tardi, per Aristotele, la possibilit di ima
conoscenza scientifica del soprasensibile diventa il pro
blema pi difficile fra tutti, perch dopo la negazione
delle idee platoniche non i pu pi capire come si
possa concepire l'essenza delle cose merc iconcetti
universali, ilProtreptico dimostra, con rigore notevole e
con evidente riferimento a presupposti affatto diversi, la
possibilitdi unascienza checonosca ilgiustoeilbuono,
la natura e la restante verit (cio
l'Svxto; 5v). Per
l'autore del Protreptico ci che primo nella sfera del
l'essere coincide con ci che inmassimo grado cono
scibile, e questo, definito insieme come l'assolutamente
determinato, ordinato e normale, coincide a sua volta col
bene e con la causa a). Ora, per quanto espressioni come
npxspov eptiaei e 7xpxepov pi? e
7tp<Sxa nel senso
di principi supremi ,
compaiano certo anche altrimenti
nellafilosofia aristotelica, tuttavia nonc' dubbio che esse
derivino originariamente
dalle dimostrazioni platoniche
dell' esistenza delle idee, alle quali convengono in modo
eminente e per le quali devono essere state inizialmente
coniate. Significato preciso esse hanno solo se applicate
a un essere trascendente in senso platonico, mentre di
ventano equivoche quando siano riferite all'essenza im
manente. Per questa ragione il loro significato subisce in
Aristotele variazioni profonde, ed esige aggiunte deter
minanti (piasi, npi Jjpccg). Il senso assoluto, che vien
loro attribuito nel Protreptico, pu convenir loro solo col
presupposto che nel pi alto oggetto della
conoscenza,
come nelle idee, verit, essere e valore coincidano. Solo
quando nei 7tpxsp e nell' ficya-ifiv s' intendano
signi
ficate le idee divien comprensibile quella stretta fusione
di etica e ontologia che ha luogo anche in
questo argo
mento.
*) Framm, 52 (p. 60, 17 segg. R.).
IL PROTREPTICO
123
Decisivo poi il paBso
del Protreptico in cui compa
re quella dottrina degli elementi (axoista) della realt
che invece ampiamente
combattuta nella Metafisica
J).
Nella prima opera Aristotele dice: il precedente causa
in grado maggiore che il conseguente, giacch,
tolto
quello, tolto insieme questo,
che dal primo deriva il
suo essere (x7"/V
oaiav) tolto il numero tolta la linea,
tolta la linea tolta la superfcie, tolta la superficie
tolto il solido. La Metafisica
nega invece ogni .esistenza
agli oggetti
matematici, numero punto
linea superficie
solido, ed anzi informa come l'attribuzione
dell'esi
stenza a questi enti fosse propria
dei platonici. In essa
detto: essere (oata) b dice anche ci, la cui elimina
zione elimina insieme il complesso a cui appartiene, nel
senso in cui, secondo
alcuni, tolta la superficie tolto il
solido, e tolta la linea tolta la superficie. Essi consi
derano inoltre anche il numero come un essere di que
sta specie. Le parti pi antiche della Metafisica
rivol
gono
la loro critica del platonismo principalmente
con
tro quest' ultima forma della dottrina delle idee, che o
giustapponeva alle idee gli oggetti
matematici, conside
rati anch' essi come
esistenti, o interpretava addirittura
ia le idee come numeri. Intali luoghi Aristotele definisce
a questa dottrina come un
pceXax?. Tanto pi
significativo quindi il fatto che egli stesso sia stato,
in altri tempi, seguace della dottrina combattuta. La
sorte di questa
identica a quella dell'esistenza tra
scendente delle idee e degli oggetti
matematici, e del con
cetto platonico dell' essere.
Aristotele lascia intrawedere che nell' Accademia
si
discuteva circa il problema degli elementi dell'essere:
osserva infatti come, sia che a principio e causa di tutto
') Framm. 52 (p. 60, 26 R): cfr. Mcluph., A 8, 1017 b 18;
N 3, 1090 b 5.
124
IL PERIODO ACCADEMICO
venga posto il fuoco o 1' aria (cio
gli elementi della
filosofia naturalistica), sia che venga considerato tale il
numero o certe altre nature (tptiaei;, le idee), risulti in
ogni caso impossibile procedere comunque nella cono
scenza prima di avere conosciuto iprincipi x). Anche Pla
tone, nei suoi dialoghi pitardi, ha fallo allusioni simili,
senza per chiarire come stessero le cose. Nel Filebo, ri
cordando la dottrina delle idee, egli parla apertamente
della
noXA/i) OTtouSrje della pet Siatpaswg 2)
a cui essa dava origine. A queste discussioni Aristotele
partecip vivacemente. Tanto pi notevole quindi, nel
Protreptico, la subordinazione di quella opinione par
ticolare alla dottrina accademica dominante. Si possono
trarre da ci due sicure conclusioni. Anche in questo
primo periodo Aristotele non ha professato la dottrina
delle idee come un rigido principio dogmatico, ma da
seguace che ne parlava con piena consapevolezza delle
difficolt ad essa collegate.
Queste
non debbono per
essergli ancora sembrate cos gravi, da sentirsi in grado
di confutare senz'altro la dottrina platonica, come fece
invece nello scritto Sulla
filosofia
e nella
Metafisica
su
bito dopo il 348. Si potr quindi dire, forse, che anche
nel Protreptico, come nei pi tardi dialoghi platonici,
l'Accademia,
esponendo letterariamente ilproprio lavoro
scientifico, non svela del tutto il vero stato delle discus
sioni esoteriche che inessa si venivano nello stesso tempo
compiendo. Tanto nelle ultime opere di Platone, quanto
nei primi scritti di Aristotele significativo come spesso
il massimo interesse risieda proprio in ci che non vi s
trova esplicitamente detto.
Tanto maggior valore ha quindi, accanto alla con
creta manifestazione dello spirito dell' Accademia data
")
Framm. 52 <p. 61, 13 R.).
s)
l'hileb. 15 A: cfr. Parm. 130 B segg.
il
protreptico: 125
da Platone nei suoi scritti, la professione
di fede del
rappresentante
della nuova generazione.
Possiamo infatti
apprendervi ci che per lui l'essenziale nel lavoro del
l'Accademia.
Quando
egli parla, in tono entusiastico, dei progresso
(7t($oais) della filosofia compiutosi in breve tempo sulla
via della scienza esatta, ci si sente trasportati diretta
mente nell' ambito della comunit scientifica dei pla
tonici. Nell'Accademia ri ha la sensazione di trovarsi
in un vivo moto d sviluppo, a petto
del quale il pro
gresso delle altre atti sembra piuttosto immobilit. Ari
stotele parla del ritmo celere di questo
movimento e
crede che la scienza sia prossima al raggiungimento della
sua perfezione. Tale sicurezza deriva dalla giusta co
scienza della propria energia creatrice e dell' eccezionale
favore dell' ambiente, che empie 1' animo di questa ge
nerazione. Non da dimostrazioni libresche, ma dal felice
senso di ima tanto elevata forma di vita nasce la sua
fede nella forza beatificante propria della vera attivit
scientifica: fede che, se mai in altri tempi, fu allora ef
fettiva verit. A chi la considera dall' esterno, essa pu
sembrare aspra fatica; ma chi l'ha gustata, esclama
Aristotele, non pu saziarsene mai J). l'unica forma
di attivit umana che non sia legata ad alcun tempo, ad
alcun luogo, ad alcuno strumento. Non ha bisogno di
esser confortata dal miraggio di una ricompensa este
riore. Chi la conquista, conquistato da lei, e non cono
sce nulla di pi bello che sederlesi accanto (rcpooe-
opea). In questo ambiente di ricercatori nato l'ideale
aristotelico di vita, il frectpijtttis o;: non nella movi
mentata palestra del Liside e del Carotide, ma nella
xaXjhfj del solitario giardino dell'Accademia. La sua tran
quillit ilvero modello su cui esemplata nel Protro-
') Framm. 52 (p. 62, 20 R.).
126 IL PERIODO ACCADEMICO
ptico V immagine delle isole dei beati, il paese di sogno
della solitudine filosofica 3). Iltipo di questo nuovo ideale
filosofico non pi Socrate: Pitagora, Anassagora, Par
menide sono quelli che il Protreptico chiama ora ar-
chegeti.
Su questo importante mutamento dobbiamo ancora
soffermarci un poco.
Ilproblema della distinzione del Socrate platonico da
quello storico sembra sia stato per la prima volta posto
gi in seno all' Accademia, in quanto veniva sempre pi
avvertito il distacco dall'ideale tipo socratico. Natural
mente, in questo primo tentativo di separare il contri
buto socratico da quello platonico, venne tolto al Socrate
storico quasi tutto ci che di filosofico gli era ascritto nei
dialoghi platonici.
Questa
tendenza radicale dette luogo
pi tardi a una reazione, e Aristotele giunse alla con
clusione che si dovessero giustamente lasciare a Socrate
due meriti: il metodo induttivo e le determinazioni dei
concetti universali2). In ogni modo la filosofia teoretica
del Protreptico non ha nulla di comune con Socrate.
Aristotele vi designa la metafisica, che ivi non ha ancora
il nome di itptirij (ptXoaotpfa, come speculazione del ge-
*) Fraaim. 58 (p.
68. 3; 69, 1
R.). Modello letterario Platone,
Gorg., 526 C; Resp., VII, 540 B. Iplatonici riferivano questi passi
all'esistenza nell'Accademia. L'immagine ripresa anche dalla Epin.,
992 B.
s) Melaph., M 4, 1078 b 27. Questa
prudente formulazione mi
sembra sempre pi dimostrata anche la meglio aderente alla realt
storica. H. Maier (Sofcrates, Tubinga, 1913, p. 77 segg.) ha
certo, e
con ragione, negato a Socrate ogni teoria logica del concetto uni
versale e dell'induzione: per troppo tempo infatti, in base al passo
aristotelico, si considerato Socrate come il primo teorico della
logica. Le parole di Aristotele non giustificano peraltro affatto una
simile concezione, giacch egli si limita ad indicare quali opera
zioni logiche fossero nel fatto eseguite da Socrate. Inoltre egli
Io considera soltanto dal suo punto di vista, e non intende allatto di
fornire una caratteristica complessiva di Socrate, ricercando in lui
soltanto, come in Democrito c nei Pitagorici, iprimi e pi elemen
tari tentativi di metodologia logica (cfr. 1078 b 20).
IL < PROTREPTICO 127
nere inaugurato da Anassagora e da Parmenide .
Quale
antico progenitore della filosofa platonica considerato
Pitagora 1). Ancora nel primo libro della
Metafisica
si
dice, del resto, che la dottrina di Platone sostanzial
mente di origine pitagorica, anche se essa vi abbia ag
giunto qualcosa di suo 2).
Questo
giudizio, che non
dev' essere stato letto senza qualche sorpresa, non nato
dall' intento di diminuire la figura di Platone, ma cor
risponde alla teoria ufficiale dell' Accademia, a cui Ari
stotele apparteneva ancora quando scriveva quelle pa
role, intorno all' anno
348/7.
Il Socrate platonico era
stato una creazione del suo plastico impeto creativo: il
culto pitagorico dell' Accademia, uno dei pi singolari
esempi di autosuggestione religiosa, era un rispecchia
mento dell'Accademia medesima e della sua metafisica
numerica nella quasi mitica personalit di Pitagora, esal
tato come fondatore del d-ewpyjtixs e presto consi
derato anche come autore delle stesse dottrine moderne
della cuoia.
Nella narrazione pitagorica del Protreptico, per poco
importante che essa sia, possiamo ancora osservare diret
tamente il processo di formazione di questa leggenda,
che doveva riuscir fatale per la tradizione della storia
dalla filosofia greca. Pitagora viene interrogato circa lo
scopo della vita umana. Risponde: contemplare l'uni
verso, (le stelle, la lunae ilsole) s). Interrogato di nuovo,
risponde designando se stesso come dedito a tale con
templazione (ifewps). Confrontiamo a questo racconto
la classica narrazione delle Tusculane di Cicerone circa
1' origine della parola filosofo, derivante d un compa-
')
Jambl., Protr., 51, 8; li;frumm. 52 (59, 4 R.).
') Melaph., A 6, 987 a 30.
*) Jambl., Protr., 51, 8. L'apoftegma anassagoreo a p. 51, 13
una variante.
128 IL PERIODO ACCADEMICO
gno di
gcuola
di Aristotele, Eraclidc Politico '). L' inter
rogato anche qui Pitagora, che si d il nome di filo
sofo, e per spiegare tale nuovo nome espone quel che
segue. Paragona la vita alle grandi feBte di Olimpia, dove
tutti convengono in folla brulicante. Gli uni vengono
per trattare iloro affari alla fiera annua e per divertirsi,
gli altri vogliono ottenere la vittoria nelle gare, altri
ancora sono solo spettatori di ci che avviene.
Questi
sono
ifilosofi, di cui scarso il numero. Nelle due prime
specie di uomini si riconoscono, quando si parta dal
Protreptico, i rappresentanti del pio? ttoXauatixi?
e
della Sovi,fj e della ciperi*). Hfilosofo vive solo
per la ftecapCa, per la pura cppvrjai;. Per quanto ade
guata e attraente sembri la narrazione, essa non tut
tavia n unitaria ne originale. Eraclide, il pi fervente
pitagorico fra iplatonici, evidentemente sotto l'in
fluenza del Protreptico. Egli trasferisce nella remota an
tichit la distinzione dei tre
Jifoc.
Il motivo sostanziale
del racconto nel duplice significato, che si presentava
spontaneo, della parola tempia. Il paragone della con
templazione filosofica dell' essere col sacro spettacolo fe
stivo di Olimpia si trova gi nel Protreptico, e in un
passo non lontano da quello che narra del colloquio
con Pitagora5). Entrambi questi elementi sono stati col
legati ed abbelliti da Eraclide in un piccolo racconto.
Il paragone, adoperato da Aristotele solo come mezzo
stilistico, viene ora ampliato in una comparazione dei
tre pot (giacch non tutti quelli che si recano ad Olim
pia sono O-ecopoQ e questa viene attribuita a Pitagora
stesso, ax{ icpa. Inrealt, il racconto presuppone icon
cetti fondamentali dell'etica e della metafisica del tardo
periodo platonico.
')
Ciecr., Tuscid., V, 3, 8.
') Jambl., Protr-, 53, IP.
IL PROTREPTICO 129
Infine, il Protreptico dev' essere anche valutato come
espressione del sentimento morale e religioso del gio
vane Aristotele. Sotto questo aspetto esso viene a inte
grare l'Eudemo, mostrando come dal punto di vista
della fede nell' aldil, sostenuta da Aristotele in quel
dialogo, si modifichi essenzialmente anche la posizione
da assumere rispetto all' aldiqu. In entrambi gli scritti
Aristotele imbevuto dello stesso pessimismo circa il
mondo terreno e ibeni e gl' interessi temporali. Ci or
dina di rifiutare, per spontanea decisione, ivalori della
vita per ottenere, in cambio, un bene pi alto e pi
puro. Se l'Eudemo, con la sua dottrina dell' anima e
dell' immortalit, prevalentemente speculativo, il Pro*
trcplico ci trasporta invece in un' atmosfera pi per
sonale.
Sull' esempio e sulla dottrina di Platone fondata
la sua convinzione che esistano pi alti, incorruttibili
valori, un pi reale mondo, a cui conduce la scienza
vera. Per ottenere un tal bene egli rinuncia a tutti i
beni apparenti, potenza, ricchezza e bellezza. Mai si
asserita con maggior dispregio la mancanza di valore
di ogni realt terrena. Per quella limpida serenit, ar
monia e gioia estetica, che fu l'ideale estetizzante attri
buito dal secolo decimottavo all'et classica, non tro
viamo qui se non 1' espressione del pi profondo tedio.
Esso non ha del resto mai veramente appartenuto al
l'essenza dello spirito greco. Se ci furono momenti in
cui, come nel quarto secolo, sembr che nella vita e
nell' arte vincesse l'ideale estetico, la conversione non
tard a seguire. Forza, bellezza e statura sono cose risi
bili, senza alcun valore . La bellezza del corpo nella sua
massima energia fisica aveva da lungo tempo perduto
ogni valore ideale quando furono scritte queste parole,
e I'arte, che era chiamata ad interpretarla, viveva solo
di un' illusione estetica, del vuoto culto della forma.
9. W. Jabqbb, AHstoteU,
130 II. PERIODO ACCADEMICO
Aristotele colpisce il punto pi vulnerabile della u
et quando nel Protreptico manomette il suo idolo, il
bell'Alcibiade, nel cui geniale e affascinante decaden
tismo essa, compiacendosi, riconosceva s stessa. Chi
avesse potuto con gli occhi di Linceo gettare
uno
sguardo nell' interno di questo ammiratissimo corpo,
avrebbe scorto un' immagine odiosa e ripugnante
1).
questo il linceo sguardo di un nuovo senso della vita,
che attraversa lo schermo materiale delle cose onde gli
uomini sono visibilmente circondati, e al di l di questa
quinta fittizia scopre il nuovo mondo di ci che fino
j
allora era rimasto invisibile, il inondo di Platone.
j
Per questa concezione, la perfezione di ogni imper- I
fettibilit della vita umana nel trascendente. La vita 1
divien la morte dell' anima, la morte crisi di transizione I
a una vita superiore. Letteralmente tratta dal Fedone . ,1
la sentenza che la vita del vero filosofo debba essere
J
una continua esercitazione alla morte2). Egli non trova
|
in essa nulla di grave e di fiero, giudicando piuttosto
|
condizione innaturale, e piena d' indicibili sofferenze per )
l'anima, la costrizione di questa nel carcere corporeo3). !
Ilparagone dei pirati etruschi dava a questa
concezione
ipi atroci
colori,
Ipirati, per torturare iloro prigio
nieri, li legano vivi ai cadaveri, viso contro viso. E la-
j
sciano che le loro vittime vengano a poco a poco meno,
') Framra. 59 ("0, 11R.: cfr. 70, 7 segg.).
!) Cfr. Diels in Archiv
f.
Gesch. d. Philosophie, I, p. 479.
5) Nel capitolo finale degli estratti dal Protreptico, che rie-
laborato da Giamblico (cfr. sopra p. 103), si trovano concetti del
Protreptico mescolati con clementi neoplatonici. Inconfondibilmente
autentico mi sembra il passo a p. 60, 10: SXX* ivTa50-a [lv 2l -t
nap cpoiv loco; Elva1. (?) t yivo
xa'-SItv fivMv6tv
ti
al oxossTv isti xal jj-Xcg (Sv) aioOivoito (?) 8i ti!jv -putav xal
tv zapi (puGiv ujv, v 8 note SuvyjO-fijisv otoO-ijvai zXiv 88-sv
XtjXtjftauev (l'Eiidemo.'), SijXov ; fjSiov xal p?ov a5t tiolsoiisv
Ilduplice itap tpoiv mostra che anche qui la fonte stata
maldestramente abbreviata.
il
protreptico
>
131
in quel tremendo nesso della vita con la corruzione mor
tale 2). La comparazione del giovane Aristotele insiste
sui dolori dell' esistenza dualistica dell' uomo, avvertiti
prima di lui da Platone e dagli Orfici, con una passio
nalit nervosa, che nonostante una- certa tendenza gio
vanile, chiaramente sensibile, a esagerare l'esperienza
pessimistica, tradisce un profondo sentimento personale.
un' idea del tutto insopportabile, anzi blasfema, quella
di voler vedere in questi simboli platonici solo una ma
schera stilizzata, dietro la quale si celi untemperamento
in realt pacifico, gioioso e giocoso. Dobbiamosenz'altro
dimenticarla. C' realmente stato un tempo in cui Ari
stotele ha sentito questo mondo ideale come ima parte
inseparabile della propria personalit. Egli ne approfon
disce ilineamenti con sempre nuove espressioni ed im
magini. Trae volentieri isuol termini dal linguaggio
dei misteri, perch pu comprendere e superare solo in
senso religioso le barriere dualistiche. Come sussurrano
le antiche dottrine dei misteri, tutta quanta la vita
umana non che espiazione di una grave pena, che
1' anima si attirata in una precedente esistenza.
E anche il problema morale strettamente connesso
con quello del ritorno soprasensibile dell' anima. Con
ci la morale perde il suo valore indipendente ed auto
nomo. Per quanto Aristotele rimanga lontano dal dissol
vere l'attiva vita morale in un momento unico di con
templazione mistica, e per quanto poco 0 suo metodo
conduca all'estasi, certo che egli subordina il mondo
della volont e dell' azione alla contemplazione del Lene
eterno.
D filosofo deve tenersi il pi lontano possibile dalla
dispersione della vita attiva. Il Protreptico esorta a non
*) Framm. 60 R.
132 IL PERIODO ACCADEMICO
immischiarsi troppo in faccende mortali e a non per
dersi nelle false strade dell'umanit. Tutto ci non Berve
che a rendere pi difficile il ritorno a Dio. L' unica cura
dev'esser quella di estinguersi una volta in pace, e di
ritornare, da questa dura prigionia, in patria. 0 vol
gersi alla verit e consacrarsi ad essa, o, meglio, rinum
ciare alla vita. Tutto ilresto vuota chiacchiera1).
') Framm. 61 (72, 20 R.). Con questi concetti e altri simili, da
lu attinti al Protrvptico, Cicerone termin ilsuo Ortensio: quindi
probabile che anche nell'originale essi appartenessero alla conclu
sione.
PARTE SECONDA
GLI ANNI DI VIAGGIO
I.
ARISTOTELE AD ASSO E IN MACEDONIA
La morte di Platone e la quasi contemporanea di
struzione di Stagira, compiuta dalle truppe devastatrici
di Filippo di Macedonia in guerra contro le citt com
merciali della Calcidica, privarono Aristotele, con un re
pentino colpo, della vecchia casa paterna e della se
conda patria: ch tale era ormai divenuta per lui la
famigliarit con Platone. Nessuna fase nella sua evolu
zione spirituale, per quanto rivolta nel senso di una
sempre maggiore indipendenza, aveva potuto separarlo
da Platone, per tutto il tempo della vita di questo. II
nesso che lo legava ai condiscepoli si sciolse invece ra
pidamente appena il maestro ebbe chiuso gli occhi per
sempre. Immediatamente dopo, ancora nello stesso anno,
Aristotele abbandon Atene e 1' ambiente degli amici,
sede di una ventennale comunanza di lavoro e delle pi
alte esperienze, per recarsi in Asia Minore*). Circa la
ragione interna di questa importante decisione, che forse
egli aveva gi presa prima della morte del maestro, non
ci stata tramandata alcuna notizia. Ci ha dato ori
gine alle
congetture pi disparate; e siccome Aristotele
') Apollod. presso Diog., V, 9 (cfr. V, 3, dove la cronologia
irrimediabilmente
confusa) ; Dionys. Hai., ep. ad Amm., 5.
136 GLI ANNI DI VIAGGIO
critica spesso
severamente, nei suoi scritti, le dottrine
platoniche, cos non fu difficile procacciar fede all' opi
nione che Aristotele si fosse staccato dal maestro e che
la sua partenza da Atene fosse tata la manifestazione di
questa
rottura. Si cercarono ragioni personali nel carat
tere di Aristotele. La sua maniera sarcastica, che del
resto cede il luogo all' espressione della massima reve
renza in tutti iluoghi in cui egli parla di Platone, urt
inervi a gente di sensibilit delicata: particolarmente
ingrato riusc poi il suo carattere a quei contemporanei
che nel suo prepotente intellettualismo e nel suo ineso
rabile rigore logico vedevano soltanto il segno di uno
spirito dissolvente. Gi lo stesso Aristotele si difende pi
volte dal sospetto che le sue critiche, obbiettivamente
fondate, dipendessero da ragioni personali. Posteriori
pettegolezzi scolastici lo accusano apertamente di odio
sit e d' ingratitudine. La tenace nebbia del sospetto mo
rale gravava gi nella tarda antichit sui motivi della
sua partenza, e ancora oggi, per quanto siamo diventati
pi scettici circa 1' etica delle consorterie intellettuali,
non superfluo dissiparla esplicitamente, tanto pi in
quanto quei motivi non sono mai stati veramente
chiariti *).
Un intelligente e colto studioso dell'et imperiale,
Aristocle di Messene, ha avuto la forza morale di strap
pare il velo della leggenda e di farla finita con le osti
nate ripetizioni dei compilatori, risalendo alle fonti pri
marie. Egli dimostr la pietosa miseria degli argomenti
'} Gi Io stesso Aristotele si difende da accuse provenienti
da scolari di Platone in Eth. Nic., A 4, 1096 a 11-16 e nel framm.
8 Rose. La tradizione circa le chiacchiere scolastiche fu indagata
criticamente da Ad. Stahr, Arislotelia (Halle 1830), I, p. 46 sgg.,
che attinse il suo materiale a Francesco Patrizio, Discussiones peri-
pateticae (Basilea 1581).
Questi, platonico della Rinascenza, era
accecalo dall'odio, e credeva infantilmente anche alle pi stolte
accuse contro Aristotele,
ARISTOTELE AD ASSO E IN MACEDONIA 137
sui quali si basavano le chiacchiere di scuola, e dob
biamo esser grati al caso che ci ha conservato proprio
il brano dell' indagine critica in cui egli, dopo aver
vittoriosamente distrutto quel consunto tessuto di bugie,
prova come le voci di un'apostasia di Aristotele da Pla
tone risalgano a un passo, miseramente frainteso, dello
scolaro di Aristotele Aristosseno di Taranto1). Secondo
ogni verosimiglianza1, Aristocle dev' essere stato anche
colui che, eliminati gl'imbrogli apocrifi, riport alla
luce il prezioso documento personale, che circa l'inte
riore atteggiamento di Aristotele rispetto al maestro
c'istruisce meglio che tutte le congetture nate dall'altrui
malignit; l'elegia dell'altare, da lui dedicata a Eu-
derao2). Se si fosse sempre tenuto presente
che questo
raro gioiello deve il suo ritorno alla luce solo a un de
siderio di critica documentazione biografica, e cio al
fatto che nella poesia doveva trovarsi un' aperta affer
mazione di Aristotele circa isuoi rapporti con Platone
e una sua presa di posizione rispetto agli odiosi critici
di tali rapporti, non si sarebbe certo mai avanzata l' idea,
psicologicamente inverosimilee inse contraddittoria, che
Aristotele, con la tanto entusiastica attestazione del suo
frammento, si riferisse a Socrate, da lui non mai visto'
in vita sua s). La dotta indagine circa irapporti di
Aristotele con Platone, alla quale itardi neoplatonici
attinsero la poesia, citava iversi solo nella misura incui
essi gettavano
luce immediata su questo problema. Chiaro
') Aristocle presso Euseb., Praep. ev., XV, 2,3.
3) Ci secondo la verosimile opinione di 0. Immisch fin
Phlologus, LXV, p. 11), dopo che gi lo Stahr (o. e-, I, p. fi])
aveva fatto risalire ad Aristocle le indicazioni della Vita di Am
monio circa irapporti di Aristotele con Platone, in base alle loro
consonanze verbali col frammento di Aristocle conservato in
Eusebio.
')
J. Bernays, Ges. Abhandl-, I, p. 143 sgg. Di parere contrario,
a ragione, 'Wilamowitz, Aristotclcs und Athen, li, p. 413 e di re
cente Immisch, 1. c,
138 GLI ANNI DI VIAGGIO
dunque che nell'elegia l'uomo che i cattivi non
hanno neanche il diritto di lodare non pu essere altri
che Platone, e che i cattivi, dalla lode dei quali Pla
tone sembra ad Aristotele inattingibile, non sono una
qualsiasi misera plebs, ma proprio quei falsi ammiratori,
che credono di dover difendere Platone dalla critica ob
biettiva di Aristotele '). Ma lasciamo ancora una volta
la parola ai versi medesimi:
X&bv
5'i?
xXsivbv KexpoTiiyjj BiteSov
eae(5o){ aejivfjg 3puaa-to jStojiov
vSp? Bv o' aivelv tote: xaxciot
oq fivog ) &V7]X<i>v xaxiEisv ivapy?
ohzCfi
te jSJfp xal |ie85oiai Xywv,
ti)? yas te xal E3ca|AU)v fipa ytverac vi)p.
o vv o'lexv Xastv oSsvl xaxa xot 2).
Non sappiamo chi sia stato il fondatore dell' altare,
di cui si parla in terza persona; e anche l'indicazione
che la poesia sia stata diretta a Eudemo non ci aiuta
a procedere innanzi, non potendo noi pi stabilire di
quale dei due Eudemo si trattasse, se di quello di Cipro
o di quello di Rodi. Del tutto illecito porre a punto
di partenza dell' interpretazione ci che le pi tarde >.!
terazioni neoplaloniche della Vita aristotelica preten-
') Soltanto cos la commozione sentimentale di quei non in
terpellati giudici acquista un significato concreto. Dato l'uso lin
guistico di Aristotele non si pu d'altronde trattare di una vuota
iperbole retorica; e pensare che si parli del cinico Diogene, avendo
questi parimenti professato l'autarchia dell'ipstrj, comunque
troppo forzalo. Inoltre questi poteva tutt'al pi richiamarsi a So
crate, e non a un teorico cos lontano da lui come Platone (ci
contro Gomperz, Griech. Dcnker, II, p. 539 e Immiscb, 1. c., p. 21).
!) Giunto all'illustre terra della citt di Cecrope, elev pia
mente un altare alla veneranda Amicizia, all'amicizia dell'uomo che
ai malvagi non lecito neppur lodare: colui che unico, primo,
tra 1 mortali svel chiaramente, con l'esempio proprio e con le
argomentazioni, la maniera in cui l'uomo riesce insieme buono e
felice. A tale altezza nessuno c ormai pi capace di giungere.
ARISTOTELE AD ASSO E IN MACEDONIA 139
dono di sapete circa l'iscrizione dell'altare: secondo esse
ilsuo fondatore sarebbe stato Aristotele.
Fortunatamente,
in base alle diverse rifrazioni della tradizione
biografica
scolastica che ci sono
rimaste, siamo in grado di seguire
in modo cos chiaro la progressiva formazione della leg
genda, da poter constatare anche come si sia venuta man
mano costituendo questa
sedicente iscrizione
dell'altare1).
In ogni modo, se non del tutto chiara la situa
zione esteriore descritta da Aristotele, tanto pi chiara
quella
interna, che poi la sola che importi. Ilprimo
verso parla di un uomo, certo uno scolaro di Platone,
che venuto ad Atene e vi ha fondato un altare. Che
egli fondasse un altare di Platone, e quindi rendesse a
questi onori divini, non riesco ad ammetterlo. Igenitivi
riferentisi a (3w[t, cio
e
vp?, possono sulle
prime confonderci; ma per un Greco era certo fuori
di discussione che il passo si dovesse intendere nel modo
seguente: egli fond un altare della veneranda
Philia, in
onore dell' amicizia dell' uomo, che icattivi non hanno
nemmeno il diritto di lodare1). L'attributo 0[avt)
mette
') LTmmsch
(1. c p.
12) considera autentica questa iscri
zione dell'aitare, per quanto nella Vita Marciana l'esametro fittizio
piopv 'ApioTotiXiis ISpoaxo xvde IUtiovcf sia ancora citato'
esattamente a s (p. 432 Rose) e subito dopo si dica : xal
iXXaxoS
ispl 8toS tptjoiv vpg Bv o8' atvstv xatoi xaxotoi
fljitg. l superficiale compilatore della cosiddetta Vita di Ammo
nio (p, 439 Rose) combin poi, senza pensarci troppo, questo pen
tametro dell'elegia con l'esametro: credette che vSp; fosse appo
sizione di EXdxiovog e che idue versi distintamente tramandati
fossero gli elementi di un distico. Inconcepibile infatti il pro
cesso inverso, cio che l'autore della Vita Marciana abbia scisso
in due versi il distico
tramandatogli come un tutto unico e scritto
che il pentametro si trovava altrove. In origine dev'essere stalo
citato tutto il frammento dell'elegia, essendo evidente che la no
tizia proviene da Aristocle (cfr. p. 137 nota 2).
') II Wlamowtz (o. e., p. 413 segg.)' riunisce Cpoa-ro Pojjav
4v8p<; (seil. IlXitiovog) e considera oey come genitivo
di causa o anche come oxfjpa 'lomxv, il che per gli sembra meno
conveniente. Nella semplice lingua prosastica, affermatasi nell'elegia
fin dal tempo di Evcno e di Crizia, entrambe le costruzioni sareb-
140 OLI ANNI DI VIAGCIO
fuor di dubbio cbe Philia fosse la dea a cui era intito
lato l'altare. Ma il secondo genitivo rende ugualmente
sicuro che questo altare dell'amicizia non doveva essere
sacro a una qualsiasi allegoria razionalistica, a un'astra
zione senza sangue e senza vita, ma bens all' uomo nella
cui persona e nelle cui opere la dea aveva manifestato
ai giovani la sua forza soccorritrice :*). "Una deificazione
della persona umana oltrepassa ilimiti di ci che pos
sibile per la religiosit platonica, e l'esempio dell' apo
teosi di Alessandro, Lisandro o Epicuro qui non giova.
Solo ci che ideale ha piena partecipazione al di
vino2). Un esempio di questo specifico sentimento reli
gioso platonico dato dall' aristotelico inno
ad Ermia
(v. sotto, p. 153). Anch' esso non si dirige alla
persona
umana del defunto n personifica il concetto astratto
della virt. Concepisce bens
questa come la forma di
vina {due volte usata la parola della virt vi
rile lottante pel sommo premio dell' esistenza, quale si
realizzata, agli occhi suoi e degli amici, nella vita e
nella morte di Ermia, e quindi come 'Apsr 'Epjifou. ,
Celebrata la dea immortale, non mai visibile dagli
uomini: ma
celebrata essa in onore dell'ultimo por-
bero apparse ricercate. L'Immisch, che avvertiva ci ma voleva
salvar l'idea dell'altare dedicato a Platone, modific il testo in
sosPscdv os[ivr/v piXirjv, il che semplicemente impossibile.
') Scritti ttspl tp'.Xtaj sono composti,
nell'Accademia, da Ari
stotele, Senocrate, Spcusippo e Filippo di Opunte: ne nasce, in
torno al vecchio Platone, un'intera letteratura. Certo, si trattano
accora,
per tradizione, S-iasij ipcoTixat: ma per questo ambiente
l'Eros non pi il simbolo unificatore. Proiettato sul piano
meta
fisico, esso sopravvive in Aristotele nell'amor dei, che muove il
mondo: xivst pt&psvov. Il neutro significativo per il cam-
biamento della situazione ideale.
') L'immagine del dio Platone, al quale il Wilamovitz (I.
C-,
p. 413 segg.) immagina dedicato l'altare, certo sentita entusiasti
camente, ma m realt estranea al
temperamento pio e austero
degli uomini dell'ambiente platonico.
Certo Aristotele colloca Pla
tone in una posizione
eccezionale tra gli ftvtjto( (v. 4);
tuttavia
egli resta sempre per lui la guida mortale verso l'ideale
divino.
ARISTOTELE Al ASSO E IN MACEDONIA 141
tutore
visibile, che essa ha trovato sulla terra. L' altare
recava, parimenti, solo ilnome di <HXas, maAristotele,
che interpreta qui l'iscrizione nello stile del pio
di un sacro oggetto di culto, la riferisce esattamente
alla
<lHX(a llXxtovoi;, N possiamo sentire la mancanza del
l'aggiunta
di un secondo nome, visto che per l'amicizia
ne occorrono due, giacche chi era, nel complesso dei Xoi
tale il nome che si davano gli accademici
l'indi
viduo singolo che avrebbe potuto pretender per s tale
posizione? Per tutti loro l'amicizia di Platone era sacra
come la forza, che nell'intimo teneva insieme la loro
comunit.
Ipredicati che nei versi finali vengono attribuiti, col
tono dell' inno, a Platone sono strettamente connessi
con l' idea della consacrazione all'Amicizia. Secondo il
concetto fondamentale della dottrina platonica dell'ami
cizia e della regola cenobitica dell'
Accademia, vero
amico solo l'uomo buono nella sua perfezione. Gli ul
timi versi esaltano quindi Platone come il mortale che
ha recalo in atto questa eccezionale idea. Lui solo, o
almeno lui per primo, ha infatti mostrato*) come l'uomo,
quando buono, sia lbero di fronte a qualsiasi
destino
e signore della sua vita. Non l'ha insegnato soltanto in
teoria, ma ne ha offerto agli amici il vivente esempio.
Nessuno sar pi capace di farlo cos vorrebbe scri
vere Aristotele, per trarre la coerente conseguenza del
brusco egli solo fra tutti imortali : ma chi pu pre
vedere l'avvenire e predire le possibilit degli uomini?
Perci egli limita il pvo? con l'aggiunta dell' ) np&xoc,
e l'otmoxe dell' ultimo verso col vv : per lo meno all'et
') Il vocabolo xatSsiSs
usato come se si
parlasse del Fon
datore di una dottrina religiosa o misterica: cfr. la mia ulteriore
analisi dell'elegia in The Classical Quarterly, XXI (1927), p. 13.
E ci costituisce la chiave di volta dell' interpretazione dell' intera
poesia: Platone, come fondatore di una religione, in essa solle
vato al di sopra di ogni ristretta antitesi di scuole filosofiche.
142 GLI ANNI DI VIAGGIO
presente impossibile di riuscire in ci eguale a lu1).
Nella contrapposizione della generazione presente al do
minatore, emergente di gran lunga sulla statura umana,
consiste la
rassegnazione tragica che trasforma la poe
sia commemorativa da semplice lode solenne,
in commo
vente confessione umana. Com' noto, l'etica di Aristo
tele nega il
principio platonico che la fortuna dell'uomo
dipenda solo dalla forza morale della sua anima 2). Espri
me anzi la sua riserva di fronte alle ripetizioni banali
di quella
sublime sentenza. Ma per Platone, che l'af
fermava, essa era piena verit. Chi sar il secondo, ca
pace di seguirlo per la sua erta via? Come nell' ultima
') Dal verso finale dipende l'intendimento di tutta la poesia.
Dal punto di vista del contenuto essa non offre difficolt,
sfuggito
agi' interpreti che ox Ioti Xagstv nei trattati di Aristotele
espressione fissa per l'irraggiungibilit
dell'ideale: in Pol., H,
1332 b 23 egli dice di un ideale .politico nsi S voB-r' o cj3iov
Xajslv, c in r,
1286 b 7 atpsttvepov fiv eli).... ctpioToxpatia jJaai-
Xag,. 5v
-fi XafJsiv
-Xeloug poCoog (incontrare
nella realt e
rispettivamente
tradurre in realt ). La difficolt linguistica
che
si e avvertita nella vicinanza di 06 note e vv deriva dalla con
cisione, che concentra in unit le due possibili espressioni non
mai o almeno non ora e pi a nessuno tra quelli d'adesso
(o&Ssvl tSv ys vBv). Aristotele scrive nella lingua sua propria, che
non tollera assolute regolamentazioni. Tutto quel clic gl' importa
l'esattezza della sfumatura intellettuale che mira ad esprimere, non
la politezza della dizione: anche l'i) ttpStog (v, 4), con la sua
nettezza distintiva, conviene pi a una lezione che a una elegia.
Il maestro ha indicato qual' l'ideale, ma noi, uomini del nostro
tempo, non possiamo giungere cos in alto: tale il significato
della
conclusione. La poesia slata quindi composta dopo la morte di
Platone, e diretta a Eudemo di Rodi. Il sentimento che l'agita
tuttavia troppo immediato perch esso possa appartenere al pi
tardo periodo dell' attivit aristotelica. Essa sembra nata da un
momento di viva agitazione e scissione interna. Se, come ritengo,
tanto Eudemo quanto Tcofrasto sono stati scolari di Aristotele gi
ad Asso, l'elega pu essere stata composta subito dopo la morte
di Platone, per l'impulso del suo animo a stabilire, con un'atte-
Btazione energicamente personale, la sua posizione
interiore ri
spetto al maestro proprio nel momento in cui egli
di fatto si
divideva da lui.
!) Il che stato giustamente rilevato dall' Immisch, 1. c, p. 27.
ARISTOTELE AD ASSO E IN MACEDONIA 143
scena del
Faust, qui rinauingible diviene realt con
creta, l'indescrivibile
un fatto compiuto x) :
Das
Unzulangliche
Hier wirds Eieignis,
Das Unbeschreibliche
Hier ists getan.
Con tutto ci, la partenza
di Aristotele da Atene fu
la manifestazione di una crisi interna della sua vita. Re
sta il fatto che egli non torn pi nella scuola che lo
aveva maternamente allevato.
Questo
distacco certa
mente connesso col problema della successione di Platone,
che doveva determinare per lungo tempo l'orientamento
spirituale dell'Accademia e la cui soluzione non poteva
essere innessun modo approvata
da Aristotele. La scelta,
sia stata essa operata dal maestro stesso o dai colleghi,
cadde ani nipote di Platone, Speusippo. Data la sua et,
ci non poteva essere evitato, per quanto la superiorit
di Aristotele potesse apparire indiscussa ad ogni intelli
gente. La decisione fu provocata
forse da circostanze este
riori, quale la difficolt del trapasso dell'Accademia a
un meteco: difficolt, certo, a cui pi tardi non si bad
invece pi. Con la scelta di Speusippo, la propriet fon
diaria dell'Accademia restava assicurata alla famiglia di
Platone. Se oltre a tali ragioni di convenienza esterna
fossro in giuoco anche ostilit personali, ormai im
possibile dire. Ins, cosa quasi naturale. Ma un fatto
si pu affermare con sicurezza: non fu la critica che
*) [D'accordo con lo Jaeger e con lo spirito della sua citazione,
attribuisco aiVVnziUangliche non il senso attivo, consueto
agl'in
terpreti del Faust, di ci che non giunge (insufficiente , indi-
gens), ma quello passivo di irraggiungibile (e cio quello stesso
dell'Unerrekkbare dallo Jaeger sostituito mnemonicamente, nel suo
testo, all'Unbeschreibliche del terzo verso), riservando a sede pi
opportuna 1 giustificazione di tale capovolgimento dell'interpre
tazione tradizionale. Nota del trad.].
144 CLI ANSI DI VIAGGIO
Aristotele esercit sulle concezioni fondamentali di Pla
tone quella che gli tolse di succedergli nella direzione
dell'Accademia. Lo stesso Speusippo aveva, vivo ancora
Platone, dichiarata insostenibile la dottrina delle idee e
rinunciato anche all'ammissione di numeri ideali, nel
senso in cui essa era stata compiuta dal vecchio Platone.
E da esso egli divergeva anche in altri punti fondamen
tali. Che poi Aristotele lasciasse Atene non proscritto,
ma anzi altamente stimato dalla sua scuola, dimostrato
dal fatto che fu accompagnato da Senocrate, bravissima
persona per quanto scrupolosa al massimo, tra tutti gli
scolari di Platone, contro ogni innovazione della sua
dottrina. La partenza di Aristotele e di Senocrate fu
una secessione1). Essi si recarono in Asia Minore per
suasi che Speusippo avesse ereditato soltanto la carica
e non lo spirito, e che essi muovessero alla costruzione
di una nuova dimora per quello spirito, rimasto senza
patria. Nei primi anni, sede della loro attivit fu Asso
sulla costa della Troade, dove essi si strinsero in comu
nanza di lavoro con due altri platonici, Erasto e Corisco
di Scepsi sull'Ida.
L'importanza di questo soggiorno finora rimasta in
compresa. Nella sesta lettera, la cui autenticit dopo
la decisiva dimostrazione del Brinckmann!) indiscussa,
Platone si rivolge a due suoi ex-scolari dell'Asia minore,
Erasto e Corisco, e al loro amico Ermia, signore di Atar-
neo. Egli esorta idue filosofi, che appaiono come per-
') Strab., XIII, 57 (p. 610).
'j Rhein. Mus., N. F., LXVI (I9II), p. 226 segg. i\"ella conce
zione degli eventi esterni concernenti Ermia coincidiamo quasi
dappertutto (cfr. la mia Entstchungsgeschchte der Metaphysik des
Arhtotcles, Berlino 1912, p. 34 segg.): il che ha per me lanto
maggiore importanza in quanto il punto di partenza del Brinck
mann era diverso e noi, procedendo indipendentemente, ci siamo
incontrati nello stesso punto. Ilmio libro uscito s nel 1912, ma
quando apparve la nota del Brinckmann era gi stato presentato
come dissertazione alla facolt filosofica di Berlino.
ARISTOTELE AD ASSO li IN MACEDONIA 145
sone onestissime ma senza esperienza pratica, ad assi
curarsi la protezione di Ermia; e a quest'ultimo segnala
l'importanza della loro sicura e costante amicizia. Sulla
singolare relazione dei due amici platonici col tiranno
di Atarneo getta luce una iscrizione edita per la prima
volta dal Boeckh1). Ermia e icompagni ('Eppiag xal oi
ixatpot riappare cinque volte, come formula fissa, nel
documento) vi concludono un trattato di alleanza col
comune di Eritre. Il commentario di Didimo alle Filip
piche di Demostene, ritrovato di recente,
non lascia dub
bi circa l'identit dei compagni, i quali appaiono
j
nel trattato insieme con Ermia come contraenti di di-
\ ritto pubblico, coi due filosofi della vicina Scepsi, se
condo quanto faceva gi prevedere la lettera di Platone.
Ermia era uomo di modesta origine.
Quanto
alla sua
'I condizione di eunuco, non ci sono elementi per negarla;
e anche la notizia che in tempi anteriori eia stato, come
impiegato di banca, cambiavalute (notizia data da Teo-
pompo, che presenta la sua figura nel modo pi odioso
possibile) avr certo un fondo di verit8). Da principio
egli aveva ridotti in suo privato possesso alcuni villaggi
montani nella regione dell' Idai ") : pi tardi si era pro
curato ilriconoscimento esteriore anche dal governo per
siano ed aveva ottenuto la facolt, certo dietro versa-
, ') Boeckh, Hermius von Atarneits, in Abh. d. Beri. Akademie,
;j 1853, Hist. phil. Klasse, p. 133 segg. ( Klcine Schriften, V, p. 189).
*
Per l'iscrizione v.
Dittenbcrger, Sylloge, Is, p. 307.
s) Certamente era greco, altrimenti Aristotele non avrebbe
| potuto contrapporlo nell'inno, come continuatore di una tradizione
; schiettamente ellenica di virt, ai barbari che lo avevano insidio-
) samente ucciso (cfr. l'epigramma, framm. 674 R-).
Quando Teo-
pompo dice, nella lettera a Filippo (Didym., in Demosth., col. 5,
! 24 Diels-Schub.): xal gpiSapog piv pex viflv Ulatovslov
j cpikoaoips, 8oOXo{ 84 -[-eviytevog li xatg itavi)-
yOpsaiv almeno la prima delle due affrmazioni
inventata per amor dell'antitesi retorica, o si riferisce alla sua
''
condizione di eunuco.
') Didym., in Demosth., col. 5,27 D.-Schub.
10.
W. Jaeger, Aristotele,
146 CM ANNI DI VI ACCIO
mento di una congrua somma, di attribuirsi iltitolo prin- I
cipesco. Sua residenza era Atarneo. Merc il costante ac-
|'j
crescimento della sua influenza politica, il suo dominio p
raggiunse un'estensione sorprendente. Da ultimo egli do* :
vette persino organizzare un esercito mercenario abba
stanza grande, perch pot ridurre all'obbedienza, con
spedizioni militari, localit ribelli e pi tardi sostenere
anche un assedio da parte del satrapo persiano.
;
Con Erasto e Corisco, che avevano vissuto parecchio
tempo nell'Accademia e poi erano tornati nella patria
i
Scepsi, Ermia entr da principio in relazione certo non
per entusiasmo teoretico verso la filosofia platonica. Essi
devono avere esercitato una certa funzione politica nel
piccolo paese, evidentemente superbo dei suoi due dotti
cittadini. Che piccole citt greche si facessero scrivere le
leggi da cittadini divenuti famosi non era cosa incon- ;
sueta, come dimostrato dal caso del matematico Eu-
dosso, altamente onorato nella patria Cnido, ove torn
quand'era gi in fama di gran dotto. Gli fu votato un
decreto d'onore ed affidato l'incarico di scrivere nuove
leggi per la citt1). Certamente Erasto e Corisco cerca
rono di attuare a Scepsi le pi diverse idee di riforma
politica, importate dall'Accademia, cos come altri sco
lari di Platone fecero in altri luoghi, gli uni come con
siglieri dei principi o come dittatori, gli altri come co
munisti e uccisori di tiranni. Pur riconoscendo piena
mente l'intento ideale dei due compagni, Platone deve
aver temuto il loro dottrinarismo, e cerca quindi di sta
bilire rapporti di amicizia tra essi e il loro vicino
Ermia. La lettera superstite il solenne documento di
questa singolare alleanza tra politica pratica e teoretici
ideali di riforma. Platone, il cui spirito aleggia su que
sta costituzione di alleanza, esorta itre
tra iquali
') Diog. L., VITI, 88.
ARISTOTELE AD ASSO E IN MACEDONIA 147
Ermia, che non gli noto personalmente1) appare uomo
pratico del tutto estraneo alla filosofia
a leggere in
sieme la lettera tutte le volte che si trovino riuniti, e
per il resto a rivolgersi all' Accademia, ad Atene, come
ad arbitra prestabilita in ogni caso di disparit di pa
reri. Il tentativo di riforma appare quindi emanazione
di un sistema filosofico-politico, che evidentemente de
v'essere recato in atto in ogni parte della Grecia in cui
se ne offra l'opportunit, e del quale l'Accademia vuol
conservare la direzione suprema.
Naturalmente, quando fondarono questa oligarchia di
sapienti, ifilosofi pretesero da Ermia che studiasse geo
metrica e dialettica 2), come gi Platone aveva preteso da
Dionisio, il suo scolaro Eufreo dal re Perdicca di Mace
donia e Aristotele da Temisone di Cipro. Eanche Ermia,
al pari di questi uomini, che un'et illuminata e operosa
ma intimamente vacillante rendeva assetati di cultura,
nutr con crescente zelo il suo spirito di scienza e, ci
che pi conta, regol la sua vita su prncipi morali, che
Teopompo invece dice, forse non senza ogni ragione,
estranei a lui nei tempi delle sue prime fortune. Igiu
dizi antitetici dello storico di Chio, che lo dichiara del
tutto privo di scrupoli morali, e dei platonici, la cui
sincera ammirazione si riflette in Aristotele e in Calli-
stene 2), fanno pensare che egli fosse una natura non co-
') Cfr. Plat., epist. VI, 322 E, mentre Stratone, XIII, 57 (p. 610)
considera falsamente Ermia come filosofo ed ex-discepolo di Pia-
Ione, per spiegare le sue relazioni coli'Accademia. inconcepibile
come in altri tempi si sia ritenuta spuria la lettera di Platone pro
prio per questa discordanza, mentre il racconto di Stratone , an
che per altri rispetti, colmo di inesattezze (Brinckmann, 1,
c.,
r>. 228). Contro il Rrinchmann cfr., ancora, C. Rilter, in Pkilolog.
Wochensckrift, 1029, coli. 1340-42. Egli cerca di salvare la tesi del
soggiorno di Ermia ad Alone allegando passi delle lettere dei so
cratici: ma queste non possono valere come fonti storiche sicure.
!)
Plat., epist. VI, 322 D.
s) Cfr. la contrapposizione dei giudizi favorevoli e ostili in
Didimo, col. 4,60 segg., ohe mette insieme, uno dopo l'altro, estratti
143 GLI ANNI DI VIAGGIO
mune, una mescolanza (l'intelligenza instinliva, energia
intraprendente e volont impetuosa, e racchiudesse nel
suo intimo molti inconciliati contrasti. In ogni modo i
due filosofi d Scepsi non gli giovarono soltanto per la sa
lute dell'anima: secondo quanto ora sappiamo da Didi
mo, egli li onor con la donazione della citt di Asso,
perch gli avevano dato giusti consigli politici. Seguendo
questi, egli aveva spontaneamente
trasformato la sua ti
rannide in una pi mite forma costituzionale .
Questo
gesto, che gli procur simpatie tra le popolazioni delle
coste eoliche, ebbe per conseguenza che iterritori dal
gruppo montuoso dell'Ida fino alla costa di Asso si sot
tomisero spontaneamente a lui. In questa pi mite
forma di governo possiamo riconoscere iconcetti di
Platone e di Dione, persuasi che l'adozione di un regime
costituzionale avrebbe consolidato la tirannide a Sira
cusa e poi unificato, dal punto di vista della politica
estera, le citt della Sicilia sotto ilsuo energico governo
monarchico. In piccole proporzioni, riusc in Asia Mi
nore quel programma politico7) che non era stato pos
sibile recare in atto in Sicilia.
dal libro XLVI delle Storie Filippiche e dalla lettera a Filippo di
Teopompo, dall' Encomio di Ermia di Callistene, dalle poesie di
Aristotele dirette ad Ermia, dalla biografia aristotelica di Ermippo
e dal libro VI delle Storia Filippiche di Anassimene.
') Didym., col. 5,52 D.-Schub. Sul principio ho aggiunto, a
titolo d'esempio, alcune integrazioni.
xal s]ij [ttjv tc] pcg I-
OTpatijYttlce, tplXouj 6' jtaiiJao.io Koptaxov] -/.al "E-
pactOY xal Apiotot[sXy;v xal SsvoxpGtrqy]* Sii xal
ttvt[s o5]toi xap ('Epiij Sifov....] ots-
pov.. [....] ijxoFoosv aTtv....]. ISlUXSY
aflx[ots S]iops|g.)..[ ..... 8 t-qi
tupav[vi8]a stj itpaiojtipav 8o-
vocrcslav' 816 xal 7i3[r|; Tijg av]e[YY]uS 4ttfjp-
Jtv
tuig 'A-oo, 8rs (5r) xal SjispyjcjUsl? toO? et-
p7][ivaip cp'.Xoaicpo'.j [itlvst|iv] tyjy 'Aoairnv
tiXiv, jiXioxa S" a&x[iov xo5eS]4jisvs; "Api-
ototXijv olxsitaxa [SisxeiTO tip]ig toOtov.
ARISTOTELE AD ASSO E IN MACEDONIA 149
Le riforme di Erasto e di Corisco devono essere state
precedenti alla morte di Platone, perch Aristotele, nel
347, li va a raggiungere ad Asso e non a Scepsi. La do
nazione di Ermia era quindi allora un fatto compiuto.
Didimo riferisce esplicitamente la notizia, prima igno
rata, che Ermia abbia ascoltato l'insegnamento dei filo
sofi e vissuto a lungo insieme con loro. E di fatto Platone
non avrebbe potuto parlare, nella VI lettera,
di problemi
cos Btrettamente scientifici come la dottrina delle idee
(322 D), se non avesse saputo che tutti e tre idestina
tari s'interessavano ad essa. L'espressione di Didimo co
stringe a pensare che non si trattasse soltanto di colloqui
filosofici occasionali ma di effettive lezioni. A queste
sembra che Aristotele prendesse parte eminente, perch
Ermia gli si sent particolarmente obbligato: del resto
era anche naturale che inquella cerchia la direzione toc
casse a lui. Fu quindi una filiazione dell'Accademia pla
tonica quella che si form allora ad Asso. Con essa venne
posta la prima pietra della futura scuola aristotelica.
E cos si vede, ora, come un germe di verit storica sia
implicito anche nella narrazione contenuta nel dialogo
Sul sonno del peripatetico Clearco, alla quale si richia
ma Giuseppe Ebreo nel suo scritto polemico contro
Apione (176 segg.). In questo dialogo Aristotele, che
Clearco introduceva come interlocutore, raccontava di
un ebreo, greco d'idioma, che si era recato da lui, per
studiare, duraute il suo soggiorno in Asia Minore, e ri
cordava a questo proposito il gruppo di compagni di
studio, in seno al quale tutto ci si era svolto. Clearco
dunque deve aver avuto ancora nozione almeno dell'esi
stenza di una scuola di Aristotele in Asia Minore, qua-
l'era quella che effettivamente vi si era formata.
Solo qui Callistene pu essersi giovato dell'insegna
mento di suo zio, perch in Atene egli non fu piad
ascoltarlo. Oltre a ci dobbiamo presupporre che egli
150 GLI ANNI DI VIAGGIO
conoscesse personalmente Ermia, avendo scritto per lui
un encomio. In seguito, il figlio di Corisco, Neleo, fu
uno dei pi ferventi e segnalati aristotelici, e Teofrasto
proveniva da una citt finitima, Ereso di Lesbo. Verosi
mile infatti che Aristotele, quando dopo tre anni di
soggiorno lasci Asso, fosse spinto proprio da Teofrasto
a scegliersi come dimora Mtilene a Lesbo*). Com' noto,
la biblioteca di Aristotele e il complesso dei suoi mano
scritti pass poi in eredit, attraverso Teofrasto, a Neleo,
che li lasci ai suoi parenti di Scepsi. La stretta familia
rit scolastica e filosofica di Aristotele con gli amici di
Scepsi e di Asso toglie quindi, finalmente, ogni carattere
romanzesco alla storia, spesso sospettata, del ritrovamento
dei suoi manoscritti nella cantina della casa posseduta
')
Che Teofrasto si trovasse gi inMacedonia insieme con Ari
stotele dimostrato dalla sua conoscenza personale di Stagira e
dai beni che vi possedeva (Diog. L, V, 52; Hist, plant.. Ili,11, 1;
IV, 15, 3).TaIe possesso dev' essere stato acquistato per un sog
giorno di una certa lunghezza: ma questo pu riferirsi soltanto
all'et precedente alla fondazione della scuola ad Atene (335), et
nella quale Aristotele, insieme con la ristretta cerchia degli amici
che lo avevano accompagnato in Macedonia, viveva spesso, e per
periodi abbastanza lunghi di tempo, lontano dalla corte, special
mente negli ultimi anni precedenti la salita al trono di Alessandro,
quando questi prendeva gi parte agli affari dello stato. Di con
seguenza irapporti di Teofrasto con Aristotele risalgono fino al
l'et in cui questi era in Asia Minore, donde egli accompagn
il maestro in Macedonia. Non anzi neppure impossibile che Teo
frasto sia stato anche scolaro di Platone e abbia poi seguito Aristo
tele nella sua secessione (Diogene Laerzio, V, 36), cio nel suo
abbandono di Atene. Ci tuttavia non molto verosimile. Teo
frasto mor nell'Olimpiade 123: se anche si pone la data di morte
ne! primo sreno dell' Olimpiade (283) e si ammette che avesse
vent' anni quando, nel 348-7, s rec da Aristotele ad Asso, si ot
tiene gi un et di ottant'anni, aumentabili ancora di altri quattro.
Un lungo periodo di discepolato presso Platone pu quindi dif
ficilmente essere ammesso. Assai pi naturale che l'attivit didat
tica di Aristotele e degli altri accademici ad Asso attirasse Teo
frasto dalla vicina Lesbo. Anche la sua amicizia con Callistene, a
cui egli dedic, dopo la sua morte, uno scritto KaXXiaS-ivijj f, nspt
itiv&oug (Diog. L-, V,
44) risale all'et precedente la fondazione
della scuola in Atene, perch Callistene and nel 334 in Asia in
sieme con Alessandro e non torn pi.
ARISTOTELE AD ASSO E IN MACEDONIA 151
dai discendenti di Neleo11). El'uso frequente del nome di
Corisco, come esempio scolastico, nelle lezioni aristote
liche risale, come ora chiaro, a un' et in cui l'amico
sedeva realmente di fronte a lui, ad Asso, sui banchi
dell'aula. Le esperienze di questo soggiorno in Asia Mi
nore furono sotto ogni aspetto decisive per il seguito
della vita di Aristotele. Ermia gli diede in moglie la ni
pote e figlia adottiva Pizia. Circa questo matrimonio, da
cui nacque una figlia dello stesso nome della madre, non
sappiamo nulla di preciso. Ancora nel suo testamento
Aristotele stabilisce che le ossa della moglie, morta prima
di lui, debbano essere, secondo T ultima volont di lei,
tumulate accanto alle sue. Anche qui il racconto di Stra-
bone tratteggiato con colori romanzeschi, con la narra
zione sensazionale di una fuga di Aristotele insieme con
la figlia del tiranno, cronologicamente collocata dopo la
cattura di Ermia. La scoperta del testo di Didimoha cor
retto e ampliato anche qui lenostre conoscenze. Dopo tre
anni di attivit ad Asso, Aristotele si rec a Mitilene.
Ivi insegn fino al 343/2, poi ader all'invito di recarsi
alla corte del re Filippo di Macedonia come precettore
del principe2).
Poco dopo l'inizio di questa sua nuova attivit gli
giunse la notizia della tremenda sorte di Ermia, che, chiu
so in Atameo ed invano assediato da Mentore, generale
')
Strab., XIII 54 (p. 608).
*) Cfr. la mia Entstekungsgeschickle der Melaphysik des Ari
stotele:, p. 35. Per 1' erronea opinione opposta v. p. es. A. Gercke
in
Realenzykl. d. kloss. Alt., II, col. 1014, che considera la rovina
di Ermia come occasione della fuga di Aristotele, e la fa risa
lire di conseguenza al 345, essendo certo che Aristotele rimase ad
Asso solo tre anni (3-18-345). Il nuovo testo di Didimo ha mostrato
che Aristotele lasci Asso quand'era ancor vivo Ermia, la cui fine
accadde solo intorno al 341. La congettura, avanzata da alcuni (tra
cui ilGercfce, 1. e.), di un breve soggiorno intermedio di Aristotele
ad Atene, dove avrebbe insegnato nel Liceo, deriva da un teme
rario fraintendimento di Isocrate, XII,
18,
152 GLI ANNI DI V1ACCI0
del re persiano, era stato perfidamente attratto a un col
loquio e trascinato a Susa dove, messo alla tortura e in- ;
terrogato circa isuoi segreti accordi col re Filippo, era
stato, dopo tenace silenzio, messo a morte per crocifis
sione. Sul patibolo ilre gli fece domandare quale ultimi
grazia chiedesse. Ripose: Annunciate ai miei amici e !.
compagni (npbs
tos
ptXoug xe xal xaJpouc) che non ho
compiuto nulla che non convenisse alla filosofia e alla
dignit .
Questo
fu l'ultimo saluto, che fu recato ad Ari
stotele ed ai filosofi di Asso*). La commozione di Aristo
tele per la morte dell'amico e ilsuo affetto per lui vivono t
ancora nel cenotafio delfico, per cui egli stesso compose
l'epigramma dedicatorio, e nel bell'inno ad Ermia. Men-
tre in Atene il partito nazionale, con a capo Demostene,
diceva male del defunto, mentre l'opinione pubblica circa
'
di lui era in Grecia ambigua e l'avversione a Filippo e
ai suoi partigiani raggiungeva intutto ilpaese ilpi alto
punto di tensione, Aristotele mandava pel mondo la sua
poesia, in cui prendeva appassionatamente le parti del- ).
l'amico ucciso. 7
'Apei yvs: j3po-up,
Wjpapa xXXtcxov j3ui),
oS( rtpt, ttapSivs, popep?
xal fravelv rjXuxs 'EXXaSi rtxpos
xal
7rvou5 xXf/vat
paXEpo? xpavxaj*
xolov rti eppva
flXXa?
xaprtv laaO-vaxov puao 11xpsfaat0
xal yovcov paXaxauyiot
{POrtvou.
ao
8'Ivex'
Sx Al-
'HpaxXsrjs Ai)8a? xs
xoOpoi
rtXX' dvxXacav Ipyoi?
av
&Y.C'JvtsS
Svajicv'
aots
8
rtS-oi? 'AxtXss Ala?
1'
'A(8a
Spov fjXfroV
aag S'Ivexsv cpiXCoo popcp? xal 'Axapvo; Ivxpocpo?
')
Didym., col. 6, 15.
ARISTOTELE AD ASSO E IN MACEDONIA 153
deXlou xi7fJtl)CTev a&YS'
xolfxp o(8i[io? Ipyoi?,
frivaxv xs piv aScouai Moaat,
Mvaooijvas liyaxps?,
Atg
evfou
aaj aOijouaat tptXfa? xe ypaq pejJatou ')
Per lo pi, questa poesia stata considerata solo come
documento umano, e non ancora valutata nell'insosti
tuibile valore che possiede per la conoscenza dell'evolu
zione filosofica di Aristotele. Essa dimostra come, dopo la
dissoluzione critica dell'idea platonica, compiuta nel frat
tempo, pensiero esatto e sentimento religioso procedano
inlui per vie diverse. Al tempo incui scrive questi versi,
l'idea non esiste pi per lui come realt, dal punto di
vista scientifico, ma sopravvive nel suo cuore come sim
bolo religioso, come ideale. Intende le opere di Platone
come poesia, e nella
Metafisica
interpreta l'idea e la par
tecipazione del mondo sensibile al suo essere come im
magine poetica che si crea la fantasia contemplante: e
cos essa gli riappare nei suoi versi trasfigurata nella per
sona virginea, per la quale ancora oggi in Eliade pre
zioso morire. Le parole in Eliade hanno un partico
lare valore, che non deve sfuggire. Anche Callistene, nel
suo contemporaneo encomio ad Ermia, contrappone nel
l'immagine della sua morte eroica la greca 'Apexal ca-
s) e Virt, al genere umano ricca fonte di travagli, preda bel
lissima della vita! per la1 tua bellezza, 0 vergine, anche morire
nell'Eliade invidiabile sorte, e sopportare duri incessanti sforzi:
tale il premio che tu infondi nell'animo-, pari all'immortalit e
superiore all'oro, alla nobilt e al sonno che ammollisce Io sguardo.
Per te Eracle, il nato di Zeus, e ifigli di Leda molto sostennero
nelle loro gesta, perseguendo la tua potenza; per brama di te
Achille e Aiace giunsero alla casa di Ade; per la tua cara bel
lezza anche il cittadino di Atarneo priv isuoi sguardi della vista
del sole. dunque degno di esser celebrato per le sue imprese:
e immortale lo canteranno le Muse, figlie di Mnemosine, accre
scendo la veneranda gloria di Zeus ospitale e l'onore della salda
amicizia,
15i OLI ANNI DI VIAGCIO
ratiere dei barbari (& twv (3ap(Spti>v Tpitto?) l), e l'epi
gramma dedicatorio di Aristotele a Delfi spira dispregio e
odio contro iMedi , cbe non hanno vinto Ermia in
aperta battaglia, ma hanno perfidamente mancato alla
loro parola e l'hanno orribilmente ucciso. Se d'altronde
Ermia viene annoverato accanto a Eracle e ai Dioscuri,
ad Achille e ad Aiace, non si tratta di movenze stilistiche
nella maniera del panegirico. Aristotele non intende di
decorare l'amico con l'apparato patetico dell'eroe ome
rico. Ogni eroismo ellenico, da quello ingenuo di Omero
a quello morale del filosofo, gli appare come l'emana
zione di un unico programma di vita, che attinge iver
tici dell'esistenza solo quando la supera. In questa virt !
platonica, sia essa l'onore virile del combattente o la
tacita resistenza al dolore, egli trova l'anima della forza
greca, 1' eroismo. Di
queste idee egli ha empito il cuore
del protervo Alessandro, che in mezzo a un secolo illu
minato ha sentito a lungo in s l'anima di Achille e ha
combattuto come Achille. Alla stessa antitesi si riferisce
1' artista figurativo che sul sarcofago di Alessandro ha
rappresentato la battaglia decisiva degli Elleni e degli
1
Asiatici: nel volto degli Orientali le profonde tracce '(,}
della sofferenza fisica e psichica, nelle figure dei Greci
l'invitta energia atavica, corporea e spirituale, degli eroi.
La disposizione
antipersiana di Aristotele e del suo
ambiente era allora in generale quella della corte ma
cedone. Dalla quarta filippica di Demostene, ora riabi
litata dall'attestazione di Didimo, sappiamo con certezza
che gi intorno al
342/1
Filippo meditava seriamente il
piauo di preparare la guerra nazionale contro il nemico
ereditario di Persia, alla quale da lungo tempo incitava
la
propaganda panellenica della cerchia isocratea. Senza
questa guerra non c' era giustificazione legittima del do*
') Didym., col. 6,10-13,
ARISTOTELE AD ASSO E IN MACEDONIA 155
minio, fondalo sulla pura forza, del re macedone sulle
libere citt elleniche. Attraverso isuoi agenti segreti,
Demostene sapeva che Ermia aveva preso con Filippo
accordi iquali aggravavano
molto la sua situazione nei
riguardi della Persia. Con questa
convenzione militare
era aperta la via per un'offensiva macedone contro la
Persia. Politico lungimirante, Ermia sapeva: e perci
provvide cos tempestivamente
a farsi garantire da Fi
lippo la posizione faticosamente conquistata nella re
gione nord-occidentale dell' Asia Minore. Riteneva ine
vitabile 1' avanzata della potenza
militare macedone con
tro l' impero persiano e cercava di salvare la propria
indipendenza cedendo a Filippo la testa di ponte asia
tica e assicurandogli nell'Eolia una forte base di ope
razioni. Non sappiamo da chi iPersiani venissero in
formati di questi progetti: comunque, catturato Ermia
dal generale persiano, Demostene esulta prevedendo che
il re di Persia possa con la tortura strappare ad Ermia
confessioni le quali illuminino bruscamente ilcomplotto
di Filippo e rendano matura la Persia per 1' alleanza
con Atene da lungo tempo invano da lui propugnata1).
Sembra escluso che Aristotele non abbia saputo nulla
degl' importanti accordi politici del suo amico e suo
cero con Filippo, alla corte del quale soggiornava. Nel
342 egli si trasferi a Pella, nel 341 ebbe luogo la rovina
di Ermia. Se gli accordi segreti venissero conclusi du
rante quell' anno o sussistessero gi quando Aristotele
arriv in Macedonia, non ci noto: per verosimile
che essi non siano rimasti celati lungo tempo e che
quindi non siano stati conclusi molto prima della cata
strofe. In ogni modo Aristotele si rec a Pella d'accordo
con Ermia e non senza una missione di carattere poli-
!) Dem., or., X, 31; e cfr. gli scoli ad locum, riferenti ad Ermia
le misteriose allusioni della quarta filippica e in ci confermati
dal Commentario di Didimo.
156 GLI ANNI DI VIAGGIO
tico. La versione tradizionale e dominante rappresenta
le cose come se il re Filippo si fosse guardato attorno, j
nel mondo, per trovare un educatore per il suo gran
figlio, e si fosse perci rivolto al maggior filosofo dei
suoi tempi. Ma quando Aristotele faceva lezione ad Asso
e a Mitilene non era ancora il capo spirituale della Gre
cia, e Alessandro non aveva ancora alcuna importanza
storica. Le antiche relazioni che Aristotele aveva con la
corte macedone a causa della funzione del padre Nico-
maco come medico personale del re Aminta, non pos-
\ ]
sono avere maggior valore per spiegare la sua scelta,
perch da quel tempo erano ormai trascorsi quarant' an- ;
ni. Ogni circostanza indica nella relazione di Ermia con
Filippo 1' effettiva causa occasionale delle relazioni, poi ]
assurte a significato simbolico dal punto di vista della
storia universale, del pensatore col gran re. La semplice
carica di
precettore non rispondeva al suo virile carat
tere, e d' altra parte non e' erano troppe prospettive, ini
zialmente, di potere esercitare in Macedonia una fun
zione come quella di Platone alla corte di Dionisio o y
di Aristotele stesso presso il suo amico tiranno di Atar* }
neo.
Qui
acquista importanza il fatto che l'analisi della
'
Politica aristotelica ci mostra ilgraduale
trapasso del suo
pensiero politico dalla sfera del radicalismo etico e della
speculazione platonica circa lostato ideale a quella della
politica realisticamente concepita, e rende verosimile che
questa trasformazione si sia compiuta essenzialmente
sotto V influsso di un esperto uomo d stato come Ermia.
Aristotele non ha presentato agli occhi di Alessandro
l' ideale immagine platonica dello stato-citt, a cui pur
tengono fede le parti pi antiche della sua Politica e
che serb importanza anche pi tardi, quando egli tenue
ad Atene corsi di poltica, per le citt greche
rimaste;
formalmente autonome. Egli era consapevole
e che si
assumesse
questo compito caratterizza la sua personalit
ARISTOTELE AD ASSO E IN MACEDONIA 157
meglio che ogni dottrina politica di dirigere sulle
vie del suo pensiero l'erede della maggior potenza greca,
del pi forte regno europeo del tempo, e di agire insie
me come intermediario diplomatico tra Filippo ed Er
mia. Con la morte di Ermia tutto assunse un orienta
mento inaspettato: ma la tendenza antipersiana della
coalizione con ci andata in fumo divent per Aristotele
una questione di sentimento, e Alessandro crebbe in
tale atmosfera.
Per Aristotele era un articolo di fede che l'Eliade
avrebbe potuto dominare il mondo se avesse avuto unit
statale. Come filosofo, riconosceva l'egemonia culturale
della grecit, che penetrava
nelle popolazioni finitime
con mirabile capacit di espansione, dovunque dirigesse
il suo corso. Nessun altro popolo era spiritualmente al
l'altezza del tipo, compatto ed armonico, del cittadino
greco, che riusciva vittorioso, al confronto, tanto sul
piano economico quanto su quello militare anche sol
tanto per la sua superiorit tecnica e per la sua indipen
denza personale. D'altra parte, ilfilosofo nato nella Cal-
cidica non poteva sentire con la passione liberale, radi
cata nella tradizione storica, del democratico attico gli
ostacoli clie ilegami tradizionali della vita politica nel-
1' autonomo stato-citt opponevano dall' interno ad ogni
organica unificazione dei Greci. Figlio di una famiglia
che viveva alla corte
macedone, gli riusci facile di af
fezionarsi all'idea dell' unificazione della Grecia sotto la
direzione della Macedonia. L'antinomia tra la monar
chia agricolo-patriarcale e la libert civico-democratica,
che sarebbe sempre sopravvissuta in tale labile forma
di stato e che di necessit avrebbe cooperato
alla sua
interiore scissione, poteva essere superata
solo dalla per
sonalit eminente di un vero re, nella cui figura tutta
la civilt ellenica potesse vedersi impersonata. Aristotele
sapeva che un uomo simile un dono degli Dei. Non
158 CU ANNI ni VIACCIO
era
seguace ad ogni patto del principio monarchico: con
forme, del resto, alla natura del pensiero greco, almeno
del
quarto secolo, a cui manca in generale il senso giu
ridico del valore di legittimit di una stabile successione
ereditaria. Ma quanto meno comprendeva il monarca
come legittimo soggetto di diritto nel senso nostro, tanto
pi facilmente il Greco, anche dell'et pi illuminata,
s'inchinava di fronte
all'innata superiorit regale dell'in
dividuo che, possedendola
per natura, apparisse coma
salvatore in mezzo al caos e prescrivesse la legge del
l'inesorabile necessit storica a un mondo politico invec
chiato nelle sue forme.
Questa
innata regalit cerc Aristotele in Alessandro,
ed opera sua se il giovane monarca, pur basandosi
sempre, con realismo politico, sul
compatto suo dominio
ereditario macedone, sulla sua natura di Eraclide e sulla
sua posizione di signore di eserciti, sent tuttavia since
ramente, pidi una volta, la sua missione storica come
cosa che interessava tutto il mondo ellenico. L'enorme
differenza che lo distingue da Filippo si manifesta nel
modo pi chiaro nella loro posizione rispetto ai Greci.
Come dimostra anche la chiamata d Aristotele, Filippo
sapeva sfruttare accortamente la civilizzazione greca.
Senza la tecnica, 1' arte della guerra, la diplomazia, la
retorica dei Greci egli non sapeva immaginarsi uno stato
retto con criteri moderni. Ma nell' intimo restava pur
sempre 1' astuto barbaro. La sua forza geniale si mani
festava soltanto negli aspetti pi rozzi e offensivi. Certo,
Alessandro era di sua natura l' autentico rampollo di
questo ceppo selvaggio, e i suoi contemporanei greci
non riuscirono mai a capire, accanto alle sue grandi
qualit, la sua demoniaca irresponsabilit, la sua folle
sete di piaceri eleesplosioni, sempre pifrequenti, della
sua brutalit e crudelt, perch, tratti in errore dalla
sua alta cultura, pensavano di poterlo valutare con un
ARISTOTELE AD ASSO E IN MACEDONIA 159
criterio di misura ellenico. Ma il grado mirabile di ca
pacit
riflessiva, nel campo personale e in quello sto
rico, fa riconoscere
facilmente, in
Alessandro, l' in
fluenza di Aristotele. La sua idea prediletta,
di muovere
contro l'Asia come un secondo Achille, mostra in ma
niera caratteristica la singolare mescolanza di elementi
che vive in lui e la chiarezza con cui egli ne consa
pevole. Egli greco nella sua cultura letteraria ed etica
e nella sua tendenza all'petVj, ad una forma armonica
d'individualit superiore: ma nel suo baldanzoso senso
di affinit con Achille vive anche il contrasto, romanti-
)
camente passionale, che egli avverte in s rispetto alla
raffinata cultura e politica del quarto
secolo, e certo
: anche qualcosa della coscienza cavalleresca
e semibar
barica, che gli rende impossibile di compenetrarsi pie
namente con l'ellenismo illuminato. Circondato di stu
diosi e di storici egli muove verso 1' Asia, cerca ad Ilio
Ja tomba di Achille e lo chiama felice, per aver trovato
\
Omero quale araldo delle sue gesta. Da questo
giovinetto
I
Aristotele poteva aspettarsi che unificasse iGreci e sulle
rovine dell' Impero persiano edificasse il loro mondiale
dominio in Oriente, idue concetti essendo per lui inse
parabilmente connessi. La comunione spirituale dei due
uomini fu, a quanto
sembra, assai stretta, e non solo
durante il soggiorno di Aristotele in
Macedonia, ma an
che per lungo tempo dopo gl' inizi della guerra persiana.
Solo quando l'orizzonte del paesaggio eroico iliadeo si
fu, per la spedizione d' Asia, esteso fino all' illimitato,
il giovane re abbandon
il suo atteggiamento achilleo
perrivestire altre maschere orientali, e lamissione greca
pass per lui nell'ombra di fronte al nuovo ideale, com
battuto energicamente da Aristotele, della conciliazione
dei popoli e del conguagliamento delle razze. Ma que
sta fine delle loro relazioni interiori non pu gettare
ombra alcuna sull'et in cui Alessandro, erede del trono
160 GLI AJiNI DI VTACCIO
macedone, attinse all'insegnamento di Aristotele ifon
damenti del suo pensiero politico, e questi si un con
Antipatro in una stretta amicizia, che in certo modo
prese il posto di quella con Ermia e dur oltre la morte
del filosofo. Dopo la morte di Filippo, Alessandro esaud
il pi caro desiderio del suo maestro e fece ricostruire
la sua citt natale, Stagira, che le truppe di Filippo, in
guerra con la Calcidica, avevano devastata. Anche la
patria di Teofrasto, Ereso di Lesbo, fu risparmiata,
quando iMacedoni occuparono le isole. Callistene ac
compagn Alessandro in Asia come storiografo.
IL
LO SCRITTO PROGRAMMATICO
IIEPI 4>IAOSO<IA2
Per la conoscenza di Aristotele che si aveva sinora,
l'et intercorrente tra la sua uscita dall'Accademia e il
suo ritorno dalla Macedonia ad Atene, con la
conseguente
fondazione della scuola peripatetica (347-335), cio il
periodo della sua vera e propria maturit, dal trenta
settesimo al quarantanovesimo anno, non era altro che
una pagina bianca della sua vita. Iviaggi non erano
legati da alcun visibile nesso interno alla precedente, ri
tirata vita nell' Accademia. In ogni caso, non sembrava
che essi avessero profondo interesse per la compren
sione del pensiero aristotelico. Data la mancanza di scritti
databili, essi costituivano una completa lacuna anche in
seno alla sua produzione letteraria, tra l'attivit del pe
riodo accademico e quella dell'insegnamento nel Liceo,
dove si pensava fossero nati itrattati. Non avendosi
alcuna precisa notizia circa la sua attivit didattica e
letteraria anteriore alla fondazione della scuola, com
prensibile come non lo si potesse concepire altrimenti
che compiuto nel suo sviluppo, e si considerassero i.
13.
\V. JADOER, Aristotele.
162
GLI ANNI DI VIACCIO
trattati come l'espressione, sistematicamente conclusa,
di questa perfetta forma del suo pensiero.
In eeno al
sistema sembrava occupare 1' estremo e supremo posto
la metafisica, la pura scienza doli' essere, che coronando
l'edificio scientifico comprendeva nel suo ambito ogni
scienza particolare,
tutto dominando e tutto in s risol
vendo come materia e premessa.
Ilnuovo testo di Didimo ci ha invece ora appreso che
l'attivit didattica di Aristotele riprende subito dopo il
347, e che la sua prima manifestazione indipendente
risale al periodo della sua residenza ad Asso. Ci che co
nosciamo della sua attivit durante questi anni attesta la
sua nuova tendenza verso un' attivit pubblica di vasto
respiro, ma nello stesso tempo mostra 1' ininterrotta so
pravvivenza del suo legame interiore coi problemi li
Platone e coi suoi scolari, in mezzo ai quali egli continua
a vivere e a insegnare. Come si visto, la partenza dalla
scuola di Atene non era stata affatto una rottura con Ja
comunit accademica in s considerata. Sarebbe del
resto un'idea inconcepibilmente contraddittoria quella
che egli vi si fosse trattenuto fino alla morte di Platone,
per mancai subito dopo al dovere della fedelt al mae
stro ed ai condiscepoli. La sua evoluzione spirituale as
sume tuttavia sempre pi quella tendenza caratteristica
ad estendersi ed espandersi, che aveva sempre determi
nato l'attivit di Platone. Egli diffonde il germe della
filosofia in luoghi diversi, fondando scuole. Interviene
nell'organizzazione politioa e statale come gi aveva fatto
Platone, ed acquista influenza alle corti dei pi potenti
principi del suo tempo. Tra isuoi scolari cominciamo a
sentire annoverati individui d notevole importanza.
a priori verosimile che allora egli sia pure apparso
per la prima volta di fronte a un vasto pubblico come
critico di Platone, dovendo professare
filosofia platonica
in nome proprio e quindi con la responsabilit di una
LO SCRITTO SULLA FILOSOFIA 163
propria interpretazione. Da questo punto di vista de
v'essere possibile di penetrare pi a fondo nella miste
riosa oscurit di questi anni decisivi, in cui egli viene
alla prima formulazione complessiva della sua conce
zine. Tra il primo periodo, dogmatico-platonico, della
sua evoluzione spirituale e l'ultima e compinta forma
assunta dal suo pensiero negli anni dell'insegnamento
ateniese sta un' et di transizione, che assume sotto molti
aspetti particolari una ben determinata fisionomia. una
et di liberazione, di critica e di ricostruzione, di cui
finora non si sospettata 1' esistenza e che ancora chia
ramente diversa dalla fase definitiva della filosofia ari
stotelica, pur rivelandone gi, in ogni tratto essenziale,
la finale destinazione. L' indagine di questo periodo di
transizione non offrir il solo vantaggio di fare osservare
il progressivo eviluppo dei principi filosofici di Aristo
tele. Solo, infatti, quando si scorge quali elementi, nel
coreo del tempo, egli abbia pi energicamente elaborati,
quali messi da parte e quali aggiunti, si riconoscono
chiaramente le forze decisive, che hanno in lui coope
rato a formare ima nuova concezione del mondo.
A capo di questo periodo evolutivo io pongo il dia
logo IIsp cpiXococpia?. Generalmente esso viene annove
rato tra gli scritti pi giovanili, che con esso hanno in
comune la forma dialogica 2) : ma la filosofia che vi
contraiuta evidentemente un prodotto di questa et
di transizione. IIlargo numero dei frammenti, e la rela
tiva ampiezza di vari tra essi, promettono al tentativo
di ricostruzione risultati maggiori che per qualsiasi altra
') Il Bcrnays e lo Heitz non vedono alcuna differenza fra esso
e gii altri scrini essoterici, in quanto presuppongono che in tutti
<juc6ti scritti Aristotele abbia polemizzato
contro Platone. Viceversa,
ilDyroff (1. c, p. 82) generalizza la sua giusta opinione, che idia
loghi e il Protreptco abbiano avuto in gran parte contenuto pla
tonico, estendendo la medesima supposizione anche ai libri Ilepltpi-
Xoooytaj.
164 Gli ANNI DI VIAGGIO
delle opere perdute. Anche in questo caso dovremo ad
dentrarci in particolari problemi d'interpretazione, per
estrarre gli elementi caratteristici dal contenuto, poco
compreso, della tradizione. Per il suo
stile,
per il suo
intento e per il sua contenuto l'opera occupa un posto
che le attribuisce un' importanza singolare per l'evo
luzione della filosofia aristotelica.
Il dialogo viene esplicitamente citato per la sua po
lemica contro la dottrina dei numeri ideali, ed inrealt
J' unico scritto, tra quelli composti da Aristotele con in
tento letterario, di cui ci sia effettivamente attestato il
contenuto antiplatonico. Tale critica sembra esser stata
connessa a una generale confutazione della dottrina delle
idee, non trattandosi soltanto della ipostatizzazione, ope
rata da Speusippo, dei numeri matematici cernie entit
per s esistenti, bens di quella pi tarda forma della
dottrina delle idee, che procedeva da Platone stesso ed
interpretava le idee come numeri. Se leidee sono un'al
tra specie di numeri, diversa da quella matematica, non i
potremmo averne alcun intendimento. Chi infatti, al
meno della maggior parte di noi, pu intendere che sia
un numero di specie diversa? ').
Queste
parole ci sono
state conservate da Siriano, cli le ha tratte dal secondo
libro del dialogo. Chi parla Io stesso Aristotele, che
in forma personale, tra asseverativa ed ironica, mani
festa la sua insoddisfazione critica nei riguardi della
dottrina di Platone.
Nato dallo stesso atteggiamento interiore mi sembra
un' altro frammento di una critica alla dottrina delle
idee, la cui connessione col precedente non invero
esplicitamente attestata, ma pi che verosimile. il
passo che, attingendo ad una fonte comune, Proclo e
Plutarco allegano a dimostrazione del fatto che Aristo-
') Framm. 9 Rose.
LO SCKITTO SULLA FILOSOFIA : 100
tele abbia combattuto Platone non solo nei trattati ma
anche nei dialoghi 1). Non risultando dalla tradizione
clie una critica di Platone sussistesse in alcun dialogo
all' infuori del llep cpiXoao:p(a;, e coincidendo in ma
niera sorprendente, quanto
alla situazione interiore, que
sta critica tramandata senza indicazione dell' opera con
quella contenuta nel frammento esplicitamente citato dal
dialogo, sarebbe forzato non attribuire entrambe alla
stessa opera, la quale gi col suo titolo, insolitamente
programmatico per un dialogo, annuncia un' ampia presa
di posizione circa iproblemi fondamentali della filosofia.
La precisa forma dell' osservazione, che Aristotele com
piva anche in questo caso come personaggio del dia
logo, non si conservata, ma entrambe le fonti ne ren
dono 1' energico tenore: egli non pu seguire la dot
trina delle idee, anche quando si creda che le contrad
dica per mera smana di aver ragione. ncora pichiara
mente che l'altro frammento, questa solenne afferma
zione chiarisce la situazione di fedelt al reale, nella
quale Aristotele aveva rappresentato s stesso in mezzo
all'ostinata battaglia di opinioni svolgentesi nel dialogo.
La sua alternativa senza via d'uscita: ed egli a ap
pella alla stima che l'indagatore deve ad ogni onesta
e fondata persuasione. Si difende energicamente con
tro l'erronea e maligna interpretazione delle sue diver
genze come derivanti da ragioni personali, interpreta
zione che nell' ambiente dell' Accademia non aveva po
tuto mancar del tutto. Evidentemente fu questa una delle
ragioni fondamentali che lo spinsero a render pubblica
la sua critica, quando gi da lungo tempo, certo, essa era
oggetto di discussione nella ristretta cerchia dei plato
nici. Nel momento in cui egli dichiarava a tutti di non
poter
fare altrimenti che mantenere il suo atteggiamento
') Framm. 8 R., c cfr. sopra, p. 45.
166 GLI ANNI DJ V1ACG1U
di antitesi, non gli importava pi molto di riconquistar
quelli, tra isuoi antichi amici, che rigettavano la sua
interpretazione, e si giustificava ormai solo di fronte al
giudizio pubblico 1).
Stando al titolo e ai frammenti, il dialogo assunse
un aspetto caratteristico anche dal lato formale. Che nei
dialoghi Aristotele introducesse s stesso come direttore
della discussione, attestato da Cicerone, quando egli si
richiama a lui come a modello della propria tecnica dia
logica. Ma 6 gi mostrato che questa caratteristica
tecnica dimostrabile, e verosimile, solo per pochi dia
loghi: oltre che per ilibri sull' Uomo di stato solo,
proprio, per il IIsp tpiXooocpfas '). Ma in quest' ultima
opera un cosi energico accento ed intervento personale
dipende certo dallo stesso carattere programmatico e po
lemico della posizione che egli vi prende. Dal punto di
vista della disposizione interna, iltitolo fa pensare a una
trattazione pi sistematica che negli altri dialoghi, e i
frammenti confermano questa supposizione. Certo v' in
terveniva contro Aristotele, con un'ampia esposizione, un
difensore della filosofia platonica. Che l' architettura
fosse didascalica pu inoltre esser dedotto dalla notizia
di Cicerone, che Aristotele, nei dialoghi in pi libri,
abbia premesso un proemio ad ogni libro. Il contenuto
dei singoli libri era quindi certo unitario e in s con
cluso, come nei dialoghi di Cicerone3). L'opera
occupa
') Ilpasso s conservato in grazia della sua singolare impor
tanza per la storia dell'atteggiamento critico di Aristotele rispetto
a Platone. Da questo punto di vista esso era, pi che raro, unico.
E quindi un metodo che si condanna da s stesso quello che si
segue quando, generalizzando, si estende a tutti idialoghi una situa
zione cos individuale e irripetibile.
J) Cfr. sopra, p. 37.
*) Ciccr., ep. ad. Att., IV 16, 2 gtioiiiom in
singulis libris utor
prooanis, tx Aristoteles in es quos ijjamptxos vocat. Iproemi
non devono quindi essere stati intimamente connessi con ci che
seguiva, secondo quel che Proclo (in Parm., torn. I, p. 659 Cousin)
dice dei dialoghi di Teofrasto e di Eraclide Poutico. Questi erano
to SCRITTO SULLA FILOSOFIA 167
cos una posizione intermedia, tanto dal punto di vista
formale quanto da quello filosofico, tra gli scritti pla-
tonizzanti della giovinezza e itrattati, ai quali si avvi
cina nella disposizione interna.
La possibilit di datazione data dal rapporto tra
questa critica dell' idealismo e quella contenuta nel
Y
primo libro della
Metafisica.
Uno dei pochi punti fermi
che si offrano all' esame cronologico dei trattati ilfatto
che Aristotele, poco dopo la morte di Platone, tent
con geniale improvvisazione di estrarre, dal fermento
delle discussioni accademiche circa la dottrina delle idee,
certi risultati fondamentali, e di elaborare con essi le
prime linee della sua nuova filosofia, nella forma di un
platonismo riveduto e reso pi schietto. Il risultato fu
ilprimitivo abbozzo, la cui introduzione leggiamo ancora
nel primo libro della
Metafsica
Non si pu pensare
che Aristotele avesse dato pubblicit letteraria, nel IIsp
cpiXoaocpCa;, alla sua critica prima ancora di questa in
dagine esoterica.
Questa
pubblicazione non costitu il
primo, bens 1' ultimo passo. Neil' interesse dell' Acca
demia, egli deve avere evitato fino all'estremo limite pos
sibile di parlare di fronte a tutti di divergenze interne
della sua scuola, concernenti problemi logico-metafisici
dei quali solo pochi erano in grado di giudicare; e le Bue
dichiarazioni superstiti confermano che egli si difese >.
pubblicamente solo quando vi fu costretto. Il dialogo .
appartiene perci allo stesso periodo di tempo della cri
tica delle idee contenuta nel primo libro della
Metaf
sica, o a un periodo poco posteriore: non antecedente,
in ogni caso, alla morte di Platone. Esso si presenta alla
composti sul modello aristotelico. Nell'Eudemo, invece, il dialogo
si sviluppa ancora organicamente dall' inquadramento narrativo del
proemio, come in Platone.
') Cfr. le mie Studien tur Entstehungsgeschichte dcr .Ifefaphy-
si/e des Aristoteles (Berlino 1912), p. 28 segg. e specialmente p. 33.
163 CLI ANNI DI VIAGGIO
tribuna filosofica non solo con una critica negativa ma
anche con una concezione propria. Per gli antichi esso
rimase, fino all' edizione della
Metafisica
compiuta da
Andronico, la fonte principale per la conoscenza della
concezione filosofica di Aristotele, e attraverso essa ne
presero nozione gli stoici e gli epicurei. Era, certo, un
Aristotele ancora incompiuto quello di cui essi si dovet
tero contentare.
Aristotele cominciava trattando dello sviluppo storico
della filosofia. Non si limitava soltanto, come nella Meta
fisica, ai filosofi greci da Talete in pen, legati da un'ef
fettiva continuit interiore e intenti allo scopo della
pura ricerca, Benza presupposti indimostrati e secondo
salde linee direttive; ma si spingeva fino all'Oriente, e
ricordava con reverente interesse le sue antichissime e
grandiose creazioni. Nel primo libro della
Metafisica
sono
brevemente lodati isacerdoti egiziani, sia per iloro me
riti nel campo matematico sia per 1' esempio di contem
plativa vita filosofica che essi diedero ai Greci. Nel dia
logo Aristotele risaliva ancora, oltre di essi, a tempi
pi antichi (stando alla sua concezione cronologica), e
parlava dei Magi e della loro dottrina J). Seguivano poi
ivenerandi rappresentanti della pi antica sapienza el
lenica: iteologi, come egli usa chiamarli, le dottrine
degli Orfici e certo anche Esiodo, per quanto non ap
paia nei frammenti superstiti; infine la sapienza gnomica,
che si faceva risalire ai cosidetti sette 6aggi e la cui tra
dizione era sotto la protezione particolare della divinit
delfica. Ci dava opportunit per una menzione dell'an
tica
religione apollinea. notevole che Aristotele sia il
primo
pensatore posteriore a Platone che si sia mante
nuto
immune dal giudizio platonico circa isofisti e dalla
proscrizione
del loro nome. A questo egli restitu il suo
')
Framm. fi R.
1.0 SCRITTO SULLA FILOSOFIA
169
autentico e migliore significato, ed ebbe l'acume storico
di collocare isette saggi a capo di questa
serie di spiriti
sovrani, il cui influsso sullo sviluppo del pensiero greco
gli appariva cos rilevante da includerlo senz' altro nel-
1' evoluzione della sapienza filosofica 3).
IIcomplesso di questi dati era elaborato criticamente
e disposto secondo un certo ordine. A proposito della
religione orfica Aristotele poneva la questione dell' au
tenticit delle superstiti composizioni in esametri e com
batteva l'idea che Orfeo fosse stato un poeta e avesse
scritto versi. Distingueva fra iconcetti religiosi e la forma
della loro tradizione letteraria, la genesi della quale egli
ascriveva giustamente a un' et piuttosto
tarda, intorno
alla fine del sesto secolo. Di qui proviene 1' opinione,
ancor oggi valida, che Onomacrito, il teologo di corte
di quei Pisistratidi che per la mistica orfica avevano in
teresse, abbia messo in giro la falsificazione del poema
contenente la dottrina orfica2). Presa in esame era an
che la questione dell' antichit del motto rvGvfh aeat/cv,
sovrastante l'ingresso del tempio delfico. Aristotele cer
cava di risolverla con argomenti tratti dalla storia della
costruzione del santuario di Delfi3). Parimenti, a pro
posito della sapienza degli Egiziani e della religione ira
nica, invece di ammirare ingenuamente
la loro indefinita
antichit, si sforzava di datarla nel modo pi preciso
possibile
4).
J) Attestato in modo esplicito come appartenerne al Ilepl <pt-
Xooocptas, oltre alla collocazione cronologica della religione dei
Magi, solo il calcolo dell'et del motto rvffi&i osautv a Delfi
(fraram. 3 R-), che conduceva Aristotele a trattare la questione del
l'epoca dei sette saggi. Egli assegnava il motto a un'et anteriore
a quella di Chilone. Anche il framm. 4 e 5 appartengono
dunque
a questa generale trattazione: ed evidente che non dovessero man
care iteologi, dato che anche la Metafisica
fa iniziare da essi l'era
della riflessione filosofica.
!) Framm. 7 R.
') Framm. 3 R.
i Framm. 6 R.
170 GLI ASMI DI VIAGGIO
LO SCRITTO SULLA FILOSOFIA 171
Questa
rigorosa ricostruzione cronologica non il ri
sultato di una semplice curiosit antiquaria: le sta alla
base un principio filosofico. Aristotele insegna che le
stesse verit non affiorano nella storia umana solo una o
due volte, ma con infinita frequenza 1). Perci egli inizia
una raccolta dei proverbi greci, sentendo nelle loro brevi
e taglienti verit d' esperienza iresti di un' originaria e
non ancor letteraria filosofia, conservatisi per via orale,
in grazia della loro laconica ricchezza di contenuto, at
traverso tutte le vicende spirituali della nazione. Con
acuta intuizione, egli riconosce il valore dei proverbi
e della poesia gnomica per l'indagine dei primordi della
riflessione inorale. Ilminuto lavoro di ricerca necessario
a
questa collezione, che al Greco colto doveva sembrare
|
volgarmente meccanico, attira su di lui l'aperta irrisione ?
dell'ambiente isocrateo2).
L'indagine circa l'antichit
del motto delfico conosci te stesso mira a decidere
chi dei cosiddetti sette savi ne sia stato 1' autore. Inbase
ai suoi argomenti, tratti dalla storia dell' edificio, Ari
stotele appiana la
controversia, piuttosto priva di con
tenuto, accesasi a tale
proposito con la salomonica ri
sposta che esso non risale ad alcuno dei saggi, essendo
pi antico del sapiente Chilqne
e dovendo quindi essere
stato rivelato dalla Pizia stessa. Lo scopo di questa argo
mentazione divien chiaro quando le si accosti la testi
monianza di Plutarco, attestante che Aristotele scrisse,
nei discorsi platonici , che tra imotti delfici il pi
divino era il rv>5k tjsauzv.
Esso diede infatti anche a
Socrate il tema della sua indagine filosofica. Come la
convenzionale formula di citazione Iv toTj Suxpattxots
*) De Caelo, A 3, 270 b 19; Meteor., A 3, 339 b 27; Metapk.,
V
8, 1074 b 10; Pol., H10, 1329 b 25.
s) Circa l'interesse di Aristotele per i proverbi cfr. Bonitz,
l'idex Arist., d. V. ttotpoqtCa. Nel frainin. 13 R. iproverbi
sono de
finiti come YxaxaXe(|iaaTa
naXmSs iXoootaf.
Per la raccolta
dei proverbi cfr. Diog. Laert., V 26 e Athen,, li, 60 d.
indica idialoghi socratici di Platone, cos la singolare
designazione v -cai; nXatamxo; deve riferirsi
alla forma
e non al contenuto, e significar quindi nei dialoghi
platonici di Aristotele . D' altronde la relazione, qui po
sta tra l'antico motto delfico e la genesi del nuovo in
dirizzo socratico di ricerca etica, conviene al nostro dia
logo pi che a qualsiasi altro. Si tratta infatti di un
esempio a sostegno della dottrina dell' infinito ripetersi
di tutte le opinioni filosofiche nel corso della
gtoria.
Socrate diventa il rinnovatore dei principio etico della
religione apollinea, anzi, come Aristotele cerca di di
mostrare con la visita di Socrate a Delfi, ha ricevuto pro
prio nella sede dell' antico oracolo l'impulso esterno per
lesue indagini analizzanti ogni esigenza morale del suo
tempo
1).
Hnesso di religione e filosofia, che qui diviene evi
dente, si estende per tutto il dialogo. La missione apol
linea di Socrate era gi stata ricordata da Platone nel-
l'Apologia: qui la teoria dei ritorni periodici permette
d' interpretarla pi profondamente, come una rinascita
della saggezza delfica. Apollinismo e socratica sono idue
fuochi della evoluzione etica del popolo greco. Lo stesso
significato deve aver avuto l'indagine circa la data d'ori
gine della
religione orfica. Aristotele non aveva dubbi
circa la storicit di Orfeo, e insisteva sulla tarda origine
della codificazione letteraria dell' orfismo solo per ri
mettere, al posto
di un versificatore di oracoli dell'et
J) Che iframni. 1 e 2 siano connessi col framm. 3 non pu
esser messo in dubbio quando si sia scoperto che la chiave per
comprendere l'intento di tutta la trattazione nella dottrina del
ritorno periodico di ogni conoscenza. Che poi imotti delfici conten
gano realmente la sapienza apollinea, o siano piuttosto il portato
di una cultura estranea, messa poi sotto la protezione della divinit,
questione che qui non ci riguarda. Ilparallelo di Socrate e della
dottrina delfica si trova anche in [Plat.], Alcib.l, 124 B:wst.il|U-
vo( pilre xel r$
Iv JeXpotg pdppctxi yvMH
oskutv.
172
GLI ANNI DI VIAGGIO
LO SCHttiO SULLA FILOSOFIA 173
dei Pisistratid, un
autentico profeta della pi antica
et
ellenica. Circa la tarda genesi degli scritti orfici ion
gli sembrava possibile alcun dubbio, mentre non trovava
alcun ostacolo ad ammettere 1' alta antichit della loro
dottrina religiosa. La
trattazione del problema della sua
origine traeva certo
argomento dal suo ritorno nella spi
ritualizzata fede nell'
aldil, propria di Platone, e nella
sua
mitica dottrina dell' anima.
Un altro esempio di questo metodo si pu ricavare
dal
seguente
frammento. Nella sua Storia
naturale
(XXX, 3) Plinio racconta: Eudosso, che voleva si con
siderasse la dottrina dei Magi come la pi augusta e sa
lutare tra tutte le fedi filosofiche, ha tramandato la no
tizia che il cosiddetto
Zaratustra visse 6000 anni prima
della morte di Platone. Cos riferisce anche Aristotele.
noto che Eudosso, 1'
astronomo amico di Platone, s'in
teress della scienza dell'Oriente e dell'Egitto
durante
il suo soggiorno in quei paesi. E rec con s in Eliade
le notizie che aveva attinte dai
rappresentanti di quel
mondo
culturale, ancora in gran parte chiuso alla cono
scenza dei Greci.
L'Accademia
costituiva allora
proprio il
centro di
una
tendenza orientalizzante, . che come presagio della
spedizione di Alessandro e del
conseguente avvicina
mento dello spirito
ellenico a quello
asiatico d' im
portanza grande, sebbene per lungo
tempo non. abba
stanza valutata. Le vie attraverso le quali penetrarono
in Grecia gii influssi
orientali ci sono note solo inpiccola
parte. un caso che
possiamo
desumere dall' elenco de
gli scolari
dell'Accademia, un pezzo del quale si con
servato in un papiro
ercolanese, come un Caldeo appar
tenesse alla scuola platonica
quale membro ordinario1).
Ci accadeva, a
quanto sembra, nell'ultimo decennio della
')
index AcoA. Hercidan., col. Ili,p. 13 (Mekler).
vita di Platone: e alla etessa et si riferiscono altre trac-
eie d'influsso orientale, come il paragone delle quattro
virt platoniche con l'etica di Zaratustra ne\VAlcibiade I,
e la teologia astrale che lo scolaro e segretario di Pla
tone Filippo di Opunte presenta, inappendice alle Leggi,
come oocpfa suprema. Per le nuove concezioni religiose,
che solennemente annuncia ai Greci , quest' ultimo si
appella esplicitamente a fonti orientali1). Certo, queste
tendenze risalgono all' et in cui Eudosso era presente
nell'Accademia: del resto solo la povert del materiale
che non permette di valutare in piena misura l'enorme
influsso che quest' uomo esercit sui platonici. Le ten
denze orientalizzanti si riconnettono in parte all'ammi
razione per l'astronomia caldea e siria e per la sua
antichissima conoscenza empirica dei moti celesti, alla
quale l'Accademia attinse il calcolo delle orbite e la co
noscenza dei sette pianeti, per la prima volta affiorata
in Europa con Filippo di Opunte; e in parte alla pre
dilezione per il dualismo religioso dei Parsi, in cui si
trovava un sostegno per la metafisica dualistica del vec
chio Platone. La cattiva anima del mondo, che nelle
Leggi si presenta come oppositrice dell'anima buona,
costituisce un tributo a Zaratustra, al quale Platone fu
condotto dall' ultima fase, matematizzante, della dottrina
delle idee e dalla sua estrema accentuazione del duali
smo5). D'allora in poi, Zaratustra e la dottrina dei Magi
furono, nell'Accademia, oggetto di vivo interesse. Lo sco
laro di Platone Ermocloro si occup della religione
astrale nel suo scritto Espi [ia&rjjixiuv, e deriv etimo-
') Epin. 986 E; 937 B; 937 D-988 A; Cl'lat.], Alcb. 1, 121 E-
122 A.
:) Leg., X, 896 E:A
9'axV'
SioixcDaav xal ivoixoOuav iv
Srcasiv -cots xrtfl xivoofiivois
(iffiv o xal tv opavv vaf*1]
Sioixev cpvai; KA. T jir/v ; A. MCav nlsCouj; nXsiouj- iy>
5xp a-pijiv ixoxpiYoOjiai' 8ootv |iY y xou IJ.anov [n;8v xtfriijiEV,
xs sepfuoj -/.al tSJ; xSvavtCa Suvanvrjs itpy&$,so&a.i.
174
CLI ANNI DI VIACC10
logicamente da essa il nome di Zoroastro, interpretan
dolo come adoratore delle stelle (orpohky}?) ').
Da questi influssi derivava l'interesse che Aristotele
manifesta per iMagi nel dialogo Ilep cpiXococpla?. Anche
nel tentativo di
determinare la posizione cronologica di
Zaratustra egli era stato preceduto da altri. Ermodoro
lo aveva considerato precedente di cinquemila anni alla
caduta di Troia. Furono
appunto le indagini di
questo
platonico quelle su cui si basava ancora sostanzialmente,
a proposito di tali problemi, ildotto alessandrino Se
zione nella sua storia delle scuole filosofiche. Accanto a
quella di Ermodoro egli ricordava la datazione di Xanto,
secondo ilquale Zaratustra sarebbe vissuto seimila anni
prima della spedizione di Serse2). La datazione di Ari
stotele e di Eudosso, riferita da Plinio, si distingue da
tutte le altre, di cui rimasta notizia nella tradizione,
per ilsingolare punto di partenza del calcolo degli anni;
accanto ai calcoli riferentisi alla spedizione di Serse (pi
tardi a quella di Alessandro) o alla caduta di Troia, si
vede bene che la designazione seimila anni prima della
morte di Platone non deriva da un dato sistema crono
logico, ma dal desiderio di stabilire una relazione in
trinseca tra
Zaratustra e Platone, come fenomeni storici
analoghi. Ci che sta a fondamento del paragone, e che
costituisce in particolar modo l'interesse della determi
nata estensione del
tempo intermedio tra idue, calco
lato per millenni, evidentemente la concezione, profes
sata nel HeplpiXoacepla?, della necessit naturale e del
ritorno periodico di ogni verit umana. Ora, in un fram
mento attestato come appartenente al primo libro del
dialogo, Aristotele parla della dottrina dei Magi, del dua-
)
Hermodor., Hept
pathjiinov (utilizzalo da Sozione nella
Ata8oxi?) presso Diog. Laert., I, 2 e 8; e cfr. lo scolio a [Plat.],
Alcib. 1, 122 A.
s) Diog.
Lacrt., I, 2.
LO scaltro SULLA F1LOSOP1A s 175
lismo iranico: e riferisce come Becondo tale concezione
vi siano due principi, un demone buono e un demone
I cattivo, Ormuzd e Arimane, paragonandoli
alle divinit
I
greche Zeus e Ade, al dio della luce celeste e a quello
1 della oscurit sotterranea. L'esplicito paragone del dua-
I lismo dei Caldei e dei Magi con la dottrina platonica
I della buona e della cattiva anima del mondo si trova
gi, pi tardi, in Plutarco, ed ovvio che anche per
I Aristotele, nel frammento in cui egli poneva in paral-
1
lelo Zaratustra e Platone, doveva avere importanza
de-
t|
terminante questo
stesso motivo critico3). A tale conget
tura fornisoe certezza l'unico luogo in cui egli, altri
menti, fa menzione dei Magi. Esso appartiene
a una delle
parti pi antiche della Metafisica, e cio a un brano la
cui genesi va assegnata, per altre ragioni, alla stessa et
1
dello scritto Sitila
filosofia.
Anche lsi parla del dualismo
(
platonico, e Aristotele cita, come antichissimi predeces-
Bori
di questa visione del mondo, Ferecide, per l'am
biente ellenico, e iMagi, per quello
asiatico2). L'infa
tuazione accademica per Zaratustra
fu un impeto entu
siastico, simile a quello di Schopenhauer quando fece
la scoperta filosofica del pensiero indiano. La coscienza
j
storica, che la scuola aveva di se, era esaltata dal fatto
> che il profeta dell'Oriente avesse gi rivelato da mil-
\
lenni, alla sua umanit, la dottrina platonica del bene
i
come principio divino del tutto.
I Questa
interpretazione confermata dal numero 6000.
Sappiamo da Teopompo che la generazione
di Aristo
tele e di Eudosso (il quale forse anche fonte di Teo-
;
pompo
stesso) aveva avuto nozione del grande periodo
; cosmico della religione iranica e della lotta
drammatica,
costituente la storia del mondo, di Ormuzd
e Arimane 9).
') Arist, framm. 6 R.; Plul, Is. et Osr., 370 E.
t
Meiaph., N4, 1091 b 8.
') Theopomp. in F. Gr. Ilist., fr. 64-65
(Jacoby): e cfr. Jackson,
170 (XI
ANNI DI VIAGGIO
A turno (v pepo;) essi dominano per un periodo di tre
mila anni, e per altri tremila rimangono in lotta, cer
cando di distruggere l'uno ci che ha creato l'altro e di
danneggiarsi a vicenda. Ma da ultimo lo spirito buono
resta vincitore. La tradizione iranica determina varia
mente la lunghezza del dramma escatologico, fissandola
talora in 9000 (che , come sembra, la dottrina seguita
dalla fonte di Teopompo), talora in 12000 anni. In di
pendenza da ci le singole fasi del processo cosmico,
duranti ciascuna 3000 anni, acquistano un significato
diverso. Per questo motivo non sar forse possibile, coi
mezzi di cui disponiamo, di determinare inmodo esatto
e indiscusso quali momenti di questo processo fossero
rispettivamente rappresentati da Zaratustra e da Pla
tone1). certo per che non dipende soltanto dal caso
se la cifra di 6000 anni, che secondo Aristotele ed
Eudosso corrisponde all'intervallo separante Zaratustra
da Platone, divisibile per 3000. Evidentemente l'uno
e l'altro rappresentano due tappe importanti del pro-
The date t>f Zoroaster, inJournal
of
the American Orient. Soc., XVII
f
(1896) 3, F. Cumont, Textes et monum. de Mithra, I, 310 n. 6 e ulti- |
inamente Gisinger, Erdbeschrcibung des Eitiloxos '(Lipsia 1907). La
?'
creazione della divinila buona compiendosi in 6000 anni, ipadri h
della chiesa identificano, nelle loro filosofie della storia, questo pe-
jj
riodo cosmico coi sei giorni della creazione secondo la Genesi. I
*) Nell'originaria
edizione tedesca ho cercato di determinare t
pi esattamente la posizione che si poteva congetturare spettante |
a Zaratustra e a Platone nel dramma cosmico della religione ira- Il
nica. Frattanto la tesi da me proposta, che la collocazione cronolo- j
gica di Zaratustra 6900 anni prima di Platone presupponga un ,
riferimento intrinseco dell' uno all' altro e dei principi dell'uno a
quelli dell'altro, ha avuto larga eco nel campo orientalistico ed
stata universalmente accolta. Tuttavia, dopo le pi recenti inda-
gini degli iranisti, preferisco ora rinunciare alla conciliazione della
'
tradizione greca con quella
iranica, giacche ai fini della mia dimo
strazione importa soltanto stabilire il fatto che Platone, quando
ancora era in vita e subito dopo la sua morte, sia stato ricollegato ,j
a Zaratustra e alla dottrina iranica della lotta del principio buono 1
contro quello cattivo. Su Platone come fondatore di religione cfr. ;
ora il mio articolo in The Classical Quarterly, XXI (1927), p, 13.
LO SCRITTO SULLA FILOSOFIA 177
cesso evolutivo onde il mondo tende al dominio del
bene, suo scopo finale.
L'aBsegnazione del frammento tramandato da Plinio
al primo libro Uep cpiXooocp; anzitutto sostenuta dal
fatto che esso diviene pienamente comprensibile solo se
considerato in tale contesto concettuale. Giacche per
il Rose lo ha posto,
senza che se ne veda la ragione,
tra
iresti dello spurio. Maytx;, bene che venga eliminata
esplicitamente anche la sola ombra di sospetto,
che po
trebbe perci cadere sulla sua autenticit1). Plinio non
attinge la notizia all'opera di Apione Sui Magi, secondo
la congettura affatto priva di fondamento del Rose, bens
all'omonima opera erudita del callimacheo Ermippo, che
cita come fonte, in modo indiscutibile, una riga dopo, e
la cui ricchezza d'informazione documentaria egli am
mira con una ingenuit tanto meglio giustificata, in
quanto personalmente la lascia a desiderare. Non Plinio,
ma Ermippo ha consultato Eudosso ed Aristotele, com'
confermato anche dal confronto col frammento concer
nente iMagi del primo libroIIspl cptXooocpi'a (framm. 6).
Anche questo proviene da Ermippo, e qui pure egli ha
citato come foute Eudosso e Aristotele. Confrontiamo:
P'iin., Nat. hist., XXX, 3.
Sine dubio illic orla in Per-
side a Zoroastre, ut inter aneto-
res convenit. Sed unii.? hic juerit
Diog. Laert., 1, Prooem., 8.
'AptaxotXeg S'iv x p t
-
itp teepl qjtXooi?ag tal
Kpeaginpoog slvat "tffiv AtyoK-
')
rist., iratnm. 34, e cfr. V. Rose, Arist. Pseudepigr., p. 50. Il
Rose ba supposto die il frammento appartenesse al per
ch questo scritto citato come aristotelico, in Diog. Laert., Ile
I8, in immediata vicinanza del passo circa iMagi tratto dal IIspl
'pO.oaocploc. Ma un'esatta
indagine delle fonti mostra che Dio
gene, citando come aristotelici i due scritti, non si basava sullo
stesso autore per l'uno e per l'altro, Lo spurio Mayixg era infatti
allegato da Sozione, accanto ad Ermodoro, come fonte principale,
giacch tutti e tre sono citati insieme da Diogene tanto in I1-2
quanto in I7-8 (l'estratto giunge fino a cptjol ti xoxtxo xal 6
12. W. Jaeoie, A listatele,
178 CL! ANNI DI VIAGGIO
tcov stai 5d xat" aToiis (se. toj
M-fO'jj) Etvai pyctg, aS-v
Saipova xal
xay.v
Salpava" xtzl
Tip jxm vopa elvai
Zeus
xai
'iipojioSvjj, Tip Si "Ai5r;g xal
'Apei|ivi2{.
cf
ij=t Si
tgto
v.al
"Eppiitwog iv Tip npiTtp
rcspl Mdywv xal E&Sogog iv
rg iteptStp xal Ss/toptiog v
TjJ S-pSj tv OtXinrctxcBv.
are postea et alius, reo satis con
stat. Eudoxus, qui inter sa-
pientiae scctas clarissimam uti-
lissimamque eam intellegi vo-
luit, Zoroastrem hunc se* mi-
libm arereorum ante Platonis
mortem juisse prodidit. Sic et
Aristoteles. Hermi ppus,
qui de tota ea arte diligen-
tissime scripsit et vicieits centum
milia versuum a Zoroastre con
dita indicibus quoque volumi-
num eius positis explunavit,
praeceplorem.... tradidit Agonu-
cere, ipsum vero quinque mili-
bus annorum ante Troianum hel
ium juisse.
Ermippo si evidentemente valso entrambe le volte,
per le notizie circa iMagi, delle stesse fonti, lalIepfoSo?
di EudoBso e il dialogo Ilepi cptXoco'f a$. In entrambi i
luoghi avr citato esattamente tali opere. Diogene ha
conservato la citazione completa; Plinio, secondo ilme
todo a cui di solito si attiene, nomina soltanto gli autori
che gli servono di fonte, e non ititoli dei loro libri. Il
frammento conviene inmodo eccellente alle indagini cro
nologiche del primo libro Espi eptXocospa?, che trattava
anche altrove dei Magi, e alla teoria dell'eterno ritorno.
Esso sar quindi da comprendere tra iresti del dialogo,
in una futura nuova raccolta dei frammenti aristotelici.
Il parallelismo, inquadrato nella universale storia del
mondo, di Platone con Zaratustra non appar tale da po
ter essere stato istituito in tempi in cui era ancor vivo
Platone. Certo non si trovava ancora nella Descrizione
della terra di Eudosso, morto molto tempo prima di Pla
tone. A Eudosso spetta soltanto la priorit nell'assun-
*Epp65u)pog) ; mentre le notizie risalenti al Espi qstXoootpCas; di
Aristotele e a Eudosso derivano, come s' provalo, da Ermippo.
LO SCRITTO SUI.LA FILOSOFIA 79
zione del periodo di seimila anni ai fini della data
zione di Zaratustra: ed stato Aristotele che, riconnet-
tendosi alla sua dottrina del ritorno periodico di ogni
conoscenza umana, ha particolarmente riferito la data
zione di Eudossso al ritomo del dualismo e dato con ci
a Platone un rilievo conforme alla sua profonda vene
razione. Il dialogo, in cui egli inquadrava cosi il suo
maestro sullo sfondo luminoso dei millenni, senza dub
bio stato composto solo dopo la sua morte1).
La teoria della verit ricorrente a determinati inter
valli presupponeva che gli uomini non fossero in grado
di serbarla in modo duraturo nella loro coscienza, una
volta che l'avessero conosciuta. Con ci non era detto che
l'umanit non si potesse mai mantenere per un lungo
periodo di tempo alla stessa altezza, e che perci anche
verit da lungo tempo scoperte dovessero sempre andar
perdute di nuovo. La teoria si basava bens sull'assunto
di una distruzione periodica della religione e della ci
vilt per opera di violenti fenomeni naturali, e non era
quindi nient' altro che l'applicazione della dottrina pla
tonica delle catastrofi alla storia della filosofia. Gi il
Bywater ha cercato di dimostrare, e con luminose ra
gioni, che la teoria delle catastrofi appariva nel dialogo
aristotelico 2). Il Timeo ammette che tutta la pi antica
') Se le parole di Plinio sex milibus annorum ante Plato
nis mortem non derivano dall'intermediario Ermippo (nello
stile tecnico dei cronologi le indicazioni ante mortem significano
spesso, come a ragione mi suggerisce Ed. Fracnkel, semplicemente
ante aliquem) ma bens dalla sua fonte, esse possono essere, comun
que, solo di Aristotele, perch Eudosso mor prima di Platone (n
si pu, basandosi su! passo di Plinio, pensare invece che sia morto
dopo, come fa il Gisinger, loc. cit., p, 5 n. 1). In ogni modo, che
una simile comparazione potesse essere istituita solo dopo la morte
di Platone pare a me certo gi soltanto per ragioni interne; e la
stessa cosa da dire per ci che concerne la posizione dell'intero
dialogo rispetto a Platone e alla sua filosofia.
') Il Bywater (Journal oj Philology-, VII, p. 6S) ascrive al dia
logo liepl piXoaoyiaj brani di Filopono, in Nicom. arithm. La
teoria <lei cataclismi vi messa in rapporto con l'i-deu della evolti-
180 GLI ANNI
1)1 VIAGGIO
tradizione sia stata annientala, presso iGreci, da eventi
naturali di violenta natura. Come residuo di tali cata
strofi nella memoria dell'umanit interpretato, p. es.,
il mito di Fetonte e quello del diluvio universale. Anche
nelle Leggi questo metodo di interpretazione dei miti
viene applicato alla pi antica storia della civilt, nello
stesso modo in cui nella
Metafsica
aristotelica imiti di
vini sono considerati come resti rudimentali d una fase
primordiale, oscuratasi nella tradizione, della sua teoria
del movimento delle sfere11). 11 razionalismo di questo
metodo di trattazione dei miti non certo nato dallo spi
rito intuitivo e fantastico di Platone: esso reca l'im
pronta della scienza ionica, e probabilmente deriva da
Eudosso, come del resto si pu congetturare per la stessa
teoria delle catastrofi. Di questo metodo Aristotele si
valso liberamente: nella Meteorologa, p. es., egli deduce
dalla tradizione mitica l'esistenza preistorica dell'ipotesi
dell'etere, per la prima volta dimostrata proprio da luia).
L'idea del ricorso di tutti ifatti spirituali , viceversa,
certamente non eudossiana. Ma inmodo tanto pi chiaro
essa manifesta l'influsso della moderna scienza naturale
sulla considerazione storica della civilt, sulla sua valu
tazione del mito e sulla concezione dell'essenza dello
spirito umano, il quale reca sempre nuovamente in luce
zione scientfica: e questo uno dei inolivi elle Aristotele attinse
a Hatone ed elabor ulteriormente. La teoria analizzata dal By-
svater per, nella sua forma, stoica, e specialmente lo ilconcetto
dell'evoluzione delle arti e quello della continua mutazione di
significato del termine ooiffa, che da tale evoluzione deriva. Cfr.
per ci il mo Nemesios von Emesa, Qucllenforschungen zur Ge-
schichte des alteren Nettplalunismits und zu Poseidonios, Berlino,
1914, p. 124 segg., e Gerbausser, Der Protreptikos des Poseidonios,
Diss. Heidelberg, 1912, p. 16 segg.
3) Plat., Tim., 22 -C, Critias 109 D segg. Leg., Ili, 67? A. Ar.,
Metaph., A 8, 1074 b 1-13.
Meteor.. A 3, 339 b 20 segg.; de ertelo, A 3, 270 b 16 segg.;
de anim. mot., 3, 699 a 27; Pol., H 10, 1329 b 25.
T.O SCRITTO SULLA FILOSOFIA 181
ci che in lui giace nascosto, cosi come la natura fa con
le sue forze.
Se nel primo libro la figura di Platone appariva sol
levata, su uno sfondo di secoli, al di sopra di ogni misera
contraddizione, e costituente il culmine di tutta l'evolu
zione filosofica compiutasi fino allora, questa valutazione
determinava la prospettiva piadeguata per la critica che
seguiva negli altri libri. Alla dissoluzione della dottrina
delle idee, data nel secondo libro, seguiva nel terzo la
costruzione cosmologica propria di Aristotele. Si trattava
di una cosmologia e di ima teologia che venivano egual
mente esposte merc un continuo riferimento critico alla
filosofa platonica, appunto in quanto si riconnettevano,
ad ogni passo, strettamente a quella. Sul contenuto gene
rale del libro d notizie il personaggio epicureo nel De
natura dcorum di Cicerone. In sostanza, Aristotele ri
prendeva qui la teologia astrale del tardo periodo pla
tonico. Inessa egli trovava il punto a cui ilpensiero me
tafisico doveva riconnettersi dopo ilcrollo della dottrina
delle idee. Per Platone, dietro al mito siderale della
sua pi tarda fase filosofica si celava sempre il mondo
soprasensibile delle idee, copia del quale era il cosmo
visibile. Aristotele si restringe al solo
aspetto cosmolo
gico di questo duplice universo, cos come anche un altro
scolaro di Platone, Filippo di Opunte, fa
nel]
'Epino-
tnide, se pure in diverso modo. Egli diventa con ci il
vero e proprio creatore della rehgione cosmica della filo
sofia ellenistica, liberatasi dalla fede del volgo e ricer
cante ormai solo nel celeste mondo degli astri gli oggetti
della sua venerazione. Ifili, che connettono da un lato
l'aristotelica religione astrale con l'Accademia e dall'al
tro la teologia stoica con la pi antica fase del pensiero
aristotelico, non sono stati finora scoperti; e in partico
lare non stata chiaramente riconosciuta l'importanza
di Aristotele sotto questo rapporto,
inquanto si son presi
1S2 GLI ANNI DI VIAGGIO
troppo esclusivamente, come punto di partenza, itrattati,
che invece rimasero completamente estranei alla cultura
ellenistica.
/ Secondo l'esposizione critica conservatasi in Cicero
ne, e derivante da una fonte epicurea utilizzata anche da
Filodemo, Aristotele nel terzo libro llepl cpiXooocpla;
avrebbe designato come divinit ora lo spirito, ora il
mondo, ora l'etere, ora un' altra entit, sovrastante al
_X mondo e dirigente il suo moto merc una specie di ro
tazione retrograda (replicatione quadam) 1). Valendosi
della dottrina epicurea come di criterio di giudizio, il
crtico ricava da queste tesi grossolane contraddizioni.
Per quanto questo giudizio possa essere superficiale, l'e
sposizione in s non d luogo a dubbi. La divinit, che
vien detta sopraordinata al mondo, iltrascendente mo
tore immollile, che dirige il mondo come causa finale
merc la perfezione del suo puro pensiero. In ci la
cellula originaria della metafisica aristotelica. Aristotele
designava poi l'etere come corpo divino o pi divino, allo
stesso modo che nei trattati: come Dio esso non compa
riva certo2). La divinit dell'etere non conviene, appa
rentemente, a un monoteismo di rigorosa trascendenza:
ma al disotto del motore immobile stavano le divinit, di
materia eterea. Soltanto apparente poi la contraddi
zione risultante dal fatto che Aristotele avrebbe in un
caso attribuito la natura divina al mondo, e in un caso
*) Arist.,
(ramiti.
26 R (Cic., de nat. deor., I, 13, 33).
')
Cicerone traduce il termine, come al solito, con caeli ardor;
e anche il fatto che lo chiami divino mostra che egli allude all'ipo
tesi aristotelica dell'etere (cfr. Cic. de nat. deor., I, 14, 37 ardorem,
qui aelher nominetur, secondo il richiamo' del Plasberg ad loc.).
Aristotele avanz dunque l'ipotesi dell'etere come quinto elemento
quando ancora si trovava nell'Accademia, dove essa si afferm lar
gamente, se anche con alquante attenuazioni e modificazioni. Al
pubblico essa fu per resa nota per la prima volta nel Ilept <pio-
ootpfas.
LO SCRITTO SULLA FILOSOFIA V 183
all'etere: prima al tutto e poi alla parte. Per mondo
non da intendere, come fa l'epicureo, il concetto elle
nistico del cosmo vivente e comprendente in B ogni es
sere, bens il cielo, la semplice periferia della sfera.
Que
sto uso linguistico dimostrato peculiare dell'antica Ac
cademia anche aWEpinomide. Essa lascia libera, a pro
posito del sommo iddio, cio del cielo, la scelta fra le
denominazioni di Urano, Olimpo o Cosmo; e altrove os
serva che quest' ultima denominazione quella che esso
merita di pi1).
Ma in questo dialogo Aristotele si muoveva nell'am
biente del tardo platonismo non soltanto sotto l'aspetto
della terminologia.
Quasi
completo, nei tratti fondamen
tali, l'accordo fra la teologia dell'opera aristotelica e
quella deWEpinomide. Sorprende il fatto che il critico
epicureo, in caccia di appigli polemici, non ricordi af
fatto le 55 divinit astrali della pi tarda metafisica.
Evidentemente, questa
concezione cosmologica non appa
riva ancora affatto nel dialogo aristotelico.
Conferma di ci d la notizia, fornita dallo Pseudo-
Filone nello scritto SulUeternit del mondo, che Aristo
tele abbia accusato di tremendo ateismo (8etvV]V d-eT7]T)
ifilosofi che dichiaravano ilmondo generato o perituro,
non vedendo essi in una cos grande divinit visibile
(xoaotov 5paxv frsv) nulla di superiore a un qualsiasi
manufatto. Egli stesso chiamava il cosmo un Pantheon,
che accoglieva in s il sole, la luna e gli astri mobili
e immobili; e canzonava gli avversari, dicendo come fino
allora egli avesse temuto soltanto che la sua casa po
tesse andare in rovina, per tempesta
o per logoro o per
l'insufficiente tecnica costruttiva, mentre ora c' era da
preoccuparsi che il mondo intero potesse una volta croi-
') Epin., 977 A-B, 987 B.
J84 GLI AKNl 01 VIAGGIO
lare merc le ipotesi di quei dotti, che lo demolivano gi
con le loro sole parole1).
Iltono ci noto: nella confutazione della teoria dei
fisici concernente la fine del mondo, esso di asprezza
mordente, mentre si attenua nella sostanza e si fa pi
rispettoso nel rifiuto della concezione creazionistica del
Timeo platonico, che quella a cui si allude con l'imma
gine del manufatto. lo stesso tono personale che si e
trovato nella critica della dottrina delle idee del secondo
lihro Jlspl cpilocctplx. Anche nel terzo libro, dice la
relazione ciceroniana, Aristotele espose la Bua cosmolo
gia in continuo contatto polemico con Platone. Ci deve
riguardare in prima linea la dottrina della eternit del
mondo, perch in questa che egli diverge al massimo
da Platone2). E giacche il passo non proviene da alcuno
dei trattati superstiti, e per ilsuo stile appartiene indub
biamente a un dialogo, come sua fonte non pu essere
presa inconsiderazione altra opera all'infuori del dialogo
Sulla
filosofia.
Esso era l'opera, oggi perduta ma molto
letta nell' antichit, nella quale erano manifestate en
trambe le concezioni filosofiche che secondo il giudizio
degli antichi caratterizzavano pi che ogni altra la po
sizione di Aristotele, e cio l'assunzione dell'etere come
elemento celeste e la considerazione del cosmo come non
nato n perituro. Idossografi sogliono citare, con piena
esattezza, entrambi questi elementi come motivi di no
vit, accanto alla concomitante cosmologia platonica.
Infatti, nonostante il contrasto nelle questioni sin-
') Arist.,
framnv
18 R. (Ps.
Philo, de net. mundi, 3, 10, p. 53
Cohn-Reiter).
') Arisi., framm. 26 R. <Cie. de not. deor., I, 13, 33)
Aristote-
lesgue in tertio de philosopkia libro multa turbat a magislro suo
Platone dissentens.... L'inserzione del non innanzi a disscntiens,
fatta dal Manuzio e accolta dal Rose dopo l'esempio del
Lambino,
insostenibile dal punto di vista del contenuto, ed stata dimo
strata inammissibile dal Yahlen ancbe da quello stilistico (cfr. Pia-
aberg, nell'edizione maggiore, p. 218).
LO SCRITTO SVLLA FJIOSCWA 185
gole, la dottrina del dialogo, per quanto si tratta delle
concezioni positive di Aristotele, ancora completamente
platonica. Tale , anzitutto, la fusione della
teologia con
l'astronomia. L'imputazione di ateismo, diretta contro i
seguaci di concezioni astronomiche eretiche, deriva dalle
Leggi di Platone: eppure proprio per opera di Platone,
come detto nelle Leggi, divenne appunto teologia
quell'astronomia, che prima appariva come la pi atea
di tutte le scienze 1). Con la relazione ciceroniana quadra
ilfatto che anche in. Filone la parola cosmo sia usata
nel senso di cielo . La teoria del cosmo compren
dente ins ilsole, la luna e le stelle non infatti altro
che un riflesso della cosmologia del Timeo {30 D) : Vo
lendo fare il cielo simile ai pi bello e al pi perfetto
di tutti gli enti concepibili,
Dio cre un unico vivente
visibile, comprendente
ins tutte le altre realt
viventi, ad esso affini per natura. Per Aristotele, certo,
il cielo non pi la copia visibile della idea suprema
contenente in s tutte le altre idee, l'intero cosmo intel
ligibile. Ilmondo delle idee caduto, e con esso il de
miurgo, che guardando ad esse creava il mondo visi
bile. Tanto maggior dignit metafisico-religiosa acquista
perci, ora, la copia, e cio il cosmo stesso come unit
visibile del mondo e della celeste regione degli astri,
uniche realt che all' esperienza sensibile garantissero
la soddisfazione dell' esigenza platonica, che nel flusso
del divenire dovesse esserci qualcosa di eterno e di du
raturo. Platonica anche 1' espressione Dio visibile;
e per quanto
il paragone del cielo con un pantheon, che
comprende in s ogni singola divinit, potrebbe essere
nella lettera non aristotelico ma filoniano, aristotelico
il concetto, che si ritrova anche nell' Epinomide attra-
') Leg., 821 D; 822 B-C; 898 C; 899 A. Scissione del binomio
astronomiu-aleismo: 967 A segg.
186 CM ANNI LI VIAGGIO
verso la designazione del cielo col nome di Olimpo ').
Ilsentimento del mondo, che avverte il divino nel cosmo
in questo senso tale parola un simbolo della mu
tazione decisiva, che cos si compie nella storia della
religione greca prende in tal modo il posto del vec
chio Olimpo. Le stelle sono gli esseri razionali e ani
mati, che, nella loro divina immutabilit e bellezza, Io
abitano. la teogonia dell' ellenismo e della tarda an
tichit, icui primordi sono gi in Platone.
Com' noto, la posteriore metafsica aristotelica ha
tolto al suo isolamento il principio del motore immo
bile, ed ha attribuito uno speciale motore trascendente
a ciascuna delle sfere dalle quali deriva, nel movimento
di corpi celesti, ilcomplesso delle loro progressioni, re
gressioni e immobilit. Di questa concezione nessuna trac
cia si trova ancora nel nostro dialogo. Ilmotore immobile
sovrasta a tutte le altre divinit, incorporeo e separato
dal mondo inquanto pura forma. Da esso dipende l'unit
del mondo. D'altra parte, il cielo e le stelle sono esseri
dotati di anime, e che quindi obbediscono spontanea
mente e consapevolmente alla loro legge interiore. L'am
missione di immanenti anime delle stelle esclude cos
1' altra forma d' interpretazione. Da lungo tempo si di
scuteva, nell'Accademia, circa le cause del moto degli
astri. Nelle Leggi Platone cita come ammissibili tre ipo
tesi, senza decidersi propriamente per l'una o per l'altra.
Esse devono, invero, valere senza distinzione per tutti i
corpi celesti. O bisogna immaginare le stelle come corpi
abitati da anime al pari dei nostri (e per Platonel'anima
appunto il principio del movimento spontaneo); o
1' anima non abita nel corpo astrale, ma si procura dal
di fuori un corpo di fuoco o d'aria e con esso spinge
') Per il cielo come Olimpo v. Epin., 977 B; per le stelle come
suoi yXpBTa, Epin., 981 A.
LO SCRITTO SULLA FILOSOFIA S 187
innanzi il corpo astrale; oppure, infine, l'anima to
talmente incorporea e dirige di movimento dell' astro
merc certe altre forze, oltre misura mirabili J).
L' ammissione dell' anima immanente negli astri sar
quella platonica, e corrisponde di fatto, nel miglior
modo, tanto all' energia animatrice e alla plastica sem
plicit del suo pensiero quanto alla dottrina dell'anima
come principio di ogni movimento. La seconda da lui
designata come ipotesi di alcuni (Xyo? Ttviv), e cio,
certo, di astronomi: vien fatto di pensare alle sfere di
Eudosso, per quanto sia difficile che questi abbia am
messo gi 1' esistenza di anime delle sfere. L' anima in
corporea della terza ipotesi evidentemente un eidos
trascendente, che muove la stella come causa finale, cos
come l'amato muove 1' amante. il principio del mo
tore immobile: le forze mirabili, di cui parla Platone,
sono pensate come simili al desiderio delle cose sensi
bili per l'idea e all'aristotelica
Probabilmente rimarr sempre per noi una questione
insolubile, se Aristotele stesso o un altro accademico ab
biaper primo concepito l'ideadel motore immobile e l'ab
bia applicata al problema del moto degli astri. Data la
comunanza dell' indagine, il contributo dei singoli non
pu piessere esattamente distinto. Stando al suo spirito,
si tratta di un concetto platonico, cio di un concetto
nato dal mondo ideale di Platone e che non avrebbe
potuto avere una genesi indipendente, chiunque ria
stato colui che ebbe tanta intelligenza da concepirlo
per primo. Aristotele lo applic solo al principio su
premo, che si contrappone al mondo nella sua assoluta
immobilit, mentre gli astri e il cielo sono mossi da
anime. Ci risulta non soltanto dal passo filoniano, ma
anzitutto dalle dimostrazioni aristoteliche che si sono
') Plat. Leg., X, 898 E.
188
GLI A.NNI DI VIAGGIO
conservate in Cicerone e che ora andranno esaminate.
Secondo Platone, ciascuna delle .tre ipotesi doveva va
lere senza distinzione per tutti imovimenti celesti.
Forse la
combinazione della prima con la terza, com
piuta da Aristotele, pu valere come indicazione del
fatto che egli le attinge entrambe da altri.
Nel secondo libro del De natura deorum
Cicerone
cita, accanto a prove dell' esistenza di Dio risalenti a
Cleante, Crisippo e Senofonte,
anche varie soluzioni ari
stoteliche dello stesso problema, attinte evidentemente
non alla propria lettura ma a una raccolta, gi sussi
stente, di tali dimostrazioni a), Inmolte delle prove si
trova ripetuto, e con insistenza, ci che era gi stato pro
vato. E
la fonte stessa non doveva riferire tutto di prima
mano, come anche il caso della silloge di prove del
l'
esistenza di Dio, sotto molti aspetti analoga, di cui si
vale Sesto Empirico2).
Idati riferiti da Cicerone eolio
quindi da accogliere con discernimento critico, per
quanto siano nella sostanza autentici. Entrambe le cose
risultano gi a proposito della
prima prova. Giacch es
seri viventi nascono in ogni elemento, alcuni sulla terra,
altri nell'acqua, altri nell'aria, secondo Aristotele as
surdo non ammettere l'esistenza di esseri viventi nel-
l'elemento pi adatto, per la sua finezza e per il suo
energico
movimento, alla generazione di tali esseri, e cio
nel]'
etere. Ma nella regione
eterea esistono le stelle.
dunque da pensare che esse siano esseri viventi, d' in
telletto acuto e di movimento rapidissimo.
Si giustamente
sentita l'esigenza di ascrivere questa
prova al dialogo Hsp
: ma impossibile
che
gli appartenesse in
questa forma. Abbiamo visto che
')
Cic., de 'tat. deor., II, 35, 42-44 (parziulmenle riprodotto
dal
Rose tome fiaiir.n. 23-24).
')
Sext. Emp., adv. phys., I, 49 (401, 26).
LO SCRITTO SULLA FILOSOFI
189
Il Aristotele sosteneva gi in quell'opera la teoria dell'etere
I]
come quinto elemento. La dottrina dei quattro
elementi,
presupposta
dalla prova conservatasi in Cicerone, non
deve per risalire a un' et precedente all' introduzione
del quinto
elemento, in modo da dover essere ascritta
a un' opera anteriore. Essa rappresenta un adattamento
della dimostrazione aristotelica
alla dottrina stoica de
gli elementi, che costituisce un compromesso tra la con
cezione tradizionale e quella
aristotelica in quanto
con
sidera ilfuoco e l'etere come elemento unico. La fonte
stoica di Cicerone ha conservato fedelmente soltanto
una
cosa, e cio il carattere formale della dimostrazione
analogica. Aristotele muoveva
dalla validit incondizio
nata della tesi che in ogni elemento esistessero esseri
viventi, per tutti gli elementi accessibili
all' umana e?pe-
!
rienza.
Da ci egli traeva le conseguenze per quell'ele
mento
etereo, che non era immediatamente
accessi' ie
al controllo
scientifico, e per quegli esseri che in esso
dovevano esistere. Inorigine, l'argomento
doveva quindi
essere del seguente tenore: giacche in tutti gli elementi
dimostrabile la presenza di esseri
viventi, tanto nella
terra quanto
nell'acqua e tanto Dell'aria quanto
nel
fuoco, esistono certamente esseri viventi anche nell'etere:
le stelle, che in esso percepiamo, debbono quindi essere
| viventi.
L'argomento si riconnette al Timeo (39 E), che
I
rappresenta
iquattro
elementi come popolati
da altret-
tante specie di esseri divini. L'Epinomide tden conto del
dialogo aristotelico apparso nel frattempo e della sua
ipotesi
dell'etere, in quanto ammette cinque classi di ss-
j seri divini insiti negli elementi, in luogo delle quattro
f
ammesse dal Timeo. Ma gi con la sua disposizione
degli
f
elementi essa mostra di non seguir soltanto
Aristotele,
ma di volere
inserire, con intento
conservativo, l'ipotesi
aristotelica nel Timeo. In Aristotele l'elemento etereo
[
occupa, nello spazio
cosmico, il posto pi alto, ed se-
190
CLI ANNI DI VIAGGIO
guto dal fuoco, dall' aria, dall' aequa e dalla terra. In
Filippo il fuoco conserva la sua posizione di elemento
sommo, e lo seguono 1' etere e 1* aria, e poi 1' acqua e
la terra. La dottrina platonica quindi modificata solo
in
quanto inluogo dell' aria, il cui pi alto e puro strato
ha gi inPlatone ') ilnome di etere, vengono posti due
elementi distinti). Cos, mentre YEpnomide si estrin
secamente assimilata l'ipotesi dell' etere, ha evitato con
intenzione il
punto veramente essenziale dell' argomen
tazione aristotelica. La cui
dimostrazione non si riferi
sce, come quella platonica, ad esseri divini o demonici
miticamente immaginati, ma concepita come rigorosa
prova sperimentale, e presuppone quindi che Aristotele
pensava di poter dimostrare empiricamente I' esistenza
degli animali viventi nel fuoco. Ancora nellaStoria degli
animali egli manifesta interesse per insetti che, secondo
quel clie se ne dice, volano attraverso il fuoco senza ri
ceverne danno, e parla dell' osservazione di tali esseri,
che sarebbe stata fatta a Cipro8). Ma soprattutto da
tener presente un passo di Apuleio, che manca nella
raccolta dei frammenti e che fa risalire esplicitamente
ad Aristotele la teoria dell'esistenza degli
Cfija
7tupfyova.
Vale la pena di esaminare pi esattamente la cosa, in
')
Phaed., 309 B; Tim., 55 D.
) In Epin., 984 D segg. descritta la disposizione dei cinque
clementi nello spazio cosmico; in 981 C l'etere detto aristoteli
camente rcpuTov offijia, ma qui esso ha tal nome solo perch ag
giuntosi, nella serie degli
elementi, come quinto ed ultimo, e non
per la posizione da esso occupata nello spazio come corpo pi lon
tano tra tutti dalla terra. Che nel Espi qx).oao?ix; l'etere fosse chia-
mato
rcfinTov oSfix
o Tt|iicTij o-ia risulta dalla generale
diffusione
di questo appellativo presso ibiografi, i quali attingono sempre
a quello cntto. Itrattati usano invece il termine jip&tov o>p.
LEpinomide
il primo scritto dipendente dal Espi
fiXooo<fia; che
adoperi l'espressione itpmcov apa. E anche in altre occasioni il
suo autore procede spesso sulle traccie dello scritto aristotelico
Giacch le Leggi sono ricordate da Isocrate (or. V, 12)
nell'anno
346, Io srriwo aristotelico dev'essere apparso nel 348-7
*)
Arisi., hist, an., E 19, 552 b 10.
LO SCRITTO SULLA FILOSOFIA
191
grazia, se non dei prodigiosi abitatori del fuoco, dt.1
brano di storia spirituale il cui eviluppo
essi ci permet
tono di seguire.
Nello scritto sul demone di Socrate Apuleio argo
menta (in forma apparentemente
analoga a quella adot
tata da Aristotele, e in realt mirante ad assai diverso
scopo dimostrativo e presupponente premesse
diverse) :
giacch negli elementi della terra e dell' acqua vi sono
esseri viventi, e parimenti ve ne sono, stando ad Aristo
tele, nel fuoco, nati in tale elemento e in esso dimo
ranti, e giacche in fine ve ne sono anche nell' etere, cio
le stelle (l'opinione che esse fossero animate aveva in
fatti assunto nel frattempo un valore cos dogmatico,
che si pensava di poterla considerare come un dato di
fatto sperimentabile),
esseri viventi devono dunque abi
tare, per quanto
invisibili, la sfera dell'aria: essi sono
gli spiriti aerei 3), In questa
costruzione non c' di ari
stotelico altro che l'idea degli
animali viventi nel fuoco,
secondo quanto Apuleio trascrive esattamente dalla sua
fonte. Che infatti non sia egli stesso a trasformare cosi
1' argomento,
ma tragga dalla sua fonte anche tale tra
sformazione, dimostrato da vari passi di Filone, ih cui
lo stesso argomento
volto alla dimostrazione dell'esi
stenza dei demoni dell' aria (gli angeli). A proposito de
gli animali viventi nel fuoco Filone nota parimenti,
tra
parentesi, che essi si troverebbero in Macedonia: egli
cio evita di nominare ai lettori la sua fonte pagana e
sostituisce Aristotele con la sua patria2).
Dalla coinci
denza di questi due autori, cronologicamente assai di
stanti 1* uno dall' altro, risulta che il vero argomento
') Apul., de deo Socr., Vili, 137 (p. 15, 12
Thomas).
!) Philo, de gig, 2, 7-8; de piantai. 3, 12; de somn., I,22, 135.
In quest'ultimo passo egli tralascia gli animali'abitanti nel fuoco:
di fatto, nella mutata formulazione dell'argomento che appare in
Filone-Apuleio essi non barino pi alcuna funzione utile, e soltanto
disturbano.
192 CU ANNI DI YtACCIO
aristotelico era stato trasformato da un filosofo 6toco,
di et precristiana e antecedente a Filone, il quale aveva
ridotto la sua dimostrazione cosmoteologica in una di
mostrazione demonologica. Entrambi gli elementi sono
confusi insieme, nel modo pi completo, nella parallela
formulazione di Sesto Empirico, perci affatto inservi
bile 1). Senza indagare pi minutamente a chi sia da
ascrivere la trasformazione, ci si pu contentare del fatto
che soltanto interessa per 1' argomento aristotelico Ira-
mandato da Cicerone: ebe cio in esso non mancavano
originariamente gli animali abitanti nel fuoco e quindi
icinque elementi, e che solo l'intermediario stoico ne
ha poi provocato la mancanza 5).
') Sr.xt. Emp., adv. phyt
.I, 86 (410, 26).
Qui dimostrato tanto
elle nell'aria vivono demoni, quanto elle gli astri sono esseri ani
mati: l'argomento aristotelico e quello demonologico
sono, cio,
contaminati insieme.
*} La fonte di Filone e di Apuleio facilmente riconoscibile.
Nella trasformazione, da essa intrapresa, dell'argomento aristotelico
in una prova dell'esistenza degli spiriti aerei essa seguiva VEpinom.,
984 D segg., dove l'esistenza degli spiriti astrali parimenti pre
supposta, mentre quella degli esseri aerei dimostrata.
In Aristotele, invece, gli esseri aerei devono essere conosciuti
empiricamente, perch altrimenti la sua deduzione per analogia
resta senza fondamento. Essi erano, per quel che si pu pensare,
gli uccelli: e con ci quadra allora bene il fatto che l'autore di
Apuleio combatta ampiamente proprio questa concezione. Per esso
gli uccelli sono a buon diritto terrestre animai; oltracci essi abi
tano solo la parte inferiore dell'atmosfera, com'egli dimostra alle
gando misure matematiche dell'altezza dell'Olimpo (il numero degli
stadi manca per, purtroppo, nei manoscritti), che nessun uccello,
egli dice, sorvola, mentre l'atmosfera si estende ampiamente al di
sopra di esso, ab humillimis lunae
anfractibus
usque ad summum
Olympi verlicem, e non pu in tutto quello spazio essere affatto
priva di abitanti. Inoltre, per ottenere iquattro elementi stoici in
luogo dei cinque di Aristotele, questo autore considera come abi
tanti del fuoco tanto gli mplyova quanto gli astri, e si limita
a distinguere l'etere come strato superiore e purissimo della sfera
ignea, senza attribuirgli
natura 'di elemento a s. Questa barocca
fusione di escogitazioni deinonologiche con osservazioni intuitive
e con motivi di scienza esatta della natura qoadra con l'idea che
io mi faccio della personalit spirituale di Posidonio: e che sia
questi la fonte di Apuleio, conclusione gi stata tratta da A.
Ratlike (De Apulei quem scripsit de deo Socrats libello, Diss.,
LO SCRITTO SULLA FILOSOFIA S> 193
In ogni caso, la concezione degli animali del fuoco
e l' intero argomento derivano da un unico dialogo. Im
possibile infatti riferire illuogo di Apuleio, come pur
fanno isuoi commentatori, al passo della Storia degli
animali concernenti gli insetti che volano attraverso il
fuoco, giacche l'elemento essenziale e necessario per l'ar
gomento del Ilepl cptXoaotpfac, che cio gli animali siano
nati nel fuoco e vi abbiano costante dimora, si trova
solo in Apuleio e in Filone, e non nella Storia degli
animali. Si tratta anche qui di una citazione da quello
scritto di Aristotele, che fu utilizzato pi di ogni altro
dai filosofi e dossograf ellenistici.
Ma si pu anche mostrare come la forma originaria
dell' argomento abbia influito su quella serie di scritti
circa ilproblema dell' eternit del mondo, la cui genesi
fu determinata dal Ilept cptXoaotpIa?. Si pu seguire passo
per passo il processo con cui questa letteratura trae i
suoi argomenti dall' armamentario del dialogo aristote
lico. A questo proposito abbiamo gi ricordato lo scritto
SulVetemil del mondo, tramandato sotto il nome di
Filone, che oltre il modello aristotelico tien presenti an
che altri buoni autori peripatetici come Teofrasto e Cri-
tolao. Dopo l'apparizione del libro aristotelico la Stoa
aveva messo avanti la sua dottrina della distruzione e
della palingenesi cosmica, e l'opinione del Peripato do-
Berlino 1911, p.
32). Il Rathke non ha per veduto come Posidonio,
nel suo argomento, abbia utilizzato e combinato con YEpinomide
il Ilepl di Aristotele. Ilbel libro del Reinhardt su Po
sidonio (Monaco 1921) per me troppo scettico circa il luto mi
stico-religioso della sua personalit: e cosi nega anche, a torto, che
egli abbia asserito l'esistenza degli animali ignei. L'influsso che
l'antica Accademia c l'opera giovanile di Aristotele hanno eserci
tato su Posidonio e in genere sulla stoa c oggi valutato meno di
quanto converrebbe. Se, infine, in Doxogr., p. 432, 4 viene ascritta
a Platone eadAristotelo l'asserzione di solo quattro specie di
esseri viventi, ci non che una delle confusioni in cui cade di
frequente l'erudizione scolastica di questi autori (cfr.
Diels, Pro-
leg., p. 64).
13.
"W. Jaeger, Aristotele,
594 CU ANNI DI VIAGGIO
doveva essere difesa contro le opposte istanze stoiche.
Nello scritto sopra citato la formulazione degli argo
menti aristotelici, utilizzati senza che ne venga nominato
l'autore, notevolmente modificata per l'influsso di que
sta tendenza dell' autore, vivente intorno agli inizi del
l'era cristiana e incline all' indirizzo, allora di moda,
della conciliazione di Platone con Aristotele. Si quindi
lontani dal poter considerare come aristotelico lutto ci
che a questo proposito compreso tra iframmenti. Ma,
come in Apuleio e in Filone l'idea degli animali viventi
nel fuoco, cos in questo scritto sfuggito al Rose un ar
gomento, che per quanto non sia in s aristotelico,
tuttavia formulato in connessione verbale con l' argo
mento zoogonico (per usare il termine adoperato dal
l'Epinomide). Mentre, secondo la nostra ipotesi, Ari
stotele deduceva, con ragionamento analogico, dalla pre
senza di esseri viventi negli elementi noti la vitalit degli
astri che compivano le loro orbite nell' etere, lo Pseudo-
Filone presuppone come dimostrata tale vitalit e tra
sforma la dimostrazione in un argomento contro la ca
ducit del mondo: se tutti gli esseri vivi, che dimorano
nelle regioni dei diversi elementi, quelli della terra, del
l' acqua, dell' aria e del fuoco (jiup(yova), dovessero una
volta perire, secondo analogia {'/.ai'
vaXoy(av) anche
il cielo, il sole, la luna e tutte le Btelle (gli esseri viventi
nell' etere) dovrebbero essere consacrati alla morte. Ma
ci contraddice al loro carattere divino, che verrebbe
a cadere qualora mancasse la loro eternit '). Evidente
la contaminazione dei due classici argomenti del IIsp
cpiXooocpJag. L'inferenza dalla divinit del cielo alla sua
eternit meccanicamente trasferita a tutti icorpi ce
lesti, che, con imitazione verbale del passo in cui Ari
stotele chiamava il cielo b Toaotoj bparj 0-e;, sono
') Ps. Philo, de aet. mundi, 14, 45 (C.R.).
LO SCRITTO SULLA FILOSOFIA 195
designati col nome complessivo di 6
xoaoOxo?
aJcfrrjxwv
I frewv stjSalwv x TtXat vouafret? oxpax?1). Fuso con
I esso (senza che se ne avvantaggi la logica, che non
I in genere il forte di questo autore) 1' argomento zoogo-
I
nico: se tutti gli esseri viventi dei quattro elementi noti
periscono, devono analogamente perire anche quelli del
l'etere. Che un discorso vuoto, di evidenza banale, e
concepibile soltanto quando si pensi allo sforzo, com
piuto dall' autore, di mettere insieme qualcosa di ap
parentemente nuovo ed originale combinando ifamosi
argomenti del suo modello. A noi esso rende comunque
il servigio di confermar l'idea della presenza del nu
mero quintuplice degli elementi e del carattere analo
gico della deduzione nell' argomento aristotelico rico
struito merc la critica del passo ciceroniano, tanto pi
in quanto lo scritto dello Pseudo-Filone conosce in altre
dimostrazioni, evidentemente derivanti da fonte stoica,
solo quattro elementi2).
Era impossibile distinguere 1' autentico tra le molte
plici sovrastrutture aggiunte dalla tradizione, senza esa
minare il problema degli influssi storici esercitati dal
dialogo. Per le successive dimostrazioni della divinit
delle stelle, citate da Cicerone e strettamente connesse,
a quanto sembra, con la precedente, la questione della
distinzione dell' autentioo dalle aggiunte o trasformazioni
posteriori stata posta soltanto di recente; e si pen-
i|
sato che sia aristotelico solo l'ultimo argomento
( 44),
'i del resto esplicitamente attestato come tale8). Le parole
J introduttive nec vero Arstoteles non laudandus est in
) eo, quod.... accennano a rigore a una connessione con
"|
ci che precede, ma in caso di necessit possono essere
X
interpretate come un rimando al primo argomento,
') Arisi.,
framm, 18 (33, 4 R-).
Ps. Philo, de aet. mundi, 11, 29.
*) IC. Reinhardt, Poseidonios, p. 228 segg.
Ci.1 anni di \ r.Ar:>; io
ascritto in maniera parimenti esplicita ad Aristotele; ed
allora ci che sta in mezzo appartiene ad un altro au
tore, ed stato inserito solo a causa della sua comu
nanza di natura con gli argomenti aristotelici. Si pensa
di riconoscervi la dottrina posidoniana del calore, e in
liase a ci che si detto circa il primo argomento non
certo da escludere la rielaborazione stoica. Ma isin
goli argomenti sono con tanta intenzione disposti in una
progressione graduale, che non vanno separati l'uno dal
l'altro s ci non eia necessario. La linea dell' argomen
tazione la seguente.
In primo luogo vien mostrato che 1' etere non pu
esser l' unico elemento privo di viventi, e che tale na
tura debbono quindi aver le stelle che inesso si trovano :
esse debbono essere anzi, conforme alla finezza e alla mo
bilit dell' etere, organismi viventi di altissima intelli
genza e velocit. Se infatti si esamina ulteriormente il
rapporto degli elementi con la qualit degli esseri vi
venti che li abitano, risulta che tra la costituzione spi
rituale delle stelle e le qualit vitali dell' etere sussiste
una relazione simile a quella che collega l' intelligenza
e il temperamento degli abitanti della terra alle con
dizioni di clima e di vitto della loro sede. Abitanti di
localit dotate di aria pura e sottile sono pi intelligenti,
e pensano con maggiore sveltezza ed acume che quelli
circondati da un'atmosfera pesante e densa: e lo stesso
da dire persino a proposito degl'influssi che una ali
mentazione leggera o greve esercita sullo spirito umano.
Le stelle devono quindi essere di somma intelligenza,
perch vivono nella regione dell' etere, il quale tra tutti
gli elementi quello composto delle part pi sottili,
e si nutrono delle esalazioni della terra e dei mare, ra
refatte all' estremo dall' ampio intervallo di spazio.
L'esattezza di queste conclusioni anche confermata
dall' osservazione empirica dell' inviolabile regolarit
LO SC.HITTO SULLA FILOSOFIA 197
propria del moto degli astri. Dipendente dalla natura
essa non pu essere, perch la natura non procede come
una ragione consapevole; n pu essere spiegata per
mezzo del caso, perch la costante conformit ad un or
dine esclude quei caratteri di approssimazione e d' in
calcolabile mutevolezza che del caso sou costitutivi. Essa
deve quindi derivare da un piano consapevole e da un
impulso interiore. Nell'ultimo argomento questo pro
cesso dimostrativo si eleva fino alla prova della tesi che,
corno 1' ordine e la costanza presuppongono un piano
razionale, cos la circolarit delle orbite presuppone il
libero volere di esseri agenti, giacche per natura icorpi
si . muovono solo in linea retta verso il basso o verso
1' alto e neppure si pu parlare di un' influenza esercitata
dall' esterno da una forza superiore.
Aristotelica esplicitamente dichiarata la tesi del
primo argomento,
asserente I'assurdit dell' opinione che
esseri viventi compaiono in tutti gli altri elementi e
non nell' etere, che pure fra tutti il pi appro
priato alla generazione della vita animale.
Lo pneuma vitale , secondo Aristotele, analogo all'ele
mento etereo delle stelle, che contiene in s il calore vi
tale nella sua forma pi pura 1). Ilvitalismo della pre
tesa dottrina stoica del calore, contenuta iu questo ar
gomento, ha la sua origine nella dottrina aristotelica
dello pneuma, costituente il germe della posteriore con
cezione stoica. L'ipotesi delle anime motrici delle stelle
vien qui accuratamente sviluppata fin alle sue estreme
conseguenze, ed proprio il modo in cui 1' autore del
l' argomento prende sul serio la concezione, per met
mitica, della platonica anima astrale ed applica ener
gicamente ad essa le categorie della psicologia, della
zoologia e della fisica, che tradisce la mano dol giovane
') Arisi., de gen. an., B 3, 730 b 29.
108 CLI ANNI DI VIAGGIO
Aristotele. Egli abbastanza reverente, e abbastanza le
gato dall' intento dogmatico, per non mettere in dubbio
la realt di tale concezione, ma quanto maggiore la se
riet con cui la considera e il rigore logico con cui la
investe, tanto pi rapido il processso che lo condurr
a liberarsene. La teoria dell' influsso del clima e del vitto
sullo spirito e sul corpo degli uomini platonica, e ri
corda letteralmente un passo delle Leggi Anche l'Epi-
nomide mette in connessione causale la costituzione ma
teriale delle creature terrene col disordine e con l'ir
razionalit del loro moto, e lamateria eterea delle stelle
con la loro bellezza corporea e perfezione spirituale:
nel che pu darsi che essa segua lo scritto allora ap
parso di Aristotele, o che rifletta una comune concezione
accademica 1).
Nel' IIspl tfnXoaocpfas l'analogia ulteriormente appro
fondita : le stelle sono circondate dalla pi pura atmo
sfera e il loro nutrimento costituito dalle sottili esa
lazioni della terra e del mare. Dottrina fisica, questa,
che era gi antica e che fu pi tardi abbandonata da
Aristotele.
Qui
egli se ne ancora valso come di sostegno
per la sua idea dei viventi celesti e del processo fisiolo
gico della loro vita. E di qui l'ha attinta Cleante, in
sieme con tutta la primitiva teologia aristotelica, e le ha
dato cittadinanza nella Stoa2).
')
Plat., Leg., V, 717 D; Epn., 981 E.
') In Meteor., B 2, 3o4 b 33 segg. egli combatte la teoria fisica,
che il sole si nutra delle esalazioni del mare. Tale dottrina dev'es
sere stata assai antica, perch alcuni fisici spiegavano ingenuamente,
in base ad essa, il solstizio come mutuzione del luogo di nutr.
mento . Per quanto Aristotele sorridesse dcll'interpetrazione an
tropomorfica delle Tponai. quella concezione non gli era poi tanto
aliena, giacch secondo lui il caldo si nutre dell'umido (v. p. es.
M-etnph., A 3, 983 b 23).
Se egli obietta ai rappresentanti di quella
teoria che avrebbero dovuto pensare non soltanto al sole ma anche
alle stelle (355 a 19), questa pure la slessa conseguenza che egli
medesimo aveva una volta tratto nel ITspt voootas. Da que
st'opera la concezione passata a 'Cleante (Cic de nel. deor., II
LO SCRUTO SIILI* FILOSOFIA 199
Anche la deduzione della natura animata delle stelle
dalla regolarit e dall'ordine dei loro movimenti si trova
nelFEpinomide, con una certa maggior ricchezza verbale
ma con minor rigore
dialettico, ed immediatamente con
nessa, come in Aristotele, alla questione zoogonica. Da
questa
coincidenza, finora non osservata, dobbiamo trarre
la conclusione che tanto Filippo come Aristotele espon
gono la teoria accademica allora in onore 1). La for
mulazione aristotelica sotto l'influsso diretto di Pla
tone. Nelle Leggi 2), al principio della dimostrazione
della natura animata delle stelle, detto come alcuni
affermino che il divenire di tutto accade ora, ed acca
duto in passato ed accadr in avvenire, o per natura o
per azione consapevole o per caso. Gli elementi e le cose
che ne derivano, la terra ilsole la luna e le stelle, dipen
dono tutti, secondo costoro, dalla natura e dal caso, e
per nulla dall'azione consapevole, essendo assolutamente
senz'anima. Ifisici combattuti da Platone intendono cosi
per natura la stessa cosa che intende anche 1' argomento
aristotelico, il quale, partendo dalla medesima triparti
zione, li sconfigge con le loro stesse armi: e cio un
aggregato materiale, privo di spirito e di anime. Pla
tone pone invece 1' anima come principio del divenire,
e avanza quindi 1' esigenza di un nuovo concetto della
natura). Ma vi sono in Aristotele innumerevoli passi,
in cui usato senza riguardo quell' inferiore concetto
di natura, che ormai era diventato usuale: e per esem-
J
pio gi nella seguente dimostrazione la tendenza del
1 15,40 =framm. 504 Arnim), il quale si peraltro approprialo anche
* l'inlerpretazione del solstizio (.de nat. deor., Ili, 14, 37 = framm.
501 Arnim). Commisurata al grado di evoluzione raggiunto da Ari-
j
stole]- , la fisica stoica offre frequenti esempi di simile atavismo:
una fusione di cosmologia e teologia del primo Aristotele con fisica
; preoristotelic.
1
*) Epn., 982 A segg.
f
2) Plat, Leg., X 888 E segg.
:{ Plat., Leg., X 892 C; 891 C.
200 GLI ANNI DI VIAGGIO
fuoco e dell' aria verso 1' alto e quella della terra e del
l' acqua verso il basso designata col nome di movi
mento per natura. La tripartizione di ogni accadere in
naturale, casuale e intenzionale si trova anche -nel Pro-
treptico aristotelico. E il metodo etesso di dimostrar
congrua una data tesi mediante l'esclusione di tutte le
altre tesi possibili connesso col procedimento di divi
sione proprio della tarda dialettica platonica ed ca
ratteristico per Aristotele.
Esso adoperato anche iteli' ultima dimostrazione,
che aggiunge alla precedente una pi sottile sfumatura
e la cui provenienza aristotelica esplicitamente attestata.
Ogni movimento accade o per natura o per forza esterna
o per libera volont. In quanto per natura, il movi
mento dei corpi procede sempre inlinea retta verso l'alto
o verso il basso, e non in cerchio come quello dei corpi
celesti. Ma il loro movimento circolare non si pu spie
gare neppure con l'intervento di una forza esterna, per
ch quale forza potrebbe essere maggiore di quella che
essi possiedono? Per essi non resta quindi possibile che
il movimento causato da una volont libera. Anche que
sta conclusione trova corrispondenza nell' Epinomide. in
cui si parla di una perfettissima attivit deliberante
(plcxi jfouXeuct?) delle anime astrali 1). Su di essa ba
sata la natura immutabile della necessit che dirige le
orbite delle stelle. La sua perfezione consste nella ideale
forma matematica dell' orbita circolare, pensata e in
sieme voluta dallo spirito astrale. Esso per non pu
mai modificare il suo volere, perch ogni vera perfe
zione esclude la tendenza al peggioramento. La volont
astrale ilsostrato idealmente necessario della
legge che
lo spirito dell'astro impone alla materia5). Una delibe
razione che venga compiuta al fine dell' azione presnp-
') Epin.,
982 C.
') Epin., 982 B,
LO SCIOTTO SULLA FILOSOFIA 201
pone la volont libera. Inquesto senso il concetto della
deliberazione perfettissima, espresso nell' Epinomide, co
stituisce 1' esatta integrazione di quello aristotelico della
volont libera: sono elementi consoni di un' unica co
struzione ideale 1). La dottrina della volontariet dei
moti astrali, cos apertamente contrastante alle poste
riori vedute di Aristotele, ha indotto inegatori della sua
evoluzione spirituale alle pi disperate congetture e ar
tifizi : tutto dovrebbe dipendere, secondo essi, dall' as
surdo fraintendimento ciceroniano della sua fonte 4).
Non vale la pena di combattere particolarmente questi
tentativi avventurosi, perch dall' analisi della dottrina
delle anime astrali deve ormai essere risultato chiaro che
si dovrebbe quasi ricostruire a priori, nei suoi singoli
tratti, questo grado intermedio dell' evoluzione del filo
sofo, se non ce ne fosse tramandata la notizia inmaniera
tanto inoppugnabile.
Ma per mezzo dell'ultimo argomento abbiamo anche
la possibilit di spinger Io sguardo nel processo genetico
') Il moto astrale libero, in quanto dipende da una volont
consapevole /rcpoaipso'.j) : ma questa (secondo Eth. Nic., T 5) pre
suppone la riflessione, pooXso-twJ Specie. In Eth. T 5, 1112 a 21
Aristotele combatte esplicitamente l'idea che possa esserci una (3o-
Xeooi; jtepl tiv 4T8 tov. rigettando quindi la sua precedente teoria
della volont astrale. Solo l'espressione ftpTxeiv, riferita ai movi
menti dei corpi celesti, rammenta, nel periodo pi tardo, la conce
zione primitiva. Con questa iniziale teoria aristotelica della volont
consapevole degli astri non va d'altronde scambiata l'idea che Dio,
suprema causa finale, muove il mondo in virt di una 8pe?i;, che
fa tendere tutte le cose verso di lui (cfr. Zeller, Phlos. d. Grie-
chen, II2', p. 375 n. 3). Questa veduta di Aristotele non significa
che la materia sia un principio attivo indipendente, il quale tenda
verso la forma, n presuppone che tutte le cose, comprese quelle
del mondo inorganico, siano animate. Secondo Aristotele ogni
realt tende a compiere perfettamente fcoSiSvat) il suo Ippov.
In ci consiste il suo v.aXi. e attraverso ci essa si ricollega con
tutte le altre realt (cfr. Metapk., A 10nana.... oovTvaxxat nioj).
Nella loro azione collettiva essi costituiscono la del mondo,
il cui tog Dio, realt sommamente perfetta. Ogni cosa tende
quindi a Dio, in quanto realizza il suo proprio tiXog.
*) Bernays, Die Dialoge des Aristoteles, p. 104.
202
GLI ANNI DI VIAGGIO
della fisica celeste di Aristotele, e cio della sua dot
trina dell' etere. Che l'idea dell' etere sia gi presup
posta nel dialogo, stato dimostrato sopra. Altrimenti
se ne potrebbe quasi dubitare, dato che Aristotele chia
ma naturale solo il movimento rettilineo dei corpi
pesanti verso ilbasso e di quelli leggeri verso 1' alto, de
ducendo quindi il moto circolare degli astri non dalla
loro costituzione materiale ma dalla libera determina
zione del loro volere. Viceversa, insegna nel De caelo che
vi sono cinque elementi, e che a ciascuno di essi corri
sponde una forma determinata di movimento naturale:
alla terra e all'acqua quella verso ilbasso, all'aria e al fuo
co quella verso l'alto, all'etere quella circolare1). Anzi lo
chiama addirittura il corpo che si muove circolarmente,
considerando cio questa caratteristica come costitutiva
dell' essenza dell' etere. Anche qui inegatori dell' evo
luzione aristotelica ricorrono al metodo disperato d ri
solvere in un mero gioco poetico 1' esposizione del Ilep
cpiXoaocpla? 2). Ma Aristotele ha speso troppo acume e
')
Arist., De cado, A 2-3.
) IlBernaya (I. c., p. 104) non riusciva a immaginare che Ari
stotele potesse, nel dialogo Qepl aver rinnegato' cos
pienamente il concetto fondamentale della sua cosmologia (col che
intendeva, certo, la deduzione di ogni accadere da cause natu
rali >/), e aver aderito tanto incondizionatamente alla popolare ed
antropomorfica divinizzazione degli astri. Un'opinione simile si
spiega soltanto in un'et in cui non si teneva il debito conto delle
Leggi di Platone e deH'Epmom/cie, e si subiva ancora l'influsso del-
l'atetesi zelleriana delle Leggi. La concezione platonica delle anime
astrali non ha nulla clic fare con l'ingenua fede del popolo in Elio
e in Selene. La deduzione del moto circolare degli astri e del
cielo da una causa non materiale costituiva per un platonico la
soluzione pi ovvia, perch Platone concepiva il vo; come movi
mento circolare e la nuova scoperta della regolarit e semplicit
matematica delle orbite dei corpi celesti suggeriva spontanea l'ipo
tesi che le muovesse un intelletto matematico: cfr. Plat., Tim.,
34 A, 37 C, ecc. Secondo il Timeo (47 E) ilvoOp e 1' ivdyxi) si di
vidono il compito della creazione cosmica. In de an., A 3, 406 b
26 segg. Aristotele combatte con insistenza la concezione del conti
nuo moto circolare del vog. L'abbandono di questa dottrina pla
tonica e il mutamento della concezione psicologica della vrjai;
LO SCRITTO SULLA FILOSOFIA 203
seriet in queste
dimostrazioni, e le due concezioni, come
non par che si avverta, sono reciprocamente incompa
tibili. La deduzione del moto circolare della natura ma
teriale dell'etere manifesta l'intento di dedurre senza ec
cezione ogni forma di movimento dalle leggi naturali
della materia. Ci diviene possibile solo a prezzo di una
duplice fisica, una terrena e una cosmica.
Quest'
ultima
non conosce le leggi terrestri della gravitazione.
Solo la
fisica moderna ha nuovamente abolito questa specie di
partita doppia. Dal punto di vista scientifico, essa costi
tuiva tuttavia tin progresso rispetto al tentativo, com
piuto dal giovane Aristotele e dall'Accademia, di risol
vere il problema della relazione tra la legge matematica
dell'astro YEpinomide parla effettivamente di una fun
zione legislatrice1) della volont astrale
e la materia
inerte con l'inserzione di analogie psicofisiche
in senso
antropomorfico. Siamo dunque ora in grado di vedere
come l'ipotesi dell'etere non sia stata avanzata, in ori
gine, allo scopo di spiegare ilmoto celeste in virt della
costituzione naturale dei corpi astrali, ma bens per altre
riflessioni. L'ipotesi dell'etere sussisteva prima ancora che
ad esso fosse attribuita la propriet del moto circolare.
Essa fu evidentemente occasionata dai nuovi calcoli esatti
della scuola di Eudosso e di Filippo di Opunte circa la
grandezza e la distanza del sole e della luna e degli altri
corpi celesti. L'antica concezione fsica, asserente che la
parte superiore dello spazio cosmico era costituita per in
tero di fuoco, non poteva
ormai pireggere, giacch per
la piccolezza della terra e per l'infinita estensione dello
spazio cosmico l'equilibrata proporzione degli elementi
sarebbe stata turbata dalla massa del fuoco, e anzi tutti
non poteva non far cadere insieme anche la dottrina delle anime
immanenti negli astri.
') Epin., 982 B 5pxouo XX' ox pxo|iivv?
vofioft-e-csT
(scii.
ifiuxS vyxrj vo3v xsxtij|iivr]g).
204 GLI ANNI DI VIAGGIO
gli altri elementi sarebbero stati distrutti da esso. Le
nuove ecoperte avrebbero quindi abbattuto la teoria della
trasformazione reciproca degli elementi, e con essa una
delle basi della cosmologia allora" in onore1). Pi tardi,
Aristotele costru sulla stessa ipotesi dell'etere una fisica
cosmica senza anime astrali ed aggiunte mitiche. Nel pri
mo libro del De caelo, che s'inizia efficacemente con la
nuova teoria dell'etere, troviamo ora ampiamente svilup
pata questa concezione posteriore: ma non dovrebb' es
sere troppo audace il ritenere che questo corso di le
zioni sia stato pi tardi rielaborato da Aristotele e nel
suo nucleo fondamentale risalga al periodo in cui l'ipo
tesi dell'etere era ancora nuova. Con ci quadra anche
il fatto che il suo contenuto costituito quasi esclusi
vamente dalla esposizione e dalla critica della tarda co
smologia platonica, e manifesta talora un'intonazione an
cora pienamente teologica, ampie parti di esso essendo
addirittura ricavate alla lettera dal terzo libro Ilep <pt-
Xococpfaj.
La dottrina delle divinit astrali e della natura divina
del cosmo, cio del cielo, che solo nel dialogo aristote
lico raggiunse la sua piena elaborazione, , al pari della
cosmologia platonica, l'espressione duratura del grande
influsso spirituale esercitato sul mondo filosofico del
quarto secolo dalle
scoperte dell'astronomia pi recente.
L'ipotesi della circolarit e completa regolarit delle or
bite dei pianeti e del ritorno periodico dell'originaria
disposizione degli astri nel grande anno cosmico 2) illu-
') Arist., meteor., A 3, 339 b 2 segg-, c specialmente 340 a 1segg.
8)
Quanto al
fratini).
25 di
Aristotele, incui si parla del grande
anno, per, certo, difficile che abbia ragione il Rose, quando Io
annovera tra i resti del dialogo Ilepl eptXooorpfccg. Infatti Tacito
(Dial., 16, 10 6egg) attesta che esso era citato da 'Cicerone nell'Or-
lensio, ed verosimile che questi l'avesse attinto alla sua fonte prin
cipale, il Prolreptico aristotelico. Ma il problema della pertinenza
LO SC1UTTO SULLA FILOSOFIA
205
minava della luce pi sorprendente il fondamentale con
cetto platonico della signoria ordinatrice che Io spirito
esercitava sui fenomeni materiali del mondo sensibile,
e apriva la via a fecondi rapporti tra filosofia e inda
gine sperimentale. Il primo grandioso tentativo di spie
gare il dominio della ragione sulla materia costituito
dalla dottrina delle anime astrali, la quale invero pro
cede molto al di l delle esigenze d'interpretazione pro
prie della scienza naturale, ma d'altro lato schiude, col
suo mito dell'anima, nuove e insospettate fonti all'intui
zione filosofica dell'universo. chiaro che per Platone
aveva importanza prevalente, in questa dottrina, -l' ele
mento mitico-spiritualistico, mentre il giovane Aristotele
inclinava ad essa piuttosto per il fatto che la specula
zione, icui insolubili problemi
non potevano
in ogni
modo essere scansati indefinitamente dallo spirito umano,
poteva in questo
caso appoggiarsi a dati di fatto sicuri,
se anche ammettenti pi di una interpretazione. Cos la
concezione , nel suo contenuto, eguale in entrambi, ma
nel rigoroso contesto delle argomentazioni aristoteliche
vibra uno spirito scientifico nuovo, che considera anche
ilmito, pur traboccante di valori sentimentali, come sem
plice oggetto
di ricerca metodica, e che si manifesta an
zitutto nel gusto, addirittura insaziabile, per le dimostra
zioni. Se si leggono le stesse cose nell'esposizione del
l'Epinomide, che compiacendosi, con unzione mistica,
del religioso e del misterioso accetta con piena passivit
dogmatica la dottrina platonica del cielo e se ne entu
siasma crassamcnte, si avverte inmodo anche pi chiaro
come di fronte al mito platonico sussistesse l'unica alter
nativa della ripetizione scolastica o della traduzione scien-
tifico-critica. Platone stesso ha compreso in tal modo s
del frammento all'una o all'altra opera non ha per noi, in questo
caso, importanza.
206 CU ANNI DI VIAGGIO
medesimo, e ha dato ai suoi scolari il diritto di appli
care al mito tale criterio realistico, quando lo ha presen
tato come ipotesi accanto ad altre ugualmente possibili 1).
Ma quale grande pensatore ha inteso esattamente s stes
so? Assolutamente priva di intelligenza anche la vec
chia disputa, se Aristotele abbia capito Platone. Egli lotta
con lui, stando apparentemente sullo stosso piano, per
raggiungere una miglior conoscenza; ma non lo supera
contraddicendolo, bens imponendo il sigillo della pro
pria natura ad ogni elemento platonico con cui venga
in contatto.
Ci pu esser detto anche della seconda parte prin
cipale del dialogo, cio della sua filosofia della religione.
In quest'opera infatti Aristotele non era soltanto il crea
tore della teologia ellenistica 2), ma anche l'iniziatore di
un tipo di considerazione, intimamente comprensivo e
') Plat., Leg., X
Ufi)
L.
) Dal punto di vista del contenuto-, ci che sotto questo nome
assume inAristotele ilcarattere di disciplina indipendente procede
in realt dalla tarda cosmologia platonica. Ma nella sua elevazione
a scienza speciale si manifesta un'intensa concentrazione dello spi
rito sul problema .del concetto di Dio, che qualcosa di affatto
nuovo e che segna un momento decisivo per la storia della filosofia 5
ellenistica. La teologia
aristotelica serve poi di fondamento alle \
ulteriori costruzioni di quella stoica. Nella sua tendenza monistica 5
questa abbandona, s, il Dio trascendente di Aristotele: ma per va-
'
lutare l'influsso della concezione aristotelica ha importanza deci
siva non la coincidenza di contenuto, ma tutto l'atteggiamento in
teriore della- nuova et rispetto al problema teologico, e il posto
che gli vieti fatto al centro dell'intero sistema della filosofia. Dal
punto di vista del contenuto la teologia aristotelica, con la sua
brusca distinzione del Dio supremo dalle divinit astrali, giunge
ad esercitare piena efficacia solo verso l'inizio dell'era cristiana.
Questa et aspirava a un deus exsuperantissimus, che troneggiando,
in sublime lontananza ed altezza, al di sopra degli astri, dirigesse
invisibile il mondo. Aristotele cominci a reagire energicamente
sul platonismo, e si colleg in parte a motivi della religiosit
orientale e in parte alla cosiddetta teologia negativa, nella quale
culminava l'esperienza di Dio propria dell'Oriente ellenistico, tanto
cristiano quanto pagano.
LO SCUITIO SULLA FILOSOFIA 207
nello stesso tempo oggettivo, dell'esperienza religiosa, che
l'antichit non sapeva ancora designare con alcun nome
specifico, n assegnare ad alcuna disciplina filosofica au
tonoma a fianco della metafisica. Solo pi tardi essa si
resa indipendente, sotto il nome di filosofia della reli
gione. Anche questo aspetto, d'importanza incommen
surabile per la storia dello spirito, della personalit gio
vanile di Aristotele rimasto sinora ignorato o trascu
rato, forse perch si sarebbe alterata l'immagine, ormai
convenzionalmente fissata, del metafisico e intellettua
lista puramente concettuale quando fosse venuto in chia
ro che al disotto del lavoro dialettico del suo intelletto
stava l'interiore impulso di ima viva religione, penetrante
e animante tutti ipori dell'organismo logico della sua
filosofia. La storia della filosofia della religione, nel senso
moderno della parola, deve prender le mosse dai sofisti,
e dai loro primi grandi tentativi di spiegare psicologica
mente l'essenza e l'origine della religione. Ma il razio
nalismo pu percorrer sempre tale via solo per breve
tratto, mancandogli, per ifenomeni della vita religiosa,
l'organo adeguato di percezione. Al suo periodo classico
la filosofia della religione giunge solo col giovane Ari
stotele e con la tarda Accademia platonica. Ivi sussiste
vano entrambe le condizioni essenziali per uno studio
della religione, il quale avesse insieme capacit di ade
guazione psicologica e fecondit religiosa: una raffinata
sensibilit teoretica per tutti ifenomeni dello spirito
vi s'incontrava infatti con l'atteggiamento di mistica de
vozione, nato dalla fantasia mitopoietica e simbolica di
Platone e aprente la via a nuove esperienze religiose, che
contraddistingueva quella comunit, compenetrata da un
sentimento rivoluzionario per tutti ivalori della vita.
Sta il fatto, per quanto la comune storia della filosofia
possa ignorarlo, che quasi tutto il contenuto ideale della
posteriore ed odierna filosofa della religione derivato
203 GLI ANNI DI VIAGGIO
proprio da questo ambiente. Il problema che a questi
pensatori si presenta anzitutto quello delle basi teo
retiche e delle fonti naturali dell' interiore certezza circa
le cose della religione: cio, in una parola, il problema
della realt del divino. Per la coscienza religiosa inge
nua questo non neppure un problema: tale diventa
solo con la dissoluzione della fede popolare e con la par
ticolare presa di posizione della scienza rispetto al mon
do intuitivo della religione. Comincia l'et delle dimo
strazioni dell'esistenza diDio. Infatti,dopo la rapida estin
zione del vittorioso entusiasmo che animava la critica
par la propria opera di dissoluzione razionalistica, ilsen
timento religioso, cacciato in esilio e tuttavia inelimina
bile, cerca aiuto ed appoggio presso il suo stesso vinci
tore. Le dimostrazioni senofontee dell'esistenza di Dio
sono nate da questa esigenza razionalistica. Per Platone
un atteggiamento oggettivamente teoretico di critica re
ligiosa, nei riguardi del problema di Dio, non aveva ra
gion d'essere in tutto il periodo culminante della Bua
attivit. Egli stesso era un creatore di nuovi mondi, ai
quali si poteva accedere solo in atto di contemplazione
devui T.'d-a del bene non forniva allo stato platonico
soltanto uno scopo eterno, ma. diveniva per esso anche il
simbolo di un nuovo sentimento di Dio. Era, essa stessa,
religione. Con la filosofia platonica la religione entrava
cos nello stadio speculativo e la scienza in quello del
l'ideologia religiosa. Solo nel pi tardo periodo dell'at
tivit platonica appare la riflessione sulle radici della
fede, e sulla sua conciliabilit con la scienza della na
tura. La priorit dell'anima rispetto al corpo e quella
dello spirito e della legge ordinatrice rispetto alla ma
teria cieca sono iconcelti dominanti nella teologia del
vecchio Platone. Il concetto meccanico-causale della na
tura, proprio della fisica ionica, cede il nasso a una con-
LO SCRITTO SULLA FILOSOFIA 209
cczione che deduce tutto da forze psichiche, e per la
quale, ancora una volta, tutto pieno di Dei 1).
La vera e propria dimostrazione dell'esistenza di Dio
appare per la prima volta nella filosofia del giovane Ari
stotele. Nel terzo libro IIspl egli dedusse per
k
primo l'esistenza di un essere supremo merc argomenti
di rigorosa forma sillogistica, e diede con ci al problema
quella formulazione spiccatamente apodittica, che spron
l'acume dei filosofi religiosi di tutti isecoli posteriori a
render visibile, anche all'occhio dell'intelletto, l'ineffa
bile esperienza del trascendente. Si pu ritenere che
in ogni dominio nel quale vi una gerarchia di gradi, e
quindi una maggiore o minore vicinanza alla perfezione,
!
sussiste di necessit anche qualcosa di assolutamente per
fetto. Ora. giacch intutto ci che esiste si manifesta una
tale gradazione di cose pi o meno perfette, sussiste dun
que anche un ente di assoluta superiorit e perfezione,
|
e questo potrebb' essere Dio2). C'imbattiamo qui. nel
.
'
germe dell'argomento.ontologico, che per, conforme allo
spirito della fsica aristotelica, connesso con quello te-
j leologico. In ogni serie di oggetti confrontabili, di di-
verso valore graduale, si d un massimo e perfettissimo,
anche quando non si tratti di progressioni semplice
mente pensate, ma dei gradi di perfezione dell'esistente,
Nella natura, che per Aristotele forma operante dal
l'interno e finalit creatrice, tutto graduazione, rap
porto di una realt inferiore con una realt superiore
e dominante. Questo
ordinamento teleologico per lui
una legge naturale empiricamente dimostrabile. C' dun
que, nel regno di ci che esiste, cio delle reali forme
della natura, un ente perfettissimo, che naturalmente de-
') Piai., Leg., X 899 B, Epin., 991 D.
!) JTraram. 16 R. Nei grandi pensatori della Scolastica la di-
mostrazione ricompare col nome di argumentiim ex gradibus.
14.
"W. Jaeger, Aristoteli,
210 GI-I ANNI DI VIAGGIO
v' essere anche forma reale e che, come suprema causa
finale, principio di ogni altra esistenza. Inquesto senso
va intesa la conclusione che 1' essere perfettissimo potreb-
b' essere identico alla divinit. In seno alla concezione
aristotelica della natura come rigorosa gerarchia di forme
l'argomentazione serba la sua validit e si tien lontana
dall'errore, in cui s'incorse pi tardi, di concepire l'es
sere dell'ente perfettissimo come un predicato gi con
tenuto nel concetto della perfezione, e quindi ricavabile
da tale concetto per via puramente analitica, senza ilsus
sidio dell'esperienza. La forma di tutte le forme reali
dev' essere essa stessa necessariamente reale. Identifican
dola con la divinit, Aristotele non dimostra natural
mente la realt dell'intuizione popolare di Dio, ma d
a questa grandezza, soggetta come ogni realt umana
alla vicenda del divenire, un nuovo significato, conforme
allo spirito dell'interpretazione teleologica del mondo.
Accanto a questo argomento non saranno mancate nel
dialogo anche le altre prove, a noi note dai trattati,
derivate dall'eternit del movimento e dalla necessit
di porre un termine alla serie delle cause per evitare
il suo processo all'infinito. Era ilprimo grandioso tenta
tivo di risolvere il problema di Do sul fondamento di
una salda interpretazione sistematica della natura e mer
c argomentazioni dialetticamente rigorose. Di fronte a
questo problema stava Aristotele, ma solo il pi grande
costruttore logico di tutti itempi poteva avere il corag-
gio di relegare l'intero risultato del suo enorme sforzo
in quelle semplici proposizioni. Ci non significa, d'ai- |
tronde, che sia permesso di astrarle dal contesto della
f
critica aristotelica e di considerarle per s. Esse costi-
f
tuiscono la conclusione necessaria di un sistema natura-
listico fondato sul principio della gerarchia delle forme .
j
ed elaborato sino agli estremi particolari, e ci assicurano
che la fisica era gi compiuta nei suoi tratti fondamen-
j
1.0 SCRITTO SULLA FILOSOFIA 21I
tali quando Aristotele compose il dialogo. Essa nacque
perci quando il suo autore si trovava ancora nell'am
biente dell'Accademia.
Ma Aristotele, nellasua opera, si occupava anche delle
fonti psicologiche della fede in Dio, e non per fredda
curiosit scientifica, ma bens per far rivivere anche ad
altri un'esperienza che egli stesso aveva compiuta. Av
vertiva, cio, chiaramente come anche la pi geniale
logica non giunga mai a quell'irresistibile forza della
persuasione interiore, che nasce dal demonico presenti
mento dell'anima l). Nessun uomo dell'antichit ha detto
circa l'esperienza interiore e sentimentale della vita re
ligiosa, parole pibelle e profonde di quelle pronunciate
da Aristotele in questi anni, in cui ilproblema religioso
era ancora al centro del suo pensiero. Quando,
nel dia
logo IIsp 1X000
effar,
si accingeva a trattare della di
vinit degli astri, egli parlava del sentimento di venera
zione che si prova per ci che pi alto dell'uomo. Enel
raccoglimento interiore riconosceva l'essenza di ogni de
vozione religiosa s). Come noi osiamo di entrare in un
tempio solo con animo raccolto, cos, egli esortava, dob
biamo accedere devotamente anche al tempio del cosmo,
se indaghiamo gli astri e la loro natura.
Queste
parole
avevan certo lo
Bcopo di preparare ilterreno per l'accusa
di ateismo, che poi dirigeva contro inegatori della divi-
') Anche in de caelo, B 1, 284 b 3 egli parla del concorso di
speculazione scientifica ed interna inluizione di Dio, basata sul
l'immediato sentimento (pavisCa icspl tv ftsiv] : distinguendo,
quindi, chiaramente l'nna cosa dall'altra. Platone fu probabilmente
il primo che trasform il concetto del jiaviecotiai interiore, gi
usato dai poeti per designare la previsione di eventi esterni, dan
dogli il senso filosofico di un'intuizione non di cose future, ma di
celate e profonde relazioni e connessioni della realt. E Aristotele
fu il primo, infine, che lo rifer al problema del rapporto di scienza
e fede, e del sapere e dell'intuire fece due forme, reciprocamente
commensurabili e cooperanti, della coscienza religiosa.
') Framm. 14 R.
212 GLI ANNI Dt VIAGGIO
nit e indistruttibilit del cielo e delle stelle 1). Alla fine
del suo scritto Sulla preghiera era detto: Dio c spirito,
se non qualcosa di pi alto che lo spirito.
Quale
signi
ficato poteva avere una trattazione sulla preghiera,
se
non quello di dimostrare come non apparisse indegno di
un filosofo l'accostarsi pregando alla divinit, quando si
riflettesse che Dio spirito o pi che spirito, e che solo
nello spirito un mortale giunge alla sua sfera? 2). Ts'
Kant n Schleiermacher hanno segnato iconfini che sepa
rano scienza e fede, intelletto e sentimento con maggior
nettezza di
quanto abbia fatto l'autore delle dimostra
zioni speculative dell'esistenza di Dio con la sua classica
sentenza: chi subisce l'iniziazione non deve apprender
nulla con l'intelletto (parilv) ma bens vivere un'espe
rienza interiore (ttkS'sTv), e cos entrare in una certa
disposizione d'animo, dato che di tale disposizione egli
sia capace :
s).
Non un caso che la formulazione di
questa cos importante verit si ricolleghi alla religione
misteriosofica. Nel culto degli antichi Dei faceva difetto
quella relazione personale del devoto con la divinit,
che imisteri ponevano invece inprimo piano gi col loro
esclusivismo, e che traeva alimento dalla gerarchia delle
iniziazioni e dalla distinzione del fervore con cui isin
goli credenti le ricevevano. Ma era appunto questo
fat
tore psichico, e non il significato spirituale del loro
*) Cfr. sopra, p. 183.
8) Arist., framm. 49 R, L'energico rilievo dato alla trascen
denza di Dio al termine di uno scritto sulla preghiera deve lo
gicamente aver avuto per scopo l'applicazione di tale verit ri pro
blema del modo in cui convenisse pregare. L'idea della preghiera
compiuta in spirito e verit risponde a un'esigenza sorta in seno
all'ambiente platonico, merc la quale lo spirito filosofico dell'At
tica ha ridato la religione all'uomo del- quarto secolo. Che il van
gelo giovanneo (4,24) abbia modificato il suo contenuto, sostituendo
al vog il
5tv0|.ia (certo senza conoscenza letteraria di Aristotele)
non toglie nulla al significato
che questo fatto ha per la storia
dello spirilo.
sj Framm. 15 R.
LO SCRITTO SULLA FILOSOFIA S> 213
contenuto, a determinare l' appassionato interesse che
ogni vivo ambiente religioso nutr pei misteri sin dalla
fine del quinto secolo. Come frequente il caso che solo
la lingua e la simbolica dei misteri dian forma e co
lore, in Platone e nelle opere giovanili di
Aristotele,
all'espressione del nuovo sentimento religioso! La no
zione, acquistata nei misteri, che la religione possi
bile pel filosofo solo come devozione e venerazione per
sonale, come esperienza di una natura a ci particolar
mente sensibile, come commercio spirituale dell' anima
con Dio, apre senz'altro Pera del dominio di un nuovo
spirito religioso. Inestimabile l'influenza che questi
concetti esercitarono sull'ellenismo e sulla religione spi
ritualistica che vi si veniva formando.
Aristotele deduce la certezza soggettiva dell'esistenza
di Dio da due fonti: dall'esperienza
del potere demonico
dell'anima, la quale, negli istanti in cui si libera dal
l'elemento corporeo, cio nel sonno o nell'imminenza
della morte, attinge la sua vera natura e spinge il
suo occhio veggente attraverso l'avvenire, e dalla con
templazione del cielo stellato').
Questa
deduzione non
da intendere in senso storico: essa non concerne gli uo
mini delle et primitive, ma bens include in se idue
grandi miracoli che la semplice cognizione intellettiva
degli intenditori non riesce a spiegare, e che permangono
come residui irriducibili di fronte alle analisi del razio
nalismo naturalistico. Neil' Accademia era sempre stato
vivo l'interesse per la mantica e per la parte irrazionale
ed oscura della vita psichica; e da essa traeva anche ori
gine la fervida esperienza della religiosit cosmica. Non
altro che il sentimento religioso del mondo, vissuto dal
l'ambiente platonico, era ci che Aristotele chiudeva qui
in una formula. Anche questa si ricollega d'altronde a
') Framm. 10 R.
214 GLI ANN! DI VIAGGIO
Platone come a suo modello. Le Leggi deducono la fede
in Dio dalle stesse due fonti, e cio dall'essenza eter
namente rinnovantesi (cvao? og(x) della vita psichica
e dalla contemplazione dell'immutabile ordinamento de
gli astri1). Nessun'altra formula avrebbe potuto meglio
esprimere il contenuto religioso del platonismo, nella sua
verit superiore al tempo e libera di ogni mutevole ele
mento dogmatico. Nella storia dello spirito essa ricom
pare, in sempre nuove manifestazioni, come simbolo del
l'estrema ed inattaccabile posizione dello spirito di fronte
al disperato assalto della materia e del caso. Si rammen
tino le parole di Kant nella conclusione della Critica
della ragion pratica: due cose riempiono l'animo d am
mirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quan
to pi spesso e pi a lungo la riflessione si' occupi di
esse: il cielo stellato sopra di me e la legge morale in
me. La trasformazione del primo motivo, cio dell'eterna
essenza dell'anima, secondo l'espressione platonica, nella
legge morale caratteristica per la differenza dello spi
rito kantiano da quello platonico, per quanto la prima
origine di tale modificazione sia da far risalire ad influsso
stoico. Certo, Kant non lo dice, ma nelle sue parole si
avverte chiaramente che ammirazione e venerazione
sono di natura religiosa, e che in origine esse erano ci
tate addirittura come fonti della fede nell'esistenza e
nell'azione della divinit.
Anche in Aristotele si ritrova immutato il secondo
argomento, mentre in luogo del primo, e cio del mira
colo della vita psichica universalmente considerata, sono
poste le energie chiaroveggenti, che dormono nel fondo
dell'anima e che si destano solo quand'essa si libera dal
corpo.
Questa
concezione dell'anima platonica. Anche
il riconoscimento realistico di fenomeni occulti, inacces-
') Plat., Leg., XII 966 D
10 SCRITTO SULLA FILOSOFIA 215
sibili alla scienza, contraddice alla posteriore opinione di
Aristotele, che nello scritto circa isogni combatte am
piamente simili concezioni1). Si vuol forse vedere an
che in tutto ci soltanto una concessione allo stile dia
logico? Ma la posizione rispetto al problema della man-
tica identica a quella che si manifesta nell' Eudemo.
Nulla mostra pi chiaramente quanto profonde siano le
radici che Aristotele affonda nel terreno dello spirituali
smo come ilfatto che egli, ancora per un certo periodo
dopo l'abbandono della dottrina delle idee, tenga fermo
al concetto platonico dell' anima e insieme con esso,
senza dubbio, anche alla dottrina dell'immortalit. An
che Posidouio la consider sottintesa nelle parole di que
sto passo '). E l'idea delle due fonti della fede in Dio
') In Espi tt)j
jcaft' &7tvov jiavcoois, 1, 462 b 20, Aristotele
nega l'esistenza di sogni veritieri, inviali dalla divinit: cfr. 463 b
12. Invece Plat., Tint., 71 A-E e Epin., 935 C sono allo stesso livello
di Espi (piXoooJtaCi framm. 10.
Posidonio ha accolto il passo- relativo alla facolt chiaroveg
gente dell'anima (framm. 10) nel suo scritto Sulla montica, che Ci
cerone ha posto a base della sua trattazione in de div., I, 63, come
del resto anche molte altre volte nel corso di tale opera.
Sext. Emp., adv. phys.,
I20-21 (395.6)
'AptOTOtXr;{ &n SusTv
pySn ivvotav S-s&v IXsys
vivai
. . . iXX' it pv tSv itspl ti)v
<jn)X4v ouppavvivttDV 8i toOj iv
totg &jtvo: ytvo[iivou tatr(
v3-ooa:ao[ioi>s xal tj jiavtsias.
(21) 6tav cpil o tv, iv t<j5
&revov xaO-" iaotv Yivtjtai f,
c}j0X*S, tt vqv Xbiov xoXapoaa
9civ
npopavTsosxal
ts xal itpoa-
popssi t
iiXXovva.
ToiaTt] 8
isti xal iv Tj xat& tv 8-lva-
tov
xtBP"83'ai'
xoSxeTai t
'oOv xal tv noiijTv
"Oprjpov toto -apat7;paav-
Cic., de div., I63.
(63) rum ergo est sonino sevoca-
tus animus a societate et a con
tagiane corporis, turn meminit
praeierilorum,
praesentia cerrut,
futura
provide
t._ itaqua appro
pinquatile morte multo est divt-
nior. (64) divinare autemmorien-
tes ilio etiam
exemplo
confirmat
Posidonius, quod adjert....
216 CU ANNI ni VIAGGIO LO SCIUTTO SULLA FILOSOFIA 217
fu parimenti attinta a questo dialogo dalla Stoa: cos,
quando Cleante la pone sullo stesso piano delle ipotesi
di Prodico e di Democrito circa l'origine della religione,
dimostra di averla interpretata erroneamente in senso
storico ;i).
II grande influsso che lo scritto aristotelico esercit
sull'ellenismo dimostrato anche dal celebre passo, ripe
tuto in tutte le teologie stoiche, che si conservato in
Cicerone e che appartiene certamente alla dimostrazione
dell'esistenza di Diodata nel terzo libroIlep cptXoootpfa? 2).
Per l'energia suggestiva, con la quale esso esprime l'irre
sistibile esperienza del carattere divino del cosmo, il
passo merita intera lettura. Se ci fossero degli uomini,
iquali avessero sempre abitato sotto la terra in buone
e splendide dimore, adorne di statue e pitture e fornite
di tutte quelle cose di cui abbondano coloro che si sti
mano felici; se essi non fossero per mai saliti sulla
terra e avessero solo sentito parlare dell'esistenza di una
certa natura e potenza divina, e dopo qualche tempo,
spalancatasi la terra, fossero potuti uscire da quelle loro
xa" itsitoixe y.p xv jav U- ex quo et illud est... ci Homerici
xpoxXov 4v
tifi
iva'.pa&a'. itpoa- Hcctoris, aiti moriens provili-
|
YOpeovTK sspt xi;; 'E'/.topo; quam Achilli mortemdenuntiat.
va'.pxsiop, xiv S* "Exxopa aspi
xi)p 'Ay.iXXujp xsXsuxrjg.
Le parole aristoteliche npoiiavxssxat xs xeni npoayopshe'. x
gXXovxasono state riprese da Posidonio nella sua definizione
della niantica: praesensio et praedictio
futuri.
Il numero degli
esempi stato da lui accresciuto con l'aiuto della sua ricca, e
subito riconoscibile, erudizione. Tra essi non manca quello del so
gno di Eudemo (S3); e Platone, iPitagorici, Eraclide. l'ontico sono
stati, secondo quanto era da aspettarsi, tenuti presenti in modo par
ticolare (4-9; 60-62). Anche qui Posidonio si mostra fortemente in
fluenzato dall'opera giovanile di Aristotele.
')
Cleante, presso Cic., de nat. deor., II 5, 33 (framm, 528
Arnim)
determina quattro motivi della genesi- della fede in Dio:
il primo e il quarto derivano dall'aristotelico Ilspi tXoxoificcg,
gli altri du- da Democrito e Prodico.
a) Framm. 12 K,
dimore e pervenire nei luoghi che noi abitiamo;' quan
do ad un tratto avessero veduto la terra e il mare e
il cielo, e avvertita la grandezza delle nubi e la forza
dei venti, e scorto ilsole, e insieme con la sua grandezza
e bellezza avessero conosciuta l'attivit con la quale, dif
fondendo la luce per tutto il cielo, esso preduce il gior
no; se poi, oscurata la terra dalla notte, scorgessero il
cielo tutto trapunto e adorno d' astri, e le fasi della luna
crescente e calante, e le nascite e itramonti e le orbite
immutabilmente fissate per l'eternit di tutti questi corpi
celesti: se essi scorgessero tutto ci, riterrebbero certo
che gli dei esistono e che tanta grandezza tutta opera
loro .
La prima cosa che colpisce, qui, l'intrinseco rife
rimento alla comparazione della caverna contenuta nella
Repubblica platonica. Questa
fornisce una grandiosa rap
presentazione intuitiva all'esperienza fondamentale della
filosofia platonica, e cio alla trasvalutazione del mondo
visibile in mondo di mere ombre e alla contemplazione
del vero essere, la quale separa ilfilosofo, nella sua soli
tudine, dai propri fratelli. Nella comparazione aristote
lica spira invece un nuovo sentimento nel mondo. Isuoi
uomini non hanno vissuto nelle caverne: sono uomini
moderni, sazi di civilt e deformati da essa, che come
talpe ai seppelliscono nel lusso privo di luce e d'anima,
cercandovi la loro dubbia felicit. Egli immagina che
un giorno salgano alla luce e contemplino lo spettacolo
che egli stesso scorge : l'incommensurabile prodigio della
realt, la divina costruzione e animazione del mondo.
\Egli insegna loro a contemplare non un sopramondo,
ma quella stessa realt che a tutti visibile e che tutta
via nessuno vede. Aristotele consapevole di essere il
(
primo tra iGreci che contempli ilmondo reale con gli
iV
occhi di Platone. Un simbolo di tale sua concezione della
propria missione storica costituito dalla premeditata
218 CLI ANNI DI VIAGCIO
trasformazione dell'immagine platonica. Ci che egli ha
da sostituire al mondo delle idee la considerazione
religiosa del cosmo, la quale contempla il prodigio delle
sue forme e disposizioni e conduce al presentimento del
suo reggitore divino.
All'Epinomide, che inmodo egualmente deciso ricon
duce il problema teologico nel centro della filosofa, noi
dobbiamo la conoscenza della tenace opposizione, con la
quale queste alte speculazioni furono accolte tra iGreci.
Secondo la concezione popolare greca la conoscenza della
divinit, la gnosi degli Orientali, per il mortale qual
cosa di precluso in eterno, e il disperato indagatore, che
tende a impossessarsi del frutto proibito, unuomo infe
lice. Anche Aristotele, nell'inizio della Metafisica, bia
sima la ben radicata avversione degli Elleni alla ecces
siva curiosit (titptzpyla) del pensiero che si spinge au
dacemente troppo inalto. Pivolte egli combatte la mas
sima dell'antica saggezza ellenica, che il mortale debba
avere animo mortale, ed esorta, con profonda commo
zione, a vivere sul piano dell'eterno1). In linea di prin
cipio, la teologia divent possibile pei Greci solo quando
la scoperta delle leggi celesti condusse all'ammissione
delle anime astrali, e quando sicure conoscenze circa gli
Dei visibili aprirono la strada a una teologia basata
sull' esperienza, secondo l'esatto metodo scientifico del
l'astronomia. A ci si aggiunse l'influsso orientale, se
condo quel che dice YEpinomide e che altre testimo
nianze confermano. Il socratico conosci te stesso , mo-
') Epin., 988 Axs i pijBsig tcots tSv 'EXXvwv,
i
o
XP
tept tk 8st Jtois -paynaicsoD-aL 8vyjto{ Bvtcij, itfiv B
ToOttp Biavor)8r,vcu -rovavctov. In 988 B il Sstov fivsu eS-veo.
Gli stessi concetti tornano, con risonanze verbali, in Arist., Metaph.
982 b 28 segg., e cfr. anche Eth. Nic-, K7, 1177 b 31 ;) ypi) B xn
to; !teipivo8vTg (p. es. Epicharm., frarnm. 20 Diels; Eurip.,
Bacch., 395; 427 segg.) vOpiTcva Cfpovev vihpoijioy Svia oB 9vy(T
tv
9vJ]tv, XX'
Itf*
Soov IvBiys-cat
49avaTsiv.
LO SCRITTO SULLA FILOSOFIA
219
rivo essenziale della saggezza apollinea, si converti al
lora nel suo opposto.
Nella sua Vita di Socrate, il peri
patetico Aristosseno narrava come un Indiano si fosse
incontrato in Atene con Socrate e lo avesse interrogato
circa la sua filosofia. Avendogli Socrate risposto che cer
cava di comprendere la vita umana, l'Indiano gli pro
spett la vanit di tale intrapresa, non potendo
l'uomo
conoscere s stesso senza aver prima conosciuto Dio1).
Ci ha l'aria apocrifa, ma tuttavia non fa che esprimevo
in forma leggendaria l'opinione generale della tarda Ac
cademia, sintetizzata
daWEpinomide nel suo programma
di riforma religiosa. Secondo questo programma,
la dot
trina astrale e la teologia dell'Oriente doveva esser fusa
con la religione
ellenico-delfica, affinch fosse promosso
il progresso religioso del mondo greco 2). Stando all'opi-
') Aristoxen., framm. 31 Mueller. Della presenza dell'Indiano
ad Atene parla anche il frammento di Aristotele (32 Rose) conser
vato in Diogene Laerzio, li 45, che, se fosse autentico, potrebb'es-
scre ascritto solo al primo libro Hepl tpiXoaoipias- M" '.1 Rose ha
avuto buone ragioni ad annoverarlo tra iresti dello spu. ;o Haytxg,
perch il suo contenuto non conviene ad Aristotele. La massima
affinit con la teologia attribuita al presunto Indiano, e in realt
propria della pi tarda fase del pensiero platonico, s' incontra nel
Proireptco aristotelico
(la cui esigenza di una conoscenza di Dio
come fondamento dell'attivit umana sopravvive in Eth. Eud., 6 3,
1249 b 13-21) e nell'Alcibiade maggiore, che P. Friedlander (Der
grosse Alcibiades eirt Wag zu Plato, Bonn 1921) ha di recente
tentato di dimostrare autentico, assegnandolo alla giovinezza di Pla
tone. Il dialogo culmina nella tesi, trattata in modo minuzioso ed
alquanto scolastico, che l'esortazione delfica EvoIH oskutv realiz
zabile solo nell'intuizione che il voO?
raggiunge di s stesso rispec
chiandosi nella conoscenza di Dio (Ale., 132 E-133 C). Quest'ultima
diviene con ci il vero e proprio centro, in cui convergono tutti i
problemi etici, politici e pedagogici, che la scuola di Platone aveva
ereditati da Socrate. La medesima riduzione di tutte le questioni
morali, dell' eBaiuovtcc e dell' psxri, alla conoscenza di Dio so
stenuta anche dall'Epinomide. L'Alcibiade evidentemente un ten
tativo, compiuto da uno scolaro di Platone all'incirca nello stesso
periodo in cui nacquero gli altri scritti ricordati, di applicare la
teologia ai problemi della filosofia giovanile di Platone e di fon
darli su un saldo principio dogmatico, cio sulla mistica della tarda
dottrina platonica del vcB;.
*) Epin., 987 D-988 A.
I
220 CLI INSI DI
VI,ACCIO
nione dell'autore, che evidentemente manifesta la ten
denza dominante nell'Accademia {giacch improbabile
che egli, a conclusione delle Leggi platoniche, esponga
soltanto aspirazioni personali) la via che conduce a tale
meta quella della mistica. Al pari di lui e di tutti gli
Accademici, Aristotele stato invero sempre dell'opi
nione che la cognitio Dei sia concepibile solo come auto
coscienza della divinit medesima. Egli descrive questo
processo come qualcosa di eccezionale, soverchiante la
misura umana. U soggetto della conoscenza lo spirito
che penetra in noi, e che perci vieti. detto fruposflev
eatuiv e t fklov Iv
Y/inv
: per sua opera che in noi
interviene la conoscenza di Dio. L'autore dell' Epino-
mide parla addirittura della partecipazione del singolo
contemplante all'unico spirito, mentre Aristotele insiste
tuttavia pi sulla trascendenza di Dio che sulla sua uni
ficazione con Io spirilo umano1). Essenziale in ogni mo
do, per la comprensione dell' influsso che il suo pensiero
ha esercitato storicamente, resta il fatto ohe Aristotele
abbia respirato per lunghi anni in tale atmosfera, e che
in essa sia nata la sua metafisica, per quanto grande
dal punto di vista logico sia stata poi l'evoluzione di essa
rispetto al primitivo
punto di partenza. La giustifica
zione del tributo d'onori divini alle stelle, non confinate
nei limiti di alcun paese o di alcuna nazione ma illu
minanti tutti ipopoli della terra s), e alla trascendente
divinit celeste, che su di esse troneggia, inaugura l'e
poca dell'universalismo religioso e filosofico. Intal modo,
come un fiume placa la sua ultima onda nel mare, la
cultura attica sfocia in quella cosmopolitica dell'elle
nismo.
')
la Metaph., A 2, 983 a 3-11 la conoscenza ctie si ha di Dio e
identificata con la conoscenza che ha Dio;e per
l'unificazione dello
spirito umano con quello divino cfr. F.pin.,
986 D.
')
Spia., 934 A.
in.
LA PREVIA METAFISICA
1.
Il problema.
L'importanza del
dialogo Hepl cpiLoccxplas non esau
rita dal fatto che merc esso stato possibile, come si
vieto, richiamare invita iltratto della biografia aristote
lica che separa il periodo dell'Accademia
da quello del
Liceo. Esso ci permette
infatti di fissare un primo punto
fermo per ricostruire lo sviluppo della visione aristote
licadel mondo eper
analizzare, da un angolo visuale sto
ricamente esatto, la Metafisica.
Leopere giovanili stanno
ancora su un piano affatto diverso da quello di tale
trattalo; ma quaf la posizione che in rapporto ad esso
manifesta la dottrina del classico
dialogo incui era pub
blicamente compiuto il distacco da Platone? Non pos
siamo, naturalmente, trasferir senz'altro le conclusioni
dell'analisi dei frammenti nell'interpretazione dei testi
della
Metafisica
,che sono invero anch'essi
frammentari,
ma in ogni modo incomparabilmente pi'compkti.
Ma
e l'analisi della
Metafisica
ci conduce di perse
stessa sulle
medesime tracce, ecco che "la ricostruita fisionomia del
dialogo acquista per noi importanza anche per questo
aspetto.
Iconcetti fonaamcntali della Metafisica
,erano..senzo
222 GLI ANNI DI MAGGIO
dubbio gi saldi nel pensiero di Aristotele al tempo
dlia"sua composizione del dialogo. Pur se sapessimo sol
tanto ohe vi era- professata la dottrina del motore inimo-
bile, saremmo~pef~clo
gi certi cite esso
doveva..jpresup-
porre
ilconcetto aristotelico di sostanza, con. rjiTg]|i , di
materia e forma, potenza e atto. Anche le tre serie di
"indagini, in cui si distingueva l'architettura' delZdlalogo..
-
[e cio la ricerca stonc_la criticailelle_idee-e-lA--eo-
struzione speculativo-teioIogicaj_B ritrovano nella Metafi-
sica, la prima nel primo libro, l'a seconda ne.Iiliri.finali
e qua e l in tutta l'opera, la terza nel libro A. Pidif
ficile decidere in che misura abbiano avuto_corrispon
denza nel dialogo icosiddetti libri principali della Meta
fisica, che trattano della dottrina della sjtetanjleUa
potenza e dell'atto. 0 Aristotele (si potrebbe pensare) ha
considerato queste ricerche troppo astruse ed esoteriche
per la pubblicazione, o solo il caso che non ci ha
conservato nessun
frammento di questa1 parte. In ogni
modo esse non avrebbero potuto occupare nel dialogo uno
spazio cos vasto come 'quello conquistato nella Meta
fisica, nella quale, specialmente se non si tien conto del
l'introduzione (A-E), essesoverchianodi granlungatutto
il resto. Viceversa1 la teologia era esposta in modo assai
pi ampio che nel libro
A giacch dalle testimonianze
che ad essa si riferiscono apprendiamo moltecose, di cui
non. avremmo idea se conoscessimo soltantola
Metafisica.
La dottrina delle anime astrali ci trasferisce senz'altro in
una fase pi antica di sviluppo.
molto probabile che
se possedessimo maggior parte del dialogo, la1 differenza
si manifesterebbe ancora pi notevole. Ci parrebbe co
stituire una prova della tarda composizione della Meta
fisica, che dovrebbe allora essere ascritta all'ultimo pe
riodo dell'attivit
aristotelica. E ci si accorderebbe pie
namente con la comune opinione, giacch fin dai tempi
dell'Impero
romano convinzione diffusa che la Meta-
LA rltlMA METAFISICA
223
j
fisica
sia opera del vecchio Aristotele, da lu lasciata in
compiuta 'alla sua morte.
Ilquadro delle cose cambia per altro completamente
quando si tenga conto dei risultati ottenuti dall'analisi
della Metafisica.
La genesi del libro che reca tale nome
assume in questo
senso importanza per l'interpreta-
j zione della genesi della stessa speculazione
metafisica 1).
Non lecito considerare come unit ibrani raccolti nel
corpus metaphysicum, e di porre a base del loro con-
! fronto una categoria comune, ottenuta facendo la media
di elementi affatto eterogenei. Come ho dimostrato
al
trove, l'analisi conduce per ragioni: interne ad ammettere
stratificazioni di diversa et, e la tradizione conferma
che la silloge, che oggi c_i_s jrresenta
col nome di Meta
fisica
,_ stata mes6a insieme solo dopo 1-a morte
JJeTfio-
Bofq,__Crto,
le indagini si limitavano finora ali storia
del testo della
Metafisica
in quanto essa si evolse dopo
la morte di Aristotele, e cio all-a fortuna libraria della
sua eredit scientifica. La descrizione di tale storia co
stituiva senza dubbio il primo passo dai fare. Ma essa
aveva importanza immediata solo per la storia degli
influssi postumi dell' aristotelismo, e la fatica epesa a
tale scopo non era comunque affatto proporzionata al
guadagno che essa procacciava per la conoscenza del pen
siero e della personalit
di Aristotele. Solo il tentativo
d'intendere organicamente lo stato di tradizione della
Metafisica
infunzione della forma interna2) del suo pen-
! siero torn a dare significato e importanza al lavoro cri-
[ tico. Ma dal problema
della esteriore unit letteraria
; degli scritti pervenutici sotto il nome di
Metafisica
esso
;
condusse subito a quello della loro interiore unit filo-
l) Cfr. la mia
Entslehungsgcschichle der Metaphysih des A'!-
stoteles, Berlino 2912.
*) Cfr, Enlstehungsgesch. d. Met. d. A-, pp. 150, 161.
224 CU ANNI DI VIAGGIO
soica, e con ci all'analisi cronologica e genetica. Iprimi
passi per questa nuova via furono compiuti da me nel
libro sulla Genesi della
Metafisica
: ma io vi ero ancora
troppo estrinsecamente dominato dalla vecchia imposta
zione filologica del problema (tendente a giustificare la
composizione dell'opera e la sua suddivisione in libri,
nella loro forma tradizionale) per poter approfondire i
nuovi risultati fino a ricavarne le ultime conseguenze so
stanziali. Il problema della cronologia, che gi allora
condusse, in un punto, a un risultato certo, dev'essere
ora prospettato di nuovo dal punto di vista dell'evolu
zione filosofica di' Aristotele: e ci render inevitabile,
nel particolare, qualche ripetizione. Ma esse saranno
giustificate dal contesto delle indagini.
Prima di entrare nella questione cronologica op
portuno determinar brevemente, ancora una volta, ci
che nell'odierno ordinamento degli scritti aristotelici di
pende dall'opera compiutadagli editori dopo la sua morte.
Questo
ordinamento non dovr cos, logicamente, darci
pi alcun pensiero. A questo proposito io mi baso sui
risultati della mia precedente ricerca.
Iredattori antichi erano lontanissimi dal moderno
principio filologico di giustapporre ci che cronologica
mente prossimo, anche a ecapito dell'effetto comples
sivo.
Quelli
che si occuparono deUf edizione degli scritti
postumi di Aristotele erano dei filosofi. Molto essi avreb
bero dato per far risorgere dalle preziose carte super
stiti il quadro pi fedele possibile di quel sistema di
prima filosofia alla cui costruzione esse miravano, se
questo desiderio non fosse stato attraversato dall' incom
pletezza ed incongruenza del materiale. Assolutamente
indubbio, infatti, die gli stessi editori non credettero
che l'ordinamento da loro scelto bastasse a tramandare
alla posterit il testo completo delle lezioni di metafi
sica. Essi ebbero la coscienza di ricorrere a una eolu-
T.t PRIMA METAFISICA 225
zione di compromesso, la quale soddisfaceva solo nella
misura in cui Io permetteva la condizione del materiale.
L'appendice al libro introduttivo, il cosiddetto piccolo
a, segue al grande A solo perch non si pot collocarlo
in nessun altro luogo. Esso il resto di un complesso
di appunti presi alle lezioni da Pasicle, un nipote del
l'aristotelico Eudemo di Rodi 1). A B e P sono tra loro
connessi: viceversa una buona tradizione bibliotecaria
attesta che A sussisteva ancora nell'et alessandrina come
scritto indipendente.E una breve trattazione, che serve
di passaggio al complesso Z H 0.
Questo
costituisce una
unit coerente in s, ma problematica appare invece la
sua congruenza coi libri precedenti. Del tutto indipen
dente I, una trattazione sull'ente e l'uno; e di qui
in poi viene a mancare in generale ogni nesso interno
ed esterno. K contiene soltanto una diversa redazione dei
libri B r E, con un'appendice finale di estratti dalla
Fisica, che in s non sono meno aristotelici di qualsiasi
altra parte di questa silloge di manoscritti, ma sono
privi di ogni connessione col contesto. Similmente, un
estratto dada Fisica inserito nel libro A. A un'esposi
zione indipendente, che offre un quadro d'insieme del
l'intero sistema- metafisico, ed del tutto conchiusa in
s, senza alcuna traccia di connessione col resto. Ilibri
finali MNnon hanno alcuna relazione con ci che pre
cede, secondo ci che fu gi notato dagli antichi e che
indusse, in molti manoscritti, alla loro trasposizione in
nanzi a K A, senza che per ci risultasse costituito un
') Asclepio incorre in un equivoco quando, nel suo commen
tario alla
Metafisica
(p. 4, 20 Hayduok), riferisce al grande A que
sta notizia, a lui pervenuta attraverso la tradizione della scuola pe
ripatetica. Egli ha evidentemente capito male, e ilsuo commentario
non c infatti altro che la trascrizione di un corso esegetico tenuto
da Ammonio. La notizia esatta data dallo scolio del codex Po'
risinus al piccolo a (cfr. Entstehungsgesch. d. Met., p. 114).
15. AV. Jaxuue, Aristotele.
226 CLI ANSI DI VIAGGIO
nesso pi plausibile. Pi che con ogni altro libro essi
mostrano parentela coi primi due.
In quale et e contingenza sia nato, caso per caso,
questo materiale, e come esso sia da valutare per la ri
costruzione della filosofia aristotelica, pu essere chia
rito solo da una minuta indagine, In ogni modo, affatto
illecito partire dal
presupposto
della sua omogeneit
filosofica, per nascondere iproblemi che esso pone ad
ogni passo anche dal punto di vista del contenuto. Da
respingere ogni tentativo di ricostituire coi brani su
perstiti una postuma unit letteraria, merc la trasposi
zione o la esclusione di libri. Ma non, meno da rigettare
la precipitata ammissione della loro unit filosofica
a scapito delle caratteristiche dei singoli documenti. Cia
scuno di questi documenti di un'attivit di pensiero, che
con gli etessi problemi lott senza tregua per decenni,
sta a rappresentare
un momento fecondo, un grado dello
sviluppo, uno stadio de]
processo risolutivo, un
punto
di partenza per una formulazione nuova. Certo, ogni ele
mento singolo sorretto dall'unit potenziale dell'idea,
che agisce universalmente in ogni particolare espressione
del filosofo. Ma chi si contenta di fermarsi ad essa non
voglia dire di aver contemplato lo spirito aristotelico
nella sua attualit. La forma del pensiero aristotelico
rude e aspra: l'animo abituato al sereno e dilettoso sen
tire, l'occhio assuefatto ai vasti orizzonti non sono fatti
per avvicinarsi ad esso. raro che vi si apra un pano
rama, in cui la vista abbia modo di deliziarsi. La 6ua
essenza si svela solo nel singolo e nel concreto, a chi
l'interroghi con intenso approfondimento, yp vo vsp-
ye:a
LA PRIMA METAFISICA 227
2.
Primitivo abbozzo della critica delle idee
E INTRODUZIONE ALLA METAFISICA.
La reverenza degli editori ha conservato la famosa
critica della dottrina platonica delle idee induplice reda
zione, nel capitolo 9 del libro A e nei _capj).__45 del
libro M. KT"cTue~rl3azionl, la cui .coincidenza quasi
letterale, non possono essere state destinate alla mede
sima stesura della
Metafisica.
Se la redazione del libro
M, che saldamente inserita nel complesso della dimo
strazione, dovesse restare al suo luogo, bisognerebbe pre-
supporre che Aristotele avesse avuto intenzione o di pre-
mettere un altro libro introduttivo o almeno di cancel-
lare, alla fine dell'introduzione quale oggi appare (A
I
8-10) icapitoli che risultano inparte ripetuti. Ma da pa
recchie citazioni ]) dei primi due libri nel libro M ri
sulta che quest'ultimo doveva, in qualsivoglia modo e
luogo, seguire ad essi, e che quindi Aristotele non po
teva avere altra intenzione all'infuori di quella di can
cellare la parte critica alla fine del primo libro. Con ci
dimostrato che Aristotele, in un'ulteriore elaborazione
della sua opera, si seiv di parti del libro A come di
semplice materia prima.
La differenza di et, stabilita con questa osserva
zione, confermata dalle poche divergenze letterali delle
due redazioni. Se si prescinde da un nuovo argomento
; contro le idee, che Aristotele aggiunge nella redazione
posteriore2), esse si distinguono solo per l'eliminazione
sistematica della prima persona plurale, con la quale
Aristotele designa sempre, nella redazione pi antica, i
l) M 2, 1077 a 1(= B 2, 997 b 12-34), M9, 1086 a 34 ( B 6,
; 1003 a 6), M9, 1086b 2 {=A 6, 987 b 1), M10, 1086 b 15 (
=B4,
i 999 b 24; 6, 1003 a 6).
s) M 4, 1079b 3-11, e cfr. Entstehungsgesch. d. Met., pp. 29.30.
228 CLI ANNI III VIAGGIO
sostenitori della dottrina delle idee. Tale caratteristico
uso del primo libro dimostra clie esso stato scritto
in un'et in cui lo stesso Aristotele poteva apparire an
cora come platonico e seguace della dottrina delle idee J).
L'intervallo cronologico che distingue idue libri dev'es
ser perci rilevante, perch nel libro M il distacco di
Aristotele dalla comunit platonica ormai unfatto com
piuto. Ed anche il tono della polemica contro iplato
nici qui spesso acerbo o addirittura sprezzante,
in
contrasto con l'atteggiamento riguardoso con cui essi ven
gono trattati nel primo libro.
La stesura della redazione pi antica pu cadere sol
tanto inun periodo ben determinato e irripetibile della
vita di Aristotele. atonejmn_pij:n_vita:_ ci_risult_a
chiaramente dall'
imperfetto,
p.i..v.olte..ripetutQ...qjiando...
sTparldriui"2)! E_in generale, leggendo la critica delle
idee, non si ha
l'impressione
ch Aristo:tele v
Lr.tti per
l'prim volta quel tema nell'ambiente dell'Accademia.
Lai maniera nlla.',quale.yengpnq qui citati,igliargomenti_
platonici per l'esistenza di idee separate, per Io pi
| solo nella forma di designazioni abbreviate e riferentisi
j
a una terminologia tecnica, presuppone una lunga fami
liarit dell'uditorio con tali questioni. Ma persino le
] obiezioni, che contro quella concezione vengono mosse,
! sono considerate da Aristotele come gi note. A noi sa
rebbe quasi impossibile di comprenderle, e d ricostruire
dalle sue parole gli argomenti infavore delle idee da lui
') Con ci sottratto ad ogni dubbio il risultato della nostra
indagine sulla filosofia dell'Eudemo e del Protreplico: fino al mo
mento in cui egli ha per la prima volta diretto- una simile critica-
contro la dottrina delle idee, Aristotele Ila considerato come pro
pria tale dottrina. Ipassi sono raccolti in Entstp.hungsgesck., p. 33.
Anche oltre ilimili del brano conservato in doppia redazione si
trova usata nel primo libro, dovunque si parli della dottrina delle
idee, la prima persona plurale: cos in A 9, 992 a 11 tCSHpsv,
23
sidxa|tsv e XiYG|-lcv< 27 cpapiv, 28
XYOpn,
31
esajisv.
*) A 9, 992 a 20 Siepevo, 21 ixAsi, 22 tCOat.
7.A FHIMA METAFISICA 229
criticati, se il commentario di Alessandro di Afrodisia
non ne avesse conservalo le formulazioni, traeudole dal
perduto scritto aristotelico IIsp ioz/v z). Solo col tono
di chi cita formule convenzionali egli parla del yos
xwv 7ttatT]|Av, del Xyoq xax x Ev Et teoXv, del
xptxo? V'O'pWTEO? (cio di un argomento a sfavore, di cui
non affatto autore egli stesso, bens il sofista- Polis-
seno 2), e contro cui gi Platone combattenel Parmenide),
e cos degli y.pioxzpu xfiiv yuv, che porterebbero ad
ammettere l'esistenza anche di idee del relativo, e del
Xyos xax x voslv xt >&plvxo$ s). Nella sua forma ori-
gmaria la critica delle idee
presuppone
dunque un ani-
b'iente di filosofi pIat o nic i, di fronte al quale Ari
stotele, dopo la morte del maestro, riassume ancora una
volta" ni breve tutfe le obiezioni a cui la sua
dottrina,
dava lugo e che avevano dato da fare all'Accademia per
lunghi anm,~al~fine d"dedurne la necessit di un com
pleto rinnovamnto del platonismo su base"critica. Or
fana dl~padre, la scuola si trova in un mome_ntp-..dech.
sivo della sua storia. Un simile ambientejji.plalonici,.
dopo la morte di Platone, ha circondato Aristotele (se si
prscin"d"da Atene",'che egli lasci subito) solo una volta
ad Asso, e poi non pi. Ad Atene difficile che.egli af>-
hfatrovato,""prima della
partenza,
la calnminteriore
j>er
elaborare isf'su'a nuova trattazione, comprendente tutte
le istanze critiche a cui dava luogo la dottrina di Pla
tone e tutte le sue persqtmJi_rifle6siflni_sui....problenii
"metafisici. Ad Asso egli aveva invece non soltanto il
tempo
necessario, ma anche un uditorio d'intenditori di
filosofia, tra cui ipi noti scolari di Platone, iquali o
') Framm. 187, 188, 189 R.
!) Secondo ci che riferisce Fama iv ftp; ii?u>pov
(frumiu. 24 Mueller), presso Alex. Aplirod., in Arisi, metaph.,
p. 84, 16 Hayduck.
') A 9, 990 a 12 segg.
2:0 GLI ANSI DI VIAGGIO
erano abbastanza oggettiviper porgere orecchio agli_ar-
goment dell'oppositore, come Senocrate, o erano__essi
stessi pieni di dubbi circa la dottrina
platonica, come
sembra siano stati Erasto, Corisco e illoro adepto Ecmia.
Infatti gi Platone, nella lettera a loro inviata, aveva_ri-
,tenuto necessario dichiarare che egli si sentiva costretto,
pur nella"sua tarda et_,_ a tener fede,.
alla...dottrina
delle idee. Egli presuppone cos che anche presso idue
filosofi di Asso avessero luogo controversie a proposito
!
di questa bella1 sapienza : e forse furono essi stessi a
chiedergli consiglio. Egli li esorta a rivolgersi per ogni
difficolt all'Accademia, e manifesta ilsuo intentodi scon
giurare ogni minaccia di scissione1). Dopo la sua morte,
iplatonici di Asso fecero venire presso di loro i due
rappresentanti delle opposte tendenze dell'Accademia,
quella conservatrice e quella critica: ed a questo
udi
torio che stata letta la pi antica redazione della Meta
fisica.
Essa cosi contemporanea al dialogo Hspi piXo-
cofiaq.
Che ilprimo libro della
Metafisica
sia un'improvvisa-
j zione tirata gi a grandi linee cosa che si avverte anche
adesso. Gi nell'analisi del Protreptico venuto in luce
come ifamosi capitoli introduttivi derivino nella so
stanza da quello scritto giovanile2). In altre parole, la
disposizione spirituale di Aristotele verso la scienza era
rimasta la stessa. La eziologia che vi si- riconnette, la dot-
')
Plat., episl. VI, 322 D'Epa-tip Ss xat Ko.orixip rcpg tfj idiv
st85v
00919
(t$ xaXij vkutj, 9-i)p' xatitsp fipu>v
t vi
npooSst (correxi.itpooSsv codd.) oo<pla$ xrjs nepl too; Ttovrjpo;
xal iStxo-jj puXaxxtxijs xat xivog |ivuxij; uvjisiug. Le parole
spaziate stanno a s, giacch la connessione di 9'/] ni con npcoHtv
toglie ogni senso al participio concessivo che sta in mezzo a loro.
Certo quindi che jcpooSsiv vada corretto in npooSst. Restituita al
suo vero senso, l'espressione diventa altamente significativa per le
lotte che a proposito della dottrina delle idee si svolsero in seno
all'Accademia durante l'ultimo periodo della vita di Platone, e
per la posizione clic egli stesso vi assunse.
')
Cfr. p. 88 segg.
LA PRIMA METAFISICA 231
trina delle quattro cause, cos come gli altri concetti
fondamentali di forma, potenza ed atto, sono desunti
dalla Fisica, ed Aristotele si riferisce esplicitamente ad
essa quale vero e proprio loro fondamento. Nuova la
derivazione genetica della dottrina delle cause dalla sto
ria della filosofia- precedente, al termine della quale, con
clusione del vecchio e inizio del1 nuovo, appare Platone.
Con la critica della dottrina delle idee,_messa insieme
con analoga sveltezza, Aristotele si apre poi la via per
la propria
po6zione).dei problemi, che ha luogo nel se
condo libro e che egualmente determinata dalla situa-
zione interna"~spr" descritta, riuscendo quindi piena
mente comprensibile solo in funzione di tale ambiente
"itficpT
Questi
risultati completano l'immagine dell'atteggia-
(
mento- di Aristotele rispetto a Platone e alla scuola pia-
tonica, che abbiamo potuto
ricostruire analizzando il
dialogo Ilepl ipcXoaoyfag. Essi confermano che la pubbli-
cazione della critica delle idee fu solo l'ultimo passo
di un lungo processo evolutivo, icui inizi si perdono
nell'oscurit del comune lavoro esoterico che si compiva
inseno all'ambiente accademico. Xa distinzione'degli ar
gomenti specificamente aristotelici da quelli di altri cri
tici non pipossibile, perch ci che egli d nella Me
tafisica
evidentemente una slloge di tutte le pi im
portanti istanze che potevano essere avanzate contro la
dottrina delle idee, senza distinzione di orgine. jVello
6tesso tempo
in cui attacca apertamente la dottrina pro
fessata dall'Accademia,__egh cerca,
concorso
-esoterico
.d
"
metafisica tenuto ad Asso, di condurre gli, amici pi di*
spost73~3nteh3re j,_suo metodo critico _alla convin
zione che linucleo essenziale dell'eredit platonica j>u_
esser salvato solo a1 patto di un deciso abbandono della
dottrina asserente il Ytopj'3Ug.deIle._i.deg_e_iI dualismo.
Ci che egli offre non e non vuol essere, secondo ilsuo
232 CU ANNI 1>I VIACGIO LA PRIMA METAFISICA 233
modo di vedere, altro che puro platonismo: la piena
reaTizzazne dllTdeale a cui Platone ha mirato scienti
ficamente, senza_tuttavia attingerlo. Ci che sorprende
inquesta valutazione della propria opera, che nonostante
le radicali riforme della dottrina platonica gli permet
teva di conservare la reverenza del discepolo, special
mente la tendenza consapevole verso un'organica evolu
zione ulteriore. Isuoi compagni giudicarono per altri
menti. Sotto la parvenza conservatrice essi riconobbero
lo spirito rivoluzionario di una nuova concezione del
mHdoVe'noh
"considerarono pi Aristotele come un pla
tonico. Per suo conto, egli non scorgeva ancora la pro
pria evoluzione dalla distanza necessaria per poter rico
noscere l'esattezza di quel giudizio. Solo nel pi tardo
periodo della sua vita egli assunse una posizione piena
mente autonoma, senza diretto collegamento col passato.
A seconda che 6 terranno maggiormente presenti ipre
supposti storici della sua filosofia o la forma individuale
del suo modo di vedere e di pensare le cose, si conside
rer come pi vero il pi antico o il pi tardo di tali
giudizi che Aristotele rec di sfe stesso. necessario ri
cordare con quanta difficolt Platone si sia venuto libe
rando dall'idea della sua identit cori_ Siocrateper_com
prendere,Tn funzione dell'elemento irrazionale della sua
relazione di discepoIoTacOnsiderazione modesta, e sce
vra di ogni mbzrhe~f2rhnginlita*, che Aristotele...ebbe-
di_sstesso.
La questione che si presenta ora per prima quella
dell'estensione di questa redazione pi antica della Me
tafisica, e delle parti ad essa pertinenti. All'abbozzo pi
antico appartiene, oltre alla critica delle idee, che per il
suo uso della prima persona plurale si assegna da s
nel modo pi palese al periodo di transizione, anzitutto
l'intero primo libro, il cui carattere unitario incontro
vertibile e che perci viene ad esser soggetto nella sua
totalit alle conclusioni cronologiche che valgono per
quella sua parte. A quanto pare, gi nell'antichit si not
con sorpresa la denominazione di platonico, che Aristo-
tele d ripetutamente a se stesso. Alessandro di Afro
disia e Siriano raccontano che dotti antichi considera
rono il libro come spurio1). Secondo una notizia di Al
berto Magno lo si ascriveva nel Medio Evo in parte a
Teofrasto, e nelleversioni arabe sembra che mancasse2).
Entrambe le cose si' spiegano in funzione di un'antica
tradizione dotta: evidentemente qualche editore della
tarda antichit aveva omesso di fatto il libro, in base
3) Alex. Aplirod., in At. metaph., B 2, 997 b 3 (p, 196, 19
Hayduck) piAAtov l-poj aiix-Q (scil. tsag) itpt&tov
uitorii'ivrjaxEi iaota; uvj lAeyov at; etva"., ccvaaprcujv e?j
T EtpTj Ava iv ti Tipix'j). SJsv aat SrjAov ix
jiXeivcov
8r) bv.
vcv.iivo 'Aptototic-ug t iati xal ix xafixc -efjg paya-isia;. xat
yp tip Tj&ei poCwg xst te itepl a-tiv Etprjxe rat ivtafta
i|iv- pv.oasv d)C yp aspi otxsCag tfjs SiEpig tJ] icspt 8eiv o5crjf
too?'. y>of v pcoTpoig -nExsIrjTai, e cfr. Syrian., comm. inmetaph.,
ad loc. (p. 23, 9 Kroll), che per non fa, certo, altro che seguire
Alessandro.
2) Valentino Rose (Arist. pseudep., p. 184), che gi cita anche
la testimonianza di Alberto Magno, spiega giustamente l'attribu
zione del primo libro delia Metafisica
a Teofrasto. Nei manoscritti
il cosiddetto frammento metafisico di Teofrasto precede spesso la
Metafisica
di Aristotele. E in essi, non escluso il Par/sinus E risa
lente a un'edizione antica, si trova al termine del pezzo teofrasteo
una subscriptio erudita, la quale avverte come i cataloghi di Er-
mippo e Andronico non conoscessero questo libro , e come in
vece Nicol Damasceno Io ricordi nel suo scritto sulla /kfeta/isica
di Aristotele e lo ascriva a Teofrasto. Ora questa subscriptio, che
concerneva il precedente scritto di Teofrasto, fu erroneamente ri
ferita a ci che seguiva, e cio al primo libro della Metafisica
ari
stotelica. Con ci si spiega anche come contemporaneamente a quella
dcll'atetesi sia tramandata anche la notiza della paternit teofra-
stra. Il Rose sbaglia solo quando crede di poter ascrivere questo
errore al traduttore latino medievale. La testimonianza di Alessan
dro dimostra infatti che l'atetesi era gi nota nei primi due secoli
a. C. Oggi nessuno potr pi esitare a far risalire l'ordinamento
degli scritti aristotelici, quale si presenta nei pi antichi c migliori
dei nostri codici medievali, a un'edizione antica, che fu fatta dopo
Andronico c dopo Nicol Damasceno
il quale era cancelliere
del re Erode e dotto storiografo e peripaletico
eprima di Ales
sandro.
234 GLI ANNI 01 VIAGGIO
alla dimostrazione della sua non autenticit. Dall'anno- a
tazione di Alessandro a proposito del secondo libro ri-
sulta che una delle ragioni dell'atetesi appunto da ri- &
cercare nell'imbarazzante prima persona plurale del
primo libro, per opera della quale esso apparentemente
assumeva una posizione singolare rispetto agli altri. Ari- 3t
statele scrive (B 2, 997 b 3): Nell'introduzione stato i M
) detto che ammettiamo (XsYopcv) le idee tanto come cuse i %
j quanto come realt ins esistenti. Tra le varie difficolt I
! che presenta questa dottrina suscita particolare opposi- j
zione la nostra tesi dell' esistenza di certe realt oltre a
1
,k
quelle
comprese ne! mondo visibile, e l'asserzione della
\ loro identit alle cose sensibili, se se ne esclude la
loro/
eternit inconfronto della natura transeunte di queste
,
Da questo passo Alessandro deduce l'insostenibilit del- 5
l'atetesi del primo libro, dato che esso vien qui esplicita-
mente citato e che anche I'TjUoj, lo spirito dell'osserva-
'>
zione aristotelica si accorda pienamente con quello
del
libro precedente, considerando Aristotele in entrambi i
luoghi la teoria delle idee come dottrina propria.
Questa
obbiezione contro la critica propugnante l'atetesi preaup- '
pone che il primo libro fosse divenuto sospetto appunto \
per quell'eidos. Nessuno capiva pi, allora, come Ari-
?
stotele potesse designare l'asserzione delle idee come dot-
<.
trina propria, e lo stesso Alessandro riusciva a spie- ?
garselo solo presupponendo l'intenzione retorica dell'eto-
pea. L' atetesi deriva dunque dall' ambiente ortodosso
della scuola peripatetica dell'et imperiale, che cancel
lava ogni traccia di dipendenza di Aristotele da Pla
tone considerando la dottrina delle idee come un'eresia
alla quale ilmaestro non poteva aver minimamente par
tecipato. A noi questa forma di critica serve a mostrare
ancora una volta quanto poca autorit sia da attribuire
alla tradizione della scuola peripatetica a proposito di
problemi concernenti l'evoluzioue di Aristotele.
Questa
LA PRIMA METAFISICA 235
fonte principale infatti assolutamente tendenziosa nelle
sue testimonianze. Del modo come vennero ridotti al si
lenzio idialoghi, che protestavano altamente contro que
sta deformazione della verit, stata gi fatta parola (v.
sopra, p. 40). Ma il passo del secondo libro, che Alessan
dro allega contro l'atetesi del primo, mostra in realt
quanto stretto eia ilnesso genetico ohe lega l'uno all'al
tro. E a questo passo, tratto dall'inizio del secondo libro,
egli avrebbe potuto aggiungerne un altro simile della
conclusione, dbe anch'esso non stato fino ad oggi mai
sfruttato per l'indagine cronologica, per quanto inconce
pibile ci possa parere (B 6, 1002 b 12): In generale
si pu essere in dubbio circa la ragione per la quale
convenga ricercare altre realt di diversa specie oltre
quelle sensbili e l'intermedio mondo delle matematiche,
quali leidee, lacui esistenza noi asseriamo (olov & tHdepev
eTSf)) .
Questi
due passi' ci permettono di far risalire
con sicurezza l'intero secondo libro alla pi antica re
dazione della
Metafisica
:esso stato scritto subito dopo
il primo, nello stesso periodo di tempo.
La medesima
conclusione verr ricavata pi tardi anche a proposito
del suo contenuto teorico.
3. Critica
pi
antica e critica
pi
recente
DELLA TEORIA ACCADEMICA DEI NUMERI.
Ilibri M ed Nsono considerati per lo pi come un
tutto unico, principalmente per ilcarattere unitario del
loro contenuto, e cio della critica della dottrina acca
demica concernente le idee e inumeri. Nel capitolo in
troduttivo (M 1) Aristotele chiarisce lo scopo della trai?'
tazione. Egli pone
'
ir~fTfblm
"
sVotre alle realtjlel.
mondo fehbmOTico~'su668ta ancora un altro essere che
"sia immoto ed e"terh."Anzitutto devono essere presi in
-------
-----
.il - r
esame ipensatori die finora hannp_assento resistnza di
236 GLI ANNI DI VIACC.IO
LA PRIMA METAFISICA
237
un simile essere,
e,cio...i!latone..e,la sua scuola. Aristo
tele stabilisce un piano preciso, secondo il quale egli
intende di procedere e che gi per la sua disposizione
metodica presenta altissimo interesse. Anzitutto egli
vuole considerare le entit matematiche ne11aoro_p
i
_
rezza idealcio'
senza riguardo alle tesi metafiscbe,.che..
|
ad
essei_ cqnnettonj quale' per esempio quella,
che esse
siano
ideer
principio ed essenza di tutte le cose. Inse-
...# |
conda linea devono essere sottoposte ad indagine le idee,
parinienti_8enza alcun riguardo
airinterp.retaziqim_che_.
nella sua pi tarda fase ne diede Platoneconsiderandole
come numeri: esse debbono infatti_
Msere.etndiate-nella.--.
loro forma originaria ed autentica1. Ilterzo luogo dev'es
sere'occupato dalla discussione critica della filosofia1 ma
tematica di Speusippo e di Senocrate.
_
Le due prime parti, l'indagine circa l'essenza (oaia)
delle entit matematiche e la critica della dottrina delle_
ideei'nelYa sua forma originaria quale conosciamo dai
dialoghi di Platone, non hanno in questo organismo va
lore autonomo. Esse servono come gradi per la dedu
zione
metodica della dottrina di Speusippo e di Seno
crate, da esse storicamente derivata. su questa dot
trina che s'impernia principalmente l'interesse della trat
tazione, come appare gi dallo spazio ad essa dedicato.
Evidentemente essa costituiva per Aristotele, quando egli
scriveva M, il problema di attualit, mentre la conce
zione platonica delle idee era da lui presa in esame
solo affinch non sussistessero lacune nel sistema orga
nicodella sua trattazione. Aristotele Iodice chiaramente,
quando inserisce la dottrina delle idee nel programma
del libro. Non perch essa trovi ancora difensori nell'Ac
cademia, ma bens Scov vjioo yvdptv, come a dite solo
per una questione di forma1) egli la comprende ancora
!) Motapk., M 1, 1076 a 27, c cfr. per l'espressione Boraays,
Dialogc des Arist., p. 130.
r
V
"
'
'i
'
una volta nei limiti della sua trattazione. Speusippo met
teva completamente
da parte le idee e sostituiva ad
esse, quale superiore realt, inumeri.
Senocrate, pi
conservtorci
cercava di tenere""in vita la dottrina-dei
numeri ideali professata
dal tardo Platone e
identificava..,
"TTcIWai matematiche con le idee concepite da Hatone,
come numeraggiungendo cio" a"un'compromesso tra.Pia-.
tone'e'Speusippo.
t/ust'Tormd
della tlottrina .chia-_..
mata da AriFtbtI"i xpCroj rptto?. Anche dal punto di
vista
cronologfic~eBffa"'devrea8ere,
naturalmente, la pi
tarda delle tre.
Con ci l'et di composizione del libro M risulta
ampiamente distanziata da quella dei primi libri. Certo,
le dottrine circa inumeri vengono ricordate
da Aristo
tele molto tempo prima, nel Protreptico; ma nell' et
immediatamente posteriore alla morte di Platone, nella
quale nacque la prima Metafisica, la forma della tratta
zione critica circa la dottrina delle idee stava addirit
tura al polo opposto.
Nel primo e nel secondo libro la
dottrina delle idee costituiva
ancora, senza
contestazioni,
il centro dell'interesse filosoficoi. Ivi essa era ancora, per
Aristotele, ilpunto di partenza
dell'intera indagine spe
culativa nel campo della metafisica e della logica. Nel
libro M invece si scorgono gi chiare le tracce del
l'influsso che la critica aristotelica esercit, di riflesso,
sull'Accademia. Qui
egli pu considerare come invec
chiata, per consenso
comune, la forma classica della me
tafisica platonica. Contro di essa egli si limita soltanto
a richiamare la sua precedente minuziosa critica delle
idee, e non gi quella1 che si trova nel primo libro, ma
bens quella contenuta nei suoi yot
essoterici, osser
vando come essa sia universalmente conosciuta e come
quindi egli non abbia bisogno di tornarvi su. In questa
citazione noi riconosciamo il dialogo
Ilepl cptXoaocpfa?,
elie non era ricordato nella critica della dottrina delle
23S CLI ANNI DI VIAGGIO
idee data nel primo libroe che
pu anche darsi sia stato
|f
composto poco tempo' dopo. Da allora era trascorso un
perodo di
tempo abbastanza lungo, tredici anni e forse
pi. Alla mutata situazione slorica corrisponde il fatto
che Aristotele non ponga pi inprima linea la polemica
J.
contro leidee, che subito dopo la' morte di Platone ave- '4
vano invece avuto certo, nell'Accademia, ancora molti di.
fensori. Intale situazione il motivo pi profondo del
4
fatto che nella nuova elaborazione Aristotele cancelli
completamente la critica di Platone che aveva data nel
primo libro, quando essa costituiva1 la questione cruciale
; f
della sua pi antica metafisica. Con le necessarie modi- 4
ficaziori. che a loro volta dipendono
dalla mutata situa-
zione interna ed esterna '), egli la trasferisce nella nuova 'i
'
trattazione polemica contro la filosofia matematica di
Speusippo e Senocrate, in funzione della quale le idee
4
conservavano ancora un interesse storico per la cultura {-
contemporanea, in quanto costituivano una sua forma
preliminare. G-h antichi compagni vi sono fieramente ;
assaliti e la loro dottrina delle idee dichiarata una
allucinazione.
|
Tutto rimanda all'et in cui la scuola peripatetica \
fronteggiava gi, in atteggiamento
ostile, quella piato-
I
nica. Convien qui, anzitutto, far seguire uno schema della . ]
disposizione del libro.
1
A. Introduzione: MI, 1076 a 8 a 32.
B. Prima parte: tcs pi tjv
paS-Tj pax txv
(solo inquanto tali) 1076 a 32
1078b 9.
I.Ivys ioli atod-q-oii tlvzt Suvaxov 1076a 33
h11.
II.7za,p i
aoibjT stvai y_Li)piar Suvaxov 1076
b 12
1077 b 11.
III.6 ipizo$ io stvac 5 twv palbjpaiixcv
TSi?
nq
(fl Tioaa ecc.). 1077 b 12
1078 b 9.
'} Cfr. sopra, pp. 227-28.
LA PRIMA METAFISICA 239
C. Seconda parte: nep tv ioefiiv (solo in
quanto tali, senza riferimento ai numeri) 1078 b 9
1080 a 11.
I. Analisi storica delia genesi della dottrina delle
idee 1078 b 12
b 32.
II. Confutazione dialettica 1078 b 32
1079 b 11.
III. Confutazione fisica 1079
;b
12
1080 a 11.
D, T e r z a p a r t e: ntpl & p ulpfi) v d)?
xstepi-
cpiv?]; oafas
1080 a 12 1085 b 34.
I. Discussione di tutti icasi possbili 1080 a 12
b 36.
1. Tre casi ideali sono concepibili 1080 a 18
b 5.
a) ol pi&pol doupPXr]xoi
b) oupXxof
c) ol pv apjjXijioc, ot o aupjJXrjica
2. Ciascuna di queste tre concezioni (eccetto quella
dei numeri TtavTsXw; aaupPXtjxoi) ha trovato sostenitori
1080 b 6
b 36.
a) Platone: numero ideale e numero matematico.
b) Speusippo: solo il numero matematico.
c) Senocrate (kXXo? b etSijxty-j xcd ipaSvj-
paxcy.; piO-u; 6 ajii au.
II. Confutazione di questi singoli ipnoi 1080 b 37
1085 b 34.
1. Confutazione di Platone 1080 b 37
1083 a 17.
a) Primo caso: izaxt povdSe aupJ3Xi}'ca atee 1081
a 5
17.
b) Secondo caso: nSoat aupjXijxoi 1081 a 17
b 35.
c) Terzo caso: od pv v 5XXm Std'popoc ai S'Iv Tip
at dptSpw povaSs; bifopo:
108]
b 35 1082 b 1.
d) Ogni forma di distinzione delle monadi incon
cepibile, e ci esclude la possibilit di porle come idee
1082 b 2
1083 a 17.
240 CLI ANNI DI VIAGGIO
2. Confutazione degli altri metafisici dei numeri
1083 a 20
1085 b 34.
a) Distinzione dei tre casi possibili 1083 a 27
b 18.
a) Speusippo 1083 a 27
b 1.
fi) Senocrate ( Tpfto;
-piioi;) 1083 b 1
8.
y) IPitagorici 1083 b 8 18.
) Confutazione di tali dottrine 1083 b 19
1085
b 34.
E. Conclusione: 1085 b 35
1086 a 20.
: I. Ilreciproco contraddirei dei difensori di tali teo
rie rende sospette queste ultime.
I II. Imoderni sostenitori di questoi platonismo non
{hanno effettivamente compiuto alcun progresso rispetto
> a Platone.
III. La ragione del loro insuccesso nell'inesattezza
dei loro presupposti.
Questo
processo dimostrativo mostra un rigore di di
segno, che non incontriamo di frequente in Aristotele.
Ifascicoli delle sue lezioni sono soggetti a una rielabora
zione
troppo continua, per poter giungere facilmente a
una forma compiuta ed armonica.
Questo
libro invece
limato con visibile accuratezza, e segue dal principio alla
fine un piano determinato. un tutto, con
[isoov
e xeoj. La sua originalit non consiste tanto nei par
ticolari quanto nell'idea complessiva. ArstoieTe_viinl
me.
cogliere ancora una volta, in una graejsiUes.L.cntca.
tutto ci che,ggli-ha.pensato.circaJa.questione delle en
tit soprasensibili, le idee e inumeri. E concepisce il
piano, caratteristico del suo genio dimostrativo, di non
attaccare soltanto le concezioni allora dominanti nel
l'Accademia, ma di dedurre sistematicamente e di con-
futare tutte le singole forme dei 7Xda]iara accademici
che potessero in generale immaginarsi. Le diverse va-
LA PRIMA METAFISICA 241
; rianti della teoria delle idee e dei numeri presentatesi
nella realt storica vengono inserite in questo quadro
i! e fatte risalire a pochi presupposti fondamentali, dime-
strati a loro volta falsi. Nell'introduzione, e specialmente
verso la fine, lo stile dello scritto attentamente curato,
e la fredda lingua scientifica assume nella conclusione
un certo colorito rettorico. La conclusione non si trova
del resto alla fine del libro, ma gi in M9, 1086 a 20.
Con leparoleche seguono comincia unatrattazione nuova,
come gi hanno rilevato antichi commentatori e come
ho dimostrato minuziosamente sulle tracce dello Schive-
gler1). Ci provato soprattutto dalle precedenti frasi
conclusive (M9, 1086 a 15
20), il cui tono affatto da
epilogo. Aristotele ama di concludere siugole trattazioni
con citazioni poetiche, come si vede nel libro A della
Metafisica
o nel coreo di lezioni
Ilsfl
tpiXfa?, pi tardi
accolto nell'Enea Nicomachea (libri 0I): e qui la chiu
sura affidata a una citazione da Epicarmo. E come al
termine dei Sotpicmxol IXsyx0- egb toglie commiato dal
suo uditorio, e alla fino di un discorso sullo stato ideale
rinvia ad altra occasione gli ascoltatori che nutrano an
cora dubbi 2), cos egli rivolge qui al pubblico, nel quale
si trovano evidentemente anche studiosi della tendenza
opposta, non ancora scossi nella loro fede, una parola
di conclusione. Un ulteriore approfondimento della
questione potrebbe convincere solo chi gi convinto,
ma a persuadere chi non ancora persuaso non servi
rebbe pi. E qui il manoscritto s'interrompe.
Peraltro, per quanto originale sia l'impostazione me
todica della trattazione, il materiale da essa adoperato
non nuovo. In essa appare elaborato ogni precedente
abbozzo, preparato
da Aristotele a proposito di tali pro-
') Entstfihungsgesch. d. Met. d. At., p. 41 segg.
') l'olii., H 1, 1323 1> 36.
16. AV. Jaeger, Aristotele.
242 CU ANNI DI VIAGGIO
bleini. Non infatti verosimile che egli abbia attinto
dalla pi antica redazione della
Metafisica
solo la cri
tica delle idee contenuta nel quarto e quinto capitolo:
l'intero libro buttato gi rapidamente e reca dapper
tutto le tracce di un'elaborazione disuguale. Significa
tivo il fatto cbe una perfetta levigatezza di stile s'in
contri soltanto nella introduzione, nella conclusione, nel
l'ampia esposizione dello schema dell'opera e nei tra
passi, cio in tutti iluoghi che sono stati scritti per la
trattazione complessiva data in questo libro, e debbono
quindi essere di origine recente. Lostile della critica delle
idee, che deriva dall'antico abbozzo, si differenzia com
pletamente da quello di tale cornice, e tradisce gi con
questo il suo carattere eterogeneo. Ma anche affatto
inconcepibile che le lunghe serie degli argomenti a sfa
vore, giustapposti l'uno all'altro con un monotono ir.
(D II2 b), che nello schema dato sopra non ho perci
cercato di sottoporre a pi minuta partizione, abbiano
ricevuto tale forma stilistica allo scopo della trattazione
data con questo libro. Evidentemente essi sono stati tra
scritti senza mutazione da un precedente appunto.
Una chiara prova1 di questa genesi del libro fornita
dal brano che gli aggiunto come appendice (M 9, 1086
a 21
fine del libro). Gi gli antichi commentatori vole
vano in parte annetterlo al libro seguente, scorgendovi
giustamente un proemio1). Se essi volevano eseguire la
sua unificazione col libro N in una maniera cos estrin
seca, gli autori della redazione che sta alla base della
nostra tradizione manoscritta ebbero invece occhio pi
acuto. Essi scorsero la mancanza di un immediato tra
passo1e perci, come gi avevano fatto inaltri simili casi,
aggiunsero ad M l'isolato proemio superstite come sem
plice appendice. Essi dettero con ci a divedere l'opi-
*) Syrian., comm. in A. mctaph., p. 160, 6 Kroll.
LA PRIMA METAFISICA 243
nione che questo brano fosse in stretto rapporto col
libro al quale lo aggiunsero. Quale
sa questo rapporto,
dimostrato dal 6UO paragone col proemio31 1, al quale
conviene sia qui messo a fronte.
Proemio M1, 1076 a 8
IIspl (lv o3v xrj; xiv
ato-D-rjTiSv oOota; eTpvjxat
xt; axiv sv [lv xf} p-
&5q> xiv cpootxiv tispl
x4); Ooxspov t nepl Tfje
xax' ivpy;av. nei 5' Vj ax'iu;
rti icxspov Ioti ti; na-
p x ; atottijx; oola;
xtvrjxo; xal tSto; ?)
ox Ioti, xal Et Ioti, xl;
Ioti, ttpQxov x itap x>v
SXXuv Xeyi*16VK S-stoptj-
xov.... Suo 8' etal Sjai nspl
xoxtov. x xs
YP
[iKtHuiaxixS
qsaoiv ovata; stvai xtvs;, otov
pi8-[io; xal
ooyysv xoxot;, xal itXiv x;
tSia;. itisi Ss ot [lv 8o
xaxa YM sioioOot, x;
x' I5a; xal xot>; pa8-r(|iaxiy.o;
pi8-|io;, ol Si [itav cpvoiv ]i-
cpotiptov, Ixepoi Si xivs;
x; |iav] [laxix; jivov
oola; stvat cpaoi, axsnxov
ttpfijTOV [lv tisp! xSv (ia9-rj[ia-
xtxSiv, [irjSefilav jipoaxiS-syxa;
tpaiv SXXvjv avxot; (otov nxepov
ISai
xoYX"vouat
oOoat f) oO....)
....Insixa [ex xaxa y.uipl;
nepl xiv tSsfflv axSv SrnXS;
xal 8oov v[iov xP'v-
Il programma prospettato dal proemio M 9 non
altro cbe l'argomento trattato nelle precedenti parti del
libro. Che inumeri siano designati come o come
Proemio M9, 1086 a 21
IIspl Si xiv npixMv Spjriv
xal xfflv cpixcov atxloiv xal
axoixeitov
5aa [lv Xsyouoiv o
itspl [ivij; xfj; ata&ijxfj;
ovata; 8toplovxs;, x [lv
iv xo; itspl tpfiosoi; eTpij-
xai, x 8' oix Ioti xfj; jis&Soo
xij; vv. Boa S ol cpaxovxs;
slvai itap x; aloO-tjx;
xipa; oata;, ixjisvv ioxi
O'Ewpcai xfflv sp)j[i4vtov.
ssi o6v
XiYouat
xtve; xotai-
xa; elvai x; ida; xal xo;
pi$|io>;, xal x xoxuiv
atov/tta
xiv ovxoiv slvat
axoixsta
xal
px;, oxstctov tispl xoxtov xl
Xyouoi xal jii;
XYOuotv.
ot [lv o 3 v ptS-[io;
ttoioOvxs; jivov xal xo6-
xou; [iaO-T][iaxixo;, 6oxepov
i-iaxsitxioi" xiv 6 x;
tSa; Xsyvxuiv fijia xv xs
xpitov 9-saatx' Sv ti; xal xrjv
-optav xvjv nspl
afjxtv.
244 Cl.I ANNI DI VIAGGIO
l'O'.yziy. dipende dalla terminologia accademica, la cui
presenza si manifesta in Aristotele fin dal tempo del
Prolneptico. La1 cosa non quindi da intendere nel senso
che inJI 1-9 egli avesse trattato inumeri come ocfai
indipendenti, e voglia ora discutere la concezione che li
considera principi ed elementi di ogni essere1). Ci che
6egue mostra chiaro clie inM9, esattamente come inM1,
si allude all'esistenza
separata (y_iispia[tc) delle idee e
dei numeri e delle altre grandezze matematiche, punto
linea superficie corpo. Si leggano ora le parole seguenti
(M 9, 1086 a 26): E giacch alcuni pensatori1 consi
derano come tali entit le idee e inumeri, e vedono nei
loro elementi gli elementi e iprincipi di ogni realt, a
proposito di essi dobbiamo indagare anzitutto il conte
nuto della loro dottrina e in secondo luogo la forma in
cui essi la espongono. Ma ci esattamente il conte
nuto del libroM. Non sarebbe possibile che Aristotele
parlasse in tal modo se M dovesse realmente precedere,
u che egli ricominciasse qui di nuovo a trattare delle
idee e dei numeri, come se non ne avesse ancora fatto
parola. Inoltre, inM9 egli parla del xpincg e dell' inopia
della dottrina platonica, come se si debba far distinzione
fra l'uno e l'altra.
Questa
distinzione basata sullo stesso
metodo d'indagine critica delle vedute di altri filosofi,
ohe seguito inM 1-9. Anzitutto viene esposta la dot-
') L'antica esegesi aristotelica spiega la differenza delle duo
trattazioni nel senso che dal principio di M fino al cap. 9, 1086 a
20 siano considerate le oJtai platoniche come entit separate, e
da questo punto sino alla fine di N le stesse oaiai siano invece
considerate come principi ed elementi della realt. Ma la seconda
indagine non muove affatto, in nessun punto, dalla precedente, c
anzi l'ignora del tutto. In realt, nella seconda trattazione Aristo
tele discute insieme entrambe le questioni, cio critica le pla
toniche entit soprasensibili tanto come o&otca separate quanto
come
oToi/sta
y.al t'jjv
vriov. Che poi qui s'insista pi
sulla loro funzione di ototysa riv Svtwv che sul loro carattere
di sostanze, dipende dal mutamento frattanto avveratosi nella me
tafsica aristotelica, come risulter nel seguito dell'indagine.
LA PRIMA METAFISICA \ 245
Irina, e quindi fatta seguire una critica che mette
in luce le 6ue difficolt. Le coincidenze si estendono fino
a singole forme di espressione verbale. Cos, entrambi i
proemi si richiamano egualmente, sull'inizio, alla Fisicu,
per ci che concerne la dottrina delle sostanze sensibili.
Entrambi contengono la formula che conviene anzitutto
esaminare quelle specie di entit soprasensibili la cui
esistenza ammessa da altri pensatori (t trap ttv
CcXXov Xy[ieva corrisponde a ocra 81ol cpaaxovxE? rivai
xtX., 6-eiopT)Tfov a &Wprjazi). Cos, tanto dal conte
nuto quanto dalla forma verbale risulta chiaro che qui
sono superstiti due redazioni parallele del proemio a
tj! una trattazione critica sulla metafisica accademica.
Quale rapporto
cronologico lega, ora, le due reda-
i). zoni? La prima idea che si tentati ad accogliere
quella cheM 9 si distingua solo per la sua diversa forma
letteraria, poi rigettata da Aristotele.
Ma la possibilit che M 9 sia una pura variante sti
listica risulta esclusa dal fatto che idue proemi, ad
onta di tutte le loro coincidenze, divergono in un punto
decisivo, e cio nella disposizione della materia, che essi
vogliono porre a fondamento dello scritto di cui eBpon-
j
gono il programma. In M 9 detto: Quei
filosofi che ;
. . . . .
ipostatizzano 1numeri, e 1numeri propriamente mate';
matici, devono essere esaminati pi tardi. A proposito i
dei sostenitori delle idee si pu invece indagare nello J
etesso tempo la forma (zpKOc) della loro dottrina e la
:X difficolt (duropi'a) che a quelle si riferisce1). Ilproemio
I Miemolto pi accurato nell'elaborazione dello schema
programmatico concernente lo stesso argomento. L Ari-
; slotele annovera, accanto alle idee e ai numeri, anche
i' le sottospecie che vi si collegano, e premette a queste
\ le grandezze matematiche considerate in quanto tali. Gi
')
M 9, 1086 a 29.
246 CU ANNI DI VIAGGIO
in questo annuncio preliminare si avverte, cio, la pre
senza dello stesso metodo, progrediente con prudenza
pei vari gradi della sua costruzione, che abbiamo mo
strato peculiare dell'intero libro. Nei proemio M 9 l'in
dagine si trova invece in un pi rudimentale stadio di
sviluppo, awertendovisi la deficienza di quella pi sot
tile differenziazione del problema, che costituisce la ca
ratteristica dell'altra esposizione.
Esso non quindi un semplice doppione stilistico,
ma bens l'introduzione a una pi antica1 critica della
metafisica accademica dei numeri, che aveva trattato tale
argomento seguendo un metodo intrinsecamente meno
evoluto1). Altri brani di questo pi antico scritto de
vono essere stati egualmente rielaborati, come si gi
supposto, nel rifacimento costituito dall'odierno libro H,
senza che sia pi possibile identificarli nel contesto.
Per determinare la data della redazione pi antica
necessaria anzitutto una digressione, a cui costringe il
bisogno d'interpretare un passo oscuro e finora mal com
preso. Anche qui, l'appiglio che esso offre per una pi
precisa datazione sfuggito agli sguardi di tutti, cos
come accaduto per ipassi decisivi del primo e del
secondo libro.
In M 10, 1086 b 14 Aristotele inizia la confutazioue
delle idee con un'aporia che aveva formulata in B 6,
1003 a 6. 8 Ss vest xo; Xyouoi xa; iSsag lysi xtv
rtopfav xa
ioti jri) Xeyouciv xa xax' py; iv
xo; Slavs paoiv rcpxspov, Xsywev
vv. (I) si [lv yap xc; p) iWjast xi; oata; slvat -/.e-
*) Nella mia Entstchungsgeschichtc d. Mntaph., p. 42 segg., ho
esattamente riconosciuto al brano che da M9, 1086 a 21 va sino alla
fine del libro il carattere di appendice, aggiunta dai redattori alla
compiuta trattazione M 1
9, 1086 a 20. Mi peraltro curiosamente
sfuggito che MI e M 9, 1086 a 21 segg. non sono che due reda
zioni parallele dello stesso argomento, le cui et debbono essere
separate da un notevole intervallo cronologico. Ci muta, come si
vedr in seguito, l'intera considerazione dei libri M e N.
LA PRIMA METAFISICA 247
ytoptapva;
xa xv xpJiov
xoxov <5>; Xsysxat x xaff'
'gxaaxa
xwv ovxiov, vatpcst xy)v
oaiav, PouXpfra
Xsysiv.
(II) v Ss ti; fhj) x; oaiaq ywpcax;, nS;
freest
x axoty_sa xa x; py; axcv ;
(1) si [sv yp xa&' Sxaaxov xa xa&Xou, xoaax'
lexat x 8vxa, oaaixsp x axotsa, xa ox jxtaxijx x
oxo'.sta....
(2) XX pjv
s! ys xa&iXou a pya [r) xa
a ix xoxtov oala.1 xa&Xou] lazzi p-ij-ocfa ixpxspov
ocda;. x pv yp xaffXou ox oaa, x o cxotystov
xa i] pyfj xaS-Xou, Jtpxepov Ss x CTOiysov xa "f, pyy)
)v
pyj] xa axoiystv iaxu
Immediatamente prima di questo passo (1086 a 35
b 13) Aristotele ha chiarito le difficolt
implicite
jnel-_
l'ammissione
delLdV'mostrando come esse derivino
dal suo processo genetico. L difficolta principale pro-
viene
'
d!" fatcTche si concepisce
l'idea, tanto ,come,..uni-
versale (xafl-Xou) quanto come esistente per semcerto
senso cme una nuova1forma di realt smgola(x>y
_
xafr'
T/Toatov). La ragione di questo singolare carattere di ,,
cannante
duplcita"er*ril
fatto che Platone negava l'ee-
"sere" alle realt del mondo fenomenico, essendo giunto,
eotto l'influsso di Eraclito, a considerare ogni singola
realt percepibile per mezzo dei sensi come sottoposta
a un continuo flusso e perci come priva di consistenza.
D'altro lato, dalle indagini etiche di Socrate era risultata
indirettamente la nuova e importante nozione, che solo
dell'universale ci fosse scienza. Socrate non aveva per,
i
completando il processo di astrazione, considerato icon-
! cetti come distinti dalle cose reali. Platone procedette
innanzi e ipostatizz
secondo la considerazione retro
spettiva di Aristotele
1
iconcetti generali attribuendo
loro la natura della vera oaia.
A ci segue il pasBO
decisivo. Aristotele discute qui
la questione se i__princip
siano universali o, in certo
senso, singolari. Con le sue difficolt, questo problema
248 CLI ANNI DI VIAGGIO
investe tento isostenitori delle idee quanto iloro ne-
*
gatori. Egli cerca di mostrare come entrambe le possibili
{soluzioni del problema sembrino condurre necessaria-
Smcnte ad
assurdit,
Se i priucipi sono realt singole,
allora essi non sono conoscibili, perch conoscibile sol
tanto l'universale. Se invece essi sono universali, ci che
non sostanza sarebbe antecedente alla sostanza, e si
dovrebbero dedurre le sostanze dagli universali che ne
sono iprincipi; il che impossibile, perch l'universale
non mai sostanza.
Queste
sono le conseguenze logiche,
prosegue Aristotele, che derivano quando si pongono le
.%
idee in funzione di elementi, e si ammette l'esistenza
di esse quali unit trascendenti accanto alle cose della
stessa specie. Basta questo riassunto per vedere come
gli tenga principalmente d' occhio la dottrina delle
idee, e non rivolga la medesima attenzione anche ai
;
suoi negatori, come ci si aspetterebbe dopo gli accenni
.
introduttivi. Il binomio degli assertori e dei negatori
? gli serve in realt solo' per formulare la questione nel
l'aspetto di un'antinomia. II dilemma, se gli elementi
e iprincipi siano realt singole o universali, da lui
considerato come caso particolare di un dilemma pi
.vasto: se non si pongono le sostanze (x? oaa?) come
(esistenti
nella stessa forma in cui si asseriscono esistenti 1
le cose singole, se ne toglie l'essere (xrjv ocdav) : ma se
>'<
invece si pongono le sostanze come
separate ed esi-
stenti per s, ecco che si presenta la gi veduta difficolt
6e iloro principi siano realt singola o realt universale.
La prima parte del dilemma pi generale sembra
contenere una tautologia, ma ci soltanto un'appa-
le 6|ioXoy&iisvH oiWai, le realt sensibili, giacche in tal
caso non avrebbe senso l'aggiunta xal xv xpitov xoOxov
3
Z
if
renza. Ilplurale x? oot'ac e ilsingolare xVjv oacav in- ;s
dicano chiaramente una differenza di significato. Le so-
stanze a cui qui allude Aristotele non possono essere
.:;i
V I.A MIMA METAFISICA 249
\
-
id)? XyexKi x xafr' fxaaxa xtSv 5vxwv. La forma singo
lare di esistenza propria delle cose sensibili serve solo
come analogia per chiarire il significato dell' esser per
s proprio delle cuoiai. Ma questa l'espressione con la
quale Aristotele suole costantemente designare il carat
tere di realt delle idee platoniche. Nonc' quindi alcun
dubbio (e cos interpreta anche il Bonitz) che dietro
le oaiai si celino le idee, o un essere soprasensibile
ad esse corrispondente. Se non si ammette l'esistenza di
tali realt sussistenti per s, nel senso di Platone e della
sua scuola, si toglie ogni oaia (Aristotele concede ci
senz'altro); ma se si ammette una qualsiasi realt esi
stente per s (ooi'a? -/_(j)piaxa?) ecco che conseguono le
gi vedute difficolt per la deduzione dei1 loro' principi.
Abbiamo finora lasciato da parte le parole co?
(jqoXo-
ps&a Xyeiv. IlBonitz1) le interpreta come vogliamo
pur concedere una volta (ed altri lo> seguono, come di
solito nei casi pi
difficili). Egli fonda questa interpre
tazione sull'esatto intendimento del primo membro del
l' alternativa, scorgendovi come Aristotele vi ammetta
qualcosa che hi realt non coincide colla sua opinione.
Tale la forma consueta del dilemma aristotelico, e dal
punto di vista concettuale essa non presenta
altre diffi
colt, Ma con
tutto, ci questa interpretazione del Bo
nitz non sostenibile. Ilconcetto come vogliamo pur
concedere una volta non pu essere espresso in greco
con le parole <b?
j3ouXpe&2 Xlyeiv. Anche lo Pseudo
Alessandro evidentemente non le cap, e la sua sbriga
tiva e stolta parafrasi
grcep o (3coXuea
dimostra sol
tanto il suo totale disorientamento, in quanto
trasforma
'
le parole aristoteliche addirittura nel loro contrario. Che
si possa d'altronde scorgere in essa la lezione migliore
stato a ragione escluso gi dal Bonitz.
!) Aristotcles' Metapkysik iibersetzt von Herm. Bonitz, fliis dem
Nachlass hcrcusgegcben non Ed. Wellmann, Berlino, 1890, p, 298.
250 CLI ANNI DI VIAGGIO
Ai commentatori efuggito che
d>?
(louXpsfra costi
tuisce un frequente uso linguistico. Si confronti il passo
A 9, 990 b 17 oXti>;xe vaipoaiv ci ixsp x>v eSSwv Xycn
& pXXov elvai [iouXopeO-a [o Xsyovxe? ?5ig] xo x{
lotxq etvac : Essi negano ci, la cui esistenza noi plato
nici consideriamo ancor pi importante di quella delle
stesse idee, e cio iprincipi delle idee. Ilcodice A
l'
legge (JoXovxai e interpola ci Xyovxes slot) (e quest'ul
tima lezione ripresa dalla recensione mista bizantina
E) seguendo il passo parallelo M 4, 1079 a 14, dove il
contesto garantisce l'intangibilit di tale lezione. Ma nel
l'altro passo invece proprio la prima persona plurale
che assicurata dal contesto. Ilmotivo principale del
fraintendimento di questo (louXeafkcL nel passo male in
terpretato dal Bonitz era costituito dall'infinito Xyetv
ad esso aggiunto, in modo apparentemente superfluo per
tale significato. Un semplice w; pouXjtsfha o Xyopev
sarebbe stato difficilmente frainteso. Ma proprio il nesso
j3ouXea9-ac Xyscv serve non di rado come espressione tec
nica per designare ci che un filosofo intende coi
propri concetti, come p. es. in Platone, Leggi, X, 892 C,
cpuoiv jSo'jXovTai Xyeiv yveatv xrjv rcep t aporia ifisici
intendono per natura il divenire in rapporto ai prin
cipi elementari .
InAristotele questa espressione stata pi volte cu
riosamente fraintesa. InMetqph., N 2, 1089 a 19, egli
parla del significato del non-ente nel
Sofista
platonico:
(louXexat [lv 5-fj x 'jjsSo; xa
xauxrjv xrjv yatv Xyeiv
(cos imanoscritti, mentreilBonitz scriveXsy et seguendo
1* interpretazione dello Pseudo-Alessandro) x ox v,
Il
ot> xa xo
5vxc?
noXX x 5vxa Platone intende per
non-ente l'errore e tutto ci che ha affinit con esso .
[loXexai Xysiv, che l'unica lezione attestata, da re
stituire nel testo, mentre anche il Christ, seguendo il
Bonitz, ha sostituito nella sua edizione ilXyeiv col Xyet,
S
LA PRIMA METAFISICA 251
che una cattiva congettura dello Pseudo-Alessandro ed
da questi connesso erroneamente con xa xauxijv xyjv
tpaiv. Esattamente nello stesso modo si spiega quest'uso
lingustico in N 4, 1091 a 30 S'chxopav xa eitopVj-
oavxi Iraxipjaiv,
Ttfj ijei rcp? x ya&v xa x xaXv
x oxaieta
Kai a'1 PXa' dnopav pv xauxijv, Jixepov laxi
xc Jxefvwv,
olov [BooXjiS&a Xysiv ax x yafiv xa x
piaxav, 7)
gB, XX'axspoyevf). La questione infatti se
tra iprincipi della realt si trova alcunch di simile a
ci a cui alludiamo parlando dell'idea del bene e del
sommo bene, o se questo invece un prodotto finale del
l'evoluzione . Anche in questo passo il Christ ha consi
derato Xyeiv come aggiunta spuria, senza avvertire quel
l'uso linguistico.
Sfruttiamo ora questa osservazione per il passo da
cui siamo partiti (1086 b 18-19) : ei pv ydp xi; [ri) rjasi
x?
oaa; elvat xeiopiapva; xa xv xprcov xoxov (l;
Xysxai x xa'Sxacxa xv Svxcov, vaipaei xVjv ocav,
pouXjxe&a Xiyeiv (scil. axv). Se si nega che le so
stanze esistano indipendentemente, in modo analogo a
quello delle singole realt sensibili (come fa lo stesso
Aristotele), si distrugge l'cuoia nel senso in cui l'in
tendiamo noi platonici. Con ci anche
finalmente chiarito del tutto il eingoiare xy)v oaav, ti
pico del linguaggio di Platone. Nel primo membro del
dilemma Aristotele segnala la difficolt che nella nega
zione delle idee e della loro esistenza separata egli
incontra in quanto platonico; nel secondo
membro fa seguire le difficolt che sono inerenti alla
tesi del
|
Xpiop?. Finche non si vede chiaro come gli
oppositori del (tpioji; vengano nel primo membro giu
dicati secondo il concetto platonico della sostanza,
non s'intende affatto il significato del dilemma. Ed ora
evidente che gli oppositori delle idee non sono irap
presentanti della filosofia materialistica ne quelli del co-
252 CLl ANNI )>!
VUCC10
5
_
,J.
mune buon denso. Come potrebbe egli infatti confutarli
f.
innome di un concettoi dell' oalz estraneo al loro mondo
).
mentale, che essi quindi dovrebbero a priori respingere ,
come petitio principii? Ildilemma era senza via d'uscita
solo per chi stesse sul terreno del platonismo. Esono piut-
;
tosto due specie di accademici quelli che (
Aristotele distinguenelnostro passo, ofXyovcs? x$ ESag
e of [X"?j Xlyovxei;. Presupposto il concetto platonico del*
l'essere, tanto gli uni quanto gli altri s'impigliano in
contraddizioni. La1 conclusione ovvia: tali contraddi* A;
zioni possono essere risoltesolo da una nuova concezione -v
deYoeict. il concetto dell'immanenza dell'universale v
del singolo quello che qui balena di fronte al pensiero
'..V
di Aristotele. Ma la forma della questione non offre na- ;{
turalmentc in questo' punto nessun appiglio per espri-
merlo; e per ci egli si limita a far comprendere che
'
nulla si ancora concluso quando si semplicemente
abbandonata la dottrina delle
idee.
Questa incursione
critica nei concetti .fondamentali del platonismo implica
l'obbligo morale di rinnovare dalla base la concezione
platonica dell'essere presupposta dall'idea del topiopc?.
Il problema dell'et del proemio M 9*10 con ci
risolto. Come idue libri iniziali, esso una parte della
!
prima metafisica, ed nato
insieme ad essi, nel pe
riodo critico di Asso, in cui Aristotele combatteva la
dottrina delle idee come platonico tra platonici. Non ab*
biamo perci ragione di essere sorpresi e anche pi
strette relazioni appaiono sussistenti tra quei due libri
e il brano test scoperto.
singolare come nei libri
centrali della
Metafisica
non si trovino affatto citazioni
dei due primi libri, non essendo ricordate neppure le
aporie del secondo. Ben diversamente stanno le cose se
passiamo al brano ora ritrovato della trattazione che in
origine seguiva ad A e B. In M 9-19 s'incontrano, nono-
tA PHIMA METAFISICA
253
stante la brevit del brano, pi rinvi1) ad A e B che
nell'intero complesso dei libri Z-A.
Si presenta
ora il problema: di questa parte
della
prima
metafisica possediamo soltauto il proemio,
o sus
sistono ancora traccic della trattazione vera e propria?
Tale questione ci conduce ad esaminare illibroN. Con
tiene forse unnocciolo di verit la veduta di quei critici
antichi che separavano M 9-10 da M 1-9 e lo considera
vano come introduzione al libro seguente? stato sopra
mostrato come untrapasso agevole manchi, e come quindi
sia impossibile risolvere meccanicamente la questione
coi soliti metodi di suddivisione
e trasposizione. Tuttavia
l'esperimento
di questi critici insoddisfatti della parti
zione tradizionale
potrebbe basarsi su un principio di
giusta
osservaizione, nonostante il carattere rude e ina
deguato- del loro espediente. Le cose etanno, di fatto,
proprio cos. Come M'9*10 contiene ilvecchio proemio,
che fu sostituito dal nuovo inM 1, cos una fortunata
combinazione
ha posto in mano agli editori dell'opera
aristotelica, nel libro N, quel brano della prima
melali*
sica che Aristotele, nell'ultima
rielaborazione, volle so
stituire con la pi raffinata e completa trattazione con
tenuta in M 1-9.
Pure questa
volta conviene che ci lasciamo condurre
dal criterio esterno, che ci finora servito d sicura guida.
Anche nel libro N troviamo un'allusione al fatto che
Aristotele, quando abbozzava queste esposizioni, si sen
tiva ancora membro dell'Accademia.
Ilpaeso, finora tra
scurato da questo- punto- di vista, si trova nella discus
sione critica delle dottrine di Speusippo
(N 4, 1091 a
30-33):
?Xt
S'critoptav xaf sTtoprjaavx:
sttixfpatv, jx&g
ixei
Jtp? x yx'&bv v.ai x xaXv x
axocx'K
xa
afpxaf"
') Metaph., M 9, 10S6 a 34 cita B 6, 1003 a 6; Cvl 9. 1086 h 1
si riferisce e A 6, 987 b 1; M 10, 1086 6 15 s B 4, 999 b 24 e
a B 6, 1003 a 6.
254 CLI ANNI DI VIAGGIO
etaiopiav [lv Tauxijv, TtTspv lati ti ixetvwv, olov j5oy* I
XpsO-a Xyetv
aijx
x ya&v zal xb
Ccptaxov,
7) ou, dXX' 'jaTepoyev-f). Dal punto di vieta linguistico il
$
passo stato gi chiarito sopra: da' esso non abbiamo
'
qui da ricavare, a proposito dell'et del libro N, altro
che la medesima conclusione gi tratta per M9-10. Non
soltanto l'espressione propria di un platonico, ma au-
che l'intenzione teorica conviene esattamente alla sca
brosa situazione in cui Aristotele si trova al tempo del
'
suo soggiorno ad Asso. Noi platonici, dice Aristotele, po- j
niamo al vertice della filosofia e al principio del mondo
:
ilbene ins (ax x ya&v) o sommo bene (t ptaxov).
Speusippo considera invece 1) il mondo presupponendo
un'evoluzione del buono e del perfetto, il quale si af- i;
ferma sempre pi attraverso igradi di un processo, rea- :
lizzandosi conclusivamente al termine di questo (oxepo-
yevfs). In questo problema fondamentale della conce
zione del mondo Aristotele sente di essere il platonico
pi schietto, in quanto pone all'inizio di tutto uu prin
cipio che, se non il platonico bene in s, comunque
l'e/is perfectissimitm e da esso fa procedere ogni dive
nire. Egli resta con ci fedele al principio fondamentale
del pensiero platonico, mentre Speusippo Io capovolge e
lo trasforma nel suo opposto 2). Chi non avverte inqueste
parolel'accento di citi giustifica s stesso?
Se il libro stato realmente scritto ad Asso come
A, B e M9-10, si capisce perch Aristotele non vi abbia
attaccato Senocrate, che col lo aveva accompagnato,
*J Speusippo, framm. 34 a segg. e 35 e (Lang).
8) Anche nel Espi cpiJ.ooocfta; (cfr. sopra, p. 175) il nucleo
duraturo del platonismo' veduto nell'intuizione del bene lyaOv,
Spietov) come principio dominante del mondo. Ingrazia di questa
dottrina centrale Piatone vi prende posto a fianco di Zaratustra,
e ad essa si ricollega la nuova
ftsoXofia
aristotelica, che cerca di
conservare il platonico aO-v nella forma di oOoia e fonda
la sua realt trascendente sulla costruzione teleologica della natura.
LA PRIMA METAFISICA 255
con la medesima mancanza di riguardo con cui l'assal
pi tardi nel libro M (1-9), dopo la definitiva rottura
con l'Accademia. Anche l, invero, Aristotele assale so
prattutto Speusippo, ma Senocrate vi trattato nel modo
peggiore, al suo ibrido compromesso toccando ilpoco lu
singhiero giudizioxptaxa Xysxat. Cosi scrive Aristotele
nel Liceo, quando Senocrate gi scolarco dell'Accade
mia e la sua concezione comincia ad esercitare pi vasto
influsso. Nella redazione pi antica del proemio invece
ricordata, accanto alla dottrina delle idee, solo la teo
ria di Speusippo, e a ci corrisponde l'esposizione del
libro N, che solo inunluogo accenna, e in forma breve
e riguardosa, all'opinione di Senocrate1).
Questa
bene
comprensibile manifestazione di riguardo per il compa
gno e collaboratore di Asso reca cos una gradita con
ferma alla nostra tesi.
Ed effettivamente illibroNsi dimostra nel suo com
plesso come l'esecuzione del programma annunciato nel
proemio pi antioo. In(M 9, 1086 a 29 detto: Ifilo
sofi, che pongono come reali1 inumeri, e inumeri pro
priamente matematici (cio Speusippo), debbono essere
esaminati pi oltre . L'indagine che immediatamente se
gue dev'essere infatti dedicata alla dottrina delle idee:
essa s'inizia subito dopo, c giunge alla sua conclusione
con M 10. Le prime parole del libro geguente, tanto sia
detto su questa specie di essere , si riferiscono quindi
alla dottrina platonica dell'essere soprasensibile fino al
lora trattata, giacch in ci che segue si1 parla soltanto
delle entit matematiche e della loro deduzione. Certo,
la discussione delle idee data in M 9
10 piuttosto
breve, anche se si tien conto che la vera e propria critica
della dottrina delle idee s trovava gi, nella pi antica
*) Metaph., N 3, 1090 b 28, mentre in M 8, 1083 b 2 cpavspv
8'x
to6t(uv
otal 8ti /slptaxa Xiys-cai 6 xptiog -tpitoj (la teoria di
Senocrate).
255 CLI NXJ DI VIAGGIO
redazione della Metafisica, nel primo libro. Manca anche
uria formula di trapasso, e si ha l'impressione che le ci
tate parole iniziali dell'ultimo librosiano soltanto un'ag
giunta redazionale, fatta per ovviare alla stretta necessit
di un collegamento
esteriore. per altro verosimile che
Aristotele, anche nella sua pi antica critica, prendesse
inesame, accanto alla dottrina delle idee e all'ammissione
speusippea delle occat matematiche, la posizione teo
retica intermedia, e cio la teoria dei numeri ideali del
vecchio Platone.
Questa discussione pu bene avere col
mato la lacuna tra idue libri, e probabilmente stata
rifusa nel libro M nella rielaborazione posteriore. Ma,
comunque stiano le coso, nessun dubbio ammissibile
circa la congruenza del libro N al proemio pi antico,
giacch esso contiene quell'ampia confutazione di Speu-
sippo che da tale proemio principalmente promessa.
E come nel proemio s'insiste soprattutto sul significato
dello idee e dei numeri in quanto elementi e principi
(axor/_sta
y.c
pat) della realt, cos anche la trattazione
del libro N costantemente condotta da tale punto di
vista x). Ci da un lato storicamente connesso con l'im-
') Cfr. sopra, pp. 243-44. Il libro N mostra clic Aristotele con
l'espressione clementi e principi della realt allude alla teoria
del grande e del piccolo, cio dell' piozog Soci; e dell' ev, da cui
Platone deduceva le idee. Questa dottrina era professata anche da
Speusippo e da altri Accademici, in molteplici varianti, dei cui
aspetti particolari non vai qui la pena che ci occupiamo. Da questa
ultima forma della speculazione platonica deriva per il giovane
Aristotele la convinzione che la metafisica sia una scienza degli ele
menti e dei principi della realt. E giacch la sua metafisica pi
tarda, almeno in quanto una dottrina della sostanza, tutt'altro
che una scienza degli elementi dell'essere, la definizione tradizio
nale poteva esser conservata da lui solo in quanto egli considerava
come metafisica soltanto la teologia.
Questa infatti, se non una
teora degli elementi, almeno una teoria del principio. In generale,
la designazione rtepl
o-oixs'tBv conviene soltanto a una metafisica
matematizzante, sul tipo di quella che Platone, secondo ci che
riferisce Aristotele, aveva professalo nel suo ultimo corso Iltpl
tfat-oO (Aristoxen., El. harm, II init.). Mentre dunque il libro
N indaga, in forma del tutto platonica, tanto la realt quanto gli
LA PRIMA METAFISICA
257
portanza
die la questione degli elementi e dei numeri
ideali aveva per ilvecchio Platone, e d'altro lato quadra
coi particolare carattere dei due primi libri, che defini
scono sempre la prima filosofia come dottrina dei su
premi principi e fondamenti della realt. Egi qui si pu
dire, per quanto
la piena' giustificazione di questa
tesi
possa risultare solo dall'analisi dei brani pi tardi, che
la concezione della metafisica come eziologia della realt
e scienza dei principi, la quale si riconnette all'ultima
fase del pensiero platonico,
una caratteristica della pi
antica forma della Metafisica, mentre nella rielabora
zione pi recente si fa sempre pi vivo l'interesse per
il problema della sostanza come tale. Anche nella teoria
dell'essere soprasensibile la rielaborazione posteriore
mostra chiaramente come il punto di vista dei principi
ceda sempre pi il passo a quello dell' cuoia.
evidente che nella prima Metafisica
la polemica si
dirigeva sopratutto contro Speusippo. Allora egli era il
capo della scuola d'Atene, e gli attacchi di Aristotele si
avventavano con tutto il loro impeto contro ilfalso in
dirizzo in cui quegli cercava rimedio. Anche Speusippo
era persuaso della necessit di un'ulteriore elaborazione
della filosofia platonica, ma,
secondo, l'opinione di Ari
stotele, muoveva proprio dal punto che nella dottrina
delle idee non era suscettibile di evoluzione feconda : ab
bandonava l'idea della forma e la relazione col mondo
delle apparenze sensibili e manteneva1 l'insostenibile se
parazione
dell'universale, sostituendo solo, nel luogo della
pura realt, ai numeri1ideali del vecchio Platone gli og
getti stessi della matematica. Anche nel prim-o
libro Ari
stotele rinfaccia ai contemporanei, cio a Speusippo, di
elementi e iprincipi del soprasensibile, Aristotele si contenta pi
tardi, in M, di esaminare il carattere di realt delleootcu sopra
sensibili affermate da Platone e dalia sua scuola.
17. W. Jaeger, Aristotele,
258 CU ANNI DI V1ACCI0
aver messo la matematica al posto della filosofia1). E se
pi tardi, in M, iltono della critica pi freddo, come
di chi guardi dall'alto inbasso, nella redazione pi an
tica esso acquista invece pi volte l'impeto della pas
sione e persino, come nel Ilepl cpc).oaocp(a$, un'asprezza
mordace, come quando, a proposito della dottrina piato
nica del grande e del piccolo, esclama : Gli elementi
stessi, il grande e ilpiccolo, sembra che gridino, quando
son trascinati cos di qua e di l, giacch nonson capaci
di generare il numero 8).
') Metnph., A 9, 992 a 32 4XX yiyove l fia)H)|iata
tate
v5v
V) yiXoiowla....
') Metaph., N3, 1091 a 9.
IV.
L' EVOLUZIONE DELLA METAFISICA
L'opinione corrente, che la
Metafisica
sia un'opera
tarda, divenuta insostenibile dopo il ritrovamento, da
noi compiuto, di ampi resti di una redazione pi antica,
risalenti alla prima met del decennio tra il 340 e il330.
Quell'
opinione dev'essere sostituita dall' idea, del resto
evidente di per s, che iproblemi metafisici hanno costi
tuito ilvero e proprio centro dell'indagine critica di Ari
stotele durante gli ultimi anni di vita di Platone e
quelli immediatamente successivi alla sua morte. D'altra
parte
(e
questo un risultato d'importanza non minore)
nell'ultimo periodo della sua attivit Aristotele ha ri
messo mano all'opera e ne ha intrapresa una rielabo
razione, la quale permeava il vecchio materiale di nuovi
concetti, in parte eliminandolo, in parte disponendolo
innuovi ordinamenti sistematici e trasformandolo a tale
scopo. Dalle traccie di quest'ultima elaborazione noi pos
siamo ancora intuire il senso, in cui egli voleva svol
gere e perfezionare la sua filosofia. Naturalmente, la dif
ferenza individuale che distingue le parti pi auliche
da quelle pi recenti riesce chiaramente avvertibile solo
quando si riconosca la loro TtaXfvcovo; ppovCvj in seno
260 GLI ANNI DI VIAGGIO Jfjj
__
$>:'
alla costruzione definitiva, che entrambe le comprende
ed inquadra.
L'analisi deve muovere da quel tronco, o torso, della
Metafisica, che la critica indagante la genesi dell'opera
ha delimitato nei suoi confini, e la cui connessione inte
riore, voluta dallo stesso Aristotele, stata resa perspi
cua dall'allontanamento dei brani indipendenti, ad esso
aggiunti dai redattori. Si tratta, in sostanza, della com
patta massa, gi esattamente isolata dal Bonitz '), dei
libri da A a I, fatta eccezione di % e di A. Che questa
serie di trattazioni non giunga a termine, e in partico
lare che non ne costituisca la conclusione il trattato teo
logico superstite in A, gi stato a buon diritto chiarito
dal Bonitz, e dev'essere espressamente
riaffermato contro
pi recenti tentativi di risolvere altrimenti il problema,
iquali oscurarono di nuovo una situazione gi illustrata
in modo cos convincente. Solo nel giudizio circa idue
ultimi libri noi dobbiamo integrare il Bonitz, il quale
nutr evidentemente interesse minore per essi, in quanto
la sua attenzione era soprattutto rivolta alla dottrina del
la sostanza. 11 libro M doveva, come abbiamo dimo
strato, sostituire il pi antico N nella rielaborazione pi
recente, e appartiene quindi anch'esso al torso deli
mitato dal Bonitz. La metafisica, che qui Aristotele espo
ne a grandi linee, la ben nota teoria generale della
sostanza, cio la filosofia delle forme sostanziali, che ha
servito alla speculazione di tanti secoli successivi come
di armatura di sostegno per le sue intuizioni della na
tura e dell'essere. Si possono seguire le traccie dell'evo
luzione di questo possente edificio incompiuto muovendo
dal centro, la teoria della sostanza.
! ?v
l'i'"
*)
H. Bonitz (nell'introduzione al suo commento alla
Metafi
sica, vol. II) il quale a sua volta si basava sul Brandis (ctr. Ent-
stehungsgesck. d. Melaph., p. 3 segg.l. .
l'evoluzione della metafisica 261
Nel libro B, incui vengono enunciati iproblemi della
scienza ricercata , Aristotele conosce ilproblema della
sostanza solo nella forma della speciale questione con
cernente la realt del mondo soprasensibile. Dopo iquat
tro problemi introduttivi, che si occupano della costitu
zione. della nuova scienza, egli pone tale questione come
iXauy{ 7tpawTtov alla testa degli undici problemi, che
fanno penetrare nel vero e proprio campo d'indagine di
queBta disciplina. Con ci egli d un rilievo anche este
riore all'importanza fondamentale della questione *). Dal
tempo della creazione platonica dell'idea essa , senz'al
tro, il problema della filosofa. Nella sua formulazione
del problema metafisico Aristotele si ricollega cos im
mediatamente al problema fondamentale del platonismo,
ed anzi lo esprime addirittura come questione posta da
un platonico: le realt, che noi ammettiamo come es
seri trascendenti, separati dalle apparenze sensibili, quali
le idee e gli oggetti del pensiero matematico, esistono
effettivamente? E se non esistono, lecito ammettere, ac
canto alle cose sensibili, qualche altra simile realt di
natura soprasensibile? Per il mondo sensibile (atefhjr)
oafa) egli non epende nemmeno una parola. Subito con
la prima frase va diritto alla questione centrale, il pro-
blema della trascendenza. E iproblemi seguenti si svi
luppano da questa radice come il ceppo e irami mag
giori e minori. Gi un semplice sguardo d'insieme basta
a far vedere come anch'essi siano tutti nati sul terreno
platonico. Principi di tutte le cose sono i concelti di
specie, come sostiene Platone, oppure gli elementi della
natura visibile, come insegna la scienza naturale? Ani-
')
Iquattro problemi introduttivi sono trattati in Melaph., B
2, 996 a 18-997 a 33, quindi seguo la questione circa il soprasensi
bile, in a 34. Circa la distinzione dei problemi introduttivi, costi
tuenti la scienza fondamentale, dai problemi principali efr. Enlste-
hungsgesch. d. Melaph., p. 100.
262 GLI ANNI DI VIACCIO
messa la prima tesi, sono principi le specie supreme o
quelle infime? E, in generale, in quale relazione sta
l'universale, che Platone considera come oiaCa, rispetto
all'essere, alla realt? La pi astratta delle astrazioni
davvero quel che veramente , oppure ci avviciniamo
tanto pi alla realt quanto pi dall'altezza dell'astra
zione discendiamo verso la concretezza, verso la singola
rit, verso l'individuo? Iprincipi costituiscono un'unit
nel senso del numero, individualmente, o nel senso della
specie, universalmente? Iprincipi delle cose transeun
ti sono gli stessi che quelli delle cose eterne? lecito
considerare, con Platone, l'essere e l'uno come principio
e fondamento di tutte le cose, o essi non sono altro che
vuote astrazioni prive di contenuto reale? Hanno ra
gione Platone e isuoi scolari quando ritengono ocfai
numeri, linee, punti, superfici, corpi?
Quale
motivo ha
indotto all'ammissione dell'esistenza di idee, se vero
che l'astratto non nulla di reale e di essenziale, ma
solo unattributo comune di molte cose? Bisogna conce
pire iprincipi nel senso di una mera materia e potenza,
di una semplice possibilit di evoluzione, come fa la
scienza naturale, oppure come un'entit esercitante fin
da principio un'azione efficace, come energia? Era questo
il problema, gi ricordato, che fu dibattuto fra Speusip-
po e Platone, e a proposito del quale Aristotele si schie
r dalla parte di quest'ultimo. Cos, nel libro dei proble
mi, non
esposto
inrealt altro che la problematica del
la dottrina platonica, alla correzione della quale mira
Aristotele nella fase pi antica della sua speculazione
metafsica. Iproblemi che egli pone si riferiscono senza
eccezione alla sfera del soprasensibile. Nel loro comples
so ossi offrono l'immagine di un tipo di filosofia che non
soltanto ha tutte le sue radici in Platone, ma merita
essa stessa il nome di platonica, anche se il suo presup
posto e il suo motivo conduttore costituito proprio
!
l'evoluzione della metafisica 263
dal dubbio circa l'esistenza delle idee. Tutti iproblemi
della scienza a cui Aristotele mira derivano dalla crisi
della dottrina platonica e tendono alla restaurazione del
la conquista operata da Platone nella sfera del sopra
sensibile.
Noi cerchiamo la trattazione di questi problemi nelle
indagini della parte principale, quali, secondo l'opinione
corrente, sono contenute nei libri Z-0. Iquattro pro
blemi introduttivi, che determinano il concetto, l'argo
mento e ilmiti della metafisica, trovano la loro solu
zione nelle parti che seguono immediatamente (T E). Ci
si aspetterebbe che Aristotele si attenesse anche in ci
che segue al suo schema programmatico, e che quindi
nel libro Z venisse discussa la questione del soprasen
sibile. E si desidererebbe anche che, come avviene in
T e in E, un rimando qualsiasi avvertisse del passaggio
della trattazione all'indagine circa il fondamentale pro
blema metafisico. Invece, al posto
del problema concer
nente l'esistenza del soprasensibile, s'inserisce in Z im
provvisamente la teoria della sostanza in generale. Con
ci Aristotele abbandona completamente, per itre libri
che seguono, la linee programmatiche determinate nel
libro B con l'esposizione dei problemi. Non solo que
sti non costituiscono lo schema fondamentale delle trat
tazioni che seguono, come invece accade nei libri intro
duttivi, ma non dedicata ad essi neppure una parola.
Questa contemporanea sospensione tanto dei rinvi ai
problemi quanto della loro stessa discussione non si pu
spiegare che in due modi. 0 Aristotele, a met dell'o
pera, ha rinunciato al piano originario, che aveva avuto
di fronte agli occhi nel libro B: il che certo strano,
anzi quasi incomprensibile, in una costruzione proget
tata ed eseguita unitariamente. Oppure ilibri sull'
oa(
(Z-0) non rappresentano affatto l'esecuzione del piano
originario, ma sono qualcosa di pi nuovo e recente, che
264 CM ANSI DI VIAGGIO
Aristotele ha sostituito alla trattazione primitiva o ha
inserito in essa,
Di fatto, non difficile dimostrare che il libro B ap
partiene a un'elaborazione essenzialmente anteriore ri
spetto ai libri sulla sostanza, come per brevit vogliamo
chiamarli. Come abbiamo sopra chiarito (p. 235), il
libro dei problemi nato contemporaneamente al libro
A, e risale agli anni immediatamente successivi alla mor
te di Platone. La prima persona plurale, con la quale
Aristotele si presenta col come platonico, non si trova
pi nelle parti del libro Z, in cui egli sottopone
la dot
trina platonica ad esame critico 1). D'altra
parte
noi ab
biamo ritrovato un ampio brano della metafisica pi an
tica in M 9-10 e nel libro N, ed prova palmare del
l'originaria indipendenza di Z dal piano della metafi
sica esposto inB il fatto che, in primo luogo, entrambi
ibrani della relazione pi antica caratterizzati dall'uso
*) Sono i capitoli 13 sega, del libro Z. In questo Aristotele
tratta, sulla pi ampia base, la questione dell'essenza dell' obota.
A tal fine egli muove dalla distinzione di quattro diversi signifi
cati dell' oioCa, in quanto BXtj, sTBog, xa&iXoo e -ti ijv slvcu, mi
rando a dimostrare che in un esatto concetto dell' oBota itre ul
timi significati debbono essere compresi e ridotti in unit. Per
rispondere alla questione della misura in cui la BXi) concorra a
costituire la realt della forma e dell'essenza concettuale, egli
espone il suo duplice, concetto dell' ocla. E ci conduce nello
stesso tempo a riconoscere l'esigenza della forma suprema, scevra
di materia, La discussione del problema se anche l'universale
(xaS-Xou) possieda realt porta poi a una presa di posizione ri
spetto alla dottrina delle idee (Z 13 segg.), nella quale tornano i
principali molivi della confutazione datane nel primo libro (A 9),
se anche prospettati da un diverso angolo visuale ed espressi in
diversa forma. In un solo e identico contesto le due confutazioni
sono difficilmente compatibili tra loro. La loro relazione reciproca
diventa invece spiegabile quando si ammetta che il libro Z non sia
stato in origine destinato affatto al pi ampio complesso in cui ora
appare inserito, rappresentando bens una trattazione indipendente
del problema della sostanza. Giacch nella critica della dottrina
delle idee compiuta in Z 13 segg. manca la prima persona plurale.
!
tutto questo scritto nepl o'jclat dev'essere di genesi posteriore a
quella delle parti pi antiche della Metafisica, - - ,1
l'evoluzione della metafisica 2C5
della prima persona plurale nella polemica
( M9-10 e
1
N) si occupino, com'era da aspettarsi, esclusivamente
dei problemi enunciati in B, e cio,
della questione
della
realt del soprasensibile, e che, in secondo luogo, nello
stesso momento in cui si rientra in questo campo pi
strettamente determinato di problemi metafisici ricomin
cino anche irimandi al libro B l).
iQuesta
conclusione, che ilibri sulla sostanza non
hanno affatto appartenuto all'originario disegno gene
rale dell'opera, sembra urtare contro l'idea fondamen
tale della metafisica aristotelica. Debbo perci rassegnar
mi all'obiezione che: ilmotivo caratteristico di questo tipo
di speculazione pur costituito dal fatto che in essa
il soprasensibile non oggetto di contemplazione im
mediata ma di mediazione logica, e che quindi non
punto di partenza, ma punto
di arrivo. La teoria dell'es
sere del principio supremo, che nessuna esperienza pu
attingere, non si eleva forse sul fondamento di xina dot
trina dell'ooCabasata sulla percezione empirica del rea
le, in graduale e costante ascesa dal noto all'ignoto? E le
indagini contenute nella teoria della sostanza e dell'atto
(Z 0) non conducono esplicitamente fino alla soglia della
dottrina dell'essere soprasensibile? Ora, non c' dubbio
che questa parte
della
Metafisica
abbia carattere prepa
ratorio, e nel suo ultimo progetto Aristotele le ha evi
dentemente assegnato
con intenzione il posto
che era
occupa. La teoria generale della sostanza doveva costitui
re, d'allora in poi, la porta d'ingresso alla dottrina della
sostanza immateriale del primo motore. Come il carat
tere specifico della metafisica aristotelica fu preservato
di fronte a questo definitivo compimento della sua strut
tura, sar indagato pi tardi.
Qui
dev'essere anzitutto
messo in chiaro come l'odierno tato dell'opera sia stato
*) Ofr. sopra p. 227, n. 1,
266 CLl ANNI DI VIAGCIO
f
preceduto da un altro, nel quale mancava quella graduale
esplicazione del concetto dell'essere. Ilprospetto dei pro
blemi metafisici dato nel libro B non prevede 1' excursus
dei libri Z-0 circa la teoria generale della sostanza e
dell'atto, e questi stessi tradiscono ad ogni passo come
*i
non possano essere tati originariamente scritti per lo
scopo metodico al quale essi sono stati subordinati in . y
quell'ultima sistemazione, che ora il testo presenta.
Data l'importanza della cosa, voglio dimostrarla an-
cora pi minuziosamente. Sul principio del libro Z
si rileva, s, come l'indagine proceda metodicamente nel j
miglior modo partendo dalle sostanze percepibili per !
mezzo dei sensi. Segue una bella,
e giustamente famosa,
digressione circa la natura del conoscere umano e circa
la norma metodica, che prescrive di procedere sempre
%
da quel che noto a noi , cio dal sensibilmente certo,
a quel che noto per natura , cio al puro oggetto del
pensiero. Questo chiarimento circa imotivi che indu
cono Aristotele a premettere l'indagine generale circa
I'oafa alla teoria del soprasensibile si trova per fuori
posto in tutti imanoscritti. IlBonitz ha notato per pri
mo lo spostamento (senza per altro trarne alcuna illa
zione), e d'allora in poi le nostre edizioni presentano
il passo nel luogo che gli conviene. Motivo di tale spo
stamento non pu essere stata una confusione di un ma
noscritto tardo, perch esso si trova inentrambe le classi
della tradizione del testo, e doveva quindi comparire in
tutti imanoscritti antichi. Il fatto non si pu quindi
spiegare se non ammettendo che il passo costituisse una
aggiunta in foglio staccato, inserito nel testo in luogo
erroneo gi dal primo editore '). Ed anche un altro ri-
'-V
') Melaph., Z 3, 1029 b 3-12. Le parole sono andate a finire
nell'inizio dell'indagine circa il -ci
i5v
stvai, dove non hanno al
cun senso. Esse continuano le parole di 1029 a 33: SpoXofoOvtxt
5'oOaiai elvai
x)v
atoSbjxfflv xivf g, d>ax* iv Taxatg Urjxijxlov icpixov,
l'evoluzione della metafisica
267
chiamo al carattere meramente propedeutico
dell'inda
gine circa la realt sensibile manifesta una cos debole
connessione col contesto, che sembra essere una poste
riore aggiunta di Aristotele I).
Fuori di ogni possibile dubbio infatti che ilibri
Z-H non trattino la questione della sostanza incostante
riferimento al loro presunto scopo, e cio a quella dimo
strazione della realt soprasensibile
che ad essi deve se
guire, come ci si dovrebbe aspettare stando a questi pas
si. All'opposto, si ha l'impressione che la trattazione sia
etata scritta solo con l'intento di confutare il concetto
platonico
dell'essere, che vedeva l'essere supremo nel su
premamente
universale, e per contrapporre
a questa su
blimazione dell'immaterialismo
la dimostrazione del va
le quali pure fanno parie dell'aggiunta. Le prime parole del passo
inserito erano evidentemente state aggiunte ancora tra le linee del
l'antico
manoscritto, e perci si trovano nei codici al loro esatto
posto. Ilresto, non rimanendo spazio, fu poi scritto su un foglio a
parte. Aggiunte su foglio volante furono anche le parole Z 11, 103o
b 32 rapi 81-1037 a 5 vov)Tii-
') Il passo Metaph., Z 11, 1037 a IO segg. sembra a me costi
tuisca un'aggiunta di tal genere, fatta allo scopo di caratterizzare
l'indagine rapi o&oteg come preambolo della dottrina dell eala
soprasensibile, e di accennare gi in questo punto a tale sua fina
lit. Se quell'indagine fosse stata scritta fin da principio a questo
scopo, Aristotele parlando della avrebbe certo speso una parola
a proposilo della BXt] del soprasensibile postulata da Platone. Del
pira xal ptxpv non fa invece neppure un cenno, per quanto in
sede di metafisica esso avrebbe dovuto
interessargli assai pi che
la materia in senso fisico, di cui pure parla tanto ut Z. Si com
prende cosi come egli, quando inseri Z-6. aggiungesse contempo-
rancamente alla fine della prima parte
dell'indagine le parole:
Tt-tspov 8' Ioti nap*, frjv
BJ/qv tffiv xoioxuiv o&oimv xig aTj xat
Sai tuxer* oalav a&xffiv Ixipav r.v oTov pi|ioi)g
\
vi xoioBxov,
uxstetov Boxepor xoxoo X*Ptv
n5Pl
atoAr,T(uv o&oiSv
raipmsS-a 8opleiv, Irai xpirav T'.vi xijg pooixfjg xal Seuxpag
miXooocrtag Iprov f] rapi xg aloHt;
o&alag &smpta. Che queste
parole siano
un'aggiunta posteriore di Aristotele e
provato
anche
dal rimando della frase che segue (1037 a
17-20), con esse insepa
rabilmente
collegata, all'aggiunta H 6 concernente la definizione.
Tanto questa quanto il rimando che la concerne
sono stati cio
egualmente aggiunti, al pari di altre modificazioni
dissimile
specie,
solo in occasione dell'inserzione dei libri Z-0 nel piano comples
sivo della pi tarda Metafisica.
. ,
268 GLI ANNI DI VIAGGIO
lorepositivo chela materia(5Xt))e ilsostrato (uTioxelpevov)
possedevano per il concetto della realt. Dal concorso
della tendenza materialistica e di quella razionalistica
deriva quindi il nuovo concetto aristotelico della sostan
za come forma ed entelechia, senza peraltro che venga
richiamata particolarmente in primo piano quella que
stione della separabilit (cpiapig), che a proposito di
tale concetto aveva importanza decisiva per ilmetafisico.
Al
contrario, viene rifiutata come unilaterale la tendenza
platonica ad astrarre dappertutto dalla materia, e si
;
m
richiama l'attenzione sull'importanza che questa possie
de per la concezione dell'essere 1). Non ci sorprende per-
") Metiph., Z 11, 1036 b 22 816 xal t xoIvt*
vdfsiv
otite xal
acpaipety tv 6?.7)v ncpUprev Ivta fp totog t48e Iv tffiSe iativ....
*) Metaph., Z 8, 1033 a 24 segg.
*) L'interesse per la considerazione fisica del problema del
l'sfiato, viene pi volte in luce nel libro, e accanto ad esso ba parte
massima quello per la considerazione dai punti di vista' della meta
fisica e dell'analitica (cfr. per quest'ultima Z 12 e H 6). La spe-
ci che l'idea della forma sia dedotta addirittura merc s
un analisi del concetto
(lei
divenire, e che 6a messa for-
temente in rilievo la sua fondamentale importanza per ',v
il retto intendimenti di questo concetto fisico2). La ma-
'
!4'i:
niera in cui nel libroZ vengono studiati uno dopo l'ai-
tro idiversi significati del concetto di sostanza e la con
clusione di tale indagine suggeriscono l'idea che qui si "l'
abbia di fronte uno scritto originariamente autonomo
circa il problema della sostanza, la cui importanza de
cisiva era venuta in chiaro gi nella pi antica reda
zione della
Metafisica
(p. 252) attraverso la critica della
dottrina delle idee. Naturalmente non c' dubbio che gi
nello stadio pi primitivo della speculazione metafisica
di Aristotele sa da presupporre l'esistenza del nuovo
concetto della sostanza, o meglio dell'essere, in s consi
derato. Ma egualmente vero che esso nato sul terreno
della fsica e della logica3), e si pu ben immaginare
*;
7
l'evoluzioni; della meiai-isica 259
che la pi antica metafisica, la quale, come vedemmo
nel Depi fiXooopiag, era ancora pura teologia, sfruttasse
genialmente
ilconcetto dell'entelechia e dell'atto per la
soluzione del problema di Dio, senza perci aver bisogno
di inserire in essa, o addirittura di ridurre a suo nucleo
fondamentale, la trattazione generale del problema della
sostanza.
Questa
congettura, che la trattazione circa la sostan
za non abbia occupato in origine il posto in cui ora si
trova, ulteriormente confermata da una serie di gravi
indizi esterni 1). Anzitutto manca, nei libri pi antichi,
ogni allusione a Z-0- Viceversa nel libro Isi rimanda
a Z-H, e questi vengono anzi designati come Je ricerche
sulla sostanza (oE rcspl rf); cicia; Xyoi). Gi questo in
dica la loro relativa indipendenza. E cos Aristotele li
cita in0 8, 1049 b 27 (dpyzxi S' iv
tots
tzspl xi]{ oalac,
Xyoij).
H complesso Z-H, che ba carattere unitario
(H
comincia con una ricapitolazione del libro Z e offre
una serie di aggiunte all'indagine compiuta in quel li
bro) di conseguenza considerato come per s stante tan-
culazione circa l'ooia penetra nella fisica merc il collegamento
con la dottrina del divenire e della mutazione, nella metafisica
merc il concetto della forma immateriale e il problema del
yuipiepbs, nell'analitica merc il t
ifi
stvai e il suo nesso con le
teorie della definizione e dell'astrazione e con la divisione dei con
cetti in
fvYi
e sI8r]. Occorre solo veder cliiaro questo carattere
multilatcre della trattazione per intendere come essa stesse in
mezzo tra le ricordate discipline prima che Aristotele la inserisse
nella Metafisico.
.....
l) Importandomi qui di raccogliere in unit tutti imomenti
della dimostrazione, mi certo lecito di riesporre ancora breve
mente, insieme con le altre, le conclusioni risultanti dai reciproci
rimandi a quel che segue e a quel che precede contenuti nei libri
della Metafisica
: conclusioni sulle quali ho principalmente insistito
altra volta (Entstehiaigsgesch. d. Met., p. 90 segg. e 106). Il cap. 4
della prima parte di quel libro, intitolato Die zusammenhangen-
den Stucken, si riferisce proprio al punto in cui ora credo di poter
spingere l'analisi fino al completo chiarimento delle intenzioni del
filosofo, mentre per ci che concerne la separazione dei brani per
s stanti non ho nulla di sostanziale da aggiungere alle mie prece
denti trattazioni.
270 oli assi ni
viaggio
to da 0 quanto da I.Ancora pi importante il fatto
che l'introduzione del libro Z venga citata spesso come
se costituisse il principio di un'opera: come per esem
pio inZ 4, 1029 b 1: stie! o' v p'/$ SistXpeOa Jtooi?
pcicpsv tVjv o
tjslav.
In generale, e per esempio nei bra
ni B ed M 9-10 appartenenti alla prima metafisica, le
parole v pxt
i
servono a designare l'inizio dell'intero
trattato, e cio il libro A. Un esempio del fatto che un
libro situato nel mezzo di una serie citi l'inizio suo
proprio con le parole v px) offerto dall'indagine
sull'amicizia nell'Etica Nicomachea (libri 0-1), che sen
za dubbio costituisce untrattato in origine indipendente.
Che anche Z fosse un tempo l'inizio di una trattazione
per s stante, e anzi che esso costituisse il primo trattato
in seno a tutta una serie di piccoli trattati consimili,
dimostrato dalla citazione 0 1, 1045 b 31, che con le
parole v
toI? itpunoig Xoyoc; non cita l'inizio di A o di
0 ma quello di Z. Il primo libro di questa serie era
dunque Z, a cui segu H; e 0 gli s sar aggiunto, nel
posto che anche oggi occupa. Difficile invece decidere se
anche I
appartenesse gi allora a
questo complesso, o
se fu aggiunto 6oIo pi tardi, quando Aristotele tolse al
loro isolamento ilibri Z-0 e li inser nella
Metafisica
:
tuttava quest'ultima ipotesi sembra la pi probabile. In
I2, 1053 b 16 Aristotele si richiama a Z 13-17 con le
parole: sS Si) pvj8v tfflv xaWou
8'jva-v
oofav elvai, xa-
ffi7csp v
xo? ntpl oafa?
v.a raspi roO 8vto; sTpvjtai
Xiyoii;.
Qui
ZH sono, s, sentiti ancora come indipen
denti, ma non risulta che essi si trovino all'inizio di una
serie a cui appartenga anche I;e a ci si oppone anzi
un'altra citazione, che si riferisce al libro B (I 2, 1053
b 9):xat S ri)v ocav xl Tf]v tpatv t)'cj}tgv rao'lpwg
xst) xaftctrasp v rots 8iaraopVjfiaoi,v rarjXikjpev, zC t v
ait.... Stando a questo passo, il complesso originaria
mente autonomo comprendeva solo ilibri
2 H 0,
ed I
l'evoluzione della metafisica
271
stalo aggiunto quando Aristotele lavorava alla forma
definitiva della
Metafisica:
per ci che esso si rife
risce a B considerandolo come introduzione.
Se ora esaminiamo la connessione del libro Z con
quello che precede, vediamo confermata anche da que
sto lato l'idea che Z sia stato inserito al posto che ora
occupa quando era gi compiuto come scritto a s. I
libri T ed discutono, come vedemmo, iquattro pri
mi problemi, concernenti il concetto della scienza che si
trattava di ricercare.
Questa
parte
si chiude con 1.
Segue ora qualcosa di nuovo: la teoria dei diversi signi
ficati dell'ente (5v) e di quello tra essi pifondamentale,
quello dell'essenza (oafa).
Comincia, cio, la
parte prin
cipale della
Metafisica.
Aristotele d per prima cosa una
enumerazione di tutti isignificati
dell'ente, nel pilargo
senso di questa parola, che possono essere pregi inesame.
Giacch l'ente, detto cos in generale, significa molte
cose, delle quali l'una l'attributo accidentale, un'altra
quella per cui l'essere designa il vero e il non essere
designa il falso, ed oltre a questi significati vi sono le
forme della predicazione, come per es. il che, il come,
il quanto, il dove, il quando e qualsiasi altra designa
zione d tal genere, e ancora oltre a tutto ci vi l'es
sere in potenza e l'essere in atto; giacch, dunque, l'ente
ha molti significati, dobbiamo per prima cosa parlare
dell' essere nel senso dell'attributo accidentale, perch di
esso non si ha ancora alcuna nozione e teoria Ari
stotele considera quindi l'essere nel senso dell'accidente,
e inseguito a ci l'essere nel senso della verit e falsit
del giudizio.
Questo
breve brano giunge fino alla fine
di E. Con Z s'inizia l'indagine circa l'essere nel senso
vero e proprio, cio circa le categorie e particolarmente
') Mctaph., E 2,
102(1
a 33.
272 CU ANNI DI VIACC10
circa 1' oaia., principale oggetto della scienza in que
stione. "*
Singolare il fatto che il nuovo libro incominci quasi
con le stesse parole e con la stessa enumerazione dei si
gnificati dell'essere, che immediatamente precede: In
diversi sensi si parla dell' essere, come gi noi (e qui ci
aspetteremmo un rimando alla precedente enumerazione
di E 2, ma abbiamo invece una sorpresa) abbiamo di
stinto nello scritto circa idiversi significali dei concetti.
Esso significa infatti una volta quel che una cosa e
l'esistenza di un essere determinato, e altra volta una
data qualit o quantit o qualsiasi altra di simili predi
cazioni 1).
Qui
chiarissimo: se E 2 avesse preceduto, al tempo
incui Aristotele scriveva questo principio del libro sulla
sostanza, o egli si sarebbe richiamato all'ampia enume
razione, gi data in quel passo, dei diversi significali
dell'ente, o avrebbe rinunciato del tutto a darne un'altra,
giacche ognuno si sarebbe ricordato di quella. Se invece
Z un'indagine sull' ooia nata indipendentemente da
gli altri libri sulla Metafisica, s capisce subito perch
all'inizio di una simile indagine debba essere breve
mente determinata la posizione dell' oaux in seno al
complesso delle possibili enunciazioni dell'essere, anzi
tutto merc un riferimento alla tavola delle categorie.
A tal fine Aristotele si richiama alle delucidazioni ETsp
T(5v
XEyopvwv, che senza dubbio dovevano
essere state oggetto di pi di un suo corso di lezioni e
che allora non erano ancora 6tate accolte nella Meta
fisica, ma stavano a s come pO-oSo; indipendente. Si
tratta del cosiddetto libro
A, che solo dai redattori
stato collocato nel posto incongruo che ora occupa.
Quan
do, nella elaborazione pi tarda, il libro sulla sostanza
') Metapk., 2 1, 1028 a 10.
Devoluzione della metafisica 273
e il trattato sulla potenza e l'atto vennero inseriti al po
sto che oggi occupano, ci determin una mutazione nel
la complessiva struttura della Metafisica;
ed anzi, per
esser pi
esatti, Aristotele comp quel passo allo scopo
di modificarne la struttura in una maniera determinata.
A modello del nuovo progetto stava il metodo seguito
nel libro sulla sostanza Z-H,
in cui Aristotele si era ser
vito dei diversi significati dell' ocJa (uXtj, eI5o;, xafrXou,
xi tjv
elvai) come di fili conduttori e aveva cos offerto
chiari alla vista, in unsintetico ordinamento gerarchico,
i diversi stadi storici e logici attraverso cui si svolgeva
11 suo concetto della sostanza. Nella seconda elaborazione
della
Metafisica
egli applic questo procedimento alla
trattazione del concetto dell'ente (5v) nel suo significato
pi generale e inseri anche I' oofa nella serie dei di
versi significati dell'
v
(in questo
senso pi lato). Alla
teoria della forma pura, scevra di materia, egli premise,
a guisa di edificio d'ingresso, la teoria della forma in
generale quale vera realt e sostanza, e innanzi a que
sta pose a sua volta, come protiro, la teoria dei diversi
significati dell' 5v,tra iquali faceva risaltare quello del
l' obala come l'unico che venisse in questione per l'in
dagine metafisica. A
questo scopo vennero prima esami
nati
} significati dell'essere non designanti una sua na
tura esistenziale ed indipendente, ma esprimenti solo mo
dificazioni che casualmente gli ineriscono o posizioni
della coscienza rispetto ad esso.
Questa
parte
(E 2-4),
dato il suo valore meramente propedeutico,
ha un an
damento molto sommario. Nell'odierna redazione della
Metafisica
essa rappresenta l'elemento di congiunzione
tra la pi antica introduzione (A-E 1) e il nuovo nu
cleo principale (Z-0, 1M). Logicamente, esso dev'essere
il brano aggiunto per ultimo, in cui Aristotele, prepa
rando il passaggio alla parte principale,
delinea somma
riamente il disegno di quel che segue. L'enumerazione
18.
W.
Jaeger.
Arlotele.
274
GLI ANNI IH VIAGGIO
dei significati dell'essere diventa con ci addirittura il
piano generale dell'intera composizione. Tuttavia dob
biamo abituarci a capire che questa composizione rap
presenta il tardo stadio, finale del processo evolutivo, e
in fondo qualcosa d'incompleto e di provvisorio ancora
in quest'ultima forma, per quanto vi si avverta dapper
tutto l'intenzione della grande sintesi. Le aggiunte, le in
serzioni e le giunture, che devono la loro origine a que
st'ultimo stadio di evoluzione, attestano un intento uni
tario, che era del tutto estraneo alla prima metafsica:
l'intento di costruire una dottrina dei diversi signi
ficati dell'ente, cio una specie di fenomenologia ontolo
gica, al culmine della quale sopravvive, s, la pi antica
teoria platonizzante della forma trascendente e scevra
di materia, ma senza per altro che essa pretenda pi
di accentrare intorno a s l'interesse principale della trat
tazione.
E sia qui detta una parola circa l'ultimo capitolo del
libro 0, del quale ho gi discusso ampiamente altra vol
ta 1). Ilbrano tratta del duplice concetto della verit:
in primo luogo, dell'esser vero e dell'esser falso, nel sen
so che comunemente si attribuisce a queste espressioui
quando si designa come vero o falso un giudizio a se
conda che il predicato vien connesso, o meno, col sog
getto a cui conviene; e insecondo luogo della verit del
l'asserzione metafisica dell'essere, che non mai operata
dal pensiero discorsivo e che perci nemmeno mai vera
o falsa nel senso dei giudizi discorsivi. La verit di tesi
metafisiche, esprimenti un essere che non oggetto del
l'esperienza, si fonda, secondo Aristotele, su una singo
lareforma di conoscenza intuitiva, laquale intanto pi
prossima alla percezione sensibile che non al pensiero
discorsivo in quanto costituisce una sorta di visione epi-
Enistehungsgesch. d. Metaph., p. 49,
l'evoluzione della metafisica 275
rituale, unpuro {byelv '/.ai pvat. l'ultimo resto dell'in
tuizione platonica delle idee, superstite nella
Metafisica
aristotelica. La ragione che induce Aristotele a trattar
qui tale problema manifestata da lui stesso in E 4,
quando avverte come l'essere nella comune accezione se
condo la quale 6t dice che un giudizio vero o falso non
appartiene al problema dell'essere qual prospettato
dal
metafisico. In questo luogo egli ha pitardi aggiunto un
rimando, il quale tradisce tale suo carattere posteriore
gi col danno che ha apportato
alla costruzione sintat
tica; oltre a quella specie di verit ce n' ancora un'al
tra, la conoscenza intuitiva, sulla quale si fonda ogni pen
siero che voglia giungere a un'assoluta concezione del
mondo; essa dev'essere esaminata pi tardi. Ci accade,
di fatto, nel capitolo finale del libro 0- Sulle tracce dello
Schwegler, bo altrove mostrato come questo capitolo co
stituisca un'aggiunta al libro 0, e come il rimando ad
esso debba essere stato inserito in E 4 quando esso fu
aggiunto alla fine del libro 0. L'indagine circa l'intui
zione intellettuale e la specie metafisica dell'
, cos, posta convenientemente da Aristotele al termine
della dottrina dell'atto e all'inizio della teoria della real
t del soprasensibile, che a quella deve immediatamente
seguire. Anche in questa aggiunta, che dev'essere pari
menti stata fatta nel momento dell'inserzione dei libri
Z-0, si manifesta quindi chiarissimo l'intento di costi
tuire un'uniforme progressione dell'essere fino alla teoria
dell'entit immateriale e di dare in tal modo un carat
tere unitario al complesso, edificato col concorso di ele
menti tanto disparati. E' questa, appunto,
la tendenza
dell'ultima elaborazione.
una felice combinazione che l'accertamento di una
duplice redazione del proemio della teoria del soprasen
sibile, quella pi antica di M 9 e quella pi recente di
M 1, ci metta in condizione di
poter provare l'esattezza
276 CU ANM DI VIACCIO
dell'ipotesi di una metafisica primitiva, non ancora con
tenente la teoria della forma materiale e sensibile 1). Se
questa ipotesi gu6ta, la redazione pi recente della
teoria del soprasensibile presuppone di necessit come ad
essa precedenti ilibri circa la sostanza, con la loro am
pia analisi della realt sensibile e della forma immanente
(svuov sloo?), mentre la pi antica, secondo quel che
ci si aspetta anche inbase al pi antico schema dato dal
libro B, deve immediatamente investire il problema del
l'essere trascendente e non pu affatto riconoscere il
mondo sensibile (alaO'Yjxr) oa(a) come oggetto
della scien
za alla cui costituzioue mira. A tal fine necessario esa
minare ancora una volta le due redazioni parallele, che
perci trascrivo qui l'una accanto all'altra.
Redazione posteriore
(M 1)
Ilepl [lv ov xvj; xfflv atsib]-
tffiv eo slpvjxat x(g oxiv v
[lv ti; [isS-Scp tv) xtv cpoctxjv
Tcspl xij? D?.7]s, 5sxepov 8
nept xfj c
nt' vpysiav.
ttsl 8' -/j axij 3xl nxepov
lati xig Ttp x; aEo9v)xj
oaiaj xal itStoj ;
o>x I'll xs s Isti, i[p iaxi,
itp&Tov -t Jtap xf&v <SXXtov Xs-
f|isva &swpi[xov.
Reduzione primitiva
(M 9,1086 a 21)
IIspl 3 xSv irpiTiuv ipxfflv
xal xffiv TtpuiTtuv atxlwv xal axoi-
Xsiwv
8oa pv Xyossiv ol Jtsp
[i6v[S xijs aoibjxiij ooUg Sto-
pOVXSg, x [lv iv xog Ttepl
lyosojj stprjxat, x 5' o&x Soxi
XTj; |1e8-68oo xg vOv Ssa 84 ol
ipsxovxej stvai itapi xg aaftyj-
xg sipap oalag, xpsviv Ioti
S-stupfjaai xfiiv sprj]ivuv.
Ricollegandosi alla definizione della metafisica come
scienza dei primi principi ed elementi, comune nella
parte pi antica dell'opera, la redazione appartenente
alla metafisica primitiva apre la trattazione circa 1' oaCx
con la divisione platonica della sostanza insensibile e so
prasensibile. Anche qui, come inA e inB, la primameta-
') Cfr. p. 213 segg.
l'evoluzione della metafisici 277
fisica muove dall'esame delle opinioni dei precedenti pen
satori. Le opinioni dei materialisti presocratici (8aa pv -
youaiv oi raspi |a<5 vtj ?
xfjs iafftjxfjs oalac, S:opavxeg) sono
omesse, in parte perch gi esaminate nella Fisica, in
parte perch estranee all'oggetto della presente
indagine.
Qui
da notare che non si parla propriamente della
atofl'i'jx'i) oafa, come accade invece nella redazione poste
riore. Che essa, come tale, possa formare oggetto della
Metafisica, un pensiero qui ancora del tutto estraneo
alla mente di Aristotele. La realt sensibile appartiene
alla Fisica. e col sono discusse le diverse opinioni dei
naturalisti che conoscono soltanto la realtmateriale. Per
il resto le opinioni di questi materialisti non apparten
gono alla indagine presente. Sono gi state infatti criti
cate nel libro A. impossibile riferirele parole x 5'ox
iaxi xfjg psllSou xrjs vv ai libri Z e H: in questi non
c' nemmeno una parola a proposito delle vedute dei
pensatori che ammettono soltanto la realt percepibile
per mezzo dei sensi. Inoltre non da credere ohe Ari
stotelesi sarebbe espresso inmodo cos negativo se avesse
proprio trattato diffusamente della realt sensibile nei
precedenti libriZ H0. L'idea che6ta alla base di questa
redazione bens espressa dal semplice dilemma: o c'
soltanto la realt sensibile, e allora non c' alcuna meta
fisica e la fisica occupa il primo posto; o c' qualcosa di
soprasensibile, e allora ce n' andhe la scienza, la meta
fisica. Perci Aristotele passa subito ad esaminare le opi
nioni dei filosofi che hanno professato l'esistenza di tale
realt soprasensibile, cio della scuola platonica.
Tra questa fase evolutiva, in cui Aristotele considera
il problema da un punto di vista ancora semplicemente
dualistico, e quella che si manifesta nella redazione Mi
cade dunque l'inserzione dei libri Z H0, accordante am
pio adito nella
Metafisica
all'alofftjx'ij oat'a, e l'estensione
del concetto di quest'ultima a quello di scienza dei di-
278 GLI ANNI DI VIAGGIO
versi significati dell'essere. Certo anche ora Aristotele, ri
chiamandosi evidentemente con la sua espressione a quel
la della redazione pi antica, allude alla precedente trat
tazione deH'aJaOrjtT] ocfa avvenuta nella Fisica. Ma
per inserisce l'aggiunta restrittiva: eipTjxai.... iv pv
TQ
[xefroti)
T)V
CfU<JlXf)V Ttsp t fj ? SXtJS, UOTSpoV
Ss 7ispl ti)? xx' vpyetav. Il compito teoretico
della Fisica, alla quale nella redazione pi antica egli
aveva senz'altro assegnato l'intera trattazione della realt
sensibile, qui limitato all'indagine circa la materia: il
che significa che la forma e la realt attuale v.ax'
vepyscav oafa) Bono principalmente di competenza del
la scienza contemplata dalla presente ricerca, e cio del
la metafisica. Aristotele cancella perci le parole della
pi antica redazione xc S'ox lati trjj |isf)-5ot> tfjs vv
sostituendole col rimando alle trattazioni, allora accolte
nell'opera, dei libri Z-0, le quali concernono infatti la
xat' ivpysiav o
oia,
delle cose percepibili per mezzo
dei sensi.
Questo
rinvio corrisponde all'annuncio, inserito
in Z 11, 1037 a 10 segg., dell'indagine circa la realt
soprasensibile che dev'essere condotta pi oltre dal li
bro M(cfr. p. 267 n. 1). Ambedue irimandi apparten
gono alla elaborazione posteriore ed hanno il compito
di agganciare saldamente insieme parti originariamente
prive di connessione reciproca. Con ci insieme dimo
strato (per quanto non ci fosse ormai quasi pi bisogno
di dimostrarlo) che la rielaborazione del trattato circa
il soprasensibile (H 1-9) stata compiuta per la Meta
fisica
pi tarda, ampliata merc l'inserzione dei libri
Z-0, nello stesso modo in cui tanto quella rielaborazione
quanto questo ampliamento sono connessi con l'inser
zione del libro I.
Ma Aristotele ha poi soltanto inserito inuovi bra
ni, e ha potuto costruire la sua teoria della sostanza sen
sibile basandola, in forma meramente estrinseca, su una
l'evoluzione della metafisica 279
1
4\
-i
introduzione che originariamente conduceva a una teo
ria del soprasensibile? Non dovevano risultarne per
forza contraddizioni insolubili? E se fino ad oggi non si
trovato alcun intoppo nel passaggio dall'introduzione
B T E alle parti inserite , qual'c il principio che ha
permesso ad Aristotele di connettere la metafisica del
trascendente con la teoria delle entelechie immanenti?
In realt esiste un simile anello di congiunzione tra i
due gradi, ed il concetto dell'ente come tale (8v
fi
6v),
che serve ad Aristotele per definire nell'introduzione
l'oggetto della metafisica. Nel concetto dell'ente come tale
noi vedevamo finora il germe dal quale si sviluppavano,
e quasi fiorivano, idiversi significati dell'essere: questo
concetto comprende infatti tanto la pura vpyeia del
pensiero divino quanto le forme inferiori della natura
mobile, soggette al divenire e alla morte. Chi indaga l'es
sere come tale non ha bisogno di limitarsi all'essere as
soluto, ma accoglie nel' suo campo d'indagine quanto di
essere possiede ogni cosa, non escluse le astrazioni del
l'intelletto. Ci compie, effettivamente, l'ultima forma
della
Metafisica.
Essa appariva quindi come l'unica rea
lizzazione possibile di tale concetto. Vediamo ora, in
vece, che ci non era altro che un'ovvia illusione. In
base alla
Metafisica
stessa possiamo anzi dimostrare che
c' stato un precedente slato della sua
evoluzione, in cui
Aristotele non traeva ancora tali conseguenze dal con
cetto dell'ente come tale, non intendendo ancora quel
concetto nel senso dell'esplicazione dialettica dei diversi
significati dell'ente e designando piuttosto quale oggetto
della Metafisica, in modo chiaro e senza eccezioni, la
realt immutabile ed eterna.
Questa
dimostrazione for
nita dal brano K 1-8, che finora stato pi volte consi
derato spurio, e la cui autenticit rivendicata in modo
addirittura lampante dai risultati della nostra indagine.
Nel mio precedente esame di questo
inestimabile du-
230 CLI ANNI DI VIAGGIO
l'evoluzione DELLA METAFISICA 2?1
cumento ho dimostrato che le minuscole particelle, il
cui frequente uso tradisce una mano estranea inseno al
complesso stilistico che per il resto affatto aristotelico,
rappresentano le involontarie aggiunte di uno scolaro,
che redigeva questi appunti seguendo le lezioni del
maestro. Ma come fonte di dottrina aristotelica il libro
un documento di aurea autenticit. Esso riproduce
punto per punto, dal principio alla fine e spesso con le
stesse parole, itre libri introduttivi, solo compendiandoli
in una redazione sostanzialmente abbreviata, la quale
non pu essere considerata n come primo abbozzo, n
come semplice riassunto della redazione pi completa,
bens mantiene la sua autonomia accanto a queste. Evi
dentemente essa una stesura di questa parte del corso
di metafisica risalente a un pi antico stadio di sviluppo,
giacche, nonostante la sua larga concordanza con la re
dazione pi completa, essa se ne distingue in vari punti
inmaniera caratteristica.
Se anzitutto esaminiamo il
rapporto di questa pi
antica introduzione con la parte principale, che qui in
primo luogo c'interessa, vediamo subito come essa risalga
a un periodo in cui non era ancora stata compiuta l'in-
serzione dei libri sulla sostanza Z H 0, e in cui all'in
troduzione seguiva ancora immediatamente la teoria del
soprasensibile. Come nella redazione pi recente della
Metafisica
c' un anello di congiunzione (E 2-4) tra la
fine dell'introduzione
(E 1)
e l'inizio della parte prin
cipale (Z 1), cos esso si trova anche nella redazione
pi antica (K 8, 1064- b 15-1065 a 26). Ma qui manca
ci che caratterizza questo anello d congiunzione nella
sua forma posteriore, e cio quell'enumerazione dei si
gnificati dell'ente da esaminare nei libri Z H , che cos
ne offre lo schema. Vero che Aristotele prende in esa
me anche nell'anello di congiunzione della redazione pi
antica, cos come poi in E 24, idue significati dell'es
sere che egli esclude dalla metafisica prima di accedere
alla trattazione principale, e cio l'essere accidentale e
quello designante la verit o falsit del giudizio,
l'uno
perch non designa alcun essere in s e l'altro per
ch rappresenta
solo un atto della coscienza. Ma del
la partizione che Aristotele annuncia in E 2, e che
svolge nella pi tarda redazione della Metafisica,
la re
dazione pi antica non fa affatto parola. In principio
si tentati di far dipendere questo silenzio dalla brevit
dell'esposizione. Ma dopo aver ritrovato, in M 9, 1086
a 21 segg., il proemio della parte principale nella reda
zione pi antica presupponente
una
Metafisica
senza i
libri Z H 6, non pi possibile credere a unmero giuo
co del caso. Anche la seconda traccia sicura di rielabo
razione pi tarda, conservata da E 24, manca nel passo
parallelo della redazione pi antica: infatti ilrinvio alla
posteriore
inserzione dell'indagine circa il concetto me
tafisico della verit (0 10), che si legge inE 4, 1027 b 28,
manca naturalmente nel passo parallelo K 8, 1065 a 24,
non esistendo ancora affatto nella prima Metafisica
un
libro
P. Natorp ha negato autenticit alla redazione K. 1-8
perch essa professa un concetto della metafsica che non
compare nella parte principale della Metafisica
stessa1).
Egli parla addirittura di un autore platonizzante
e di
una non aristotelica inclinazione di questo
scritto ad
escludere dal campo
dell'indagine la materia e tutto ci
che con essa ha rapporto.
Dati ipresupposti
di allora,
questa osservazione costituiva per lui un grave motivo
di sospetto: per noi essa diventa invece una palmare
prova di autenticit2).
Qui
incontriamo quella conce
p
>) Arckiv f.
Gesch. d. Philosophie, I, p. 1"8. Il criterio appli
cato dal Natorp quello anche altrimenti consueto, e cio il con
cetto di metafisica quale s'incontra nei libri ZH, inseriti nella se-
conda rielaborazione.
*) Nella mia
Entstehungsgesck. d. Metapk.. p. 63 se ho
282 GLI ANNI DI VIAGGIO
ziooe immateriale della metafisica della quale abbiamo |
dimostrato il carattere originario in base ai resti della
%
Metafisica
primitiva. Non potrebbe aversi pisicura pro-
va dell'esattezza del nostro criterio di paragone di quel
la clie risulta da queBta piena riabilitazione dei libri in
troduttivi. Cos anche le porte pisegrete del maledetto
castello, che per tanto tempo avevano resistito ad ogni
tentativo d'apertura di foraa, si spalancano da s quan
do si trovata
finalmente la chiave adatta nell'idea del-
l'evoluzione.
Se confrontiamo punto per punto K 1-8 con la po
steriore redazione B T E, vediamo
chiaramente come il
costante motivo di tutte le modificazioni compiute da
Aristotele in B T E sia l'intento di adattare la pi an
tica introduzione alla nuova struttura della
Metafsica
comprendente anche l'essere materiale.
Questo atteggia
mento di considerazione per il mondo materiale si ma
nifesta gi nella formulazione del primo problema prin
cipale, il quinto
dell'intera serie, che concerne la realt
del soprasensibile.
Notammo gi come l'impressione di
arcaismo data dal libro dei problemi derivi dal modo
ancora affatto platonico di porre le questioni-, ma ora
possiamo vedere che K ancora assai pi rigido ed an
tiquato a
questo riguardo 1). Se gi B supera fin dal suo
difeso minuziosamente l'autenticit del brano K 1-8
contro il
giudizio negativo del Natorp, e Bono giunto alla
conclusione cl\e
il suo contenuto filosofico c in ogni particolarit degno
di Aristo
tele. Le traccie di una mano non aristotelica, che forse si tradi
sce nel ripetuto uso della particella
Ys
non provano
nulla
contro l'autenticit del contenuto, perch
deriveranno dallo sco
laro che prendeva gli appunti e che allest la redazione superstite.
Devo tuttavia ritrattare la mia critica del Natorp per quel tanto
in cui essa si sforzava di eliminare le traccie di platonismo
da
lui scoperte. Considerate dal punto di vista dell'evoluzione del
pensiero
aristotelico, esse non offrono pi la minima difficolt, e
sono anzi proprio ci la cui presenza dobbiamo esigere giusta
l'analisi fin qui condotta,
*) Cfr. pp. 261.62. 11carattere primitivo di Bs cos conservato
nonostante la rielaborazione seriore.
l'evoluzione della metafisica 283
primo problema i confini del mondo
fenomenico, po
nendo la questione
se oltre alla sostanza sensibile ne
esista anche una soprasensibile della specie delle idee,
la redazione diK ancora pi esclusiva. Aristotele si do
manda qui ee la scienza che oggetto dell'indagine tratti
delle sostanze sensibili, oppure no, ma bens
di altre ').
Qui
esclusa addirittura ogni possibilit che
la sostanza sensibile sia di competenza della metafisica.
Essere sensibile ed essere soprasensibile sono anzi an
cora contrapposti l'uno all'altro in una semplice alterna
tiva, nella forma che gi vedemmo anche in M 9-10 2).
Nella posteriore
rielaborazione questo aut aut diventa
un non tantum sed etiam, come appare nella pi tarda
forma della
Metafisica
con la successione gerarchica onde
alle forme immanenti
sovrastano quelle trascendenti.
Lo stesso deciso aut aut troviamo in K nel luogo in
cui Aristotele manifesta la sua opinione circa lo scopo
dell'indagine ontologica. In generale un problema
se al di l delle realt sensibili si debba ammettere qual
che altra realt, o se invece non si debba, e
solo le realt sensibili costituiscano la realt, di esse
dovendosi perci occupare la scienza suprema. Evidente-
') Metaph., B 2, 997 a 34 =K 1, 1059 a 39. Prima io- supposi
che questo dilemma dovesse
significare che la verit stava nel
mezzo: la metafisica doveva essere la scienza dell' etof, compren
dente tanto l'oota del mondo delle cose sensibili quanto la realt
soprasensibile, ov'esso esiste senza materia. Ma i passi che ver
ranno discussi in seguito escludono questa idea (cfr, specialmente
K 2, 1060 a 7), e si deve ammettere che la formulazione
rigorosa
dell'alternativa fra scienza del mondo sensibile e scienza del mondo
soprasensibile c assolutamente essenziale per la concezione com
plessiva espressa in K. Se il Natorp avesse tenuto dietro attraverso
l'intera Metafisica
alle divergenze dottrinali da lui osservate in K,
avrebbe di necessit, in
luogo di giungere all'atetes del libro
K,
notato quel nesso
cronologico e interiore dei due gruppi, diversi
tra loro, di testimonianze, che si spiega in modo soddisfacente solo
con l'ammissione di un progressivo allontanamento di Aristotele da
Platone.
2) Cfr. p. 277.
284
CT.I ANNI DI VIAGGIO
niente, noi cerchiamo un'altra specie di ea-
sere, e lo scopo del nostro sforzo appunto questo, di
indagare se esiste qualcosa di separato e di esistente per
e, che non eia attributo di alcuna realt sensibile 3).
Aristotele intende qui per realt che esiste separata.
mente per e
V-afr' tauro) non la singola esi
stenza concreta del mondo fenomenico, che pure da lui
spesso designata come separata .
Qui egli adopera la
espressione nel senso del platonico delle idee,
com' dimostrato dall'aggiunto
avvertimento di ricercare
una realt che esste per se, e non come attributo di
una cosa sensibile (pijtvi twv [af-yjriBv
ijji
&p%ov). Con
tale aggiunta Aristotele esclude in modo esplicito che
si possa pensare alla forma
immanente (IvuXov e!So$).In
questo stesso brano essa c da lui designata,
per ci che
concerne la sua
esistenza, col semplice epiteto di peri-
tura(cptiap'CvJ.Se lametafisica
dev'esserci, suo oggetto non
pu esser per lui, qui partecipe di tale aprioristica con
vinzione dei platonici, altro che una realt etema ed
essenziale, sussistente di per s in modo trascendente
(fSto?
ocfa xwPLfJ'c'
it/v).
Questa, egli dice,
dev'esser
pensata come analoga non alle cose sensibili,
ma all'idea platonica. Una qualsiasi realt di tal genere
deve per forza sussistere, se non si vuole che si riduca
a parola vuota di senso tutto quello che hanno pensato
proprio gli spiriti pi colti. Come potrebbe il mondo
essere comunque ordinato, se non esistesse una tale real
t? L'ordine presuppone infatti qualcosa di etemo, tra
scendente e duraturo1).
Per la loro
risolutezza, queste
_') Metaph., K 2, 1060 a 7-13.
=) Metaph., K 2, 1060 a 21 (iaXXovx'fiv iipyjf) xupttoxpa xa'jxg
(scil.
xi) OAtj g)
5isi$v stvea -t stSog xal [lOp'j "XcOxo 3 pOapxv,
6<uj ox Ipxiv
t8io; oOo'.a yuiptOTjj xa y.a.3-'
a'jTvjv. XX'fixo-
jiov ' Soixe yP
frettai 5n xi&v xapissxdtcov
65 ooi
T-j
na'- o'>3a
xsiatrc
-nij yp laxai xd|ig fiv) xivoj 5vxoj
'iSioo xal xpiotoS xal
fivovxosjCfr. anche K 2, 1060 b 1-3.
l'evoluzione della metafisica 285
espressioni si distinguono notevolmente da quelle della
redazione posteriore. Esse sono ancora del tutto prossi
me al platonismo, e si avverte in esse un'appassionata
asserzione
dell'esigenza di un mondo soprasensibile,
che
ha tanto
maggiore efficacia in quanto 6gorga
immediata
mente dalla convinzione dell'insostenibilit della meta
fisica delle idee professata fino allora1).
Sul presupposto
di una realt eterna e immutabile
e sulle eterne leggi cosmiche che essa assicura 6 fonda,
secondo K 1-8, non solo la possibilit
della scienza ri
cercata , ma in generale quella di un pensiero logico
immune da contraddizioni e quella di verit assolute e
durature. Ilmondo sensibile infatti incontinuo flusso,
e non c' in esso dove metter saldo il piede5). IIprin
cipio di contraddizione cos fondato in forma essen
zialmente
ontologica, la quale sembra invece eliminata
in massima parte da Aristotele nella sua posteriore
for
mulazione di quel principio.
Infatti ci che detto alla
fine del libro P circa il nesso che stringe l'eternit e
l'immobilit dell'essere e la possibilit di conoscenza di
') Cfr. il rifiuto, che immediatamente
precede, della conce
zione
platonica del soprasensibile: K 2,
11)60 a 13-18. Questo
passo
ha conservato forse nel modo pi immediato di tutti il postulato
platonico della trascendenza che sta alla base della metafisica ari
stotelica. Esso prova inoltre come la vgif della natura, che sem
bra ad Aristotele inspiegabile senza l'ammissione di an yad-iv
trascendente
quale supremo principio, 6ia divenuta per lui ilpunto
di partenza per la restaurazione
della teoria del soprasensibile.
1
Metaph., K 6, 1063 a 11. In Entstekungsgesch. d. Metaph.,
p. 82, io ho avvertilo, contro
ilNalorp, rome sia esagerato ascrivere
all'autore di K l'idea che nella sfera del terreno
e del transeunte
non sussista in generale alcuna verit: ina ho esagerato a mia volta
nel senso opposto,
negando ogni differenza rispetto alla giustifica
zione altrimenti data da Aristotele del concetto della verit. Si deve
ammettere che in questo passo l'accento posto sull'eternit del
l'essere cosmico, e ehe anzitutto su di essa fondata la possibilit
di verit costanti, mentre in P 5,
1010 a 1 segg. s'insiste viceversa
principalmente sulla possibilit
di giungere ad affermazioni sal
damente consistenti anche
riguardo al mondo
sensibile, solo in se
conda linea seguendo il richiamo alla xivijxos tpoig e al cosmo
11010 a 25).
286 GLI ANNI DI YIACC10
verit durature mancava inparte degli antichi manoscrit
ti. Evidentemente, siamo qui di fronte a un capitolo che
Aristotele aveva cancellato nella pi tarda rielaborazio
ne, ma che in seguito fu trovato ancora tra le sue carte,
e compreso nel testo dagli editori. In ogni caso dimostra
anch'esso che la redazione originaria del libro T aveva
maggiormente
accentuato i fondamenti metafisici del
principio di
contraddizione 1). Tanto la giustificazione
ontologica del principio stesso quanto l'inserzione di que
sti problemi fondamentali della logica nella sfera della
metafisica appartenevano alla tradizione platonica. Euna
aporia egualmente nata solo sul terreno della tradizione
platonica la questione circa il luogo in cui si debba
trattare la materia degli enti matematici, e se ci faccia
parte del compito della prima filosofia2).
Questa
tratta
zione compiuta nel libro M, la cui stretta connessione
con K 1-8 fornisce una nuova conferma dell'antichit
di entrambe
queste parti.
Ancora nel libro B, come gi vedemmo, il senso in
cui si svolgono le aporie determinato dall'impostazio
ne dei problemi e dal contenuto propri della metafisica
platonica. La rielaborazione di
questa parte fu piutlo-
') II brano della
Metafisica che da T 8, 1012 b 22 va sino alla
fine del libro mancava secondo Alessandro {Comm.
in At. Metaph.,
p. 341, 30 Hayduck) in parte degli antichi manoscritti,
*) Metaph., IC 1, 1059 b 15-21. Nel citato mio libro, p. 74, ho
chiarito il concetto della DXi; a&v paibjpceciK&v e stabilito, con
tro Natorp, che esso appartiene alla tarda metafsica platonica. Ma
perch questo problema si trovi soltanto in K e non in B que
stione alla quale neanch'io seppi col rispondere
in modo esau
riente. La trattazione del problema si trova, come gi allora vidi,
in N 2, 1088 b 14: ma questo fatto costituisce nello stesso tempo
la migliore spiegazione della mancanza dell'aporia in B. N ap
partiene, come K, alla prima
metafsica, e contiene quindi l'adem
pimento della promessa col fatta. Nella redazione posteriore (B,
M 1-9) la questione degli
axsixera
dell* siala soprasensibile passa,
come si gi mostrato (cfr. p. 257), totalmente in ombra. Essa
era legata alla tarda dottrina platonica dell' siala separata dei nu-
meri ecc., superata la quale Aristotele elimin senz'altro nella po
steriore sua fase di sviluppo, tutto questo complesso di questioni
l'evoluzione della metafisica 287
sto estrinseca, e non riusc perci a cancellare il fonda
mentale carattere platonico. Anche prescindendo dal fat
to che in due luoghi si perfino conservata la vecchia
prima persona plurale caratteristica dell'Aristotele pla
tonico 1), altrimenti eliminata dovunque nella nuova rie
laborazione, sono stati evidentemente modificati o atte
nuati solo quei passi dalla cui lettera il nuovo con
cetto della metafisica risultava addirittura escluso. Anche
il numero e la scelta delle aporie resta nel complesso
immutata, e solo in un punto inserito un nuovo pro
blema.
Questa
inserzione d'altronde caratteristica: con
cerne il contenuto dei libri Z K , che erano stati ag
giunti all'opera. Prima dell'ultima aporia, infatti, nel
la redazione pi tarda (B 6, 1002 b 33) posto
il problema
della materia e quello dell'attualit e della potenzialit
dei principi, ed presa in esame anche la realt sensi
bile. Ora, giacch proprio questo problema, come ha gi
visto ilNatorp, manca inK 1-8, non possiamo trarre da
questo stato di cose altra conclusione da quella che Ari
stotele ha inserito il nuovo problema quando rielaborava
itre libri introduttivi per adattarli all'ammissione della
teoria della forma immanente e della potenzialit e at
tualit. InK, invece, il puro concetto dell'essere ancora
separato inmodo rigidamente platonico da ogni materia,
e identificato all'esistente per s, all'immobile e al tra
scendente. Inoltre, mentre nell'ultima rielaborazione la
critica delle idee pass da A 9 nel nuovo libro M, la
redazione pi antica dell'introduzione presuppone an
cora l'originario stato delle cose, in cui la critica pro
cedeva trovandosi nel primo libro, giacch, per la con-
') Cfr. p. 234. Ilfatto che B appartenga alla parte dell'introdu-
zione rielaborata per la
Metafisica
pi tarda, mentre la critica delle
idee contenuta in A 9 doveva scomparire del tutto, spiega a suffi
cienza perch in B si siano conservate soltanto cos poche tracce
di questa prima persona plurale. Esse vi sono rimaste soltanto
per una svista.
288 CU ANNI DI VIAGGIO
lutazione delle idee, essa rimanda appunto a quel che
precede! *). Cos il fatto della rielaborazione pi tarda
e dell'introduzione di un nuovo concetto della metafisica
dimostrato anche per itre libri introduttivi!! T E, e
quasi per l'intera
Metafisica
sono rimesse in luce la re
dazione pi antica e la redazione ultima.
possibile tuttavia dimostrare che nemmeno la pi
antica redazione dell'introduzione (K 1-8) rappresenta
ancora la forma originaria della
Metafisica.
Abbiamo vi
sto come in K 1-8 la metafisica sia definita come scienza
della realt immobile, eterna e trascendente. Accanto a
questa si trova la definizione che la determina quale
scienza dell'ente come tale (5v -g 8v), dalla quale per
altro qui non si generato ancora, come invece accade
nella rielaborazione pi tarda, il concetto di essa quale
scienza dei molteplici significati dell'essere, compreso l'es
sere sensibile della natura diveniente. Con tutto ci gi
nell'unificazione delle due determinazioni concettuali
date in K 1*8 implicita una seria difficolt, la quale di
viene anche pi chiaramente sensibile nell'ulteriore sta
dio evolutivo rappresentato dal libro E, destinato, nella
forma rielaborata che oggi presenta, a servire d'introdu
zione alla scienza dei molteplici significati dell'essere.
Giacche la redazione pi antica e quella pi recente non
si distinguono da questo punto di vista, ma solo da
quello della diversa ampiezza con cui trattano del con
cetto dell'essere, possiamo senza incorrere in errore porre
a fondamento dell'introduzione, in ci che segue, tanto
l'una quanto l'altra delle due redazioni.
InE 1(== K 7) Aristotele chiarisce il significato da
') Il passo Metaph., Ivi, 1059 b 3 presuppone la confutazione
delle idee, mentre B 2, 997 b 3, che nella redazione pi recente
gli corrisponde, presuppone soltanto l'illustrazione storica della dot
trina delle idee contenuta in A 6, la quale rimase nel primo libro
anche dopo il trasferimento della critica delle idee da A 9 in
M 4-5.
l'evoluzione della metafisica 289
lui attribuito a una scienza dell'ente come tale. Tutte
le scienze indagano certe cause e principi delle realt.
Come esempio egli cita la medicina e la ginnastica e, tra
quelle che metodicamente stanno su un piano superiore,
la matematica: cio quelle che nella metodologia ed epi
stemologia platonica erano correntemente considerate
quali esemplari tipici. Tutte queste scienze delimitano
metodicamente un determinato dominio della realt
<5v
ti) e una sua determinata specie (ysvoj T;) e indaga
no questo complesso, in s concluso, di dati. Ma non
parlano dell'essere dei loro oggetti, bens lo presuppon
gono, o sul fondamento dell'esperienza sensibile, come la
scienza naturale e la medicina, oppure partendo da de
terminate definizioni, quali gli assiomi da cui muove la
matematica. Le loro dimostrazioni, che si distinguono
solo per il grado dell'esattezza, hanno sempre per og
getto solo le propriet e le funzioni che derivano da
quelle definizioni, e rispettivamente da dati di fatto evi
denti' al senso. Il metafisico invece indaga 1' essere in
quanto esso tale. E studia cos ipresupposti di quelle
scienze, mentre esse non intendono di renderne conto
n sono in grado di farlo.
Questi
chiarimenti sono integrati dall'inizio del libro
r ( K 3). Col contrapposto, in modo anche pi
chiaro e penetrante, il carattere della prima filosofia co
me scienza universale a quello delle scienze particolari,
e l'ente come tale ai suoi singoli domini.
Qui
l'ente
concepito non come un oggetto in certo modo distinto
e separato dagli altri oggetti, bens come il comune pun
to di riferimento per tutte le condizioni, propriet e
rapporti concettuali che si ricollegano al problema della
realt. Come il matematico considera, secondo Aristo
tele, tutte le cose solo dal punto di vista della quantit,
cos il filosofo indaga tutto ci che proprio dell'essere
come tale, mentre p. es. il fisico studia quest'ultimo solo
19.
W. Jaeger,
Aristotele.
29D CU ANNI DI VIACCIO
in quanto animato da movimento. Molte cose sono,
solo perch sono affezioni, stati, moti o relazioni di
un ente, e quindi comunque derivano da ima realt che
assolutamente . La riduzione (vayuyi]) di tutte le affe
zioni (7r-0"iq) dell'essere a un'unit comune (Iv ti '/ai
xoivv) era compiuta nella scuola platonica col metodo
della divisione come distinzione di opposti (vavxKcets)
i quali venivano fatti risalire a certe generalissime, o
prime , distinzioni dell'essere. Aristotele presuppone
come noto il lavoro speciale compiuto dalla scuola in
questo campo e la letteratura ad esso riferentesi. Oggetto
della1sua parafrasi cos l'antitesi dell'unit e della mol
teplicit, dell'identico e del diverso, del simile e del dis
simile, in breve l'intero dominio della dialettica plato
nica, quale si presenta nell'indagine sull'ente e l'uno
(8v xal fv) del libro I; ed anche un'indagine del
genere di quella circa le leggi ultime del pensiero, i
principi di non contraddizione e del terzo escluso, da
lui trattati nel libro T.
Questi
problemi si ricollegano
invero solo mediatamente con la teoria aristotelica della
sostanza: ma evidentemente lo scopo dell'autore quel
lo di trovare una definizione della metafisica che assicu
ri un posto anche alla dialettica tradizionale. Per Pla
tone la dialettica era immediatamente ontologia: peT
Aristotele diventa inveoe una questione piuttosto pratica
e storica quella di decidere se si debba accogliere nella
filosofia prima, come per ilpassato, ilcomplesso di que
sta logica dell'essere. La sua metafisica originaria una
teologia, come teoria dell'ente perfettissimo, e la dialet
tica astratta, dopo l'eliminazione delle idee, difficil
mente unificabile con essa. Tuttavia egli ha compiuto
il tentativo di collegarle merc il comune riferimento
all'ente come tale (8v ij ov).
Mentre in questo contesto di pensiero la suprema
filosofia si presenta come la scienza universale, in El
l'evoluzione dei la metafisica 291
K 7), dove Aristotele cerca di distinguere metafisica,
fisica e matematica in funzione dei loro oggetti, a que
sto inquadramento ne segue immediatamente un altro
diverso. Aristotele divide qui le scienze in teoretiche,
pratiche e poietiche. La fisica una scienza teoretica:
essa indaga l'essere che pu muoversi, e considera perci
l'essenza e la forma concettuale solo in quanto essa col
legata con la materia. Ogni astrazione dalla materia co
stituirebbe errore per il fisico. Persino Io studio della
psicologia dev' esser condotto in tal modo, in quanto
esso verte circa ildominio della realt psicofisica. Scien
za teoretica, , parimenti, la matematica. Certo, Aristo
tele pone in dubbio se isuoi oggetti possiedano un'es
senza immobile ed esistente di per s in modo indipen
dente, secondo la dottrina dell'Accademia, che egli qui
discute pure accogliendone la tripartizione della filoso
fia teoretica e la collocazione degli oggetti matematici
in posizione intermedia tra quelli dell'ontologia e quelli
della fisica; ma comunque per lui la matematica consi
dera isuoi oggetti come immobili ed esistenti per s
("5 xfvq-a '/al fj ojptox fretopel). A tanto maggior ra
gione l'indagine di un essere immobile e trascendente,
nel caso che uno simile esista in realt, costituir il com
pito di una scienza teoretica. Ma qual' questa scienza?
Non pu essere la fisica, perch isuoi oggetti sono, s,
esistenti per s (xwptox), ma non immobili; e tanto
meno pu essere la matematica, perch l'essere che ne
costituisce l'oggetto , s, in parte immobile, ma non esi
stente di per s in modo indipendente. La suprema filo
sofia indaga invece unessere, che tanto esistente per s
quanto
immobile1). Da questa definizione si indurrebbe
') Metaph., E 1, 1026 a 13, dove lo Schwegler ha esattamente
corretto: v, [lv yip cpuoixr)
icspi /copiati (x">Pl5ta codd.) (lv
SXX'ox ixivijta, tijg 8 jiaOr|]iaTt/C?j Ivia rcept
ixh/ta
[lv o5
/<o-
pioti S'tou>;, XX'j li bXrj'
%
8 r.piixij v.al nepl /piati xal &Y.I-
292 CLI ANNI DI VIAGGIO
senz'altro che Aristotele pensi qui al motore immobile.
Ma egli stesso, nella frase die segue, dice che iprincipi a
cui allude sono le cause degli accadimenti visibili tra
quelli divini (altea
tol? cpavspol? tSv fts(o)v), e chiama
perci la metafisica addirittura teologia (EoXoyix).
Questa
determinazione dell'essenza della metafisica
operata solo per mezzo del suo oggetto, l'essere immo
bile e trascendente, la rende d'altronde solo una scienza
particolare accanto alle altre. Mentre essa, in quanto
scienza universale dell'essere come tale, era posta innet
to contrasto con le altre scienze, indaganti solo una spe
cie determinata dell'essere (Sv ti xal ylvo ti) *), qui
essa etessa solo la conoscenza della specie pi eminente
dell'essere (tepl t tipiitatov yvo). Il suo oggetto
detto un essere di tale specie (toiauxtj cpat?), ed da ri
cercare in un determinato genere di realt, cio nella
regione cosmica della realt visibile ma imperitura. La
contraddizione innegabile, e gi lo stesso Aristotele
l'ha notata. In un' annotazione, visibilmente distaccata
dal contesto e palesante cos la sua natura di aggiunta
posteriore da lui apportata a questo passo, che costituisce
il punto culminante e conclusivo dell'introduzione, ha os-
tjhx. Nei manoscritti penetrata la congettura di un lettore, che
diede a xupiot il senso di trascendenti e pens che questo
non conveniva agli vuXa et8j del mondo visibile. Ma xo)Piax<
significa qui solo esistente in modo autonomo : e in tal senso
Aristotele l'adopera anche a proposito di cose sensibili. Se, con
forme a questa definizione, la metafisica ha un oggetto1 che dev'es
sere nello stesso tempo esistente in realt e immoto, ci significa
peraltro che esso dev'essere
xMPlCTS
nel senso di trascendente ,
perch solo la realt soprasensibile riunisce in s entrambe quelle |
propriet.
') Metaph., E 3, 1025 b 8 XX rataal axai itepl 5v ti xal
yivog ti nspiYpaijjfiEvai nspl totou 7ipaY|iaicovcal, XX"
oxl
ttspl vTOg jtXfig o5"
-J
8v. 'Cfr. invece 1026 a 19 circa la meta
fisica come scienza del divino: o yp SSijXov 8ti si izo'i t 3-eov
itpxsi, v t t o ia t
5
cpoei Oitdpx", xal ttjv TijiitBTTrjv
(scil. iJuirijpTjv) Set ftepl t ti[i iitcctov yvog slvat (scil.
itspl t ftsiov).
l'evoluzione della metafisica 293
servato ci che segue: Si pu dubitare se la prima filo
sofia sia una scienza1 universale e se si riferisca a un. ge
nere determinato di realt(Ttsp! tiylvog) e a unessere sin
golo e determinato (ipaiv Tiv jjiav). Inci pure una
netta differenza, come si vede p. es. nella matematica. La
geometria e l'astronomia concernono un genere determi
nato di realt, mentre la matematica generale vale per
tutti gli oggetti particolari di tali scienze. Ora, 6e al
di l delle cose naturali non esistesse un altro essere,
trascendente, la fisica sarebbe la scienza prima. Se in
vece c' un essere immobile, allora questo costituisce un
prius rispetto al mondo dell'apparenza sensibile, e la
metafsica la scienza prima. Ed universale, ap
punto perch la prima. E questa
scienza dovrebbe
allora aver bene anche il compito di considerare l'essere
come tale e di studiare ilsuo concetto e le propriet
che gli appartengono in quanto ente 1).
Lai nota marginale non elimina la contraddizione,
ed anzi la rende anche pi evidente. Nel tentativo di
unificare l due definizioni, che egli compie con la sua
aggiunta, Aristotele intende per scienza- universale la
scienza dell'oggetto primo, che principio in senso
pi comprensivo di quanto
siano le specie dell'essere
che ad esso seguono. Ma in PI e sul principio di E uni
versale significava ci cite in generale non si riferisce a
un essere determinato, cio a una sezione particolare
dell'essere. Ora, che imotori immateriali, iquali diri
gono il moto delle stelle, non siano n un 5v ti n una
puoi? ti? pia to 2vxog non tesi che possa essere soste
nuta dia Aristotele, n effettivamente egli la sostiene. Po
trebbe nascere il sospetto che rxopia, insieme con la
Xuaig, la quale presenta in modo cos evidente l'aspetto
della ricapitolazione sommaria, non risalisse affatto ad
') E1, 1026 a 23-32. Gi il Bonitz not, nel suo commento, la
contraddizione implicita in questo passo, senza peraltro spiegarla.
3?
,<%
294 CLJ ANNI DI VIAGGIO
.''2
Aristotele, se essa non si trovasse anche nella redazione
K 8 e non corrispondesse al dato di fatto della contrad
dizione che vi sussiste. Nonrimane perci che ammettere
che il filosofo non ha potuto risolvere l'aporia, e che
in ogni modo essa gli si presentala solo dopo che aveva
gi fuse insieme le due redazioni.
Senza dubbio le due deduzioni del concetto della me
tafisica non sono risultate da un unico atto di creazione
spirituale. Due processi di pensiero essenzialmente di-
versi si trovano qui incastrati l'uno nell'altro. Si vede
subito che quello pi originario ed antico quello teolo-
gico-platonico, e nonsolo per considerazioni storiche, ma
anche perch quello di gran lunga meno sviluppato e
pischematico. Esso deriva dalla tendenza del platonico
a distinguere nettamente iregni del sensibile e del so
prasensibile, mentre la definizione dell' Sv 5v com
prende ogni ente in un grande ed unitario edificio ge
rarchico. Tra le due, dunque quest'ultima la pi ari
stotelica, inconformit con l'estrema e pi originale fase
evolutiva del pensiero dello Stagirita. Inorigine, Aristo
tele si rigorosamente attenuto all'indirizzo platonico
mantenendo, secondo quanto mostra lo scritto program
maticoIlepl cptXococpla?, ilmondo soprasensibile come og
getto della suprema filosofia e soltanto sostituendo alle
idee trascendenti' ilprimo motore, concepito coi caratteri
d'immobilit, eternit e trascendenza propri dell'essere
platonico.Questa metafisica piantica era esclusivamente
scienza dell'essere immobile e trascendente, cio teologia,
e non scienza dell'ente come tale.
Questo
risultato confermato ancora una volta dalla
trattazione che siamo abituati a chiamare senz'altro la
teologia , cio illibro A della
Metafisica.
Gi ilBonitz
ha rilevato come esso non abbia alcuna relazione cogli
altri libri, mentre ci si dovrebbe aspettare che esso con
tenesse la conclusione dei libri A-. Che lo scritto non
l
f
L'rvoLUzrojve della metafisica 295
si riferisca affatto a ci che precede spiegato
dal suo
\ carattere d'indipendenza. Com' dimostrato dallo stile
\e
dalla Bcelta dei concetti, esso rappresenta
una singola
lezione o conferenza, composta per una determinata oc
casione, la quale non offre soltanto la parte
della totale
scienza metafisica designata come teologia, bens qualcosa
di assai pi comprensivo: un completo sistema di meta
fisica in nuce. Inlinee serrate, Aristotele offre un pano
rama di tutta la sua' filosofia teoretica, cominciando con
la dottrina della sostanza e concludendo con la dottrina
di Dio. Evidentemente egli non mira a esporre indagini
scolastiche, ma a trascinar con s gli uditori con la ser
rata imponenza del grande quadro, Con sicuri colpi' di
martello egli scalpella frasi solenni, che anche oggi il
lettore pronuncia involontariamente ad alta voce, per
quanto si tratti di appunti soltanto abbozzati per l'espo
sizione orale. L'attivit creativa dello spirito pensante
e vita . Tutto nel mondo orientato' verso un fine .
Da questo principio dipende il cielo e la natura. Di
entusiasmante efficacia laconclusione, incui egli rivolge
ai dualisti platonici la parola di Agamennone:
ox ya-
9v rcoAuxotpavhj, si; xolpavoj
gain.
undocumentounico
nel suo genere, perch
ilfilosofo traccia qui con audace
disegno, come non fa in nessun altro punto
delle sue
trattazioni dottrinali, ilquadro complessivo della Bua vi
sione del mondo, senza curarsi di alcuna delle questioni
singole. Nello stesso tempo esso un documento inesti
mabile della sua evoluzione, giacch esso risale cronolo
gicamente a quel periodo teologico, di cui abbiamo in
ferito l'esistenza. Esso ci mostra quale fosse la relazione
che legava la
teora delle forme immanenti a quella del
motore trascendente prima che Aristotele accogliesse la
prima nella stessa Metafisica.
IIdiscorso si scinde in due parti disuguali. La prima
(capp. 1-5) discute la teoria della realt sensibile e per-
296 CU AN! DI VIAGGIO
I
1
V *
i
I
viene, merc laeua analisi, ai concetti della materia, della ( .
forma, della potenza e dell'alto. La seconda (capp. 6-10) !
s'inizia subito col concetto' speculativo del motore immo- '
bile e con l'asserzione di una realt soprasensibile. La
prima parte non fine per s stessa come la
seguente, .
bens sussiste solo in grazia della seconda, a cui serve di
fondamento. Dal mobile mondo delle cose, concepite co- :
me forme evolventisi e realizzantsi nella materia, Ari-
slotelc sale all'immobile scopo e principio del loro mo-
r.\
viwiento, alla forma di tutte le forme, all'atto puro, al- .-.v
l'energia plastica libera di ogni elemento materiale e
/''!
creativamente attiva. Su questo argomento egli indugia
perci anche quasi pi. del doppio che su quello della
prima parte. A
prima vista, la costruzione sembra la
1
;
i
stessa che quella data dalla pitarda rielaborazione della
Metafisica.
Anche col la teoria della sostanza c dell'atto
'li
precede la teologia, e la prima parte di A e sostanziai- "ly
mente parallela al contenuto dei libri ZHQ.
Ma la di-
%
stinzione essenziale nel fatto che nel libro A l'ambito
ideale della metafisica limitato alla seconda parte, la
prima non essendo considerata come pertinente ad essa.
Le parolefinali *) della primaparte dicono: Con ci ab* V
biamo definito la natura e il numero dei principi del fi)
mondo sensibile . E la seconda
parte comincia: Giac
che abbiamo distinto in principio tre specie nell'essere, fi
due che
appartengono alla fisica ed una che immobile,
dobbiamo ora trattare di quest'ultima. Noi diciamo:deve
esistere un essere (oaCa) eterno ed immobile. Aristo
tele non designa, come fa pi tardi 2), le due specie della
realt sensibile come pertinenti in certo modo alla
;
fisica, ma le chiama fisiche senz'altro. D'altro lato la
realt immobile ed eterna appare senz'altro quale oggetto
') Mctaph., A 5, 1071 b 1.
!) Metaph., Z 11, 1037 a 14 inai ipdttoy uva tfjg
tfUoiv.xc
xal
Bsuxpaj ftXoaotfia; ipyov -spi -ig alaSvjtg oatag frecopia.
I
l'evoluzione della metafisica
297
I
della metafsica, come accade anche nella redazione pi
antica delFintroduzione2), E, allo stesso modo che in
quella, egli designa la realt sensibile col
semplice at
tributo della transitoriet, deducendone che, se nulla esi
stesse oltre la forma immanente nelle coee
sensibili, tutto
nel mondo sarebbe necessariamente soggetto al! divenire
eracliteo2). K e A coincidono inoltre anche nel ricono
scere come oggetto della scienza in questione solo la
realt trascendente, che non inerisce ad alcuna cosa sen
sibile3). Le tre specie dell'essere distinte in principio
6ono semplicemente suddivise tra fisica e metafisica: le
due specie appartenenti al mondo dei sensi, cio Focix
imperitura dei corpi celesti e quella peritura delle piante,
degli animali e via dicendo vengono senza limitazione
assegnate alla fisica, in quanto
esse sono collegate col
movimento e con la materia, mentre l'essenza immota c
l'oggetto di un'altra
scienza, la metafisica4).
Se riassumiamo queste
osservazioni, vediamo come il
') La determinazione delia scienza ricercata merc le pro
priet di cctSiov, x<npu?zv, jivov richieste per il suo oggetto se
condo il modello delle idee s'incontra, oltre che nella pi antica
redazione della introduzione offerta da K 2, I960 a 26, anche in
un altro passo antico, A 2, 982 b 28
983 a 11, dove essa conce
pita a priori come teologia, allo stesso modo che nel Hept cpiXo-
ootfiaj. Anche in NI, 1087 a 30 detto come ifilosofi abbiano
ammesso pyat opposte tanto nella fisica quanto per le o&afai im
mobili (cio nel soprasensibile, dominio della prima philosophia).
L'identificazione della sfera metafisica con quella delle xvtjtoi
oetai caratteristica del contenuto dottrinale di N, che appartiene
al nucleo pi antico tra tutti.
*)' Le oaat sensibili, eccettuato il mondo astrale, sono assolu
tamente cpfrapxccC inA l, 1669 a 31 e in 6, 1071 b 6: e cfr. K2, 1060
a 22. Molto pi circostanziato quello ebe pi tardi si legge in
Z 8, 1033 b 5 e in H 3, 1043 b 15: cpOapxr) vsu voi rjOeipscS-ai,
Ysfovvai
Sveu xo
firveoOtu.
11 mondo fenomenico, che per Ari
stotele inizialmente affatto mutevole, qui appare pienamente com
penetrato dall'idea che anch'esso partecipa dell'immutabile, in gra
zia del principio formale ebe in esso domina.
*) Metaph-, K 2, 1060 a 12 /oiptatv xaO' aut6 xal |iy]BevI
tfflv alaS-rjtSv 6itpxov e cfr. A 6, 1071b 19; 7, 1073 a4.
*) Metaph., A 1, 1069 a 30; a 36.
298
CU ANSI DI VTACCIO
libro A rappresenti quello stadio evolutivo, precedente
a quello della
Metafisica tradizionale e gi da noiinferito,
che era ancora puramente platonico e che non ricono
sceva1 ancora affatto nella teoria della sostanza sensibile
un elemento integrante
della primafilosofia. Ecio, detto
intermini aristotelici: lametafisica nel senso dei libro
A non indaga l'intera categoria dell'orafa, ma ne con
sidera
separatamente una parte determinata.
Questa
co
stituita da ci che inseno alla categoria dell'orafa per
fetto e buono (ya&v): suo oggetto il fre; e il
vot> 1).
Essa ricerca unessere trascendente nelsenso dell'idea pla
tonica, che unifichi ins assoluta realt (oafa) e assoluto
valore (Yav), Secondo A gli ya& e gli co
stituiscono due distinte serie ascendenti, che convergono
verso
l'alto. Esse s'intersecano nel punto in cui il pi
alto valore (ptaxov) coincide col pi puro essere (oafa).
Questo
il concetto platonizzante all'ptcTOV (iens per-
jectisiimum) quale gi
trovammo svolto nella dimostra
zione di Dio contenuta nel dialogo llep
<piXoaocpfa;.
La seconda e anche pi importante
osservazione con
cerne la posizione della teoria delle
forme immanenti.
Solo dal libro A risulta chiaro come fosse connessa
con la teologa questa parte vitale della filosofia aristote
lica, per tutto il
tempo in cui
appartenne alla fisica: La
costruzione gerarchica che dalla forma sensbile ascende
alla forma pura e soprasensibile, compiuta
pi tardi in
seno al quadro della metafisica, si trova in A ancora
nella forma primitiva secondo la quale la metafisica, co
ma scienza
dell'immoto e del
trascendente, fondata in
modo puramente esteriore sulla fsica, scienza del mosso
') Eth. Nicom., A i,1096 a 19 segg., e specialmente a 24: nella
categoria dell' citata t'ya36- il
&-l6c e il vo;: cfr. Et/. Eud.
A 8, 1217 b 30 c Mf.toph., A 7, 1072 a 34. La prima metafisica era
dunque la scienza dell'essere puro e perfetto e de]
bene sommo,
e noi gi quella di tutte le specie c isignificati
dell'essere, come
la metafisica posteriore.
l'evoluzione
della metafisica
290
e dell'immanente.
La fisica fornisce cos alla
metafisica,
merc
logica elaborazione
degli oggetti
dell'esperienza
sensibile, il concetto della forma e
dell'entelechia, che
essa
distngue dalla
materia e dalla potenza
indagando
la sua relazione rispetto a queste ultime. Ma mentre essa
stessa nonpumai astrarre dal momento del moto e della
materia, che nell'esperienza sono sempre dati insieme
colla
forma, la metafsica, in piedi sulle palle della
fisica, si slancia fino al concetto di una suprema ed imma
teriale forma
cosmica, da cui dipende la natura come
totalit e in cui la fisica trova finalmente la sua conclu
sione. Con riguardo a questa
sua funzione di vertice del
sistema fisico del movimento, essa vien chiamata ilprimo
motore. Qui
c'imbattiamo nella concezione pi
antica
della
teologia aristotelica:
la dottrina della conclusione
della fisica merc il trascendente
di ogni visibile
moto del mondo, che cos salva % ifenomeni della na
tura.
Se nella fisionomia teoretica del libro A,
la quale
quadra esattamente col risultato della nostra analisi de
gli altri libri, contenuta la garanzia interna della sua
piantica origineJ), questa
opinione d'altra parte
con
fermata anche da certi riferimenti esterni degli altri li
bri a A- Mentre la relazione d A eoa l'ultima rielabo
razione
della metafisica, quale abbiamo presente
nel
l'opera
aristotelica, esclusivamente
negativa, si appa
lesa ormai la strettissima parentela che la lega coi 'resti
della metafisica primitiva ad essa cronologicamente pros
simi, e in particolare
col libro N. Questa
relazione
sfuggita al Bonitz per il motivo che egli mirava sempre
solo a ritrovare la connessione d A con la serie eoe-
rente dei libri che lo precedono. Ora, questa serie e il
') Al cnp, 8 del libro A, inserito oosteriormeiUc, dedicata
pi oltre
un'indagine a parte.
300
GLI ANm DI VIAGGIO
suo piano d'insieme invece cronologicamente
posteriore
a A, mentre il libro N,
che esteriormente gli segue, fa
parte, come
dimostrammo, del complesso pi antico della
Metafsici, e dal punto di vista cronologico precede evi
dentemente il libro A. Gi abbastanza ovvia in 6 la
congettura che ilfilosofo, in una conferenza puramente
occasionale, che doveva offrire solo un breve riassunto
della sua complessiva concezione metafisica, si sia basato
sugli appunti delle sue lezioni. Effettivamente, egli
non
ha dato in A molto pi che un estratto del suo corso
esoterico su tale argomento, che
naturalmente era assai
piampio, come ci permettono di provare, almeno nella
misura concessa dalla loro povert, iresti superstiti della
metafisica primitiva. Lapartepropriamente positiva della
filosofia del soprasensibile, cio la
teoria di Dio, manca
invero, purtroppo, tanto nellaredazione pi antica quan
to nella
rielaborazione pi recente;
ma la parte critica
ad essa precedente e diretta contro la metafisica degli
altri
Accademici ha servito ampiamente ad Aristotele
come fonte per la sua
conferenza, e
probabilmente
la
parte positiva della teologia di A stava
esattamente
nella stessa relazione rispetto alla non
pi esistente teo-
Iogi della metafisica primitiva: non ne era, cio, che
un estratto. La relaziona che lega A a N sia anzitutto
resa evidente merc la
giustapposizione di alcuni
passi
dipendenti1 l'uno dall'altro.
N 4, 1092 a 9
st oCv xal t
nOvai
T b
fa&v
iv zat( pxa*i
/.al a nOvai
otu>? &3vavov,
SXov Su al p/_c.l o3x Jp&ffig
noSiSov-cai.... ox ipO
8'&xoXa|igavei oS'sTtcj
napstx
ei i; -too 5Xou
pxS tij a 0v 5ipv*il
A 7, 1072 b 30
iooi 44 co Xaji p y o u -
siv, ifiaitep o U'jOaydpsioi xal
Snriainno?, t
xXXtotov
xal ptcTov iv ipxS
ttvai, 8i a xal civ
q?u-
aSv xal tu>v cptav t;
pxg altia (iiv etvai, -c6 84
xaXv xal t X e io v iv
tot; ix
(
l'evoluzione della metafisica
301
9UT&V,
5-ci il
opiouDv vsXfflv
84 alti tt
TsXsi-cspa, 8i
xal ir.t tiBv cpaitcuv cStoi? 4xstv
vjclv. uio*c jiijS ov it elvat T
iv ax. eEoi fp xal Ivca&a
xiXsiai al pxa-l i?
&i vaO-ta
&vd-pCD!tO
Y"P
Sv3-pU)rtOV
fs
v v
?
, xal ox Ioti ti
ocipiia epttov.
1
I
TOTtBV, OX pOwg oloVTat.
T yp 'xipjia 4; i-iptov satl
TtpQTgptOV TsXsltov, xal t
itpf-tov o ocpfia lo-rlv,
XX ai1 aXstov oTov
uptspov fivOptucov &v
tpaii] ti?
slvat to ocip-
jiaTO{i o av ix totou ysvi-
givov, XX' lispov g od ti
0-spp.a.
Gi a prima
vista s avverte come l'uno di questi
due passi' debba esser natosotto l'influsso dell'altro. Seb
bene A nomini esplicitamente Speusippo, mentre N po
lemizza contro di1 lui senza citarlo, non si pu dubitare
neppure un istante che la redazione data da N sia la
pi completa e originaria. essenzialmente pi precisa.
Da essa risulta pi chiaro come le p-a
t5)v iiiov xai
epUTfiv, di cui parlano entrambi ipassi, debbano costi
tuite secondo Speusippo
un'analogia rispetto alle p-ycc
too SXou, e come in ci nonsi abbia una deduzione rigo
rosa ma solo unapura
comparazione
(7sapetx<ecv). L'in
ferenza dall'evoluzione
ascendente degli esseri organici
a una
corrispondente
evoluzione della totalit cosmica
appare ad Aristotele una ptTjiaac;
st; XXo yvo;. La
esposizione di A non accenna affatto alla scarsa sicu
rezza
metodologica di questa argomentazione, e dice sol
tanto alla sfuggita : Sii t xal t&v tpurfiiv xal twv rpwv
t; pyi;
xxX. Ma anche per gli esseri organici l'opi
nione del teorico dell'evoluzione non calzante, dice
l'esposizione
nella seconda parte, perch la realt prima
non lo sperma, ma ilreale uomo
vivente, che preesiste
allo sperma.
All'inizio, con ci, sta la pura
attualit,
non la potenza o la materia. Lo stesso influsso di N con
statiamo alla fine della conferenza.
302
GLI ANNI Di VIAGGIO
N 3, 1090 b 13
Iti S iiuTj-crJoeisv v xig [itj
XCav sepS Civ spi (iv to
piO-|io
ixeevtif
xal tfiv [laOa;-
jMTO.y.&v T p. nj 8v Cu[i
ti X -
Xsofl-ett XXi]Xoi t4 pi*
t s p a toCj GsTEpov |ii
Svio; fp to piftpoQ oSv
ijtxov x jieyiOrj Inai toj t4
|jaS-T)|iBTtx jivov slvai
tpapi-
voi?, xal toBtidv Svchiv ij
4>oX') xal za oi[iaxa zi. laS-ijxd.
o&v. o ix s 8
-fi tf
6 aij
Ie lao 8 iti)
Si; j p&a
a Ix
tiv
<f
a ivo |ilvia v &axsp
lioX&yp TpaypSla.
A 10, 1075 b 37
ot Si Xiyovcsc Tv piO'iiv
Jtp&tov tv pa>b)[iaTixdv xal
oBxtof
atei SXXtjv ixojiivigv -
5m> xal p/j xisztji SXXej,
xEioo)8i(i)8ij t tr( v xo av-
t 4 j ooav oiooiv (o--
8iv yp
ri
izipa xfj itip
cojijSaXXsTai
oaaij [itq oaa)
xal pxs oXXg, t Si via
oB poBXstai o X itss o&a i
xaxff. oBx &Yaiv
oXoxoi-
pavlT], etj xotpavoj.
Tutta la parte finale del libro A , come qui viene
chiaramente in luce, sotto l'impressione
della polemica
condotta contro Speusippo in N 3.
Quando scriveva que
ste parole ne]
suo schizzo, Aristotele
aveva dinanzi a s
il suo pi antico lavoro speciale, o per lo meno questo
era
ancor vivo e presente nel suo spirito. Anche qui non
c' dubbio che iltesto originario sia costituito da Nenon
dal passo assai pi laconico di A. N pi chiaro nel
l'espressione quando dice "
TtfTSpd
tot? aiipoi? o&Blv
cup(3W.rai, mentre A
obnubila queste espressioni, in
dicanti con evidenza qua figurata idiversi
gradi del
l'essere teorizzati do
Speusippo, nel modo che segue :
otv yp
'?/
tpa z?j tspa
aupjXXsTat o&aa
y) pi; oaa.
Com' noto, Speusippo ammetteva per ogni specie d
ooia princpi particolari,
privi per di ulteriore con
nessione reciproca: uno per inumeri, uno per le gran
dezze, per l'anima ecc.1).
Queste pi sottili1 distinzioni
si
presentano chiare anche inN: secondo la concezione
di
Speusippo inumeri,
nonostantelaloronatura di prin-
!)
Metaph., Z 2, 1028 b 21.
l'evoluzione della metafisica
303
cipio supremo, potrebberovenir meno del tutto senza per
ci pregiudicare
l'esistenza delie grandezze,
die seguono
ai numeri, e a loro volta le grandezze potrebbero
man
care senza perci mutar nulla nell'esistenza
della consa-
pevolezza
o del mondo corporeamente
esteso. Con espres
sione calzante, Aristotele chiama questa
costruzione una
natura che composta
di scene incoerenti come una cat
tiva
tragedia. InA l'omissione delle ultimeparolerende
l'immagine della natura con pifiacca connessione sce
nicaoscura fino
all'incomprensibilit.
Abbandonandola,
Aristotele salta col al grandioso paragone del monarca
e della
noXuxoip-xvlr], ilquale riflette in maniera non
meno tagliente la disorganicit anarchica della dottrina
speusippea dei prncipi. Proprioilnon avvenuto compi-
mento
dell'immagine iniziata
dimostra che essa non
pi sentita come abbastanza
plastica per essere ricono
sciuta nel suo pieno diritto. Egli l'attinge tuttavia dal
suo armamentario come un elemento
dato e a lui con
sueto.
Anche N 1-2 stato utilizzato da Aristotele nella
stesura di A. La parola d'ordine di N 1 identica a
quello del capitolo terminale di A: lotta contro ildua
lismo platonico dei principi. Il resto risulta dalla giu
stapposizione dei brani.
N 1, 1087 a 29 A 10, 1075 a 25
i4vii{ 8 xoioot
5aa 54 Svaxa aujigaEvsc
Apx? .vavT la?.... si 8 tfjj -cona lots
SXXtu? Xfouai
xal
tiv ciiiVTiDv dpxijS [li) IvSixsTai
nota ci xlPl6ipuis
Xiyovtss
xpTSpv ti stvai, iSvxzzv
xal tn\ oiiov 4Xdxl0Ta-
nopiai,
sii] irjv 4p/Av trspv ti oaav Sst fu)
AavJliysiv. nivTsj yp
stvai Ti)v pxijv, otav et ti? X-
4
1
ivavitcov oio 5a i 6v -
yoi t Xedxv pxv stvai x
0ve 84 ai iv-ia oBts t4
f| l-tepov XX" fj Asuxiv, stvai ;
vavtiojv 4p&>g ' s&T* sv Scoi?
[ivioi Xa&* Bnoxsijisvoo, Xal "t ivavtla
bnpxai. it; 4x iSv
iTspv ti 8m Xsuxv stvai
"
xetya vavtoiv lara;, oh Xiysoaiv.
Yp nptgpov lavai. XX [lijv inaS-v) yip
t vav-ta X-
301 CU ANNI DI VHCCtO
flyvex ai Ttnv-a i
% ivav- XijXuv ' vjjitv 6s Xsxat
x iu> v ibj 6 noxsipivou ti- x o x o e iX s y
e)
s
x
$
x p
{
x o v
vg. dtvciyvwj pa jiiXtaxa xotg ti slvat. ol 81 x fxspov
ivavxloig xoGD-' Onpxsiv. atei xSv vavxluiv EpXyjv itotoO-
apa rcSv-a xvavxla xafl-' Orto- clv, uiaiisp ot x fivioov
y-s'.jtivou xal o58v xwpwxv....
TQ
*
0
'!> \
*v' toXXS.
ot Ss x fxspov xSv ivav-
xCuv 0 X y] v icoioSotv, ot
fiv
[ t fp ivi] x (p t o ip x
ivioov,
<S>5
xoDxo xv xo rcXij-
9-ooj oSoav qiaiv, o t 8 x i}
ivi x TX X vj 0- o g .
N 4, 1091 b 35 A 10, 1075 a 34
cujiJSatvei 5tj itcivxa x Sxi ixavnxo5
f
aOloo
Bvxa gsx
x
s iv xo xaxo [isOei I{; io xo v j x
S g co iv 6
1
axo xoiv y
P
xaxv ax ftxs p o v
(b 30) xax xs
817
ou|i(5aive". Sxo- xoiv oxo 1 xsiiov,
ita, xal x ivavxiov oxoi-
y e 10 v .. x y. ay. v ax.
L'esposizione delle aberranti conseguenze del duali
smo quale era professato dagli Accademici sfruttata
efficacemente in quale conclusione della conferenza :
essa serve a mettere in risalto il rigoroso spirito unitario,
e secondo 1' espressione aristotelica monarchico, intrin
seco alla dottrina dello spirito pensante se stesso.
Que
sto branodel libro A unmosaico di singole frasi e con
cetti semplicemente attinti a N 1. Le argomentazioni as
sai pi differenziate di N appaiono certo in A un po'
volgarizzate e semplificate, ma tuttavia risulta dapper
tutto evidente l'argomento fondamentale di cui si vale
il libro N per combattere la concezione dualistica del
principi gli svavtfa debbono essi stessi inerire a loro
volta a una terza realt che serva loro di sostrato, com'
richiesto dalla teoria aristotelica della forma e della pri
vazione, le quali esigono la materia per il trapasso dal
l'ima all'altra. Iltertium dabitur in A senz'altro asse-
l'evoluzione della metafisica 305
rito, mentre in N giustificato, Per noi, esclama trion
fante Aristotele, questo problema si risolve senza diffi
colt perch c' unterzo ente: e questo non la materia,
che la portatricedelle affezioni opposte, bens lospirito
assoluto, cio la forma libera della materia e perci non
legata ad alcun divenire e ad alcuna opposizione. Non il
materialismo consegue di necessit alla negazione del
dualismo, bens l'impero esclusivo dello spirito.
20.
\7. Jakgpp., iriilotil.
V.
LA PRIMA ETICA
L'angolo visuale dal quale necessario porsi per in
tendere l'etica aristotelica il problema della relazione
tra la Nicomachea e YEudemea. La cosiddetta Grande1!
Etica pu infatti esser qui esclusa dall'esame essendo sol
tanto un estratto dalle due altre opere, il cui autore fu
un peripatetico che da quelle pi ampie trattazioni vo
leva ricavare un compendioso manuale scolastico. Tra le
due opere principali il predominio della Nicamachea
stato in pratica quasi sempre illimitato, YEudemea pas
sando rispetto ad essa senz'altro inseconda linea. Solo di
quando in quando si ricorreva ad essa per trarne aiuto
nella interpretazione di passi difficili. Naturalmente que
sta condizione di cose non ingiustificata, perch la Ni-
comachea supera notevolmente l'altra opera per comple
tezza di concezione, chiarezza di stile e maturit di pen
siero. Gi nell'antichit ei commentava soltanto la Ni-
comachea e si trascurava quasi del tutto YEudemea, la
quale rimasta purtroppo ancor oggi simile a un terreno
incolto. Inepoca recentissima, certo, si manifestato un
consolante principio di miglioramento, ma poco si pu
ancora constatare della sua efficacia
tA PRIMA ETICA 307
Alla naturale disparit dei due scritti si aggiunse nel
l'ultimo cinquantennio l'atetesi delYEudemea operata da
L. Spengel, l'eminente studioeo di Aristotele e rinnova
tore della conoscenza dell'antica retorica1). Nel suo' fa
moso scritto, che si afferm subito universalmente e che
nella sostanza fa testo ancor oggi, egli sostenne la tesi
che YEudemea non fosse stata soltanto edita ma addirit
tura
composta dallo scolaro di Aristotele Eudemo di
Rodi. Anche se le 'forti e continue coincidenze con la
Nicomachea
potevano spiegarsi solo in forza di uno
stretto ricollegamento alla dottrina aristotelica e alla
formulazione che essa aveva trovato inquell'opera, l'altro
scritto tradiva comunque, con le sue non inessenziali di
vergenze, l'individualit di Eudemo. Molte cose nellaNi-
comachea apparivano tanto migliori, e l'intera opera
tanto pi ricca e matura, che non si riusciva a conce
pire che cosa avesse dovuto indurre Aristotele alla ste
sura di una replica tanto meno felice. La colpa del peg
gioramento era dunque dello scolaro. Soprattutto, poi,"]
[a
giustificazione teologica della morale data dall'Eu- j
demea apparivainconciliabilecon l'ideache si aveva della
'
personalit di Aristotele2). Di fatto, si tratta di diver
genze dalla Nicomachea, le quali esigono spiegazione. Si
pensava di doverle riconnettere con la religiosit perso
nale di Eudemo, di cui per altro non si sapeva se non
che egli era probabilmente l'autore di una storia della
teologia, mentre questa in realt parallela alla sua sto
ria della matematica e dell'astronomia e difficilmente pu
quindi esser valutata come espressione di vivace religio
sit personale8). sostanzialmente inbase all'attribuzio-
') Abhaiidl. d. bayr, Akad. d. tPissensch, III (1841), p. 534.
*) Zeller, Philos. d. Grlcchen, II, 2, 3* ed., p. 874; A. Grant,
The Ethic of Aristotle, I, p. 23 segg.
*) Zcller, 1. c., p. 870, n. 1. Se in quest'opera Eudemo trattava
delle cosmogonie di Orfeo, Omero, Esiodo, Aeusilao, Ferecide e
Epimenide, della teologia zoroastrica e di altre teologie orientali,
'>
1
M
3)8 CU ANNI
1)1 VIACCIO
___
__
! ne AeVEudemea che ci si venuta formando quell'imma- jV
I
gine del pio Eudemo , la quale poco vuol quadrare con
[Jo spirito positivistico della scuola postaristotelica
1). Co-
munque, VEudcmea reca nelle due edizioni tedesche oggi
accessibih del Fritzsche (1851) e del Susemihl (1884) il
titolo Eudemii RhodUEthica, ed anche imeritevolissimi
commentari inglesi alla A'icomachea del Grant, dello
Stewart e del Burnet, al pari dell'edizione tedesca del-
l'Apelt, considerano l'altra Etica come opera di Eudemo.
/' La tradizione iu s non offre alcun appiglio per
/tale ipotesi. Certo, il problema dei tre libri comuni al-
/
1' Eudemea e alla Nicomachea provoc gi nell' antichit
I
l'ipotesi che essi risalissero a Eudemo e dalla sua Etica
1 fossero stati pi tardi trasferiti nella Nicomachea per
colmare ima lacuna col esistente2). L'opinione pi
consueta era peraltro quella opposta, giacche quei tre
libri mancano,
com',
noto,
nei manoscritti dell' Eude
mea. Ci accadeva gi inet alessandrina, perch l'elenco
dei libri aristotelici noti, e certo anche esistenti, ad
Alessandria al tempo dello scolaro di Callimaco Ermippo
conosce solo un'etica in cinque libri, che evidentemente
l'Eudemea senza itre pi tardi accolti dalla Nico
macheas). Due delle ipotesi tramandate, che dovrebbero
egli dovette essere indotto a ci dalle notizie che su tali argomenti
Itaveva dato Aristotele ne! primo libro del spi cptXocotptag. ,
!) Cfr. a proposito del pio Eudemo C. Piat Aristoteles, '3
trad. ted. (Berlino, 1907), p. 394. Una religiosit sorprendente per 3
un peripatetico trova in lui il Gercke (in Einleitung i. d. klass. I
Alteri., II, 3* ed, p. 407). ,
jj
*) Aspasius, comm. in Arist. eth. Nic., p. 151, 24 e 161, 9 |
Heylbut. s
') Ci sembra a me dimostrato dall' indicazione ijS-ixwv a'
fi'
('
8' e' dell'elenco dato da Diogene e risalente a Ermippo, nonostante ,!
i dubbi sollevati di recente a questo proposito. Che la lista di
Esichio attribuisca invece all' opera dieci libri non costituisce con-
traddizione, anche se entrambe le liste provengono dal catalogo
' ,
di Ermippo. In Esichio si tratta evidentemente della Nicomachea,
o perch questa si trovava gi nominata in Ermippo accanto al-
VEudcmea o perche pi tardi la cifra 5 fu corretta in 10. Il fatto
LA PRIMA ETICA 309
chiarire la doppia redazione dell' Etica e isuoi titoli,
tradiscono la tarda origine gi con la loro ignoranza.
Cos dell' idea di Cicerone, che la Nicomachea po"~|
Irebbe benissimo essere opera di Nicomaco: idea che
non si potrebbe certo respingere, se l'Eudemea risa
lisse ad Eudemo x). Essa non peraltro che una mera
ipotesi combinatoria, come dimostra la sua misera giu
stificazione: perch il figlio di un padre eminente non
potrebbe esser diventato una volta tanto, per eccezione,
un brav' uomo? Egualmente superficiale e tarda l'in
terpretazione dei due titoli nel senso di Etica a Nico
maco e Etica a Eudemo. L' et di Aristotele non conosce .
dedica di trattati, come dimostra la falsificazione della .
Retorica ad Alessandro, la quale va sotto il nome di
Aristotele e alla quale un ingenuo ed antistorico cer- .
vello, completamente ignaro delle usanze letterarie del .
quarto secolo, ha premesso una prefazione con dedica. :
E ci anche prescindendo dal fatto che in entrambe lei
Etiche non esiste affatto dedica, e che oltre tutto non|
si tratta di opere destinate alla pubblicazione letteraria,'
ma di corsi di lezioni.
il L'opinione generale dell'antichit pi alta sembra
. dunque prospetti anch'essa soltanto una duplice edi
zione di inediti corsi aristotelici operata da Nicomaco
, e da Eudemo. Nulla osta all' ipotesi che Aristotele abbia
"lasciato diverse redazioni del suo corso di etica, come,
secondo quel che abbiamo messo in luce, ha fatto per
quello di metafisica. Anche qui a priori verosimile che
la redazione pi antica delle due sia quella superstite
solo in modo frammentario. La soluzione decisiva di
rhe ilei manoscritti dcll'Euiemca i libri siano cinque conferma
l'indicazione di Diogene.
*) Cfr. le. testimonianze per questa ipotesi e per la seguente
nell' edizione dell' Eudemea curata dal Susemihl, prolegg., p. XVIII
segg, e in P. Von der Miilill, De Arist. elh. udem. auctoritate,
Diss. Gottinga, 1909, p. 25 segg,
310 CLI MNI DI VIAGGIO
questo problema deve risultare in prima linea dalla lo
gica interna con la quale l'Eudemea &' inserisce nel pro
cesso evolutivo dei problemi aristotelici. Tale metodo
di considerazione stato inaugurato dall' acuto e pru
dente lavoro di E. Kapp, di gran lunga la cosa migliore
che negli ultimi anni eia etata scritta sul?Eudemea e
sulla sua posizione filosofica '). Merc rinnovata compa
razione delle due Etiche esso giunge al risultato di resti
tuire V Eudemea ad Aristotele e di considerarla la pi
antica. Alla stessa conclusione era giunto alcuni anni
prima P. Von der Muhll, muovendo dai caratteristici
rapporti che legano V Eudemea alla Politica e ad alcuni
altri scritti 2).
Quanto
a me, sono giunto alle mie conclusioni, che
inparte coincidono con quelle dei miei due predecessori
e in parte le oltrepassano, per via diversa, e senza an
cora avere alcuna notizia delle loro osservazioni. Esporr
questo mio processo d' indagine, giacche vedo che la
loro intuizione dell' origine antica e dell' autenticit del-
VEudemca non si pienamente impoeta, e giacch, in-
') E. Kapp, Das Verhallnis der eudemischen sur nikoma
chischcn Ethk, Diss. Friburgo 15)12.
Von tier Muhll, I. c. II merito di questo assai dotto lavoro
consiste specialmente nella tenace ricerca dei contatti tra la Poli.
tica e l'Eudemea, gi segnalati dal Bendixen (in PhiloJogus, X,
1856, p. 575 segg.), e a cui esso aggiunge molte altre simili
osservazioni. Torneremo su tale questione nel capitolo sulla Poli.
tica, dove essa diventa importante.
Preferisco invece non valermene
immediatamente come di base per I' esame dell' Eudemea, perch
queste coincidenze, prese per s, non sono ancora forse sufficienti
per una piena
dimostrazione, anche se ai difensori della paternit
di Eudenio potrebbe riuscir gi difficile Io spiegare in modo soddi
sfacente il metodo di lavoro dimostrato dal Von der Muhll come
proprio dell' autore. Un certo numero di inesattezze filosofiche, che
il Von der Miihll intende attribuire all' Eudemea, spiegandole con
l'ipotesi che l'opera intera sia una non molto accnrata trascrizione
di lezioni aristoteliche fatta da Eudemo, slato illustrato con acuto
senso interpretativo da! Kapp, l. c., p. 8 segg. Resta cos per ora
aperta la questione se l'Eudemea aia una trascrizione di Eudemo
o una primitiva stesura di Aristotele.
LA PRIMA ETICA 311
sieme, spero d' essere in grado di arrecare alla questione
il suo chiarimento definitivo. Uno svantaggio delle inda
gini finora condotte era quello che esse non si fondavano
sulla considerazione complessiva dell' intero processo
evolutivo di Aristotele. Soprattutto lasciava adito a varie
obiezioni la limitazione del confronto alle due grandi
Etiche, mancando all' indagine un saldo punto di par
tenza, cronologicamente determinabile. Un simile criterio
inderogabile ci -s offre invece nell'etica aristotelica gio
vanile, finora non mai presa seriamente inconsiderazione.
Sulla base dei frammenti del Protreptico, compreso il
nuovo materiale che a questo proposito si potuto rin
tracciare, possibile designare un quadro dell'evoluzione
dell' etica aristotelica distinguendola in tre stadi chia
ramente distinti: il periodo del tardo platonismo rap
presentato dal Protreptico, quello della riforma del pla
tonismo rappresentato dall' Eudemea e -quello del tardo
aristotelismo rappresentato dalla Nicovnachea. L'indagine
si orienta per noi anzitutto verso il problema di distin
guere quale delle due opere maggiori sia da considerare
come la formulazione dell'etica aristotelica immediata
mente risultante dalla situazione problematica del Pro
treptico, e in generale di decidere se possibile mettere
in luce un continuato processo evolutivo.
1. Relazione tra l'Eudemea e il
Protreptico
IN ORDINE ALLO SVILUPPO DEI PROBLEMI.
La Nicomachea inizia lo studio della questione con
cernente lo scopo ultimo della vita umana con uno
schizzo a grandi linee del sistema dei fini. Con ci essa
determina subito illuogo che tale questione occupa nel
sistema complessivo della teleologia aristotelica, e indica
la via che dev'essere battuta in ci che segue. In modo
assai meno sistematico, ma pi vivace e personale,
312 CLI ANNI DI VIAGGIO
V Eudemea apre col principio del primo libro la mede
sima indagine. Sul propileo del tempio di Latona a Delo,
comincia il disserente, etanno scritti i
vergi:
xXXiaxov t
otxatxaxov, Xicxov S'oytafvsiv,
ndcvxtov fSiaxGv 5' o
xt
pa z xuetv.
A
questa manifestazione apodittica del popolare
eentimento greco della vita egli contrappone con passio
nale energia la sua tesi : Noi per non vogliamo con
ceder
questo all' autore dei versi. Ilsupremo valore mo
rale (xaXXcaxov) e il massimo bene (ptaxov) consiste
infatti nell' eudemonia, e questa insieme il sommo
piacere (Stoxov) . Con ci il problema dell'eudemonia
posto al vertice dell' etica, e forma
oggetto di tutto il
primo libro. IIsuo collegamento col problema morale
tradizionale fin dall'et di Socrate e di Platone, ed an
che la Nicomachea continua a considerarlo come punto
di partenza e d' arrivo dell' intera trattazione etica.
Que
st'ultima opera per molto moderna quando, nel pri
mo capitolo, antepone all'indagine circa il concetto del
l' eudemonia un proemio, il quale deduce dall' univer
sale sistema dei fini il concetto formale di un necessario
fine supremo, verso cui tutti gli uomini tendono. Solo
sul principio del capitolo seguente esso viene identificato
con l'eudemonia.
Il secondo punto che Aristotele tratta nella Nico
machea, prima di addentrarsi nell' indagine circa l'eu
demonia, la questione del metodo. Le indagini sul Pro-
treptico hanno dimostrato come Aristotele sia giunto
nella Nicomachea a un punto di vista metodologico dia
metralmente opposto a quello proprio della sua giovi
nezza. Con netta formulazione, egli lo manifesta
gubito
nel proemio1). Anche in questo l'Eudemea non mostra
'I-
"A
a1
') Circa 1* antitesi metodologica tra il l'rolreptico e la /Yco-
la PRIMA ETICA 313
la stessa decisione. Manca in essa la riflessione circa il
particolare carattere del metodo etico: e in suo luogo
l'autore manifesta la propria opinione circa la differenza
tra la considerazione filosofica dei problemi etico-poli
tici e quella non filosofica, cio su un argomento che
gi nel Protreptico veniva sottoposto a un1approfondita
indagine "). All'empiria veniva contrapposta col bru
scamente la conoscenza razionale delle pure norme e la
dialettica, quale unico metodo filosofico. UEudemea non
oppone a questa veduta, come la Nicomachea, il rigo
roso rifiuto dell' esigenza di un' esatta trattazione geo
metrica, e tende piuttosto ad occultare l'antitesi, che
I' altra mira invece nettamente ad illuminare. Occorre
oerto, essa osserva, attingere la forza persuasiva delle ar
gomentazioni a considerazioni logicamente universali
(Xyoi), ma insieme anche basarsi sui dati di fatto del
l' esperienza (tpaivjisva) e lasciarsi guidare da essi. Inol
tre si richiede che la norma filosofica venga conciliata
con le concezioni morali dominanti nell'umanit, merc
l' estrazione, operata con l'elaborazione concettuale, del
contenuto di verit che 6ta loro a fondamento.
Qui
l'ana
lisi concettuale dell'esperienza ha preso ilposto di quella
machea cfr. sopra, p. 110 segg. II brano che nella Nicomachea
premesso al principio dell'Eurfemea (Elh. Nic., A 2) chiamalo
proemio dallo stesso Aristotele: xal Kepi [lv xpoatou xal itrp
ixoSexviov xal -ti icpoTi&i|ieda, itecppoquciolk xooaO-ca. Poi, quasi
con le stesse parole adoperate al principio del primo capitolo,
egli riprende l'idea del sommo fine, a cui tutti tendono, e lo
scorge, come l'Eudemea, nell'eudemonia. Nella Nicomachea dunque
premessa all'inizio dell'indagine vera e propria, con piena
consapevolezza, la decisa asserzione dell' antitesi del1 metodo che
si adotta rispetto a quello seguito da Platone e, in precedenza,
da Aristotele stesso.
') Che il passo Elh. Eud., A 6 sia diretto contro l'Accademia
e Platone stato congetturato gi dal Von der Miihll (2. e-, p. 21),
mentre il Kapp ne dubita. In realt, qui Aristotele corregge in
parte e in parte rifiuta le dichiarazioni di metodo, platonicamente
orientate, del suo Protreptico (Jambl., Protr., c. X): cfr. sopra,
pag. 110 segg.
314 CLI ANNI DI VIAGGIO
i
conoscenza delle idee, intuite in seno all' anima stessa,
che propugnata dal Protreptico, per quanto s'insista
sul fatto che 1' esperienza in e confusa e che solo
il logos conduce ad una chiara penetrazione dei fonda
menti delle cose. L' antitesi del metodo filosofico e di
quello non filosofico non coincide pi, qui, con quella
della considerazione logico-normativa e della conside
razione empirica, ma equivale al binomio costituito da
due diverse specie di empiria: una specie inferiore, che
stabilisce soltanto dati di fatto, e ima specie superiore,
che di quei dati indaga la ragione. L'influenza- che sulla
dichiarazione dell' Eudemea esercita ilProtreptico si ma- V)
nifesta inoltre nella posizione che essa prende rispetto
. .V-
all' esigenza, secondo la quale al politico occorrerebbe
laconoscenza teoretica della norma morale. Sembra quasi
di ascoltare la difesa di una posizione gi per met ab- .
bandonata, quando l'Eudemea dice come anche per il
politico un sapere della specie di quello sopra descritto
f
sia non superfluo , dovendo esso penetrare le ragioni .
dei fatti etico-politici. D'altro lato, essa oppone resi
stenza a quei filosofi che aggravano la disciplina in que
stione con discussioni astratte e peregrine (che un'al
lusione alla teoria delle idee e dei numeri ideali), e
spiega le loro complicazioni come prodotto di incom
prensione e di boria (Xaovefa). Tra VEudemea ed il
Protreptico cade infatti l'abbandono della dottrina delle
idee e la- separazione della metafisica dall'etica. Ilcap. 8
del primo libro contiene la confutazione dell'idea del
bene ebe si trova anche nel secondo- libro della Nicoma-
chea. Ma mentre qui vien messo avanti, con nettezza
aggressiva, l'annuncio della rivoluzione metodica a cui
aveva dato luogo -quel passo, YEudemca cerca piuttosto
di far vedere come anche dopo la critica delle idee e
del metodo precedente brani assai considerevoli del Pro
treptico continuino ad aver valore.
i*
LA PRIMA ETICA 315
La formulazione dei problemi offerta dal primo libro
dell' Eudemea si manifesta cos, anche se osservata pi
da vicino, determinata dappertutto in misura sorpren
dente dal Protreptico, e mediatamente dalla
forma
men
tis consueta a Platone. Gi per Platone fa parte
del
contenuto stabile della dottrina dell'psTfj, e in parti
colare dell'impostazione problematica che ad essa in
troduce, la questione se la virt esista nell'uomo per
natura o se dipenda da esercizio, conoscenza, dono di
vino o caso. Ora giacch, come vedemmo, la questione
dell'essenza e del valore della virt soleva essere subor
dinata a quella della vera felicit, l'Eudemea, sul prin
cipio dell' indagine circa 1' eudemonia, fonde idue pro
blemi nella questione se l'eudemonia nasca per dispo
sizione naturale o per intelligenza o per esercizio e via
dicendo. Conosciamo la rispoeta gi dal Protreptico: di
penda 1' eudemonia da una di queste
cause o da pi di
esse o da tutte, gli uomini sono sostanzialmente con
cordi nell' idea che 1' eudemonia (qui identificata im
provvisamente all'e f)v) si basa su tre fattori, la cui
importanza per lo scopo da raggiungere vien giudicata
d'altronde in diverso modo: tppVTjcc?, pexrj, -?)&ovVj.
Gli uomini scorgono la vita beata e perfetta parte in
uno di questi tre fattori, parte nella loro giusta mesco
lanza: ilFilebo platonico la trova nella mescolanza della
cfpV7]ais e dell' -fjSoVTj, e il Protreptico aristotelico Del
l' unificazione di tutti e tre iprincipi
*). Ilfine della vita
(oxoti; to xaX&; che l'etica ha il compito di
determinare, dipende dalla soluzione di questo pro
blema. Li ogni caso, la questione dell' eudemonia con
duce a quella della miglior forma di vita (jtEpl jfou
xoO xpaxCoxoo xa xi); Ccpfoxrjc). Parlare di un
paxcepo?
v sarebbe forse meno raccomandabile che
') Plat., Phil., 22 A; Jambl., Prolr., p. 41, 11 e 59, 26 PistelJi.
.<
'
>
-
I
X
316 GLI ANNI DI VIAGGIO
,4'
di un e&
y.al
xkX&s qj}v, giacch la prima espressione p-
ttehhe urtare. Anche questa
correzione mostra come
1' Eudemca si
ricolleghi qui pienamente al Protreptico,
che parlava ancora audacemente
dell'elemento divino
(jiaxiptov) dell' uomo ed esortava a vivere soltanto per
esso l).
Sul Protreplico si fonda anche il seguente capitolo
quarto, che contiene la comparazioue delle forme di
vita (|3fcu). Dai tre
citati principi fondamentali, costi
tuenti la fonte di ogni valore umano, e cio dallo spirito
conoscente, dal
carattere morale e dalla sensazione di
piacere, vengono dedotte, come
nell'opera giovanile, tre
in
forme tipiche di vita.
Quella
fondata sulla scienza ha la
sua radice nella cppvr
jat$, quella politicamente
attiva
nell'pex, quella dedicata ai godimenti
nell'Sovfj 2),
i"'..
Dal Protrcptco, a
quanto sembra,
deriva anche 1' esem- .
pio di
Anassagora, che alla domanda chi il pi f-
!
lice? rispose: Nessuno di coloro che tu ritieni tali.
||
ma chi, anzi, ti farebbe molto meravigliare . Che infatti
'
lo stesso Anassagora non abbia veduto la felicit del-
l'uomo nella ricchezza e nella bellezza, ma forse nella
vita retta, pura e
scevra di sofferenza, partecipe di una C;
divina intuizione (xtv? S-etopfas xoivwvovxa Uefa?) cor- ,
risponde
esattamente a due passi del Protreplico in . .
1
cui ilmedesimo filosofo designava
l'intuizione del cosmo
:
quale vero scopo della vita umana e faceva partecipare,
merc ilvo, ilsecolo mortale alla divinit3). Nella de-
duzione dei tre pfoc viene nuovamente in luce, come gi
-
.
VLa distinzioneideilo
Zffi
dall' e (tsitifl;, X-rgO-Bg, xctXBcl
svolta minutamente nel Protreplico: v. Jam1)1-, Protr., c. XI,
e specialmente p. 4i6, 25; 58, 1; 9; 66, 9. Per il tiaxptov e il
Haxapltoj tfjv v. Eth. End., A , 1214 a 30; 3, 1215 a 10, e cfr.
Jambl., p. 48, 9.
Eth. End., A 4, 1215 a 26 - b 6.
") Eth. Eud., A 4, 1215 b 6 - 14, dr.
Jambl, Protr., p. 51,
11-15; 48, 13-18.
4
LA PRIMA EJICA
317
nelle espressioni circa il metodo da seguire
nell' etica, la
maggior vicinanza dell'
Eudemea, in confronto
della Ni-
comachca, alla
forma
mentis dei Protreptico.
La Nice-
machea conosce invece anch' essa pi (3;a
tra loro di
sputanti il premio dell'
eudemonia, e nello stesso conte
sto nomina esplicitamente quest'ultima J). Ma la ricorda
solo di sfuggita, come unluogo comune ormai
fisso, men
tre l'altra Etica attribuisce
grande importanza
proprio
alla deduzione sistematica di essa dai tre concetti di
9pvY/at{, pixfj, Sov. Questa
deduzione mostra donde
tragga origine la teoria dei tre
fi
tot: essa nasce dal grembo
della tarda etica platonica.
IlFilebo muove dalla que
stione del sommo bene
umano, e tratteggia la gara dei
due jtoi della ypvyoiz e dell'Sovq, per il raggiungi
mento di tale dignit 2). Nel Protreptico
si aggiunta
a queste due l'pexiij, e la vita ottima consiste nella giu
sta mescolanza di tutte e tre. questo ilmomento evo
lutivo in cui s'innesta l'Eudcmea-.
Che la Nicomachea
congervi
invero ijSfoi,
ma eli
mini la loro deduzione dal trinomio eppvat?, ptxi],
f/3ovrj, cosa che ha il suo motivo pi profondo nella
mutata posizione assunta col da Aristotele rispetto alla
qpvrjots 8). A tale proposito possiamo esser qui brevi,
') Eth. Nicom., A 2, 1095 b 17.
*) Plat, Phil., 20 E.
s) In Eth. Nic., A 2, 1095 b 14 non si trova pi una dedu
zione dei ire piot dai tre Viceversa, si deve anzi riconoscere
dai ptot quello eie gli uomini considerano come yaOv.
Ncll'o-
Aauoxixg 'oc esso l'Sovrj, nel iwJU-nxig (c( la ztp.-; (non
l'ipsxij). Di fronte al Ostopijux-jg p(oc Aristotele
resta in imba
razzo,
noa potendo adoperare il termine di q-pivijaig, e rinvia
perci alla ulteriore trattazione
dell'argomento (1096 a 4): cpirog
d'ozlt i&eaiprjv.x4(, Strip 5
zr/v
4jrloxsif>iv ivtcf
ttofisvoip
icoiijoiisO-a. A questi egli aggiunge poi ancora il XpijjiaTWtg piog,
scopo del quale il xXoxo;, eliminando cos a ragion veduta
ogni traccia della tripartizione antica. Inuovi
piot sono semplice
mente attinti all' osservazione
psicologica1 della vita, mentre itre
antichi avevano un significato normativo. Lo stesso procedimento
318 GLI ANNI DI VIAGGIO
avendo gi chiarito, nello studio del Protreptico, Tanti-
tesi che il concetto di tppdvrjat?, nel senso datogli da esso
e dalla filosofia platonica, costituisce rispetto a quello
presupposto dalla Nicomachea. Nell'interpretazione di
questo concetto trova espressione la diversa risposta data
da Platone e da Aristotele al problema della fondazione
e del criterio ultimo della moralit. Nel Protreptico la
9povija15 serbava ancora ilpieno seneo platonico del vo?,
attingente per via teoretica Tessere eterno e con ci
insieme il valore supremo. Solo il filosofo vive la vita
della cppvrjctg. La Nicomachea non fa pi dipendere il
retto giudizio
morale dalla conoscenza del trascendente,
e cerca invece una giustificazione
naturale nella con
sapevolezza pratica dell'uomo e nel suo costume etico.
Perci, nel primo libro della Nicomachea, Aristotele ha
logicamente
cancellato la cppvct;, insieme con la tripar
tizione del Protreptico. L' Eudemea invece non soltanto
l'ha mantenuta nell' antico senso, come si dimostrato,
ma da essa anzi deduce ildisegno e il piano dell' intero
sistema etico ]).
Questo
da essa enunciato nel modo seguente: Ttepl
S'petiJs xai cppovaetos
da notare 1' ordine, che cor
risponde all'effettiva serie delle parti dell'etica
irpwTov S-ewpijaiopev, xv xs cpuoiv axv ixaxpou xlq otc
/.al ittspov ppta xaxa
yafrijs Ctofj? aiiv,
a5x
) al npafei? ac rx auxfijv.
Della i)5ovi) 1' autore intende
trattare pi tardi2). Non esistendo ilibri centrali del-
T Eudemea,
dobbiamo controllare nella Nicomachea
eli
eliminazione si gi
osservalo, a proposito delle quattro virt
platoniche
del Protreptico, in Eth. Nic I 4, 1178 a 24 (cfr. p. 95).
) Che lo stesso contrasto a proposito del significato
della
9P0VIJOIS, gi da noi dimostrato sussistente (p. 106 segg) tra il
Irolreplico_ e la
Nicomachea, sussista anche fra T Eudemea e que-
st ultima, e stato notato dal Greenwood iAristotle,
Nicomachean
p 48)
Cambridge 1909), a cui si ricollega il Kapp (l. c.,
*) Eth. Eud.. A 5. 1216 a 37.
1A PRIMA ETICA 319
1" attuazione del progetto qui enunciato. Essa ha mante
nuto la stessa costruzione, nonostante che la pvr/aig
vi abbia un compito essenzialmente diverso da quello
che le era assegnato nell' Eudemea. Ilibri B-E com
prendono la prima parte, Jtepi pexfjg. Ad essa si con
nette in Z la teoria della ragione e della conoscenza,
a cui l'Eudemea d il titolo di Ttspl cppovasco?. Nella
Nicomachea Aristotele non si serve pi che della bipar
tizione, parimenti data anche dall' Eudemea, dellepexal
in rjkxat e Stavoijxixal, e identifica la trattazione delle
prime alla teoria 7tspl pexfj? e quella delle seconde alla
teoria rapi tppovceti)?. La tppvTjois peraltro costituisce
ancora, nella stessa
Nicomachea, 1' argomento principale
di questa parte. Illibro Htratta zxept VjSovfjs, e a ci si
aggiunge miche la trattazione che di tale problema
data in K, NeEa parte finale di K' Aristotele compie la
sintesi dei tre Ilibri intermedi, concementi l'ami
cizia (0 I), esistono invero gi anche nell' Eudemea, ma
non possono aver occupato quel posto
fin dall' origine,
com' dimostrato dalla struttura concettuale del com
plesso, che essi spezzano e ampliano 1). Solo in base al
l'Eudemea possiamo ancora scorgere come la costru
zione sistematica dell' etica aristotelica si sviluppi orga
nicamente, dalla tripartizione data nel Protreptico, in
tre distinte famiglie di problemi. IIcoronamento, verso
cui esse ascendono insieme, la dottrina dell' eudemo-
J) La genesi delle itpaYpaTstai. di Aristotele da singoli complessi
d' indagine, insi conclusi (i.4fO'., |i&o3oc, ecc.) stata da me dimo
strata in Entstehungsgeschichte d. Metaph. d. Ar., p. 150 segg. Ci
peraltro non va inteso nel senso che un' idea unitaria non compe
netri da cima a fondo anche un ampio gruppo di tali indagini
singole, e che queste siano sempKcemente giustapposte, senza un
saldo legame interno anche dal punto di vista del pensiero.
Quella
nozione giova soprattutto per intendere la composizione delle ope
re aristoteliche e ci aiuta a comprendere le loro incoerenze ed
apparenti deviazioni, facendole dipendere dal metodo di lavoro
e di insegnamento del filosofo.
320 OLI NKI DI VIAGGIO
nia, esposta
nel libro finale e sorretta in comune da
quei tre sostegni. Nella Nicomachea si rinuncia a de
durre, nel libro introduttivo, questa forma strutturale, e
la sua provenienza resta perci oscura. Anche in ci
una prova del carattere assai pi originario della reda
zione dell' Eudemea.
Veniamo ora alla conclusione per quel che con-
'
cerne la questione dell'autore. Che Eudemo, dopo
la morte del -maestro, fosse tornato di propria volont k-
a uno stadio evolutivo che quello aveva superato da '}
lungo tempo, appare escluso, tanto pi dato lo stretto
legame costituito dalla comunit scolastica. L'ipotesi che
Eudemo sia 1' autore dell' Etica che ne reca il nome de-
v' essere perci considerata come insostenibile in base
%
alla conquistata nozione del graduale sviluppo del pro- t
blema elico. Nella storia della filosofia greca si ripete !'|
pi volte il tentativo di chiarire con motivi biografici e <
personali ci che ha la sua ragion d'essere nell'interna . i
logica delle cose. La serie evolutiva costituita dal Filebo,
dal Protreptico, dall' Eudemea e dalla Nicomachea ri- !
sponde a un'inconfutabile logica storica: in essa non
possibile mettere un elemento al posto di un altro. Fi
nora si poteva essere in
dubbio circa la posizione del
l'Eudemea, ma ora che risultano stabiliti due punti della
via percorsa da Aristotele nella sua evoluzione, cio il
Protreptico e la Nicomachea, della cui autenticit nes
suno dubita, non pi difficile riconoscere come 1' Eude
mea non giaccia sul prolungamento di tale linea ma tra
i suoi punti terminali. Essa la Vrethik, la prima
etica, se lecito designare cosi la pi antica forma
dell' etica aristotelica indipendente, cio del tempo im
mediatamente posteriore al distacco dalla metafisica pla
tonica.
Nell'evoluzione della dottrina morale di Aristotele
la prima etica corrisponde morfologicamente al grado
I.A PIUMA KTlCA 321
rappresentato
dalla prima metafisica ncil' evoluzione
del suo pensiero metafisico. Con questa essa concorda
nel palese intento di creare, dopo la dissoluzione della
principale dottrina platonica, un
surrogato
scientifica
mente sostenibile, che nello ste6Bo tempo soddisfi al
l'esigenza religiosa e possa prendere sotto ogni aspetto
il luogo dell' intuizione delle idee. L'antitesi a Platone
doveva passare in seconda linea rispetto allo scopo di
creare una nuova forma di platonismo, adeguata ai
dati dell' esperienza, ma per il resto il pi conser
vativa possibile. Dal punto di vista del contenuto la
prima etica collegata alla prima metafisica dalla
giustificazione esclusivamente metafisica della moralit.
Come Aristotele, in questo periodo natale della pro
pria filosofia, manteneva ancora merc la teologia una
certa consanguineit con la metafisica di Platone, cosi
egli si riconnetteva all' etica platonica merc la morale
teonoma, designata nella prima etica dal concetto della
cppvijac;.
Come Platone e il Protreptico, l'Eudemea intende
per cppvTjms l'energia filosofica dello spirito, che, in
trascendente intuizione 5) del supremo valore esistente,
attinge la visione della divinit ed eleva il suo contem
plare a canone del volere e dell' agire: essa ancora, in
') Della distinzione di questa 3-ecopltt dal pensiero discorsivo
e scientifico Aristotele parla in Metapk., 0 10. Non si tratta della
verit nel senso della formazione empirica del giudizio, ma di
un'intuizione immediata, di un- toccare o atlingcre (CYY'*VStvl il
voijtdv oggetto di questa conoscenza: cfr. il Protreptico (Jamb!.,
58, 14) in cui il opvifiog definito come O-stoprv t pAte-K -fi>v
vtcov Ypi[i5v, La distinzione si esprime anche nel fatto che la
tppvrjatg, secondo Eth. Eud., 0 1, 1246 b 35, non una Ttiaxrjjir)
che si possa adoperare tanto a scopo buono quanto a scopo cattivo,
bens una dpsxrj del vog, che trasforma l'intera SS'S e consiste
in un yivog SXXo yvtoeiug. Anche nel Protreptico (Jambl.,
41.
22 segg.) essa Spett -toB voB. N contraddice a questo il fatto
che col (43, 5 segg.) essa consista proprio in una iniotTjfH),
perch questa appunto quella diversa forma di sapere.
21.
W. Jazgkb, Aristotele.
322 CLE ANNI DI VIACG10
egual misura, conoscenza teoretica dell' essere soprasen
sibile e pratica intelligenza morale. Anassagora per
essa ancora, come nel Protreptico, un esempio di questa
Ustop(u, icspi xfjv aXreiav. La cppvijocj ancora 1' ele
mento vitale del filosofo e del &swpT]iiy. (5(o. E per
ci, ancora, essa continua qui ad essere considerata come
y.opta icaav 7ua-njp>v e xijicwixrj ittaxpi} x) ;tutto iu
evidente antitesi rispetto alla Nicomachea.
Essa I'attivit trasformatrice, che traduce la cono
scenza del bene eterno nell' intenzione morale del volere
e 1' applica al caso singolo dell' agire pratico 2). Nella
Nicomachea invece essa senz'altro la icpax-f/.r;, e
nessun uomo agisce senza di essa : la filosofica cono
scenza di Dio non costituisce pi, in alcun modo, il suo
presupposto interno.
Quest'
ultima una conoscenza
superiore, accessibile solo a pochi mortali, senza che per
ci la ragion pratica sia limitata al piccolo cerchio dei
filosofi. Aristotele tenta cos d' intendere il dato di fatto
della moralit non filosofica inbase all' autonoma consa
pevolezza morale e alla sua norma interiore. Solo alla
fine egli inserisce in questo quadro ilfrewprjTix; pio?,
senza perci farne dipendere sempre la pstV) etica 8).
Nella redazione dell' Eudemea egli invece assai lon
tano da questo atteggiamento conciliante rispetto a ci
') La cppvijatj Netopia itept rqv Xrjd-siav in Elh. Eud,
A 4, 1215 b % e in I'rotr. presso Jsmbl-, 42, 15-25; xupCa
jtaoiv
Tuatrjp)v in Eth. Eud., t 1, 1246 b 9 e in Jambl-, 43, 2-7.
*) Elh. Eud., 8 2, 1248 a 29 yp pexi) -uo vo Spfavov.
') InElh. Nic., K 7 la vita della cotpa e del voBp chiamata
divina e sovrumana; in E 8 contrapposto a questo supremo
ideale, come ideale di secondo grado, 6 xax xijv XXrjv &pir\'j
(Sioj, che umano in senso vero e proprio. Di questa psxij non
filosofica detto (1178 a 16): oovieoxxat 81xal cppvvjotj xo
t-oug pst xal aBtt; <ppovi)osi, elitsp al pv "cfjS ?povijostBg
pyal xa-u tip tjHxds stoiv psxdj, x 8'4p84v xfv rjfkxv
xaxTTjvcfpvijaiv. La virt etica si tonda quindi su s stessa e
trova la propria felicit in se stessa, avendo anche una sua pecu
liare razionalit.
LA PRIMA t'flCA 323
che Platone chiama morale borghese (5'ijpoala ptzi})
Inessa lacppVTjat? ancora, informa del tutto esclusiva,
la contemplazione dell' pyd) divina, e senza di essa non
possibile azione morale: soltanto, oggetto della con
templazione non sono pi le idee platoniche, ma il Dio
trascendente della prima metafisica, che una me
tamorfosi dell' idea del bene. Come nella
Metafisica
il
motore immobile, cos nell' Eudemea concetto centrale
) ancora Dio: agire morale per essa tendere a Dio.
Anche ilProtrepticoconosceva un unicoscopo della vita:
abbandonare ilmondo terreno e sensibile e andare verso
Dio. C' un principio, oltre il quale non si d prin
cipio ulteriore, dice la prima etica a proposito dei
processi interni dell' anima. Come nell' universo Dio
che muove tutto, cos anche nell' anima. Tutto infatti
mosso, in certo modo, da ci che divino in noi
(il vo;). Ma il principio della ragione non a sua volta
ragione, bens qualcosa che pi alto della ragione.
Ora, che potrebbe essere pi alto del sapere e della ra
gione all' infuori di Dio? ').
Qui
torna lo etesso con
cetto che Aristotele aveva espresso alla fine del suo
scritto sulla preghiera (cfr. sopra, p. 212). La seria con
siderazione che l'Eudemea dedica all' entusiasmo, l'alta
valutazione della mantica, della fortuna e dell' elemento
istintivo, in quanto esso dipende da ispirazione divina e
non da disposizione naturale, in breve l'accentuazione
dell' irrazionale sta sullo stesso piano dell' intuizione
espressa nel Ilepl cptXoaocpfa?, in cui le irrazionali ener
gie chiaroveggenti dell' anima sono designate come l'ima
delle due fonti della fede in Dio. Neil' Eudemea Ari-
stotele pone l'ispirazione a un grado pi alto che la ra
gione e l'accorgimento morale, non perch essa irra
zionale (per questa ragione Platone aveva appunto, in
') Eth. Eud., 0 2, 1248 a 23.
324 GLI ANNI DI V1AGCJ0
maniera schiettamente socratica, messo il logos pi in
alto che l'entusiasmo) ma perch viene da Dio. Alla
moralit razionalistica manca l'infallibilit: essa solo
un prodotto di fredda riflessione, mentre la sicurezza del
l'ispirato quale il baleno; e come un cieco, che non
vede pi quel che ha innanzi agli occhi, ha una me
moria assai piforte e nel suo intemo scorge tutto chiaro
di fronte a s, cos l'uomo sorretto dall' ispirazione di
vina cieco e tuttavia pi sicuro che iveggenti nel co
gliere il punto giusto. D' incomparabile valore per la
comprensione di Aristotele nella sua et media ilfatto
che noi possediamo questa
sua descrizione, traboccante
di esperienza personale del tipo ideale del malinconico
e dell' ispirato ').
Come nella sua et giovanile, nell' Eudemea Aristo
tele esprime l'immediata importanza della conoscenza di
Dio per l'azione morale ancora merc il concetto plato
nico della norma assoluta 2). Nella sua etica posteriore
questo concetto passa del tutto in seconda linea, perch
l'interiore sicurezza di giudizio a) della perso
nalit moralmente educata, e che perci divien legge a
s stessa, non e affatto un termine puntuale, che possa
!) Per l'entusiasmo v. Eth. Eud., 2, 1248 a 30 segg., per
la montica a 35, 38; alla fortuna dedicato l'intero capitolo 2.
Aristotele distingue
l's&Toxiafsica
da quella metafisica. Al framm.
10 del Ilepl qjiXooocpCaj si avvicina ilpasso 1248 a 39.
*) Ilconcetto platonico di 6po? nel senso di norma, raggua
gliato anche a xaviv o sostituito con esso, minutamente evolto
nel Protreptico (Jambl., 54, 22
56, 2). Esso fondamentale per
l'impostazione metodica e metafsica tanto della tarda etica di
Platone quanto di quella giovanile di Aristotele. Questo concetto
assoluto della norma s'incontra anche in Eth. Eud. B 5, 1222 k 7;
H 9, 1241 b 36; 1243 b 29; 3, 1249 a 21; b 1; 19; 22; 24. Elimi
nate le idee, che fino allora avevano costituito lo oxorep di ogni
valutazione e di ogni tendenza normativa, il loro compito assunto
dal concetto di Dio. Ad esso si riferisce la maggior parte dei passi
citati. Nella A'icomachea la parola 6po{ ha invece un significato
del tutto diverso, e il concetto di Dio non vien pi inserito nel
problema della norma assoluta.
LA PIUMA ETICA 325
| esser nettamente delimitato allo eguardo come quel bene
| supremo in funzione del quale l'Eiidemoa comanda di
! vivere. La designazione della vita moralmente retta come
imitazione
(
[UfiTjciS,
imitatio) di norme assolute s' incon
tra nel Protreptico. Nella Nicomachea si trova la nota
definizione secondo la quale 1' agire morale un giusto
mezzo, che vien determinato dall' accorgimento e nel
modo in cui lo determinerebbe il 'ipvifio?. Su questo
giusto mezzo si molto dibattuto, essendo eeBo piut
tosto astratto e non scorgendosi subito a che esso miri1).
Ora, alla fine dell' Eudemea troviamo una lunga discus
sione a proposito della norma, in funzione della quale
lo aTcouSalo; riconosce e sceglie ci che moralmente
giusto. Da questo passo possiamo desumere inche modo
fosse originariamente conoepita da Aristotele la relazione
di ragion teoretica e di ragion pratica e che cosa egli
intendesse per pfri? Xd-p?. Anche il medico, vi s dice,
segue nel suo agire una norma, in funzione della quale
egli giudica ci che sano e ci che non sano per il
corpo. Si pu quindi dire che sano quel che comanda
la ragione medica. Ci sarebbe peraltro tanto esatto
quanto indeterminato. IIconcetto di ragione medica ac
quista un contenuto solo inforza del principio oggettivo
*) Eth. Nic., B 4, 1107 a 1 ictiv 5pa f| ipe-cyj
Ifi?
rtpoaipstur)
iv [Asa"CT)Tl oaa rcpp fjufig picpivy; Xf<p xal <bg v 6 cppivi-
jiop ptCEis. Il motivo della norma affiora qui ancora una volta;
e questa formulazione costituisce 1' espressione pi pregnante che
si possa trovare per la vicenda subita dalla posizione di Aristotele
rispetto a t8le problema. Per lui non esiste pi, infatti, alcuna
;
norma universale. xav tv dp8v
Xfov
formula adope
rata da tutti i'Platonici nella definizione dell' &pezri (cfr. Z 13,
1144 b 21). Ed giusta, ma tutt' altro che chiara, dice Aristotele
in Z 1, 1138 b 25: perci in Eth. Nic., Z, egli ha determinato pi
esattamente la partecipazione della ppvyjoig alla itpoafpscis-
Qui
la sua funzione non consiste pi, come nel Protreptico, nella
conoscenza della norma universale, bens nel ritrovamento dei
mezzi adatti per raggiungere lo scopo (TXop, cxoticj) determinato
> dalla volont morale: cfr. Z 13, 1144 a 8; 20; 1145 a 5.
326 CU ANNI DI VIAGGIO
a cui esso riferito, cio la salute e la sua legge immuta
bile. La medicina consiste quindi da un lato nella cono
scenza della salute e dall'altro nell'applicazione di que
sto sapere ai casi singoli. Parimenti, la ragione morale
da una parte conoscenza di unvalore esistente inmodo
oggettivo (freupYjTOCv), dall' altra applicazione di que
sta conoscenza all' agire umano, imperativo morale
(7tctaxTtxv).Ma il valore assoluto, o bene supremo, che
la ragione
conosce, Dio 1); e questi non da concepire
come legislatore e ordinatore, come dover essere o vo
lont, ma come supremo essere riposante in s stesso. La
volont e il comando sorgono solo nella ragione
(cppoVTjot?), in quanto essa si immerge nella contempla
zione di questo essere. Sommo dovere morale perci
la scelta di tutte quelle occupazioni ed azioni, e Pacqui
sto di tutti quei beni, che promuovono la conoscenza di
Dio: la filosofia teoretica la via per l'educazione mo
rale dell'uomo. Moralmente cattivo e riprovevole in
vece tutto ci, possesso o attivit che sia, che impedisce
all' uomo di servire e di conoscere Iddio (tv &v
(d-epairsusiv xal frecopeiv) 2). Com' noto, questa ancor
oggi una
definizione corrente della religione: Deum co
lere et cognoscere. La conclusione dell' Eudemea il do
vi
:A
i
l) Eth. Eliti., fi 3, 1249 a 21 sino alla fine. Anche qui egli
polemizza denunciando 1' oscurili della definizione accademica se
condo la quale la norma tg 5
X-fo?
(1249 b 3), allo stesso moda
che in Eth. /Vie., V. 1, 1138 L 25. un problema che lo ha dunque
assillato per tutta la vita. Ma la soluzione diverge, qui, da quella
data nell' Etica pi tarda. IL paragone della eovevig con la taxpixr)
era gi stato adoperato
nell'Accademia. Nel?Etica pi antica Ari
stotele lo modifica con la distinzione della medicina teoretica da
quella pratica. La conosce la norma (la
salute.
Dio) e
quindi l'applica. In Eth. Nic., Z 13, 1144 a 4 egli chiama il primo
momento ooCt e solo il secondo cppvijotj. Del resto gi nel
Protreptico, framm. 52 (p. 61, 25 R.) detto: Iti 81 ttg fjpiv
'/aviiv T(g 8pog xpipotspog tfflv
foS-Sv
tcX'jjv 6 ippvipog;
Ma col la eppivrjoiS in generale ancora indifferenziata, ed una
nwnhii} universale.
*) Eth. Eud., e 3, 1249 b 20.
LA PBIM ETICA
327
cumento classico della moralit teonoma, nel senso da
tole dal vecchio Platone. Dio la misura di tutte le cose.
Salvandola dal naufragio della dottrina delle idee merc
iltrasferimento nella sua etica, Aristotele ha la coscienza
di conservare
il nucleo duraturo della moralit plato
nica: cio il concetto della norma assoluta e la trascen
denza metafisica del bene, che per il platonico era di
ventata la fonte di una nuova esperienza di Dio. Non
stato certo un errore, se si sempre attribuito un tempe
ramento pio all' Eudemo sedicente autore di questa
Etica. Con l'idea che ci si faceva di Aristotele tutto ci
era inconciliabile.
Invece proprio il fervore religioso
della sua giovanile fede platonica che spira dal suo
primo corso di etica. Accanto a questa
etica del puro
culto di Dio, anche la famosa descrizione del
f
1
fteoprjTixg nel decimo libro della Nicomachea s' at
tenua quasi in un'immagine soltanto ideale e ogget
tiva della vita del dotto, dedicata allo studio del reale e
alla fine elevantesi all' intuizione della forza suprema
che volge le fere. Anche in questa
immagine, certo, ri
compaiono ivecchi colori, ma non possiedono pi tutta
la loro antica vivacit. La forza dell'etica aristotelica
pi tarda piuttosto nelle parti che contengono
l'ana
lisi realistica dei tipi morali, e nella sua umanit sa
tura di vita.
Con la freiopfa S-soO in origine strettamente con
nessa la teoria dell' amicizia, che nella Nicomachea si
amplia in una dottrina universalmente
sociologica delle
molteplici forme delle relazioni umane. In questa fe
nomenologia, riccamente
articolata, della vita sociale
non riconosceremmo pi che a fatica lo stretto nesso
collegante la filosofia aristotelica dell' amicizia alla dot
trina platonica delle idee, se accanto ad essa non posse
dessimo la pi antica etica, la quale ci fornisce un qua
dro evidente del metodo originariamente prospettato e
328 Cl.I ARNI DI VIAI0.1O
seguito da Aristotele. La trascendente ed universale idea
del bene qui sostituita da tipizzazioni di classe, come
in genere accade nelle forme pi antiche dell' etica e po
litica aristotelica.
Questi tipi ideali sono immanenti al
l' esperienza, ma tuttavia normativi, e cio non mere
rappresentazioni descrittive dello stato medio delle cose,
astratte dalla realt dell'esperienza. La pi importante
di queste tipizzazioni normative costituita dalla Jipt&TTj
cptXEce, dalla quale nell' Eudotnea vengono dedotte
tutte le specie di amicizia. Essa derivata immediata
mente dal concetto del Ttpwxov epfXov evolto nel Liside
platonico 1). Ma mentre quest'ultimo concetto designa
il supremo valore metafisico (ax t dyalv) rispetto
al quale tutti icpiXopeva terreni non sono che ombre,
Aristotele elabora nella rp'n-q cpiXfa l'immagine ideale
dell' amicizia. Inessa conservato il nucleo del concetto
platonico, e cio la fondazione dell' amicizia sul prin
cipio morale dell' ya&v. Ma per Aristotele il bene -
un valore moralmente concreto, che si sviluppa nel ca
rattere dell' uomo stesso. Il fondamento assiologico, so
pra-personale, della relazione umana non allontana qui,
come in Platone, l'interesse dalla personalit dell'amico,
ma anzi concentrato ed incorporato in essa. Il con
cetto aristotelico non quindi soltanto una diversa forma
di riduzione di ogni valore sociale umano al problema
universale del valore, bens mira alla giustificazione del
valore indipendente della personalit morale, e in ul
tima analisi alla giustificazione del valore universale della
moralit umana rispetto all' yafrv cosmico, fondato sub
l'idea di Dio.
La deduzione delle diverse forme di amicizia dalla
Tzptsjzrj cptXfa compiuta nell' Etica pi antica con l'aiuto
')
Plat, Lys., 219 C. Per l'esposizione dell'ideale della Jipi&xp
v. Eth. F.ud., II2, per 6 itpnog cpUog H 2, 1236 b 28.
LA PRIMA ETICA 329
di concetti schiettamente platonici. Alla distinzione del
volere ((fouXeoS-ac) dal desiderare (xstv) corrisponde
in Platone quella del bene assoluto (yat-v), come fine
a cui la volont tende per natura, dal bene apparente
(cpaivpevov ya&v), che il fine del desiderio. Da Pla
tone deriva inoltre la distinzione dell' yafrv dall' j/
e la tesi che l'ya&v
JtXfijje l'S stTtXffis
siano una
sola e identica cosa, e che quindi 1' amicizia di ci che
veramente buono sia nello stesso tempo gradita. Alla
dimostrazione che la Tipo>-i) <pcXa unifica in s tutte le
note che sono state in ogni tempo determinate come
caratteristiche dell' essenza dell' amicizia, non escluse
quelle apparentemente incompatibili tra loro, (dimo
strazione che un perfetto esemplare di dialettica della
prima et aristotelica), VEudemea dedica la parte prin
cipale dell' indagine. Nella Nicomachea l'espressione
7upa>Ti] cptXfa, che ricordava chiaramente la teoria delle
idee e faceva pensare ad un metodo puramente
dedut*.
tivo, sostituita con quella di reXet'a <piX(a 1). La teoria
platonizzante secondo cui gli altri sTSr) cpiXia; non sono
classi coordinate e possono avere il nome di amici
zia soltanto per ucciderti , insieme con la sua dedu
zione dal concetto ideale della perfetta amicizia, conser
vata invero anche in questa fase pi tarda: ma
_per
Ari
stotele ha ora maggiore importanza 1' analisi psicologica
e sociologica, di gran lunga preponderante gi quanto
all' estensione. Pi oltre constateremo un simile processo
evolutivo anche a proposito della politica. D materiale
dell'esperienza, ohe nella sostanza soggiace a leggi pro
prie e diviene sempre pi fine a s, stato inserito in
un secondo tempo nel quadro della costruzione ideale,
elaborata in Btile platonico.
Se l'esser buono il fondamento della verace ami-
') Eth. Aie., e 4.
330 GLI ANNI DI VIACCIO
LA PIUMA ETICA 331
") Eth. Eud., II6; Elh. /Vic., I4 e 8. La speculazione filosofica
approfondisce qui un principio della saggezza popolare greca, che
si trova espresso sovente: cfr. Sopliocl., Oed. Col., 309
xfc fi?
a&\z tX
aOxtp jiiXoc ;Eur., Wed., 86; fr. 460; Men., monost., 407.
Per il voO; come personalit soggettiva (il S) dell'uomo v.
Jambl., Prolr., 42, 3; 42, 14; Eth. Me., 18, 1168 b 35;K 7, 1178
a 2.
1Eth. End., E 6, 12-10 a 23.
cizia, la relazione etica dell'Io con s atesso acquista un
significato esemplare per il suo comportamento rispetto
al non-i-o. La distinzione della parte spirituale dell'anima
da quelle ad essa sottoposte, ma accessibili alla ragione, ;
offre ad Aristotele la possibilit di rappresentare la re- i
lazione morale dell' Io con se stesso sussumendola sotto j
il concetto dell'amor di s (cpcXau-la), per il quale egli 'j
non intende 1' egoismo, che la morale popolare consi-
'
dera a ragione riprovevole, ma 1' amore costitutivo che
la parte inferiore dell' anima, designata addirittura come
unsecondo Io, ha per ilsuperiore S (at) dell'uomo ').
Il Protreptico, giusta la pi tarda dottrina di Platone,
vedeva in questo S il voO?, il divino in noi.
E quale, secondo Platone, sia la relazione giusta del
l'anima dominata dallo spirito con s stessa detto dal
Timeo (34B), che chiama il supremo Dio visibile
yv)ptp,ov xal ipD.ov Ev.avfi>$ tv
atreff).
Cos l'egoismo
dell'uomo naturale superato e
posto in servigio della
volont di raggiungere il vero S. Iproblemi psicologici
connessi eou questa dottrina non sono formulati abba
stanza nettamente per le nostre esigenze, ma questa ob
biezione colpisce l'intera teoria di Aristotele circa il vo?,
che pure l'eredit speculativa venutagli dal tardo Pla
tone. La mistica della cpcXautfa, dalla quale Aristotele
deduce le caratteristiche della vera amicizia !), im
mediatamente comprensibile nell' atmosfera religiosa
dell' Eudemea. Anche ilsuo comandamento &ev {fswpsv
xal ftepaireueiv si basa del resto sulla dottrina platonica
del V04-
H risultato cos ottenuto ha naturalmente bisogno di
essere
confermato, nel particolare, da un'interpretazione
comparativa delle due Etiche. Ma ci non pu esser fatto
qui. sperabile che d' ora in poi la filologia b decida
a riguadagnare il tempo perduto nei riguardi dell' Eu
demea procurandole un utile commentario, e anzitutto
un testo degno del nome, di cui finora si manca affatto.
Per il nostro scopo deve bastarci se ci riuscito di mo
strare come anche nell' evoluzione del pensiero etico di
Aristotele si possa chiaramente individuare lo stadio che
nella metafisica rappresentato
da quello teologico, e
come esso sia strettamente collegato con la prima me
tafisica x.
2. L' Eudemea e il
problema degli
scritti
ESSOTERICI.
Hrisultato dell' indagine concernente lo sviluppo dei
problemi integrato e confermato dalla constatazione di
una forte dipendenza letteraria dell' Eudemea dagli
scritti giovanili di Aristotele. Particolarmente importanti
sono le sue relazioni col Protreptico, che anche a questo
riguardo getta luce affatto nuova sui problemi aristote
lici. Tra inuovi brani del Protreptico rintracciati in
Giamblico e V Eudemea sussistono, per ampi tratti, sin
golari coincidenze, le quali a quanto
sembra non sono
state ancora notate e, anche quando si prescinda del
*) Il giudizio espresso da J.
Bernays (Dialoga d. Ar., p. 82),
secondo il quale la teologia di Aristotele permea la sua filosofia
tanto poco quanto il suo Dio compenetra il mondo, non pi
sostenibile, ormai, per quel che concerne ilperiodo antico e quello
medio della sua evoluzione. Kesta comunque notevole il fatto che,
6uiia base di asserzioni del suo ultimo periodo, si potesse giungere
a questa opinione.
332 oli anni ci vucr.to
.
;
tutto dalla posizione dell' Eudemea in seno alla storia
!
dei problemi, sono gi sufficienti a confutare l'idea finora
' :;.
accettata nella sua appartenenza a Eudenio e della sua
1
tarda genesi. Ma anche per la caratterizzazione del me-
'!:
todo di lavoro seguito da Aristotele e per il giudizio
circa la relazione tra la sua attivit didattica e la pro-
'
duzione letteraria esBe sono d' importanza cosi decisiva ,
da esigere che se ne tratti ampiamente. E, quale gradito
f
risultato accessorio, esse procureranno anche la sicura
soluzione di un problema apparentemente disperato, e
tuttavia dibattuto sempre di nuovo perch fondamentale
per la comprensione di Aristotele, cio quello dei cosid
detti scritti essoterici.
Partiamo dall'inizio del secondo libro dell' Eudemea,
dove l'autore pone le basi della dottrina dell' pextq
e offre una deduzione del suo concetto. In questa occa- i
sione non abbiamo bisogno di addentrarci particolar
mente nel contenuto di tale punto fondamentale del
l'etica: basti un breve sguardo complessivo al
processo
della dimostrazione. Noi scegliamo ora, dice V Eudemea
dopo aver concluso l' introduzione contenuta nel primo
libro, un
nuovo punto di partenza per l'indagine.
Que
sto consiste nella partizione di tutti i beni
(
ya&) in
pi classi. Per tale partizione l'autore si richiama poi
esplicitamente agli l;wxeptxol Xyot, al fine di rispar
miarsi in questo passo una dimostrazione pi minuta.
Le classi di valori enumerate nel primo libro(ypvr/ac;,
psvq, f)5ovV}) sono tutte di natura psichica (v
siano esse costanti stati interni (l;ts) o facolt (S'jvpst?)
o energie attive (vpyetat) o movimenti (xtvfjcsti;). Lo
stesso
presupposto {e cio che si tratti o di uno stato o
di una disposizione o di una facolt di natura psichica) |
vale ora, continua l'autore, anche per 1' ptvfj, e deve
perci servire di base per la successiva deduzione con-
cettuale.
"
i .
I.A PRIMA ETICA 333
Il passo tramandato male, giacch la partizione
dei beni, nella lettera dei manoscritti (rcavxa Sf) x
ya& t]
iy.-.b:
fi t
4uXtl svisata da una lacuna. Nel
passo corrispondente della Nicomachea troviamo una
tripartizione dei Leni: veve[iT)|Jvwv Sf] xv yafrjv xpi/jj,
x*l tW (iv xx?
Xeyopvwv xcbv S uepl
4UX*V
cSpa, x xpl t}JUX'4v xupttxaxa Xyopev xal pXtaxa
yaM,
x?
5 npcsc? xal
x?
vepyeia? x$
4"JXt"/-S
epi
x(&pv
'). Immediatamente prima la Nicomachea
dice come sia necessario chiarire l'essenza dell' eude
monia non solo partendo dai principi generali ma anche
valutando le opinioni correnti (XX xai x xt&v Xeyop-
vtov Ttepl axfjgj. La stessa partizione si ritrova infine
anche nella Politica: voplcavxa; o&v fxav?
rcoXX X=y-
ofrai xal xt&v v
xo?
icoxspixol? Xyot? itepl xfj- plaxi]?
tofj? xal vv XPXC"0V xoi?" <I>? Xil)? yp up? y
p(av Staipectv oSeI? |iqxaT]xfjasisv
v t; o xptjv oaSv
peptSuiv xv xe xx?
xal xwv v a&paxt xal xwv v xfj
4>u-
X, nvxa xaxa xxX. 2). Anche qui la stessa partizione
viene attinta ai Xyot essoterici: e anzi non soltanto la
partizione come tale, ma anche l'indagine, ad essa col-
legante, circa la miglior forma di vita. Ilpasso della
Politica parla infatti esplicitamente degli essoterici
Xyot icspl piaxTjs osservando come occorra ri
prendere iloro concetti fondamentali nella trattazione
presente.
Lo Zeller, che considerava Eudemo come autore
dell'Etica, cercava di spiegare il richiamo ai Xyot esso
terici supponendo che Eudemo non facesse in realt che
riprodurre il passo della Nicomachea dov' enunciata
la necessit di partire dalle opinioni dominanti circa
')
Etk., Nic., A 8, 1098 b 12.
*) Pol., H1, 1323 a 21. Iltermine -/pija&aii nel senso del citare
ipropri scritti in larga misura, usato come terminus technicus
anche da Isocrate, Antid., 55 e 74.
334
cr.r ANNI DI VIAGGIO
l'eudemonia (x ltv
Xeyopvov spi a'JTqc,), ma avesse
per sostituito
questa vaga designazione
coli'espressione
'.a'vpo'jp.e.vt'ci 4v voi; qit/cpr/.ots Xyoij, coniata
imitando il passo
della1 Politica1). Con questa interpre
tazione non s capisce peraltro perch
Eudemo fosse do
vuto giungere a parlare
in prima persona (oiaipoupsfra)
di uno seritto di
Aristotele.
Noi vediamo ora quel che allora non era dato scor
gere, e cio che una soluzione del problema
dei
Xfot
essoterici era ingenerale
impossibile per chi partisse dal
presupposto che autore dell' Eudemea fosse
Eudemo. In
fatti o si seguiva,
come il Bernays, il sano
istinto filolo
gico e il senso
dello stile e in quei
Xift
s vedevano
reali scritti di
Aristotele: e allora si cadeva in un'inso
lubile
contraddizione rispetto alla
citazione dei Xyot
essoterici contenuta nell' Eudemea1).
Oppure si partiva
da questo passo, ritenuto di Eudemo, e si
creava, senza
curarsi d'altro che d'essere consequenziari,
un significato
di eesoterico che
in s era ilmeno significativo
possi
bile e
costituiva non tanto un
chiarimento quanto una
scappatoia dal
dilemma, non tenendo alcun conto delle
esigenze
dell'interpretazione
filologica 8).
Restituita
l'Eudemea ad
Aristotele, nulla pi osta alla
congettura
del Bernays,
che iXyoi essoterici fossero
scritti deter
minati, e anzi
appunto le opere letterarie di Aristotele.
Tale congettura
riceve conferma dal
nuovo materiale,
3)
Hermes, XV, p.
554.
*) li Bernays,
a quanto
vedo, ha curiosamente
trascurato pro
prio il passo Eth. Eud., B 1, pur discutendo
sistematicamente tutti
ipassi di Aristotele in cui vengono citati gli t|tepixol X-j-o1..
Riferendosi ad esso, si poteva
abbattere tutta la sua costruzione in
base agli
6tessi presupposti
allora considerati validi.
*)
H. Diels, Ueber die
cxolerischen Reden des Aristoteles,
inBer. d. Beri. Akod.,
1883, p. 477 egg. : sul passo
eudemeo v. p. 481.
Isuoi argomenti
sembra siano stali universalmente
accettati: ilche
spiegabile in forza della situazione delle cose. Oggi non resta
altro che confessare che si era messo per una via sbagliata.
Nella
sua lealt metodica, peraltro, anche il suo tentativo non fu inutile.
r.A PRIMA ETICA
335
senza ilquale essa resterebbe una mera ipotesi: salvo
il
fatto che nel caso presente
non si tratta d un dialogo,
come credeva ilBernays, bens del Protreptico.
Protr., 52, 12.
ots t [isv SXXa
(seil. t
xzf) Set xpdtieiv
Sysxte riv
tv a'jTiji YlYv0!1vtu''
fatHbv,
touteov
S aOtdiv t [lv v T(p
o>]iau tv v fyayjrj, t#-,v
S
pet-qv T7j; <ppovog(og
touto
yp otiv
xpttatov (segue la
definizione
degli ya&).
Protr., 59, 26.
f&Miy z'iyi sSayioviav
ti-
9"|j.e&a jtoi tppivTjaiv stvxi xai
-uva
ootpiav ff
Tv pstijv i} t
[lXiota
/alpeiv f) nuta -cauta
(segue l'analisi
particolare).
Protr., 41, 20,
trjg 8 "X3!? t (lv Wyo;
ottv
Sitsp nata cpoiv Spxst xal
xplvsi Tispl ptv, t 8' Instai
ts xal nitpuy.sv SpysuSai.
Eth. Eud., B 1, 1218 l. 32.
itv-a 6 ti Sya8- i) xt?
i
't
(v oibpati
?/
tv)
"/a)-
totmv alpettspa t v vj
, v. a8it s p
Siaipo-
[is8a xal v tot?
u)ts-
pixot? Xiyotj.
<fp6vT]ot? yp xal psrq ai
T)8ovrj v
4>uxtS.
5,'J
gv'a
nvta "iXo; slva: Sor.st itSotv.
Eth. Eud., 1219 h 28.
bnoxt(a$(D o
[ispi] '{"J/SJ?
t Xyoi) petixovta
o tv
atv 8 tp-ov |ist-/_Et.Y yoo
cEntco, JA ti
fiv
tip mtt-
tsiv t 8 ti nsC8sc8ai
xal
xosiv nstfuxvat.
Imateriali logici, trasferiti
senz' altro nell' Eudemea
e tra loro connessi in maniera frettolosa, si ritrovano
nel
Protreptico non colo, in gran parte, in una fo-rma che
ne
riecheggia 1' espressione
letterale, ma
anche, che c
pi importante,
nella loro piena connessione
organica.
Protr., 41, 22.
Eth. Eud., B 1, 1218 b 37.
itv 8 e6 Sid-Asitai xat tata 8rj oOtws
noxelaOio
trjv otxstav pstvjv t xal nspi pstrjj, 8ti otlv
yp
tstuxTxveu
ta&iijs yaiv
fsXtiOti] 8 i8suij
3:6 GLI ANNI DI VIAGGIO
43X1. -/ai (ivjv 8xav
fs *Xfl
[Xtoxa /al /upuiixaxa /al xi-
(lutaxa xrjv psxvjv, xxs s5
S'.xsixaf xo
3sX.tIovo?
tpa aosi psXxiuiv cxlv
fj xax qsaiv psxnj. JD.xiov
81
t xax tpotv pixaixspov /al
[iSXXov ys|iovi/4v,
i? fiv8pai-
jto? Ttp? t 5XXa
$a
o 5 x o v
rp ij
y
r/
jiv oaifixxo; [sXtiov
(pxixcxspov yp),
4'UX'S
T
Xiyov
5xov
*a' ivotav.... ijx
i?
TX O X o5v Isxlv psx-q
totou t o 5
fi
ipou;, vay-
xa?ov slvat Ttvxeiv atps-
xoxoixxjv 4txX(s ts txSsi /a!
xal f&p v xoxo, olpax,
5-sv) ti?, &? [toi jivov ?| [li-
Xioxa
OflV
x [lplOV
xoxo. Itixoivuv 6xav 8 Tisffloxev
Sp-j-ov xoxou }i xax ou(i-
psjijx?, XX /a.'>'a'n
=-/-
fisvov
xdXX'.axa ixoxsXjj, xxs
xal xoxo SyaS-ov
elvat
Xe/xiov, xafixxjv xs ps-
xv' 8sxov xu p itoxx
15 v,
AK J'ijv Ixaoxov siiti
xoxo (x spyov) iccpuxev
it s p
f
&
?
e 0 9- a 1.
xo (lv o3v otivHxo xal
(ispiaxo
/Xtiou?
xal 8i4-
tpopoi slow ivp-j-siat, xo
8 xjv epoiv ti X 0 3 xal jitJ np?
ti xv ooiav ixovxop |ilav vay-
xarov slvai xv xa9-* afix xu-
pico? dpsxijv. et (lv ov aXov
XI <j)OV iOTtV 8 v8ptl>-0?
-/ai xax X-|-ov xal vov
xxaxxai axo oota, 06/
dXXo ioxlv axo Ipyov
ij (livT)
ri
dxpipsoxdxx) XrjS-sia
/al xdTxspl xiv Svxiov XijBssiv
fi Svafii?
xcxuiv,
8jmv
taxi
*'S XPac?
*
Spyov. [1 SfjXov
8* tx xij? inaYioyfiJ. ini nvxuiv
fp o'xui xl8s[isv, olov tjiaxtoo
psxrj oxiv- /al yp Spfov xt
xal ypfjalp iaxiv, xal fj J3sj.xietjj
8iS xo tjiaxiou psxrj toxiv
6[ioitoj Ss xa txXoCou xal
otxia?
xal xjv
XXtov. || fiioxs /al
Isti yiip xi Ipyov
axfjj. xal tv)? (isXxiovo?
815
S|su>5 sxio pXxiov x
ipYOV xal d); loooiv al
xpg XXijXaf,
oQxdj xal x Ipya :i
x dx totiov npj dXXvjXa '
ixxei. xal xXo{ xdaxoo x4
j
SpYov, qiavepiv xotvuv 8x1 ?Xxiov s
x ipyov xs ISetos'
t yp ..)
xiXoj dpioxov dig xsXog
5xxsi- j{
xai yP xsXog x pXxtoxov {
xal x loxavov, o Ivsxa
'%
xSXXa xvxa. 8x1 (lv xofvuv .'i
x Spy 0 v piXTiovTTjsfeMSxal
xijg 8ia83stog, BijXov. i
Eth., End., B 1, 1219 b 32.
Stapspei 3' o38v ox' st (ie-
p 10 x d| oxi! oGx' st (i s pVj g,
iXsi(ivTO'. 6ovd(isig Biao-
poog /al xg stpijfivag, ioitep
v Tip xajiitiUip x xotXov xal
x xopxv dSia/dipixxov, xal x
s58i> xal x Xstr/.v. xatxoi x
s& oO Xsuxv, XX xax cuji-
psPxj/g, xal ox ooia [xo] a-
xo. dpvjxai 8 /al et xi fiXo
ioxl (lpog
'Jioxi??
otov x
90XIKV.
dv8pioTtvT]{
YP 4,UX'S x
stpijiiva [lpia (sci!,
x
LA PRIMA ETICA 337
st S'sox'.v ix ixXsivcav 8uv]is)v Xyou (isxxovxa) I8ia.
aujATtso/g, SrjXv oxiv dig dtp* St 08' at psxat at xo 8pen-
c TxXstai ixtpuxsv noxsXstjai, xixo xal pexxixo
dv8pu)txou.
del xoxtov x psXxinov Ipyov Bet lp, st dv8pu)Jtog, Xoyt"
oxiv, otov taxpixo Systa xal ajiv vetvai [xal] pX*v
Ka
xojspvyjxoo ocoxTjpia. psXxlov xpfiv.... /al ionsp sefia
SsoSv lxO|isv Xsysiv 8p yv oyxstxai ix xfflv xax (lpiov
x jj g diavola?
j xo Siavoou- pextv, oxui xal -ij xf(g poy.'j?
(lvou xijg tpuxg vj jiiv X 7)
-
dpsxrj
% xXo?
(scl. oy/sixa1.).
8sta?.
dXijfrsia dpa x xu- dpsxg 8' stSvj Suo, fj |iv
pttxaxov Ipyov oxl xo [io- 8ixt}, Ss Stavo7]xi/7-
P iou xoxou xg 'l'UXrjg.
Neil' Eudemea l'ordine dei concelti pi volte spo
stato : infatti nel Protreptico la costruzione logica pi
chiara e metodica. L'&idemea ha in pi gli esempi, che
chiariscono induttivamente (x -ri)? TtaywY?) ilnesso di
pyov e pstfy La vera e propria applicazione al caso
dell' anima, che nel Prolteptico compiuta, con esem
plare chiarezza, da oxov 4'uXi iv hi poi, ricordata
dall' Eudemea con le sole parole diate xal he
lasciano ogni determinazione ulteriore all'esposizione
orale. Pu darsi che Giamblco leggesse nel suo testo gli
esemp e litralasciasse: ma siccome si tratta solo dei pi
triti esempi scolastici, pi probabile che Aristotele non
li abbia affatto citati nel suo scritto letterario e li abbia
aggiunti soltanto per ilsuo corso di lezioni. Egualmente
stanno le cose per quel che concerne gli esempi riguar
danti l'inseparabilit delle parti dell' anima (xotXov e
xupxv) citati nel secondo capitolo. Del resto qui si ma
nifesta chiara la diversa finalit dei due scritti. Nel
Protrepticola conoscenza teoretica razionale (tppvijaij)
costituisce l'unico scopo della vita umana. IlO-siapTjTix?
$loe
sovrasta a tutti gli altri ecopi, e si distingue netta
mente da essi. II concetto dell' anima, designata col
come l' essenza dell' uomo, quella dell' indivisibile
unit della pura anima pensante
(nel senso della tarda
22.
W. Jaeger, Aristotele.
338 CLI ANNI DI VIACCIO
dottrina platonica del voti?), che ha eliminato da s non
solo il carattere dell' esistenza animale e vegetativa, ma
anche quello della volont e del desiderio. Nel corso di
etica detto invece che non importa se 1' anima sia una
unit o se sia composta di parti, e l' attivit pratica
(rcp&ijis) si accompagna al pensiero (Xoytop?) quasi a
pari diritto. L' eudemonia si basa qui per Aristotele
sulla cooperazione e sull' equilibrio delle energie razio
nali ed irrazionali dell'anima.
Questo
piche unmero
riguardo per la vita comune e per le sue esigenze: un
nuovo ideale, che cerca di superare le asprezze del pre
cedente punto di vista puramente intellettualistico (cfr.
specialmente 1219 b 39 - 1220 a 5). Di conseguenza, Ari
stotele doveva ora sopprimere quella parte del Protrep
tico in cui la pura freopt era posta come unico Ipyov
valido ed essenziale dell'anima umana (p. 42, 22
-
43,
25). Tutte le modificazioni compiute nell' Eudemea di
scendono logicamente da questo spostamento del punto
di vista fondamentale. Anche per quel che concerne il
primo libro il Protreptico costituisce il ceppo originario,
da cui si diramano le trattazioni dell' Eudemea. Per i
primi quattro capitoli ci si gi dimostrato merc
l' analisi del processo dimostrativo. Il sesto capitolo
tratta del nuovo metodo etico, e si provato come esso
si riferisca per intero al Protreptico, in quanto pole
mizza con esso (v. sopra, p. 312). Ma anche la massima
parte del quinto capitolo deriva direttamente da questo
scritto, com' dimostrato dalla comparazione che segue.
Si tratta della dimostrazione che la vita non in s il
pi alto dei beni, e che solo la cppvTjots le conferisce
valore.
Protr., 45, 6.
itavtl
Sii
[ov] xoOt ys ttp-
5t)Xov, oBslg 2v iXoixo
X)v frjv [isy{o"T)V n'v-
Elh. End., A 5.
xspl xoXXiv [iv o5v xat
ixpcDv oh p:8'.ov t xptvai xa-
Xffig, [lXioxa 8 xept o3
xSji
LA PRIMA ETICA
339
O-pixiov oaiav xat dvafuv,
gsCTV)X){ [ISVTOl
to tpp o-
vetv xat [laivopevog,
oiB' et
[lXXoi
xg vsavty.uiTtaj f|ovg
Biysiv
oxep ivioi
xfiv
ap9povo0v tidv Bt-
youciv.
oxov d'f-poaijvijv cbg
iotxs [iXioxa
xvxeg cfEyouaiv.
ivavxEov <ppvv]cig -ppoa'ivfl,
xffiv 8* SvavxEwv
Ixxspov t jiv
CpEUXTV IOTI T S alpSTV.
)3-
xsp cv t xjivstv tpEuxxv, o-
tu)j atpsTv
t yiaivsiv.
cppvTiC o5v, d) ioixs, xat xat
totov tv Xyov cpatvsxai t
rcvTUiv atpexiTaxov.... et
yp xat xvxa xig
ix0l>
ip{top[iivog B sti) xat vooSv
Tip ppovoBvxi, ox
alpsT; 6 jiog
ot>8v yp BtpeXog o5Bi xiv fiX-
Xiov yaS-Sv. Siats wvTeg xa-
d-aov alcS-vovxai to ifpovstv
xat ysEO&ai BvavTai totou
to 7ipy|iaT0S, oOBv otovxai
xXXa stvai, xat Bi xatijv tv
atxEav oOt' v [isd-iov oli te
traiSfov 08' v stg x?j p. > v
&xo[istvsisv stv'at Bi xi-
Xoog t>
JEov.
Bi Sij toto
xat t xafrsBetv f)Sioxov
[lv ox
atpexv 8, xXv xod-c-
psS-a xoag xyi xaDsBovxi xa-
pooag xg Bovccg.
Cfr. Prolr., 40, 6 |rijv v-
BpaxoBiBg ys to f}v XX
[at toO tjv s yXixe'Etai (che
una delle espressioni favorite
di Aristotele).
p?oxov stvai Boxe? xat
-avr?
vD-pibxou
Tyvtvcu, xC
tjv
iv
t$ t|v at p ex v .... xoXX
yp Ioti xoiaTa xffiv
xopatvvxiov
Bt'& xpotsv-
xai t vjv, otov vooog
xsp:coSovCag
xEtjicevaj.
(Sots
8fJ-
Xov 8xi xv i{j
px>l atpsxv
17V, Et
Tt
atpsatv iSiSou, Sia ye
xaQxa t fii) ycvia.Sat, xp; Ss
totoi; 6 piog ov giaiv iti
xatSsj Svxsg-
xat yp itti
totov
vax|icjiai xXiv
oBelsicv
xofistvELEV e
ippovQv. Iti S ttoXX xtSv xe
[iTjSECav ixvtojv Bovrjv i) X-
xtjv, xat xiv
xvxmv
(lv 8 o
-
VI7V
|it xaXv Si,
xotaOx.
oxtv caxs t juj stvai xpstTxov
Etvai to ttjv. 6Xo)J S'eI tij
icavta
oovayyoi 8oa xpxTouot
|iiv xat
ttaxoooiv
navxeg, xv-
xs (isvxot jiijBsv a&Tiv Bi x
axo xptv, xat xpooS-siT]
Xpveu xXfros xpavxv
ti, o
pXXov Svex' v xig xo-
T
li)
V iXoiTO fj [1ij
Jijv. XX [iv oB Bi xt)v
Tg Tpoyg [1V0V f)80V)V ) TTjV
xv ippoBiotcov, ijaipsS-eisiv
tiv XXuv -/joySyi, &g x yivio-
xsiv fj pXIxEiv ij xfv XXlflV T'.g
aEar/asiDv
xoptlsi xotg vpc-
xoig, 08' 2v stg xpoxi-
[iTiosis t i)v [ir; xavxs-
Xffig Si v vBpxoBov. BijXov
yp 8xt Tip xaTTjv xoioujiivip
T17V
atpsoiv oBv v BisvyxEiE
ytvisfrai fttjpEov fj vS-puixov...
[io!o)g 8 oB Bi xtjv xo5
xa9-E8siv fjBovv xt yp
8ta?spsi xa-sSsiv vyspxov
xvov x xfjg xpxijg rjiipag
pxpi xiig TsXsuxaia; ixiTiv pi-
9-pv x'-Xiuyy fj SxoaiovoOv, /) r(v
Bvxa tpuxv ;
340 OLI ANNI DI VIACCIO
Non un caso che queste argomentazioni parallele
siano tanto simili tra loro. Non bisogna pensare che Ari
stotele abbia soltanto formulato inconsapevolmente in
modo simile, nei due luoghi, un' opinione a lui consueta.
Ogni dubbio tolto dalla citazione dal Protreptico, che
segue poche righe pi oltre:
Protr., 51, 11.
ned *Ava;aYpav . 8 cpzoiv
etrcstv ipmxMvxa tEvoj v Svsxa
IXoixo ye/G&ai ti; al pjv,
iicoxpivasS-Bi Tcps xijv pmjjtv,
(bj xot5 O-aiiaafHtt [x 7is.pl]
xv o&paviv xaE x rcept axv,
axpa xe stai osXvtjv xal rjXtov ,
j{
x)v
XXuiv ys Kvxiuv oOSs-
Y
ioiv ovxcov.
Elh., Eud., A 5, 1216 a 11.
xiv (isv ov A.'/a.3.-(pa'i paotv
-oxptvasOai sspig xiva 8ict-
Ttopovxa xoiox" fixxa
y.al
Sixpcoxfivxa xivog Svsx' Sv xij
IXoixo Ysv38"al pSAXov |vj
YsvaO'at, xo
tpvai 0xu>-
Poki xv opavv xal xv nspt
xv 8Xov xo|iov xgiv .
Giacch nell' Eudemea irappresentanti dei due al
tri j3ot appaiono strettamente connessi con questo rap
presentante
del iNcDpYjxixcn; 105, e la dipendenza dal Pro
treptico e proprio qui quasi letterale, ben lecito far ri
salire a quel modello anche il passo ohe segue, fino a
1216 a 27.
Qui
contrapposto ad Anassagora Sardana-
palo, come rappresentante
del tipo di vita dedicato al
godimento, e accanto ad esso il Sibarita Smindiride xa
xv xAuV ws
tjv
OhvxtDV xv axoXaucxixov jStov. Tutti
costoro identificano senz'altro l'eudemonia con la sod
disfazione dei sensi. Che anche irappresentanti del
l'iTzoXct'jauv.g jifos, a cui 1' .Endemica accenna solo cos
brevemente, e quelli del
JtoXcxcxs
(fos, a proposito del
quale essa non cita affatto esempi, comparissero nel Pro
treptico, sarebbe verosimile gi di per s. Con la sua
energia plstica, questo motivo conviene pi allo stile
dell' opera letteraria che al corso di lezioni. Neil' Eude
mea Aristotele non ne ricava affatto il suo pieno effetto
3
LA PIUMA ETICA 341
;|
figurativo, e lo riduce invece a un'arida enumerazione.
Ma in Cicerone troviamo citato due volte1) un passo
di Aristotele, che fornisce anche per questo luogo la pre
vi cisa prova della sua provenienza dal Protreptico. Cice*
,1
rone respinge la concezione della vita propria di Sar-
sj
danapalo, e cita a questo proposito l'epigramma tom
bale del re, che egli traduce in esametri latini. Prefe
riamo riferire i versi nella forma greca tramandala in
Strabone:
Tav*
sti)
oso' icpayov xal Itpujvptaa xal pex' Sporco?
tpTiv' ijuxflov, x Ss TtoXX xal SXjlia irvxa XXecttxac.
Cicerone dice esplicitamente di avere attinto ad Ari
stotele tanto l'iscrizione tombale di Sardanapalo quanto
la spiritosa stoccata contro la concezione frivola della
vita che da essa risulta. La somiglianza col passo del
l'Eudemea non deve indurre alla falsa ipotesi che sia
stata quest'ultima a servire di fonte a Cicerone o all'au
tore che egli segue, perch nell' Eudemea mancano en
trambi gli elementi che Cicerone dice di aver desunti.
Essi non s'incontrano innessun trattato didattico di Ari
stotele, e giacche a quei tempi si leggevano ancora esclu
sivamente le opere letterarie del filosofo, non c' dub
bio che sia una di queste la fonte della citazione cicero
niana. La coincidenza di quest' ultima con l'Eudemea
si spiega perci con la comune utilizzazione del Pro
treptico.
Ci diventa anche pi chiaro quando si esaminino
'}
'Cic., Tilsc. disp-, V 35, IDI; de fin., II 32, 106. Il Rose
riporta i duo passi come presumibili estratti dal dialogo JIspl
8v/.eaocuv7[5 (framiti. 90). Anche il Bernays suppose che fossero
resti di un dialogo aristotelico (op. cit., p. 84), e ricorse al Ncrinto,
di cui non sappiamo nulla. E non cit a confronto il passo Eth.
Eud., A 5, 1216 a 16, pur citando Eth. Nic., A 3, 1095 h 19, che ne
deriva. Come la maggior parte delle traccie del Protreptico in
questa tarda opera, essa ormai soltanto un'eco lontanissima.
342 GLI ANNI DI VIAGGIO
meglio le altre parole aristoteliche conservate da Cice
rone: quid aliud, inquit Aristoteles, in bovis, non in
regis sepulcro inscriberes? Non pi possibile accertare
se sia stato veramente Aristotele a dire ohe si sarebbe po
tuto apporre a egual diritto l'iscrizione della tomba di
Sardanapalo anche a quella di un bue. A me, veramente,
sembra che si debba riconoscere nel motto la maniera
leggermente canzonatoria propria del filosofo : per la
formulazione ha un tono che par reso pi grossolano.
Ora, YEudemea dice immediatamente prima
(1215 b 35),
a proposito della vita dedicata al mero godimento dei
sensi: una vita dedita alla semplice soddisfazione del
palato e del sesso, priva delle altre specie di pi puro
ed alto piacere, potrebb' essere desiderata soltanto da
uno schiavo. A colui che si decidesse a questo non im
porterebbe affatto di essere un uomo piuttosto che un
animale. In ogni caso il famoso toro di Egitto, col
venerato col nome di Apis, pu a questo riguardo to
gliersi pi capricci di quanto non possano molti monar
chi . Che queste parole derivino dal Protreptico ve
rosimile per il fatto che tanto quelle che precedono
quauto quelle che seguono (1215 b15-34, 1216 a 2-10 e
1216a 11-16) provengono, pi o meno alla lettera, da
esso. Neil' Eudemea la comparazione del toro Apis coi
monarchi fa un effetto piuttosto curioso ed quasi in
comprensibile, non essendo detto prima se non che una
tale vita potrebbe essere scelta soltanto da uno schiavo.
Ma Cicerone mostra come nell' originale il divino toro
degli Egiziani fosse
paragonato al voluttuoso re Sarda
napalo. Solo ora s'intende il significato della frase, che
Apis ha nei piaceri del senso maggior libert di tutti i
monarchi del mondo (1216 a 2). Aristotele si valso del
Protreptico in maniera piuttosto saltuaria. Con ci ab
biamo fatto risalire al Protreptico la massima
parte del
LA PRIMA ETICA 343
quinto
capitolo (fino a 1216a27, e per ci che concerne
il contenuto teorico fino ad a 36).
Gli estratti e le amplificazioni del Protreptico nel-
V Eudemea hanno dunque un'estensione assai maggiore
di quella segnalata dall' esplicita citazione degli scritti
essoterici. Ma si trovano ancora altri passi in cui
senza dubbio utilizzato il Protreptico: cosi, anzitutto,
nel cosiddetto libro 0, la cui dottrina della ftetoploe xal
3-spajieJa fkoO attinta a quello scritto giovanile, riboc
cante di profonda religiosit. Dal Protreptico ha l'aspetto
d' esser tratto anche il passo 0 3, 1248 b 27-34 (cfr. fr.
57 R.). Da ultimo restano ancora da chiarire alcuni passi
singolari, dei quali non ci si dato abbastanza pensiero.
Due di essi si trovano nell' ottavo capitolo del libro
primo. Aristotele vi dimostra come l'idea del bene non
possa essere ilbene supremo che forma oggetto della ri
cerca: egli trae cio le conseguenze che per l'etica di
scendono dalla confutazione della dottrina delle idee.
Per la confutazione stessa egli si richiama ad uno scritto
pubblicato:
nayizitzctt
S ttoXXo?
tispi aro zpnotc, xal
v toT?
HjaitepixoT? Xyot? xal iv
to!?
xat cptXoaocpfav 1).
Per xptioi della critica egli intende la confutazione delle
idee dai punti di vista logico, ontologico e fisico, secondo
la distinzione chiaramente segnata dalla
Metafisica.
La
confutazione essoterica delle idee (che non ha certo,
come si voluto intendere, il senso di popolare in
contrasto coi xctT cpiXoao<piav Xyo;, e che anzi nella Me
tafisica, in cui Aristotele si basa parimenti su di essa,
esplicitamente designata come la trattazione pi ap
profondita e comprensiva che esistesse sulla questione)
la critica data nel secondo libro Ilepl cpiXoaocpia?, che
era appunto pubblicata quando futenuto in Asso il corso
') Eth. End., A 8, 1217 b 22.
344 CLl ANNI DI VIAGGIO
di etica '). Ixax cpiXoaotpfav Xyoi sono le lezioni ecola-,
etiche, e in particolare, naturalmente, quelle di meta
fisica, che erano nate appunto nello stesso tempo. Anche
la seconda citazione nel medesimo capitolo ei riferisce
al dialogo Ilepl tpcXooofos : Itixai x Iv tot Xytp ysypap.-
plvov yp o5c|ii xprjaipov at x xo yafroO sTSoj
) Jtaai; Iti o Jipaxxv xxX.
2). Gli argomenti
successivi, delineati solo in forma brevissima, contro
l'idea del bene appartengono parimenti all'estratto dal
dialogo. Ci che sta scritto accessibile agli altri e
pu essere consultato nel Xoy oc. Si allude dunque a una
pubblicazione letteraria, il cui titolo non aveva bisogno
') L' Eudemea dev'essere assegnala a questa epoca per pi ra
gioni. In primo luogo peri suoi strettissimi contatti coi citati scritti
giovanili, iquali sono invece eliminati, per quanto possibile, nella
Nicomichea. In secondo luogo per il parallelismo che dal punto di
vista dell' evoluzione dei problemi essa manifesta rispetto alla pi
antica fase teologica della metafisica. In terzo luogo per l'inser
zione, fiaccamente connessa, delia parie critica contro Platone, co
stituita dai capitoli A 6-8: i brani concordanti col Protreptico
sono evidentemente resti di un corso nato ancora in et accademica.
In quarto luogo, perci il terminus post quem costituito dal
dialogo Ilepl cpoaootas, citato in A 8, elle stato compsto tra
il 348 e il 347. In quinto luogo, perch Corisco di Asso, eie nella
Nicomachea, di proposito, non pi ricordato o eliminalo,
invece citato come esempio scolastico in Etk. End., B 1, 1220 a 19
e IL 6, 1240 b 25, c in entrambi iluoghi con evidente significato
scherzoso. Il fatto che esso sia caratterizzato come 6 tfiv il tfj
yop? [e'.vxacpj non ha alcuna ragion d'essere nel contesto del
l' argomentazione, ed quindi da spiegare solo in forza del nesso
di ci che veniva detto con la situazione in cui veniva detto.
1
Eth. End,., A 8, 1218 a 36. Ouesta citazione e quella conte
nuta nel libro H. della quale riparleremo subito, sono stale consi
derate spurie dal Wilson, seguito in ci dal Susemihl. La forma
della citazione appariva inconsueta. Ma, nella massa delle citazioni
da scritti essoterici che s' incontrano in questo antico periodo e
che tradiscono un sistematico intervento dell'attivit letteraria nel
campo dell' attivit didattica e di questa nel campo di quella, ci
non ha in se nulla di singolare. Inoltre Aristotele si richiama a
discussioni orali tenute nell'Accademia p. es. in Eth. End-, Il 6,
1240 a 22 4it Si xijg npg a&tv ot Xo'.-ol Tpreoi toB wiXstv
Bmpizpivoi, xaS-' o3g v tot- Xyote inioxoitElv ttiS-apsv : dov'
ricordata una ricerca condotta sulla base delle definizioni correnti,
evidentemente di tipo dialettico. Cfr. II 11, 1244 a 20 xol oE iv
Tot?
Xiyotj Spot
ttJs
tfiXEag.
LA PIUMA ETICA
345
di essere nominato nella cerchia in cui Aristotele teneva
ili suo corso perch era noto a tutti. In ci una con
frma di quello che dovremmo concludere gi dall' in
tenso uso del Protreptico, e cio che Aristotele, al tempo
della sua prima attivit didattica, si basava continua
mente sui suoi dialoghi e sul Protreptico e ne presuppo
neva la conoscenza nei suoi uditori.
Nel libro Hei trova (1244 b 30) una simile citazione
con la formula &ansp Iv x<p Xytp ylypaTctat, e poche ri
ghe pi oltre (b 34) si legge: Set yp Spa auvfoivat Suo
Iv xtj) Xyw, Sxt xe x ijv afpsxv, xai Su x yafrv....
Le parole seguenti eono corrotte. Le due tesi, contenute
nello scritto e da riunire insieme , e cio quelle
che la vita in se un valore da affermare e che il bene
in e affermato dalla volont, si trovavano nel Pro
treptico. Col era detto che 1' asserzione della volont
di vita era nello stesso tempo
un'asserzione dell' impulso
verso la conoscenza, perch vita 1) significava per
l'uomo, in antitesi rispetto agli animali ed alle piante,
consapevolezza e conoscenza (ato&vscrS'ai, yvtspfstv). Ma
appunto questo
noi leggiamo, alcune righe prima, nel-
l'Eufonica (b 23). Immediatamente dopo segue la ci
tazione tSansp Iv Tip
Xyip flfpctnxott. Anche qui il testo
corrotto per la caduta di una parola, ma il senso
chiaro: se uno potesse fare l'esperimento ed estirpasse
all' uomo la conoscenza e la consapevolezza, e cionono-
stante potesse ancora penetrare con lo sguardo nella con
dizione di ci che di lui rimarrebbe, ci non potrebbe
accadere altrimenti che come se egli guardasse nell' in
terno di un essere estraneo e se vivesse un altro in luogo
di lui. Ilpasso non conservato nel Protreptico, ma vi
era senza dubbio contenuto, perch proprio il metodo
del separare,
eliminare, isolare, per cui Aristotele si
:
*) Jainbl., Protr., p. 56, 22: e la stessa cosa detta in 44, 11.
'Il
1
J46 GLI ANNI DI VIAGGIO
richiama al Xyo;, vien col costantemente seguito1),
e il concetto che la conoscenza e Io spirito costituiscano
il vero e proprio S dell' uomo giustifica col 1' esorta
zione a vivere solo per questa superiore parte di s me
desimi. Nella scuola di Asso, al tempo in cui nacque il
pi antico corso di etica, la discussione filosofica si ag
gir dunque sostanzialmente intorno a questi scritti.
Il vecchio problema dei Xyec essoterici ha con ci
trovato la sua soluzione definitiva. Non soltanto dimo
strato il fatto che Aristotele, nelle sue lezioni, ha uti
lizzato isuoi scritti letterari dimostrazione, questa,
che non avrebbe dovuto propriamente essere necessaria,
perch egli etesso parla pi volte chiaramente di un suo
uso di questi Ayoi
ma sono anche,
iden
tificati, merc inuovi materiali, gli scritti adoperati, ed
trovata la spiegazione filosofica di questo fatto singo
lare. Esso connesso con l'evoluzione spirituale del filo
sofo. Nei primo periodo seguente al distacco dalla dot
trina platonica, quando era diventata necessaria una
completa ricostruzione nelle discipline fondamentali,
Aristotele prese dai suoi scritti precedenti quel che gli
poteva ancora servire, ed edific il nuovo in seno al
vecchio. Cos, per esempio, la critica della dottrina delle
idee tratta dal IXspl ptXococpCa? 6ta, alla fine del primo
lihro dell' Etica Eudemea, ancora piuttosto isolata in
mezzo a brani antichi, attinti al Protreptico. Nella Nico-
machea data ima nuova costruzione, che naturalmente
deriva ora a priori dalle mutate premesse. S gi mo
strato come ilProtreptico si inserisca ancora nella Meta-
fisica
pi antica. Nel periodo di Asso Aristotele poteva
tuttavia credere che il suo distacco dalla concezione pla
tonica non fosse tanto grande, e che egli potesse dapper-
*)
lamb., Protr., p. 44, 11; 5, 8; 18; 25; 53. 3: e cfr. Erk. Eud.,
A 5, 1215 b 32; H 12, 1245 a 14; 3, 1248 a 39; 40; 1,
2.
LA PRIMA ETICA 347
tutto ricollegarsi all' antico. In seguito inuovi concetti
gli apparvero pi gravidi di conseguenze: lo portarono
sempre pi lontano dall'antico punto di partenza, e i
platonizzanti scritti giovanili finirono cos sommersi nel
suo passato. Ma evidentemente egli rigett poi anche le
prime formulazioni della sua filosofia, quale si veniva
criticamente affermando nel suo iniziale distacco da Pla
tone, giacche per lui esse erano ancora troppo dipen
denti dai presupposti del suo periodo dogmatico. Si
6piega cos il frammentario stato di conservazione delle
esposizioni pi antiche dell'etica e della metafisica 1).
')
Una parola ancora circa ire libri comuni all' Eudemea
e alla Nicomachea. Il libro Z della Nicomachea non pu appar
tenere all' Eudemea per la sua concezione della cppvqois, che
essenzialmente pi recente di quella contenuta nei libri A e 6 del
l' Eudemea e polemizza contro di essa. quindi da ammettere
che itre libri sono entrati insieme posteriormente nell' Eudemea,
e risalgono dunque alla Nicomachea. .Con ci peraltro non ancora
dimostrato che questa sia in s un complesso unitario, creato di
un sol getto. Problematica resta la coesistenza delle due indagini
itspt ovrjs in H e in K. Quella
contenuta in H certo al
quanto pi antica delle spiegazioni offerte da K e presuppone una
conclusione diversa.
VI.
LA PRIMA POLITICA
|
'
l
Dell'evoluzione del pensiero politico di Aristotele noi
possioderemmo un quadro che dai primordi accademici
giungerebbe fino all'et pi tarda, 6e disponessimo an
cora degli scritti di cui aveva nozione 1' antichit. La
serie s' inizia coi due libri del Politico, ricollegantesi al
l' omonima opera di Platone, e coi quattro ampi libri
f
Ilepl
Sixatoauvj I). Come da questi scritti noi conosce-
.-J
remino pi esattamente il collegamento della politica ari*
stotelica col pensiero
platonico, cosi il memoriale in
:
forma dialogica
Alessandro o Sulla colonizzazione,
pari-
menti perduto, ci condurrebbe in quella tarda et in cui
ilregale scolaro frantumava e fondava regni in Asia e il
filosofo, gi sul declino della vita, seguiva con sguardo
preoccupato la vertiginosa
traiettoria della sua fortuna.
Per
queste mancanze ci rimane nascosto ci che soprat
tutto
desidereremmo d apprendere, cio quale effetto
sul pensiero politico di Aristotele abbia avuto quel gran
dioso
mutamento di scena nella storia del mondo 2). Lo
*)
Cic., De rep.. Ili, 8, 12.
*)
Le sue vedute circa il problema della relazione dei Greci
LA PIUMA POLITICA
349
scritto Sul regno,per dubitare dell'autenticit
del quale
nonpossediamo
nessun elemento d fatto, e quindi nessun
diritto, contro 1' attestazione del catalogo alessandrino
degli scritti di Aristotele, deve appartenere
al tempo
in
cui egli preparava
al suo alto ufficio il figlio di Filippo:
anzi esso deve probabilmente
aver costituito 1' esteriore
conclusione di questo periodo. Non dobbiamo dubitare
neppure unistante del fatto che ilfilosofo, il quale nella
Politica affronta cos seriamente il problema della mo
narchia, abbia col tentato di dare un nuovo contenuto
morale e spirituale all'idea storica della potest regia1).
Tutte queste sono perdite che noi lamentiamo per la
conoscenza dell' ambiente storico e della personalit
del
pensatore,
mentre la sparizione della monumentale opera
dell'erudizione peripatetica,
la silloge delle 158 coelitu-
/
zioni statali, ha d' altra parte inferto una ferita insa-
con gli Asiatici, che doveva avete importanza decisiva per imetodi
di colonizzazione, risultano chiarite dal frammento
epistolare in
cui egli consiglia ad Alessandro di presentarsi ai Greci come
#lfspiv e ai barbari, secando il loro costume, come assoluto au
tocrate, trattando gli uni come amici c pari suoi e gli altri come
animali o piante (fraram. 658 R.).
Quanto
energica sia stata la
reazione che l'umano sentire dell'ellenismo
cosmopolita oppose
a questa concezione, la quale, pure essendo tipicamente greca, in
Aristotele era certo il risultato di fredde considerazioni di prassi
politica, dimostrato dal fatto che Eratostene e Plutarco la respin
gono. Poco felice mi sembra il tentativo di ascrivere tale fram
mento al flspl paci?,sia; <Heitz, Die verlorenen Schrijlen des
Aristoteles, p. 296). '
l)
Questo scritto sar stato un messaggio inviato ad Alessandro
quando sali al trono, del genere del Protreptico e del Nicocle iso-
crateo, e quindi di pi generico carattere etico. A un re giunto
al culmine della potenza e del successo non si mandano
consigli
filosofici, per insegnargli come deve
concepire il suo compito di
dominatore. Con ci s'accorda quel che Cicerone
(ep. nd Att., XII,
40, 2 e XIII, 28,
2) dice circa una lettera smbuleutica , scritta
da Aristotele per invito di Alessandro e concernente tra l'altro
il problema della vera gloria. Il messaggio sulla potest regia in
formava iGreci circa i princpi etico-politici secondo
iquali era
stato educato Alessandro ; e se fu lo stesso
giovane principe a pre
gare il suo maestro perch gli esponesse pubblicamente _ in un
aunjiouXsuT'.xj, ci significa che egli intese con ci di manifestare
apertamente il suo intento di governare secondo quello spirito.
350
CLI ANNI DI VIACCIO
nobile alla nostra nozione della storia e della cultura
greca. Il felice
ritrovamento del primo
libro di questa
silloge, la Costituzione
degli Ateniesi, elaborata da Ari
stotele stesso quasi come
canone per l' opera
comples
siva, ci ha fatto almeno
sapere con sicurezza che questa
impresa stata organizzata
solo nel periodo
dell'inse
gnamento ateniese di
Aristotele, nell1ultimo decennio
delia sua vita. Nulla tanto significativo per l'evolu
zione del
filosofo quanto il fatto che egli
abbia accu
mulato il materiale di quest'
opera gigantesca
solo quali-
d' erano gi da lungo
tempo fissati i
fondamentali con
cetti
sistematici del suo pensiero politico, al quale essa
doveva invece idealmente precedere come materia prima.
La
linea di eviluppo del pensiero politico
aristotelico
risulta cos
sicuramente determinata, nella sua direzione,
dai suoi due estremi
cronologici, ilibri sulla giustizia
e sulla natura dell'uomo' politico al principio e la grande
silloge
erudita delle
costituzioni alla fine.
Il
nostro interesse si volge anzitutto ai primordi, al
l'interiore
distacco di
Aristotele da Platone. Fonte prin
cipale delle nostre conoscenze resta
naturalmente l'ana
lisi degli otto libri superstiti
della Politica: essa pro
mette
tuttavia un
risultato solo nel caso che anche qui,
come a proposito dell' etica e della metafisica, si assu
mano iresti superstiti degli scritti giovanili
come cri
terio di misura del grado
del sempre crescente allonta
namento dal punto di
partenza. I
frammenti del Pro
treptico
identificati dalle nuove analisi offrono anche
per
questo problema
alcuni preziosi
materiali, che ci
aiutano a
rimediare in qualche
misura all'
insostituibile
perdita
delle due principali
opere politiche dell' et gio
vanile.
Lo
scopo di Platone era quello di fare della politica
una scienza fondandola, in
inseparabile
unione con la
teoria dell' peri) del
singolo, sulla
conoscenza dell' idea
LA PRIMA POLITICA
351
del bene. La costruzione
della Repubblica
sorgeva sul
fondamento dell'
indagine circa la giustizia.
Su questo
schema si modellarono
ilibri aristotelici IIepi Sixatoati-
vr)5,
a loro volta assunti corno modello da Cicerone nel
De re publico,. Che 1' &yot-9-v , gi dalla prima etica non
pi riconosciuto come vero e proprio oggetto
di ogni
scienza etico-politica,
sia stato considerato da
Aristotele,
nella sua pi giovane
et, come ilnucleo fondamentale
della scienza dello stato allo stesso modo in cui esso sta
al centro della Repubblica platonica, dimostrato dal
l'importante frammento
del secondo libro del
Politico,
in cui egli designa il bene come la pi esatta delle mi
sure. Ci presuppone
la teoria delle idee del tardo pla
tonismo, la quale, come
si sopra
mostrato, nell' etica
e nella politica
si occupava soprattutto
dei problemi del
l'esattezza
e della
norma, e poneva in primo piano il
concetto della misura e del misurare1)- Ci confer
mato dal Protreptico, che mette in rilievo, in maniera
che riesce singolare,
1' esattezza della scienza politica e
la contrappone,
come nuovo sapere
teoretico, alla po
litica degli empirici uomini di stato. Suo scopo non c
quello di risolvereiproblemi
di un singolo e determinato
6tato con mezzi di qualsiasi genere, attinti
all'esperienza
pratica. Questo
metodo
l'unico che l'Aristotele del
quarto e del quinto
libro della Politica consideri in ge
nerale valido per la pratica usuale 2)
nel Protreptico
<C!r. sopra, p. 133 sgg.
*) In Pol., a 1, 3288 b21
3289 a 7 alla comune teoria dello
stato ideale fatto l'appunto d occuparsi soltanto della costruzione
di uno stato ideato secondo norme assolute, c di trascurare la que
stione, nella maggior parte dei casi pi urgente per l'effettiva realt
politica, del modo in cui si possa recare aiuto a un
singolo stalo
empirico, non
corrispondente alla norma ideale o
magari addirit
tura scadente e guasto nella sua natura. Certo, non
possibile far
questo senza porre una norma, ma anche meno lo quando non si
possieda una ricca
esperienza e nozione di
analoghi rapporti della
realt, com' dimostrato dai libri A-Z della Politico.
352 CI.I AN.NI 1(1 VIACCIO
rifiutato in termini espliciti. Come non un buon ar
chitetto chi non adopera alcuno strumento di misura(xa-
vuivl o altro utensile del genere, ma desume la sua ma
niera di costruire solo da altre costruzioni, cos non
probabilmente buono e perfetto legislatore clv. quando
d leggi a citt o agisce politicamente, toglie a modello
della sua imitazione altre azioni o costituzioni umane,
come quelle degli Spartani o dei Cretesi o di chi altro
si voglia. Infatti l'imitazione di una realt non ideale
(p.r; y.aXv) non pu essere ideale (xaXov), e quella di un
oggetto che non sia di specie divina e duratura non pu
essere immortale e duratura I). Solo il puro filosofo, <
che per principio si affranca dall'empiria contemplando
come supremo modello la legge della natura e dell'es
sere, e che come un buon pilota getta 1' ancora solo sul
fondamento dell' eterno e del duraturo, pu dar leggi
durevoli e agire in modo giusto ed esemplare2). Il con
cetto della natura, qui usato pi volte, distinto chiara
mente, merc le circonlocuzioni che Io esprimono, dal
posteriore concetto aristotelico della <puot?. Esso designa
quell' essere della metafisica platonica, che nello stesso
tempo undover essere. Iltono particolare gli fornito
dall'accentuazione del suo carattere di esemplarit. Le
Tyvvac banausiche attingono il loroxavwv (l'esempio ha
senso simbolico) alla natura. Parimenti anche la
"xVT
pi esatta, la politica filosofica, trae il suo canone dalla
natura in s (yuci; ct>-rj), dall' essere delle idee. Essa
una canonica dei valori, ed ha che fare esclusivamente
*) Jambl., Protr., p. 55, 723. Interessante il fatto che la
teoria sofstica dello stato, secondo la quale l' rvoiiia si trovava
realizzata presso gli Spartani o i Cretesi, venga rifiutata nel Pro-
treplico perch si avvicina troppo alla realt empirica e desume
da essa isuoi criteri, mentre inPoi., a 1, 1288 b 41 essa respinta
proprio per la ragione opposta, e cio perch procede troppo sche
maticamente e riduce tutto a una norma universale invece di ade
guarsi, volta per volta, ai singoli casi offerti dall'esperienza.
) Jambl., Protr., p. 55, 24.
I. PRIMA POLITICA 353
con le norme assolute (Spot)- La relazione che lega que
sta politica teoretica a quella pratica caratterizzata
dall'ingegnosa comparazione dell'occhio, che da s non
agisce e non crea nulla, solo distinguendo e rendendo
evidenti le cose visibili, ma senza ilquale si sarebbe tut
tavia privi della capacit di muoversi e di fare qualsiasi
cosa 2).
Questa
una politica nello stesso senso svolto
dal Politico di Platone. All' inerte meccanismo del
l' astratto apparato giuridico contrapposta in esso la
vivente conoscenza delle idee propria del regale artefice
dello stato, la quale infatti gli fornisce quell' agilit,
rispetto ai pi difficili casi particolari della realt effet
tiva, che non s' acquista con la mera conoscenza dei testi
di legge e col sapere libresco, ma piuttosto paragona
bile all'arte del medico in quanto sorge da un sapere
produttivo e vivente2).
L'unica forma di pensiero politico dominante in ori
gine in Aristotele era dunque quella dell' utopia del
perfetto stato, attinta a Platone. Egli ricercava la norma
assoluta, non rintracciabile nell' esperienza.
Fissata questa nozione, veniamo ora agli otto libri
3) Jambl., Protr., p. 56, 4 wa-ep fp
fi
61)115 noojUR [lv Rat
Srjp'.oupY; oSavj iati (pvov fp atijs ipyov oTl % xpivtiv
al 5i]Xov Sxaatov tSv patfijv), itv 84 itapxst t npittsiv ti
8i' afrtv nal poijO-et itp? ,xg itp|eig Tfjptv t pyiota (oxeSdv
pp 4r(vtjtoi jEavte?.> &v etpsv oTtpq&cvct; atfjil, oBtio SrjXov
8tt *al tfji itua.
villus
S-scDpTjtixxs oBo7]g popia rcpttopev xat"
aTiv 8pu) fjpelS xalt pv Xapvopsv t 8 <pe6yofitv iffiv irpa-
Ylixuiv, Rai SXojj Ttvta t
faS-
Si' at-fjv xto'ipsSa. Sotto
l'influsso di questo luogo del Prolreptico il passo Etk. Nic., Z
13, 1144b 11, in cui Aristotele illustra la funzione della tfp6vr]0'.g
con l'esempio di un srpa S'X'jpv, che si muove senza facolt
visiva e perci ocpiXXstai JaxupSrg.
*) IGreci designano le scienze col nome di txvai, perch
non perdono mai di vista l'importanza produttiva che l'opera teo
retica ha ai fini della civilizzazione. La txvi] comprende infatti
entrambi imotivi ideali, cio quello del sapere teoretico (nel qual
senso essa contrapposta da Platone e da Aristotele alla ipiteipia,
intendendo essi per sapere il conoscere per
concetti) e quello del
potere, che rende tale sapere fruttuoso per ibisogni della vita.
23.
W. Jaeger, Aristotele.
354 CU ANNI 1)1 VIAGGIO
della Politica che ci ha tramandati la tradizione. L' eie-
mento caratteristico della costruzione di quest'opera
consiste nel fatto che il suo complesso culmina nell' ab
bozzo di uno stato ideale (piotrj TtoXtxefa), contenuto
nei due ultimi libri (H-0) J). Ma questo vertice si eleva
all' ampia base empirica di una teoria delle molteplici
forme dell' effettiva vita statale, delle loro variet e dei
trapassi dall'una all'altra, a cui si collega una casistica
delle malattie dello etato e del loro trattamento. (A-Z).
Illibro precedente (3?) determina ipresupposti elemen
tari della politica, svolgendo ilconcetto della
nis
e del
TtoXltTj? e deduoendo le diverse forme costituzionali dalla
differente partizione dei diritti civili nei singoli stati.
Questa
nostra esposizione del contenuto tien conto sol
tanto dei tratti principali, per far risaltare nel modo
pi chiaro possibile le grandi linee della costruzione.
A questa trattazione fondamentale Aristotele premette,
nel libro B, una rassegna critica dei sistemi dei prece
denti teorici dello stato. E questa a sua volta prece
duta, nel primo libro, da una introduzione pi elemen
tare, che indaga leforme fondamentali del dominio (dpVj
piuttosto insenso sociologico ed economico, e muove cio
geneticamente dagli elementi pi semplici della vita
statale.
La connessione di questi libri in un complesso unico
manifesta una costante logica intema. Apparentemente
tutto procede, inmetodica progressione concettuale, verso
lo scopo culminante, e cio verso la norma ideale di uuo
stato che soddisfi ad ogni desiderio. E invece la critica,
') Seguo la numerazione ilei libri tramandata dai manoscritti,
e noD la trasposizione preferii;) dalla maggior parte degli editori,
pur non dovendo esser negato elle essa si basa su un nucleo di
giuste osservazioni. Ma le difficolt sussistenti non risultano com
pletamente eliminate con la trasposizione dei libri.
LA PRIMA POLITICA 355
da secoli, e in generale da quando ci si occupati scien
tificamente della Politica, in ogni approfondimento
ha
sempre urtato contro nuove difficolt interne, le quali
rendono inverosimile ed anzi impossibile che 1' odierna
forma della Politica Ba stata tracciata fin da principio
secondo un piano unitario e sia sorta da un unico atto
di creazione spirituale. A questo proposito si finora
principalmente parlato di difficolt della composizione
letteraria. Ma qui non ci lecito applicare criteri lette
rari di misura, e in realt le questioni riguardanti la com
posizione hanno poi anche una ragione pi profonda:
l'aporia filologica concerne il metodo stesso e la stessa
struttura filosofica ins.
Qui
non vogliamo perci adden
trarci nell' analisi singola e seguire Aristotele libro per
libro, per perderci poi, come spesso accaduto, in que
stioni del tutto estrinseche di trasposizione e ordinamento
di libri. Occorre anzitutto considerare nel suo complesso
la bifronte fisionomia filosofica peculiare della Politica,
che agli idealisti mostra il volto dell' utopia platonica
e ai realisti quello della fredda scienza sperimentale,
essendo invero evidentemente, nello stesso tempo, 1' una
e 1' altra cosa.
Per audacia di fantasia creatrice e per grandiosit
normativa di concetto lo stato ideale aristotelico sostiene
da presso il confronto con la Repubblica di Platone e
persino con le Leggi. Giustamente si dice che Platone
abbassa nelle Leggi ilsuo stato per avvicinarlo alla realt,
e che Aristotele accentua ancora questo abbassamento.
In ci egli segue la via percorsa da Platone nella sua
tarda et, ma ancor pi la sua personale tendenza
interiore, mirante comunque alla conciliazione del
l' ideale col reale. Egli stesso dice che lecito s presup
porre a piacere, per uno stato idealmente costruito, con
dizioni favorevoli, ma che tuttavia non lecito presup-
356 CLt ANNI DI VIAGGIO
porre l'impossibile '). La parte utopistica della Politica
aristotelica non costituisce propriamente il suo forte, per
quanto
nel xXo?
dello stato ideale sia esteriormente il
motivo ultimo della sua costruzione. Sommamente origi
nale e caratteristico di Aristotele invece il modo in cui
egli, nella sua Politica, sottopone alle concezioni ideali
attinte a Platone un sostrato empirico capace di reg
gerne il peso, sostrato che meglio risponde allo scopo di
una scienza empirica dello stato e ne sviluppa in ma
niera geniale ilmetodo. Decisivo per Aristotele il fatto
che egli fonde insieme le due forme della politica e
connette i libri H 0, contenenti la teoria dello stato
ideale, ai libri A-Z, iquali svolgono la teoria dello
stato reale e storico o piuttosto quella delle sue molte
plici forme fenomeniche, malattie e conseguenti metodi
di guarigione. Ilprincipio di questa costruzione chia
ramente definito dallo stesso Aristotele alla fine della
Nicomachea, l dove egli ricollega la politica all' etica
per unificarle in un' unica scienza dell' uomo (fj rcepl
x vO-pciuva cptXocotpfa), concernente tanto l'individuo
quanto
la societ. In primo luogo vogliamo
cercare, di
stabilire quanto di giusto hanno detto caso per caso i
nostri predecessori, poi indagare sulla base della nostra
silloge di costituzioni (ix xfv auv7]Y]Asvu>v
tcoXcxecfiv) ci
che conduce alla conservazione degli stati e ci che li
porta alla rovina, tanto in generale quanto inparticolare
per le singole forme di stati, e insieme le cause del fatto
che gli uni sono governati bene e gli altri male.
Quando
infatti avremo trattato di questo, potremo forse cono
scere anche meglio come dev' essere costituito lo stato
migliore, di quale ordinamento ogni stato ha bisogno e
quali leggi e istituzioni gli occorrono2).
*) Pol., B 6, 1265 a 17 (in occasione della critica delle utopie
platoniche); H 4, 1325 b 38.
Eih. Nic., K 10, 1181 b 13 sino alla fine.
LA PRIMA POLITICA 357
/
-
Questo
programma costituisce evidentemente una
svolta nella linea evolutiva della politica aristotelica. Con
chiare parole il filosofo vi ripudia il metodo puramente
teorico gi seguito, come vedemmo, anche da lui me
desimo, e si pone sul terreno della fredda indagine dei
fatti. Egli stesso lo dice chiaramente, ed strano che non
lo si sia capito: finora ho agito altrimenti, ho costruito
logicamente lo stato ideale, senza conoscere a sufficienza
idati di fatto empirici. Ora ho a disposizione il gran
materiale delle tioXtxelat raccolte e me ne servir per
dare allo stato ideale una base positiva 3).
Questo
egli
scrive al termine della pi tarda redazione dell' Etica,
la quale appartiene all'ultimo decennio della sua vita.
Anche la silloge delle costituzioni nata solo in questa
et. l'epoca in cui egli fornisce alla precedente sua
metafisica teologica l'ampio sostrato di una generale teo
ria dell' essere, e in cui anche nell' etica il motivo rea-
Bisogna
sempre tener presente che le formulazioni del punto
di vista aristolelico tramandate nei trattati, anzi nella redazione
che ne superstite, possono esser comprese solo in seno al vivo
complesso
dell'evoluzione spirituale del pensatore, non mai paga
dei suoi risultati. Perci esse possiedono spesso un certo aspetto
relativo, che riesce pienamente comprensibile solo a chi tenga
d'occhio gli altri momenti di tale processo, E come numerosi passi
dell'Etica e della
Metafisica sono da intendere solo come colloqui
critici del filosofo con s stesso, nei quali egli supera le sue prece
denti posizioni, cosi anche la fine dell'Etica, O-aiopijiisvuDV yo
totwy
xix'
Sv pSXXov ouv(8oqiev kilnotaTcoXiteia ipCotr;, al
lude allo stadio precedente del suo pensiero, che ancora neppure
aveva idea di un cosi lungo giro attraverso la pi accurata em
piria. Che l'espressione ix
xjv
ouvrjyiivoiv noXneiffiv d-stupfjcct".
t -ota oipCs; xttl cpstcsi zig itXetg si riferisca alla silloge delle
258 costituzioni (ouvafo-p} in questo senso termine corrente in
Aristotele: confronta la cova-fav)- ts/viv) gi stato occasional
mente congetturato e spesso anche contestato con sterili soltilizza-
zioni, come ultimamente dal Heitz, Die verlorencn
Sckri/tcn des
Aristotele), p. 231 sgg. Finch non si possedeva ancora Io Sfato
degli Ateniesi, appartenente all'ultimo periodo dell'attivit di Ari
stotele, e non si riconosceva nella Nicomachea la redazione pi
tarda d'ella sua Efica, non si poteva, peraltro, trarre da quelle parole
alcuna conclusione concernente il processo evolutivo del suo pen
siero.
358 CLI ANNI DI VIACC10
listico della diretta osservazione psicologica prende il
sopravvento sul metodo propriamente speculativo. Forse
qualcuno trover sorprendente che questa evoluzione si
sia compiuta soltanto cos tardi. S'immaginava che Ari
stotele avesse proceduto fin da principio per questa via.
Ma il fatto della sua progressiva evoluzione piena
mente accertato dall'antitesi che l'espressione contenuta
nella fine della Nicomachea costituisce rispetto ai prin
cipi metodici del Protreptico e del Politico, e gli indizi
cronologici ammettono una sola interpretazione. La nota
concernente l'inserzione della nuova parte empirica
prima della teoria del perfetto stato si riferisce ai libri
A-Z, il cui contenuto Aristotele circoscrive chiaramente.
Che egli li abbia composti attingendo al materiale della
silloge delle costituzioni conclusione che da lungo
tempo stata tratta, indipendentemente dal passo del
l'Erico, in forza del loro divergente atteggiamento scien
tifico e della loro inesauribile ricchezza di esemp sto
rici *). Essa l'unica parte della Politica in cui vengano
citati avvenimenti storici recenti. L' allusione all' assas
sinio del re Filippo (336) conferma che A-Z sono stati
scritti solo nel secondo periodo ateniese s). Che in questa
') Cfr. W. L. Newman, The Polities
of
Aristotle, I(Oxford,
1887), p. 491; Wilamowitz, Aristoteles laid Aiken, I, p. 359.
s) Pol., E 10, 1311 b 2. L'assassinio non ricordato come acca
duto di recente, e comunque non per interesse al fatto in s, bens
come elemento di una enumerazione di simili attentati, citati come
esempi di regicidio operato per vendetta (nfiiopCac yoiv) Ilpasso
quindi stato forse scritto molto pi tardi, Lo Zeller (Philos. d.
Griechen, II,2, 3" ed., p. 154, n. 4, deduce da esso la tarda et della
redazione dell'intera Politica: ma il problema sta appunto nella
misura in cui lecito estendere l'illazione cronologica da esso ri
cavabile. Solo ilibri A-Z della Politica, che Aristotele alla fine
dell'Etica dice basati sulla silloge delle costituzioni e che anche
in s manifestano palese la comune impronta di tale origine, sono
da ascrivere con certezza all'ultimo soggiorno ateniese. Essi sono
contemporanei alla redazione dell'Etica Nicomachea. Che il resto
sia nato prima, sar dimostrato positivamente dal seguito della
presente ricerea. Soltanto il primo libro fa eccezione a questa
regola.
LA PRIMA POLITICA 359
occasione l'intera Politica abbia subito un' elaborazione,
non detto, e anche ins improbabile. Dobbiamo dun
que ricercare fino a che punto sia ancora possibile sepa
rare gli strati antichi dai pi recenti: e per ci possiamo
muovere dalle conclusioni della questione concernente
1' ordinamento dei libri 1).
Da quando gli umanisti italiani del Rinascimento
hanno cominciato a occuparsi della Politica, la critica
ha impugnato l'ordinamento tradito e ha tentato di re
stituire quello autentico merc pi o meno violente
trasposizioni. Neil' Ottocento queste ipotesi hanno tro
vato posto perfino nelle edizioni. Idue libri finali (H 0)
vennero posti dopo il terzo libro, ilibri A-Z alla fine.
In seno all' ultimo gruppo il quinto e il sesto libro do
vevano a loro volta, secondo alcuni, scambiarsi il po
sto. Contro questa mania traspoiskrice ha, inet recente,
elevato energica protesta il Wilamowitz, e certo un
mezzo cos meccanico non adatto a recare .ordine
nella tradizione. Nostro compito immediato deve restar
quello di comprendere nella sua necessit storica Io stato
delle cose quale ci si presenta. Certo, a questo scopo pos
sono fornirci un aiuto essenziale ifatti constatati dalla
critica. Ilibri Be T introducono non a una teoria gene
rale dello stato, ma bens, come risulta chiaro dall' im
postazione del problema, dal metodo e da alcune espli
cite affermazioni in essi stessi contenute, a una teoria
dello stato ideale secondo il modello platonico2). Se si
volessero connettere immediatamente a questa introdu-
') Ilprimo ad avanzare la congettura che nella Politica si tro
vino sovrapposti strati di diverse et stato il Wilamowitz (Aristo
teles umf Atken, I,p. 356 sgg) ; e del resto opera del suo acume
storico se in generale Aristotele, come uomo e come politico,
stato finalmente collocato al suo giusto posto nella storia del quarto
secolo.
, s) Per ci che riguarda E chiaro senz'altro che esso costi
tuisce l'introduzione critico-storica a una teoria delio stato ideale,
e non a una teoria generale della politica. T muove ai-paieiile-
360 CLI ANNI DI VIAGGIO
zione idue ultimi libri, contenenti la teoria dello etato
ideale, ci ei potrebbe richiamare al fatto che ilibri B T
e H 0 sono saldamente collegati da una quantit di ri
mandi reciproci, mentre noncitano ilibri intermedi A-Z.
Il loro nesso con questi fiacchissimo '). Al lettore at
tento non poteva sfuggire come cesi interrompano, in
modo addirittura urtante, 1' edificio teorico del perfetto
stato. Se alla fine della Nicomachea detto che essi do
vevano costituire il fondamento dello stato ideale, que
sto proposito costruttivo rimasto allo etato di semplice
intenzione, perch ilibri A-Z in realt non contribui
scono, o contribuiscono solo indirettamente, alla prepa
razione e alla fondazione dello stato ideale. Argomento
decisivo era poi quello che nei manoscritti, al termine
del libro T, e' incontra, in forma poco mutata, la frase
iniziale di
H,
Al principio di H tale frase stilizzata
come si conviene all' inizio di una trattazione indipen
dente: alla fine di T ha una forma che si riconnette
mente da questioni pi generali, cio dal concetto universale del
itoXixyjc e della noXitsia e dall'ordinamento sistematico delle
possibili costituzioni, buone e cattive. Ma gi il criterio norma
tivo di questa suddivisione dimostra come Aristotele miri all'ideale
del perfetto stato: di esso infatti si tien gi conto dappertutto, come
p. es. in r 3, 1276 a 30 segg. {cfr. 'H 4, 1325 b 39) e in T 4, dove
s'indaga se l'dpetij del cittadino e quella dell'uomo siano o non
siano la stessa dpatj; (p. es. 1276 b 37; 1277 a 2; a 5), e cos nel
l'indagine circa idiritti politici dei Jvaooot
(r 5, 1278 a 8; a 17).
nella determinazione del giusto concetto -dello stato dal punto di
vista dell'educazione del popolo e nella polemica contro lo Slato
di Manchester (T 9, 1280 b 5 ;b 31; b 39 ; 1281 a 2 ;inoltre T 13,
1284 a 1; b 25; V li,1284 b 38; 15, 1286 a 8; a 15; 18, 1288 a 33
sino alla fine).
J) Per irimandi di r a H-0 cfr. la nota precedente. Vice
versa, H4, 1325 b 34 rinvia a T 6-8; H 14, 1333 a 3 rinvia con le
parole wxOitrep it -cot; 7?ojxoif elpvjTai
X-foif
a 1' 6, cfr. special
mente 1278 b 32 segg. Anche H 16, 1335 b 4 rimanda ai seguente li
bro 0. Tanto pi sorprendente la mancanza di rinvii a -Z in
H 0 e in r, tanto pi elle in -Z non mancano invece rimandi
a T e a II Questi peraltro non sono tali da esigere che -Z fos
sero collocati tra T e H0, cosa che anzi apparve addirittura esclusa
dalle citazioni c dal nesso collegante T e H0.
, PRIMA POLITICA 361
immediatamente agli ultimi concetti di questo
libro. Gli
scritti aristotelici conoscono vari esemp di tali segnali
tecnici, che servivano a ricostruire la connessione esterna
tra x volumi contenenti ilibri. Con ci il dato di fatto
che Hseguisse un tempo a T era sottratto al dominio
dell'ipotesi, risultando attestato esplicitamente dalla tra
dizione.
Se si ammette che le parole della fine della Nico
machea, delineanti lo schema generale della Politica,
non risalgano allo stesso Aristotele (tale ipotesi stata
effettivamente sostenuta) ma al redattore, fosse esso Ni-
comaco o Teofrasto, allora bisogna insieme credere cite
sia stato quest' ultimo a interrompere l'autentica serie
aristotelica dei libri della Politica con l'inserzione di
A-Z. Se invece quello schema risale ad Aristotele, il che
sembra a me l'unica spiegazione ammissibile, evidente
che stato lui stesso a inserire ilibri A-Z, e le parole
della fine del libro non sono che un resto dell'originario
stato delle cose. In ognuno dei casi dimostrato come
originaria fosse la successione di H 0 a B T : soltanto,
se 1* inserzione stata compiuta dallo stesso Aristotele,
noi non abbiamo alcun diritto di rifare questo passo
in senso inverso. Non i tratta infatti di distinguere
tra un esatto e un erroneo, bens tra un precedente e un
posteriore ordinamento dei libri. L' aporia nata a causa
dell' evoluzione di Aristotele, e, invece di rimettere or
dine a forza, noi dovremmo esser grati alla tradizione
per il fatto che essa ci concede di penetrare
ancora una
volta con lo sguardo nel divenire del suo pensiero.
Que
sto peraltro possibile solo per il fatto che l'ultimo
ampliamento non e' inquadra organicamente nella reda
zione pi antica della Politica, e che la sutura ese
guita solo in modo del tutto provvisorio.
Se riassumiamo irisultati finora raggiunti, troviamo
anzitutto innanzi a noi l'originaria politica dello stato
362 cu ANNI DI VIAGGIO
"H
.u
ideale, che nel suo orientamento si ricollega direttamente
a Platone. Essa s'inizia nel libro B con una rassegna
storica dei precedenti teorici dello stato ideale, com
preso Platone, e con la critica delle loro utopie. Evi
dentemente questo libro costituiva in origine V inizio
dell' opera, allo stesso modo in cui eoo la
parte storica
si aprono la Metafisica, il dialogo IIzp qiXoootplai e i
libri SulVanimJi. Esso
poteva per servire solo come
in
troduzione a una politica dello stato ideale: perci pi
tardi, quando ilprimo disegno dello stato ideale fu am- *
plinto in una dottrina generale dello stato, dovette esser
gli premessa un'introduzione pi generale I). Illibro P
passa alla determinazione dei concetti fondamentali
dello stato. Suo contenuto principale la deduzione
delle sei costituzioni tipiche, a seconda della diversa
misura della partecipazione al potere che esBe garanti
scono ai cittadini. Anche qui caratteristica la tendenza
verso norme e criteri assoluti, quale si manifesta saprai-
tutto nella distinzione delle costituzioni giuste da quelle
'
?
degenerate. Il tono metodologico del libro concettuale-
speculativo nella stessa misura che quello dei libriE 0,
i
quali contengono un vero e proprio schizzo del per
fetto stato e a cui esso pi volte rinvia.
Quanto
a questi
ultimi, poi, dovremo ancora tornarvi su.
A questo abbozzo speculativo si contrappone la parte
empirica, costituita dai libri A-Z. In questi libri non si
riscontra pi traccia dello spirito platonico animante
le costruzioni logiche
e gli abbozzi ideali. Ci non to
glie che Aristotele, sul
principio del libroA, si riferisca
esplicitamente alla parte antica quando spiega come al
politico,
accanto allo scopo della costruzione ideale, in
comba il non meno importante compito d'indagare ci
'
) Per la giustificazione
di questa attribuzione del libro A a
I
un et pi tarda cfr. pi oltre, p. 365 segg. ?
1
"A
LA PRIMA POLITILA 363
che sia utile o nocivo per
un dato stato in certe deter
minate condizioni. A un'unica scienza spetta
la delinea
zione dell' assoluto ideale e la determinazione
della mi
glior politica possibile in condizioni date. La trattazione
di questo punto dimostra come Aristotele, nella sua uni
ficazione dell'utopistica' platonica con questa
forma pu
ramente emprica di considerazione, abbia incontrato
una certa difficolt, pur credendo senza dubbio di essere
in grado
di superarla. Egli rimedia col richiamo al caso
analogo costituito dal duplice aspetto
della medicina e
della ginnastica, ciascuna delle quali ha un lato che si
occupa della norma pura e un altro che applica
tale no
zione al caso determinato.
Ma difficile che sfugga come
la polemica contro le pure
costruzioni ideali accompa
gni, quale continua eco, l'introduzione della parte em
pirica, e come Aristotele sia non poco
orgoglioso della
sua innovazione. E invero accentuando duramente ilmo
tivo dell'irraggiungibilit dell'ideale non si poteva gio
vare alla frantumata
e dissestata realt storica della
Grecia.
Ma, quel che pi importa, lo stato ideale non costi
tuisce affatto, nelle indagini empiriche della parte ag
giunta, la norma secondo la quale vien determinato ci
che raggiungibile e desiderabile in determinate con
dizioni: il criterio di misura infatti qui immanente,
in senso che potrebbe dirsi biologico. Esso si attinge
merc l'amorosa penetrazione delle molteplici forme
possibili dello stato, e non con la
contemplazione di un
rigido ed unico scopo ideale. Aristotele
non si stanca
perci d'insistere sul fatto che non c' soltanto un'unica
democrazia, un'unica oligarchia e via dicendo, ma ce
ne sono molto diverse variet. E mentre nel libro F de
mocrazia e oligarchia sono considerate assolutamente
come anormali e degenerate, inA esse sono invece quei
due tipi a cui praticamente powmno ricondursi quasi
364
CLI A.VNI DI VIAGGIO
tutte le
costituzioni della realt
storica, anche se Ari
stotele continua a tener fede alle due schematiche cate
gorie di valori del suo abbozzo pi antico, p&Y) Ttoitsia
e
TtxpijkcaiS- D' importanza
decisiva
per la
compren
sione dei libri A-Z non
questa conservazione dell'ele
mento antico, bens ilnuovo metodo. Ad esso non ed sa
rebbe mai potuti giungere partendo
dalla speculazione
circa lostato ideale. Col imperava lo
schematismo
della
divisione logica, qui
domina il senso biologico
della
forma. Significativo
a questo
proposito il
confronto
metodico, e spinto fino al particolare,
delle teorie delle
forme dello stato con la morfologia degli animali, che
Aristotele pone a capo della nuova trattazione1).
L'in
flusso che la
mentalit speculativa di
Aristotele, eredi
tata da Platone,
suhisce qui da
parte del metodo della
scienza sperimentale
della natura, e in particolare della
biologia e della
morfologia, il cui
generale
sviluppo ap
partiene
al pi tardo
periodo della
sua attivit scien
tifica, pu toccarsi
con mano. Non
si tratta soltanto
del controllo sperimentale
della
costruzione logica, che
*)
Poi., 4 4, 1290b25 fiaxsp c5v t (j>ou
7cp<5flpo6[is3-a Xa-
?stv
ili//.
<Tp5uov ccv
&7to5iti>ptjojiv insp vaxatov xSv
l/atv
otov i-ili xs tSv
aaO>]it)p(oiv xal rixijj
tppqri}? p-faaTixv
%al
&sx-tt-Av, otov cc6|is xal xoiXEav, xpj B
totoij,
oli xivstxai
popCoig Ixaotov rtSv et Si) -tooaOxa sir)
jiovov, totcdv B" eUv
S'-aoptct,
l-i'i
u) 5* otov
oxjiatBg uva tcXsEu)
-pvr) xal
xoiXiag xal
-otbv
aEaOr|Hjpiti)v, l-tt S xal tv xwijtixv jiopiwv, & xrjj
ooe!;eio;
r#iC
tovjjv
ipiS-jL;
iPO-.Tjoei xXeito yvvi <j)wv* o yp
stv re Ttt&Tv 5<pov
ixcv kXeEouj ai|J.aT0j
Bia'fopj,
5noEu>S
6
o58' (5tci)v 5)30'
xv
Xisaiv, tqtiuv
h&vte; ot ivBexjisvoi
aovjuaojiol Ttortjaouaiv
olrj
C<i>au, xai Toaat' stSrj to ipou Baal-
Itsp a.1 ooefets
Ti&v vaxairnv
jiopfmv elafv -v otv Si Tp~ov
xal tSv eipyjpvtov
xoX'.iei&v. A ci segue
il parallelo Ira le sin
gole
parti dell'organismo
sociale e quelle
dell'essere vivente- Il
modo in cui esso viene eseguilo mostra come per Aristotele non
si tratti, in questo caso, di una semplice analogia geniale, ma bens
di una completa
mutazione di metodo. II risultato, su cui egli in
siste a varie riprese in ci clic segue, assai importante:
non esi
stono soltanto 1pochi tipi
costituzionali distinti nel libro, I\ bens
ciascuno di questi tipi a sua volta variabile a seconda della com
binazione delle parti, la quale pu essere assai diversa.
LA PRIMA POLITICA 365
fin da principio era implicito nella tendenza del pen
siero aristotelico. Gi nell'antico saggio sullo stato ideale
il riferimento all' esperienza era il mezzo con cui Ari
stotele sosteneva o abbatteva la speculazione platonica.
Nei libri posteriori, in seguito ad una spregiudicata os
servazione del mondo empirico, si bens venuta costi
tuendo una forma di considerazione atteggiata in modo
del tutto diverso, la quale parte dai fenomeni singoli e
spia la loro legge interiore, nello stesso modo in cui si
osservano imovimenti caratteristici di un essere vivente.
La teoria delle malattie degli stati e del loro risanamento
delineata secondo il modello della patologia e della
terapia medica. difficile concepire un contrasto mag
giore di quello che rispetto alla politica platonica, e in
un primo tempo anche aristotelica, della norma assoluta
costituito da questa concezione, per la quale non c'
stato la cui disorganizzazione sia tanto disperata da non
meritare almeno il tentativo del risanamento. Cure radi
cali lo manderebbero certo rapidamente in rovina: e il
criterio per ci che in fatto di virt salutari egli pu
ancora produrre pu esser desunto soltanto dalla sua
natura e dalla sua condizione.
Qui
dobbiamo contentarci di questa caratteristica ge
nerale, senza addentrarci ulteriormente nell'analisi mi
nuta dei tre libri. Solo una parola sia detta ancora circa
il primo. Come si gi notato, esso venne aggiunto solo
quando Aristotele, con l'inserzione della parte pura
mente empirica, ampli il testo gi esistente per tra
sformarlo in una teoria generale della politica. Il libro
dedicato all' esposizione del piano complessivo del
l'opera, quale Aristotele aveva innanzi agli occhi nel
momento della rielaborazionc pi tarda. Nell'introdu
zione egli si propone di trattare delle fondamentali con
dizioni di natura di ogni esistenza statale, per erigere
T edifcio dello stato sulla sua base naturale, in funzione
?
366 GLI ANNI DI VIGCIO
dei suoi presupposti pi semplici.
Questi
sono costituiti ::
dai tre rapporti elementari di ogni vita sociale: padrone ?
e schiavo, marito e moglie, genitore e figli 1). Dal modo
in cui la tripartizione della materia, che di qui natu-
1
|
Talmente risulta, appare compiuta (o, pi esattamente,
non compiuta) si riconosce come Aristotele trovasse la
via ostacolata da certi impedimenti. Il primo libro con
cerne soltanto la prima di quelle tre
j1
relazioni fonda- f
mentali (px*) SeaTtori'/.Vj, Yaptxr), uaipixrj), cio la que
stione della schiavit e il suo nesso con la economia
della vita sociale. Per quel che riguarda gli altri due
temi annunciati, quello del matrimonio e quello dei
figli, Aristotele consola alla fine gli uditori con l'avver
tenza che questi riuscirebbero meglio trattati, in connes
sione col problema della famiglia,Iv
tot? Jiepl noXetelaj.
Questa
mancanza di coerenza e di chiarezza, che a prima
vista incomprensibile e rende insoddisfacente la fine -/)
del primo libro, si spiega data la situazione forzata in
cui Aristotele si trovava, e da cui poteva uscire solo
merc una scappatoia. La questione del matrimonio e
quella della famiglia erano gi state ampiamente di
scusse nell' abbozzo pi antico della Politica, in occa
sione della critica della tesi platonica esigente la comu
nit delle donne e dei figli. Ora, o egli doveva cancel
lare queste pi antiche trattazioni, e con ci togliere
alla critica dello stato platonico la sua principale attrat
tiva, oppure era costretto a rinunciare a ripeterne la
trattazione nel libro A e a contentarsi di un rinvio al
l'esposizione gi esistente in B 2). Egli preferi quest'ili-
\l Pol, A 3, 1233 b 4-8.
") Pol., A 13, 1260 b 8-13. Non beilo cancellare l'articolo xg
innanzi a noXt-tslag, o cambiarlo in Con ci il rimando si
riferirebbe alla parte della Politica che contiene la trattazione dello
stalo ideale: ma col non si parla del problema della famiglia,
ed e una magra consolazione quella dell'escogitare che ci che
manca possa essersi trovato nella parte conclusiva, e mancante, del-
1
LA PRIMA POLITICA 367
tima cosa. La composizione interrotta del primo libro
con ci la conseguenza del suo adattamento all' ab
bozzo pi antico. Anche il passo finale, che serve a pre
parare il trapasso alla diversa posizione del problema
propria della pi antica politica dello stato ideale, tra
disce questo sforzo di adattamento con la sua singolare
tortuosit (e per tale motivo se n' voluta persino negare
la paternit aristotelica) senza che perci riesca a dis
simulare ilsorprendente salto ideale, che si avverte con
la prima frase del secondo libro.
Una conferma di questi risultati data anche dal
metodo di citazione di cui Aristotele si serve nella Poli
tica. Due strati di citazioni, in parte contraddittorie, si
l'ultimo libro. invero precario modificare il testo tramandato,
per riguardo a una parte dell'opera che forse non mai esistita-
L'espressione v xoCg reepl rag noXtTslag pu avere, in s, molti
significati. In A 2, 1289 a 26 esso designa la determinazione sche
matica delle sci costituzioni date nel terzo libro. In B 1, 1260 b29
Aristotele, parlando dell'indagine sulle aXXai itoXitttai, intende
per esse, in antitesi alla propria concezione dello stato ideale,
le utopie costruite dagli altri teorici della politica e da lui
criticate nel libro B ; e anche alla fine di quest' ultimo
libro egli comprende tale indagine sotto il nome di x trspl
hoXitsIb; (1274 b 26). Ora, il problema della famiglia
trattato ampiamente in B 3-4, nella critica della concezione pla
tonica concernente la comunanza delle donne e dei figli, anche se
l'opinione di Aristotele vien col in luce in forma piuttosto indi
retta, in funzione del contrasto rispetto a ci che a lui appare as
surdo. Ma proprio questa situazione di cose risulta dall'annuncio
preliminare dato in A 13, 1260 b 10: circa l'psrr} dell'uomo e
della donna, dei figli e dei genitori e circa la loro piX
(
a,
x x xixXcbg zzi pii xaXfg ioti, xat nj 8a t
fitv
s5 Subxsiv
t 8 xaxtg cp a y e tv , v -rot; nepl xg tcoXixsbs
vB-yxatov
nsiO-stv. Qui
egli prevede una trattazione del problema nella for
ma 'di una critica di ci che non va: se egli avesse invece pensato
di compierla nella stessa forma dell'indagine concernente il pro
blema della schiavit, non sarebbe possibile immaginare alcun mo
tivo per cui egli non avesse dovuto farla seguire immediatamente
a questa. Illibro A. come dimostra il brusco trapasso al libro B. che
improvvisamente designa come scopo della politica la costruzione
di una pio-?] "Otrsia mentre fin allora non si era parlato che
dello stato in generale, bens stato premesso a una trattazione
gi esistente da pi antica data, e in cui la questione era gi di
scussa.
'
I
i'
,1,
358 CLI ANNI DI VIAGGIO E
trovano infatti sovrapposti l'uno all'altro. La prima
. j
idea naturalmente quella di considerarli insieme e di
tentare di metterli d'accordo: poi si fa valere la loro
antitesi reciproca e se ne dichiara interpolata una met.
'
Ma allo scioglimento del nodo si perviene soltanto
quando si proceda tenendo conto dell' evoluzione storica
1 -s
e si distinguano le citazioni che debbono aver apparte
nuto all'antico abbozzo dlio stato ideale, presuppo-
nendo esse soltanto questo, dai rimandi posteriori, che
presuppongono l'intero complesso della Politica nella
redazione odierna. Immediatamente probanti sono natu-
ralmente solo quei rimandi che contraddicono allo stato
'
odierno della Politica, mentre quelli che lo presuppon
gono possono appartenere all'ultima elaborazione e non
sono quindi interpretabili in un solo senso. Ma se si di
vidono cos le citazioni in due gruppi, si vede come
quelle contraddienti alla condizione odierna della Po
- ;
litica non denuncino altro che l'originaria coerenza e
indipendenza dei libri contenenti la teoria dello stato
ideale (B T H 0). Il libroFha costituito un tempo l'ini
zio della trattazione vera e propria, giacche B aveva un
contenuto soltanto negativo. Per ci esso vien pi volte
citato con le parole v
tot? reputo:? Xyot?. Anche il li
bro A, che appartiene alla redazione pi tarda, cita il
terzo ancora in questa forma: l'inserzione di A-Z ha
perci evidentemente avuto luogo prima che il primo
libro fosse preposto all'intero complesso dell'opera 3).
') Il libro T 0 il suo inizio citalo con la formula iv
-cote
ttpt-coi? Xyois in 1" 18, 1288 a 37 (= f 4); H 14, 1333 a 3
(= r 6); 4 2, 1289 a 26 (= r 6): 4 7, 1293 b2 (= T 4-5);
4 10, 1295 a 4 (= T 14-17). All'odierno stalo delle cose contrad
dice, quando si accolga l'interpretazione del Sueemihl, anebe il
fatto che in 4 3,
]290al
la frase etpvjxai iv
tote
itspl triv
piotoxpa-ciav si riferisce a H8-9: peraltro non assolutamente da
escludere che si riferisca invece a r 4. II Newman (The Politics
ol Aristotle, IV, p. 155) pensa a T 12, 1283 a 14 segg. Cfr. la
nota seguente.
LA PRIMA POLITICA 369
Prima che esso ci fosse, Aristotele, per le questioni phc
ora si trovano trattate inesso, cio per il problema della
schiavit e per la teoria delle tre forme fondamentali
del potere in seno alla singola oixa (Seanozc/.rj, yapix,
TcaTpixvj), si richiamava soltanto ai suoi dialoghi essote
rici, che parlavano ampiamente di tali argomenti. Cos
in p 6, 1278b30: XX jrijv -/.al
zr/; dpiji
Y
Xe-po-
pvou? zpito'j? ptov SieXetv
'
xal yp v
toc?
iljcoTspcxoI?
Xyo:? 8topt(5|i.{)-a 7tepl
axwvTtoXXdxi?.
La partizione che
segue infatti esattamente uguale a quella che s'incontra
gi nel primo libro, distinguente itre rapporti di potest
che legano il padrone e lo schiavo, ilmarito e la moglie,
il padre e il figlio. Che nonostante ci Aristotele si
richiami per essa ai dialoghi quindi cosa ohe non
ha nulla di sorprendente solo nel caso che il libro l1
appartenga a una redazione in cui A non esisteva an
cora. Nell'ultima redazione egli concep ilpiano di com
pletare questa lacuna e di discutere ampiamente la que
stione in un libro introduttivo: nel passo citato diven
ne allora naturalmente necessario un. rinvio, segnalante
come tale questione si trovasse gi trattata nel primo
libro. Accanto al pi antico rinvio ai dialoghi, rimasto
al suo posto, questo nuovo rimando ha quindi un aspetto
pienamente contraddittorio1). Un secondo rimando al
libro
fu aggiunto da Aristotele nel libro H, in un
passo in cui egli accennava al rapporto del padrone con
lo schiavo2). Anche la singolare relazione, gi ricor-
')
Poi., T 6, 1278 b 17. Se tale rimando 6 riferisse al libro A
c se. di conseguenza quest'ultimo si fosse trovato al suo posto fio da
principio, non si capirebbe pi perch subito dopo, per mezzo di
una citazione dagli sSUu-spiv.ot
Xo-fOi, dovesse essere esposto ancora
una volta ci che a proposilo degli CspxiS Mi
era gi stato delto nel
libro A. L'esempio delie altre citazioni dagli scritti essoterici rende
evidente ebe questo brano un estratto da un dialogo, di cui Aristo
tele si vale in via sussidiaria: ma ci presuppone che in
quel tempo il libro A non precedeva ancora tale passo.
) Poi., E 3. 1325 a 30 5:tpioTa; S ttspl a&tcv Uavffig v TOtj
24.
W. JaSGIB, Arinotele.
370 CU ANNI DI VIAGGIO
data, che lega le citazioni contenute nei libri B I1 H 9
con quelle dei libri E Z si spiega in modo soddisfa
cente quando venga considerata dal punto
di vista della
loro genesi1). Che ilibri del disegno dello stato ideale,
B T e H0, siano tra loro collegati da una rete di ri
mandi reciproci, mentre non citano i libri intermedi
A -Z, cosa che ha la sua ragion d'essere nella ge
nesi precedente ed unitaria dei primi. D'altro lato si
comprende bene perch nella pi recente parte empi
rica, e specialmente in A, iriferimenti alla parte an
tica siano viceversa frequenti.
Cerchiamo ora di delimitare pi esattamente l'epo
ca della genesi dell'abbozzo concernente lo stato ideale
rispetto a quella dei libri posteriori e della silloge delle
costituzioni. Come per l'etica e per la metafisica, dob
biamo nuovamente muovere dalla relazione che lega la
parte riguardante lo stato ideale agli scritti giovanili
di Aristotele: e invero, fatto ben significativo, solo in
questa parte pi antica si parla di una simile relazione,
mentre iposteriori libri A-Z non mostrano la p te
nue traccia di un collegamento con le opere dialogi
che. Certo, quanto
a materiale di confronto a nostra
disposizione, stiamo male. Il Protreptico, l'unica opera
a cui ci possiamo attenere, offre qualcosa solo per i
punti in cui la politica si basa immediatamente sul
l'etica. Scarso, nei' resti superstiti, il contenuto pura
mente politico.
Questo
danno in qualche misura com
pensato dal fatto che il nesso interiore della politica
itpTOLs Xiyoi;. Qui, come in T 6, 1278 b18, la formula v toTg
TtptDTet?:
X-foi?
non designa, come 'di solilo nella Politica, il libro
r, ma bens illibro A: riferendosi, cio, allo stato delle cose che
era 6tato prodotto dalla rielaborazione pi larda. Entrambi irinvi
sono stati aggiunti solo in questa occasione. Di citazioni che non
siano di mano di Aristotele non posso invece riconoscere l'esistenza
nemmeno nella Politica.
') Cfr. sopra, pp. 359-60.
LA PRIMA POLITICA 371
con l'etica era nel periodo pi antico evidentemente
assai pi stretto di quanto sia nell'et pi tarda, in cui
Aristotele conserva s ancora, formalmente, l'unit delle
due discipline ed anzi le elabora sistematicamente in
un edificio complessivo estrinsecamente grandioso, ma
in cui il distacco dell'etica individuale ormai, sotto
la superficie di questa tradizionale connessione plato
nica, praticamente quasi compiuto, ed gi avviato il
processo che conduce alla autonomia ellenistica dell'e
tica.
Cominciamo con l'inizio del libro H, che pone ifon
damenti dello stato ideale. Nella sua identificazione del
fine dello stato col fine elico dell'individuo esso pie
namente platonico. Tale infatti il significato della tesi
da cui muove l'indagine: il migliore stato quello che
garantisce ai cittadini la vita migliore (apet(irato$, pi-
atos j3og). Con ci Aristotele non subordina affatto lo
stato al benessere degli individui, in senso liberale, ma,
come Platone, deduce icriteri di valore per giudicar
dello stato dalle norme etiche valide per l'anima del
singolo. La vita ottima identica per lo stato e per
l'individuo: e ci non significa per lui che, quando tutti
hanno abbastanza da mangiare e si sentono a loro agio,
le cose vanno bene anche per lo stato, bens che ilvalore
spirituale e morale dello stato basato su quello dei
suoi cittadini. La sua fonte ultima l'anima dell'indi
viduo, nella sua capacit a emettere giudizi di valore.
Dal canto suo, il supremo concetto etico dell'anima
Io 6tato, a cui l'uomo predisposto per natura.
La deduzione del perfetto stato dalle norme etiche
si compie per Platone in seno a un'unica scienza: in
Aristotele invece il processo di differenziazione della
politica dall'etica gi tanto avanzato, che in questo
punto egli deve rimediare richiamandosi estrinseca
mente al significato fondamentale proprio del teorema
372 GLI ANNI DI VIAGGIO
etico delPpwco? L'intera forma dell'impostazione
etica del problema (x[? jJEoj Spiavo?) gi di per s un
segno dell'antichit di questo abbozzo di teoria dello
stato, giacche per quanto esBa estenda ilsuo influsso an
che sull'etica pi tarda, col essa ridotta al compito
di puro inquadramento
tradizionale, in seno a cui si
sviluppa la teoria dell'ethos col suo realismo psicolo
gico, mentre nel Filebo e nel Protreptico e ancora nella
prima etica essa costituisce il centro di tutta la pro
blematica dei valori. Non ci sorprende quindi (esigendo
anzi, ormai, una seria considerazione storica, e non pi
soltanto letteraria) il fatto che Aristotele, nella fonda
zione dello stato ideale, si richiami per la questione
della miglior vita ai suoi scritti essoterici. Senza pos
sibilit d'equivoco egli parla di un determinato scritto
jiepl poxxjs Cui)?, e cio del Protreptico, servendosene
di base1). Che il Bemays, il quale etato il primo a
riconoscere come in questo luogo Aristotele citi s
stesso, sia ricorso al dialogo Nerinto, a noi totalmente
sconosciuto 2), invero inconcepibile: ma resta suo me
rito l'aver richiamato l'attenzione sul mutato ed ele
vato stile del capitolo che segue8). Dal carattere di que
sta lingua, insolito nei trattati didattici, e dalla sua coin
cidenza con la citazione dei
Xfoi
essoterici egli con
cluse che in questo passo si avesse un'ampia citazione
da un dialogo aristotelico, la quale serbava persino le
particolarit dell'impronta stilistica. Il Diels inser poi
il problema linguistico in un quadro pi vasto e con
sider la sorprendente elevazione del livello stilistico,
constatabile in molti passi dei trattati didattici, come
rispondente all' intento oratorio di agire soggettiva
mente sull'animo dell'ascoltatore, senza perci crede-
') Pol, li1, 1323 a 21.
*) Bernays, Die Dialoge des Aristotclcs, p. 89.
3) Bernays, loc. cil., p. 77.
LA PRIMA POLITICA 373
re che si trattasse di passi desunti dai dialoghi1). Ma,
dopo tutto quel che s' detto, non occorrono altre pa
role per illustrare ancora il fatto del molteplice ricol-
Iegamento dei trattati didattici agli scritti essoterici. An
che l'introduzione del libro H della Politica si basa
dunque su un modello essoterico. Tuttavia, senza dub
bio, lo stile elevato di questo brano non dipende sol
tanto da un involontario influsso dell'originale, perch
nell'introduzione della teoria dello stato ideale esso
del tutto al suo posto e s'incontra anche altrove in passi
simili, senza che ci sia da supporre imprestito dai dia
loghi2). Nel passo che ora esaminiamo entrambe le
cose, imprestito e cambiamento di stile, coincidono:
Aristotele non attinge soltanto iconcetti alla sua fonte
essoterica, ma conviene con questa anche nell'intento
di rendere quei concetti protrepticamente efficaci merc
una determinata forma stilistica.
Dal Protreptico egli desume anzitutto, come nell'ini
zio del secondo libro Ael'Eudemea, la partizione dei
beni in esterni, corporei e psichici. L'eudemonia con-
*J H. 'Diels, recensione di G. KaiLel, Stil und Text der
'A9-qvaImv noXrtsta des Arisloieles, in Goti. gel. Am., 1894, e Zrt
Aristoteles' Protreplikos und Ciceros Horlcnsius, in Archiv
/.
Gesch.
d. Phitosophie, I,p. 478. Nella mia Fntstehungsgeschichte d. Metaph.,
p. 137 lio aderito alla tesi del Diels, e ritengo anche oggi impos
sibile attribuire ad Aristotele un uso- dei suoi dialoghi per cui egli,
come un tardo compilatore, diventasse Sem' accorgersene schiavo
dello stile del suo modello. Se Io stile cambia, ce n' volta per
volta anche il motivo, che quello di ottenere uno speciale effetto.
Peraltro, se per tale ragione io credevo allora, col Diels, di poter
fare a meno di ammettere imprestiti dagli scritti essoterici, debbo
ora naturalmente lasciar cadere questa illazione. Lo studio del
Vahlen (Ber. Wiener Akad. d. Wiss., LXXII, p. 5 segg.) sull'inizio
del settimo libro della Politica, che si segnala per le sue fini osser
vazioni linguistiche, non ha portato innanzi la soluzione del pro
blema posto dal Bernays circa la provenienza del contenuto teorico
di questo capitolo,
2) Cosi, p. es., nel primo libro Hep! <u)v jiopituv. che costi
tuisce l'introduzione di un'ampia serie di lezioni sugli animali e
che si diffonde in questioni -generali.
374 GLI ANNI 1)1 VIAGGIO
dizionata dal possesso di tutte e tre le specie di beni,
ma naturalmente al filosofo non importa tanto dimo
strare la necessit dei beni esterni o dei corporei quanto
quella dei beni' morali e spirituali. Nessuno pu chia
mar felice un uomo che non possiede traccia di corag
gio, riflessione, giustizia ed intelligenza (tppvvjcts), che
teme ogni mosca che passa, che non trova troppo vol
gare la cosa pi volgare quando spera di soddisfare con
essa una brama del palato o della gola, e che per qual
che misero soldo precipita isuoi migliori amici nella ro
vina; e tanto meno colui il cui spirito sviluppato solo
come quello di un bambino o ottenebrato come quello
di un folle . Le
quattro virt platoniche, tra cui la <pp-
vrjoic, messa in luogo della coccia nel senso che ad essa
dava il vecchio Platone, bastano gi a dimostrare l'an
tichit di questo passo. Gi nel Protreptico trovammo
la etessa tetrade1).
Quanto
valore sia attribuito ad esse
dimostrato dai quattro esempi relativi, tra cui quello
riferentesi al valore della cppvcrj
et?
ancora rintraccia
bile nei nostri frammenti del Protreptico. Nessun uo
mo potrebbe vivere, anche col possesso della pi gran
ricchezza e della pi grande potenza che ci sia stata
a memoria d'uomo, se dovesse esser privato della con
sapevolezza razionale e ottenebrato dalla follia, pur se
potesse condurre una vita piena dei pi forti piaceri dei
sensi . E pi oltre detto : Se anche uno possedesse
tutto, ma il suo spirito fosse disorganizzato e malato,
la sua vita non sarebbe desiderabile. In tal caso infatti
anche gli altri beni non servono a nulla. Perci tutti gli
uomini considerano ogni altra cosa come un nulla a pa
ragone della consapevolezza dei sensi e della capacit
di fruire dell'unico bene della vita spirituale, e
per que-
')
Framm. 52 p. 62, 24 B.) ; framm. 58 (p. 68, 69 R.) e cfr.
Pol, H 2, 1323 b 3336; 25, 1334a 22.
LA PRIMA POLITICA
375
sta ragione nessuno sopporterebbe di essere tutta la vita
ubriaco o nella condizione di un fanciullo1).
Ma questo
lo concederanno tutti, prosegue
la Poli
tica: le opinioni divergono solo a proposito
della mi
sura, cio circa il problema di decidere di quali specie
di beni si abbia pi bisogno. Dell' ps-ci] gli uomini con
siderano gi sufficiente anche una parte assai piccola:
invece ricchezza, denaro, potenza e gloria 6ono da e6si
desiderate in quantit straordinaria Sirsipov f]Toac
xfjv jtep(3cXv)v). Mai, consista l'eudemonia nel piacere
o nella saggezza morale o in entrambe le cose
e que
sta era proprio l'impostazione del problema data dal
Filebo e dal Protreptico
2), essa viene incontro piut
tosto a coloro che sono adorni nella pi alta misura
dei doni dello spirito e in compenso possiedono solo
una quantit moderata di beni esteriori, che a coloro
che in quest'ultimo campo hanno possessi superiori alle
loro possibibt d'uso e che in compenso sono meno av
vantaggiati dal punto di vista spirituale.
Queste
parole
riflettono concetti e movenze caratteristiche del Protrep
tico. Il rfyv Sivoiav xsxck7|j.tj|avos xafr' &7tepjSoXV]V fa
preciso contrasto al Xajwrp? lafHjxi xsxoajitjfilvo? del
Protreptico, la cui anima xaxfflj Sixetxai 8). Di questa
internaAristotele parla, nella Politica, pocheri
ghe pi oltre. Il sommo grado (ipiaz-q
Stfreat?) di ogni
bene che pu essere posseduto dall'uomo , per quel
che concerne il suo valore relativo di preferibilit ri-
epetto al grado massimo di altri beni, dipendente dalla
differenza di valore che distingue questi stessi beni l'uno
') Framm. 55 (p. 65, 4
7 e 65, 13
21 R.).
) Jambl., Protr., p. 41, 12; 59, 27 Pist.
*) Pol., H 1, 1323 a 36 srgg., cfr. framm. 57. In entrambi i
luoghi il metodo, mirante a determinare la partecipazione della
4xi; %opr)-{la e dell' interiore S'.dS-sais dell'anima all'eudemonia.
identico.
376 GLI ANNI DI VIAGGIO
dall'altro1). La stessa cosa detta dal Protreptico infor
ma pi semplice: per colui, la cui 5i
9-sai?
psichica
cattiva, n ricchezza, n forza, n bellezza cono beni:
ed anzi quanto pi questi sussistono xa3"' uisepoXv,
tanto maggiormente danneggiano chi li possiede, se non
sono uniti con cppvTjai? (framm. 57, fine).
Ibeni esterni debbono avere un xpag, perch sono
mezzi e ogni mezzo tale in grazia di qualcos'altro:
coltivato come fine in s, il mezzo si converte in danno
per colui che esso rende suo schiavo, o almeno diventa
inutile. L'accrescimento dei beni intemi invece tanto
pi giovevole quanto maggiore, dato che, in generale,
si debba qui parlare di xprjaifxov e non di xaXv sol
tanto 2). Anche qui la fonte ilProtreptico, dov' detto:
In generale, la costante ricerca delle conseguenze utili
in ogni forma di sapere un segno del mancato avver
timento della distanza che per natura separa ibeni nel
vero e proprio senso della parola dai semplici mezzi.
Grandissima infatti la differenza che tra essi inter
corre. Le cose che si desiderano solo in grazia d'altro,
senza il quale non si pu vivere, dovrebbero essere chia
mate soltanto mezzi (dvafxala) e condizioni (auva(xta)
Beni in senso vero (cio valori) dovrebbero invece es
sere dette soltanto quelle cose che si stimano per s
stesse, anche se ad esse non connessa alcuna utilit.
Infatti non sempre una cosa desiderabile (atpexv) solo
in grazia di un'altra e
questa a sua volta in grazia di
un'altra e cos via all'infinito (ri? fijxei
pov), ma in qual
che luogo c' un punto fermo (EaxaxaC xou: cfr. Poi.,
1323 b 7 x pv yp xx;
!xet
*pj) . In generale non
1
Quanto alla predilezione per questo tipo formalistico di argo
mentazione logica nel Protreptico cfr. Jambl., Protr., p. 43, 28; 44,21.
Entrambi gli esempi si riferiscono egualmente all'atpSTv e al jiA-
Xov aioeTv.
') Pol, H 1, 1323 b 7-12.
LA PRIMA POLITICA 377
si deve chieder sempre xi xpfjcipov e x o5v fjpv ScpeXo;,
perch c' un ideale (xaXv xiafrv), il quale sta pi
in alto che la vile utilit1). Tanto ciascuno partecipa
dell'eudemonia, quanto partecipa pexfj? xa cppovfoeco?
la formula dell'Eudemea
: di ci egli ha per te
stimonio lo stesso Iddio, il quale non Sa[io)V
xa
paxpto?
per ci che ha ma per ci che (Si' auxv
axq xa x(j> Ttoi? xi? elvai x9)v cpaiv).
Questo
modo di
argomentare appartiene a un'et non molto posteriore
al distacco da Platone, in cui l'elemento teologico do
mina ancora, compenetrando anche l'etica e la politica.
Pi tardi, invece, Aristotele evita simili interventi del
l'elemento metafisico. Che anche quel modo d'argomen
tare abbia ilsuo modello nel Protreptico dimostrato
dal frammento, conservato inCicerone, circa la vita nelle
isole dei beati: una igitur essemus beali (scil. si nobis
in beatorum insulis immortale
aevum degpre lideret) co
gnitions naturae et scientia, qua sola etiam deorum est
vita laudanda2). Anche qui la vera felicit umana
dedotta dal principio da cui discende la beatitudine di
Dio. Tanto questa argomentazione quanto la distinzione,
svolta in ci che segue, dell'eudemonia dall'eutichia ap
partengono ai problemi che gli scritti giovanili e l'etica
pi antica hanno in comune con la Nicomachea. Ma
l'aspetto complessivo in cui qui si presentano quello
proprio- del periodo pi antico3).
Ilprimo, capitolo del libro H termina con le parole:
Basti ci come introduzione. impossibile non ac
cennare a questo problema, ma neppure dato adden
trarsi a questo proposito in tutte le questioni che ad
') i'rinim. 58 (p. 68, 19 R.V .Dopo Xyojisv sono cadute nel
Fvor.c (p. 69- 1), per svista del tipografo, tre righe: cfr. Jambi., Prolr.,
p. 52, 23 segg.
*) framni. 58 (p. 68, 10 R.)
') Cfr. Elh. Eud., 6 2.
378 CU ANNI DI VIAGGIO
esso si connettono. Ci spetta infatti a un altro corso di
lezioni {l~pag coAfjg) .
Chi non fosse ancora soddi
sfatto vien cosi esplicitamente confortato col rimando a
una nuova discussione del problema. Nell'ambiente pla
tonico, inmezzo' al quale i
queste lezioni sono nate, Aristo
tele si aspetta contestazioni della sua parificazione della
ESsajiovia dello stato a quella dell'individuo. Entrare
nel filosofico stato di Platone e servire ai suoi fini po
trebbe certo non esser difficile per un filosofo: ma Ari
stotele non concepisce ilsuo nuovo stato ideale come go
vernato da re platonici. Nel passo del primo capitolo
in coi egli parla dell'identit della miglior vita per lo
stato e per il singolo cittadino, egli non conosce pi,
ed significativo, che due possibili 6pecie del pfog :o
quella dedita al godimento massimo dei piaceri o quella
dedicata alla dimostrazione della propria valentia etica
e pratica. Della vita della pura ragione (cppvqoig) egli
non parla1). A ci un platonico dovrebbe rispondere
clic al filosofo non rimane alloTa altra via all'infuori
di quella di ritirarsi completamente dalia vita politica.
Questa
era la conseguenza necessaria della concezione
che Aristotele stesso aveva professato nel Protreptico.
Colsolo lafilosofia determinava la suprema norma poli
tica ed era legislatrice nello stato. Nel nuovo stato ideale,
avvicinato alla realt, dove restava pi posto'per il Deta-
ptjttxg piog dell'individuo filosofante?
Qui l'antinomia
opponente lo stato al singolo diventa per la prima volta
un problema scientifico, per quanto ancora in un senso
affatto limitato, giacche solo l'Io filosofico, l'Io della
cppvTjutg ha da rappresentare, in casi determinati, in
teressi superiori a paragone di quelli dello stato. Per un
cittadino comune, che soltanto il prodotto dell'am
biente etico dominante nello stato, non sussiste nello
') l'ol., H 1, 1323 bl.
LA PRIMA POLITICA
379
etato antico alcun problema del genere. Esso si risolve
nel corpo dello stato, come suo membro.
Dallo stato ideale Aristotele esige per che la comu
nit statale e l'individuo non debbano avere in nessun
caso scopi di vita insanabilmente divergenti. uno spet
tacolo d'interesse non soltanto storico e biografico quello
che ci si offre quando
vediamo l'autore del Protreptico
lasciar scatenare, nei due seguenti capitoli della Poli
tica, l'urto tra la sua coscienza filosofica e la sua co
scienza civico-sodale, divenuto inevitabile dopo l' ab
bandono del platonico stato dei filosofi. Come l' an
tinomia di fede e scienza nella metafisica, di ethos
e spirito speculativo nell' etica, cos l' antinomia di
stato e individuo ( valore
culturale) teoricamente
possibile solo sul piano del platonismo
aristotelico,
gi infirmato dalla sua crisi interna. H mito statal
di Platone non poteva pi trattenere, con la sua
romantica unit originaria delle diverse energie, l'anti-
nomico divergere di questi fattori, tendenti a una sem
pre maggiore separazione.
Aristotele cerca di conciliarli
di nuovo in un' unit superiore. Icoerenti propugnatori
del jEog avevano, certo, gi da lungo tempo
riconosciuto ohe estrema conseguenza dell'ideale di Pla
tone doveva essere la fuga dallo stato reale e la vita
del meteco (jevix;
(3og) a), giacch dove esisteva lo
stato filosoficamente temperato, in cui potesse inqua
drarsi il loro ideale? Ogni stato effettivo, per quel che
sembrava ad essi, era invero violenza e nient' altro che
violenza, tirannide e negazione della libert. Per ci la
conclusione suonava: non agire, non dominare, non farsi
complici della dispotica atrocit dell'azione politica, as
setata di potere e colma d' egoismo. Ad essi si contrap
pongono, secondo Aristotele, coloro che considerano de-
') Pol., H 2, 1324a 14 segg.
a
380 GLI ANNI DI V1ACGIO
gno di un uomo solo 1' agire e il dominare energicamente.
.
f
Ci sono stati la cui intera legislazione e costituzione non
li
ha altro scopo che quello di educare nei cittadini uno
|
spirito orgoglioso, imperioso e guerriero. In
quanto le
5
costruzioni statali non sono prodotti del caso, prive di {
spiritualit, come per lo pi accade, esse possiedono
j
senza eccezione, secondo Aristotele, questo carattere1).
j
Ora, egli determina il suo nuovo ideale trovando una
via di mezzo tra questi due estremi. L' individualismo
illimitato dei platonici rigorosi, che preferiscono l'as
soluta libert dell'individuo alla partecipazione alla
vita di uno stato dispotico e non vogliono n governare li,
n essere governati, da lui considerato, s\, come moral-
>'.t.
mente migliore dell'ideale di
potenza dello stato mo- V
demo: ma signoria non per lui necessariamente dispo-
~~
. t-
tismo, e un gran numero di uomini non nato che per
obbedire. Ingiustificato gli appare anche il rigetto del- .
1' attivit e la lode dell' inerzia. Con espressione intra*
;;
ducibilmente greca Aristotele dice che certo non avreb* I1
hero torto coloro i quali pensassero che Ye npxzuv
-l
non
pu veramente consistere
nell'noay.xtlv.
Per il senso
greco della vita, questa una convinzione che non ha
bisogno di essere discussa. chiaro che Aristotele pu
conciliare l'ideale filosofico della vita con questo scopo
statale e sociale solo concependo anche il S-supetv del
'
f
filosofo come una forma di agire creativo. Anche con
'
ci
egli apre una nuova via, procurando un nuovo col
legamento tra la scienza e la vita dopo la dissoluzione
della mitica sintesi che ne aveva operato il platonismo.
L'agire della creativit spirituale ha questo nome: edi
ficare.
Qui
Aristotele ha
abbandonato 1' altezza solitaria
del Protreptico. Egli sta in mezzo alla vita attiva come
1' architetto del pensiero ( taf; Stavofat; p/ixy.Twv) e
*)
Descrizione dei due tipi: Pol, H 2, 1324 a 35 segg.
LA PRIMA POLITICA
381
edifica ilsuo stato in modo che questa attivit spirituale
sia in esso riconosciuta ed eserciti efficacia quale su
prema fra tutte le forme d' azione dirette al
vantaggio
dell'umanit e della comunit x). Cos
Aristotele, com
battendo con la realt chiaramente riconosciuta
nella
sua natura, tien
fede al suo ideale giovanile. Ilfatto che
la presa di posizione rispetto ai fondamentali concetti
etico-politici del Protreptico e alla is.ua teoria della vita
migliore torni in tal modo in primo piano nell' antico
abbozzo circa lo stato ideale, allo stesso modo in cui
apparve presupposta
ad ogni passo nella prima
etica,
non soltanto una prova
della genesi primitiva di quel
l'abbozzo, ma fornisce anche la possibilit, soltanto ora
raggiunta,
d'inquadrarlo esattamente nella storia dei
problemi. La prima politica corrisponde infatti allo
stesso 'Stadio evolutivo rappresentato
dalla prima etica
e dalla prima metafsica
2).
Con ci insieme
risolto, e in un senso nuovo, il
problema costituito
dai numerosi passi
in cui 1' antico
abbozzo circa lo stato ideale si riferisce all'Urico. Questi
passi sono stati per lo pi riferiti alla
Nicomachea, an
che. nei casi nei quali poteva, ins e per s, essere stata
*) Pol, H 3, e specialmente 1325 b 15 segg.
5) La dipendenza del libro H dal Protreptico non si limita
affatto ai tre primi capitoli qui analizzati: cos p. es. nel
capitolo 35
si scorgono chiare le tracce del fatto che 1 Protreptico abbia servito
di modello. Se gi 1* enumerazione delle quattro psxai platoniche
(1334 a 22 segg.) vi richiama l'idea della forte antichit di tutto
questo saggio sul perfetto stato, Aristotele attinge poi direttamente
a quello scritto
(trami. 58) il tdirog circa la necessit della filosofia
e delle Ape-cai morali nelle sole dei beati. E dalla stessa fonte
proviene 1* invettiva contro
l'incapacit alla y.P*ia'S
degli iyaii-i, che
nel Protreptico (framm. 55) segue immediatamente
a quel -ciitoc.
Dalla stessa opera
(Jambl., Protr., p. 51, 1852,
2)
deriva anche la
chiusa del capitolo, concernente il rapporto del corpo con J anima
e le parti dell' anima. U 17, 1337 a 2 noa
TP xXv1
"c"5eta
t oooXstiwv goW.e-cat tfasco;
rtxjtX-rjpoOv ripete alla lettera
Jambl., Protr., p. SO, 1-2;_H
9, 1329 a 15 f,
Si <ppi-rr(oi; iv Ttpssgu-
tpc.g iotiv riecheggia ibid., p. 51, 24 segg.
382 GLI ANNI DI VIAGGIO
utilizzata 1' Eudemea. Strano d' altronde restava, a que
sto riguardo, ilfatto ohe alcuni passi principali quadras
sero soltanto con l' Eudemea, che pure doveva essere
stata composta da Eudemo1). Giacch in questi passi
(come per Io pi anche altrove) l'Etica non esplici
tamente citata, ma utilizzata tacitamente, doveva invece
esser stato Eudemo', si pensava, ad aver avuto sotto gli
occhi la Politica. Confutata la paternit di Eudemo e
dimostrata l'antichit dell' Etica che ne reca il nome,
;
anche questa relazione riesce pienamente chiarita. Se
l'et dell' abbozzo circa lo etato ideale risulta assegnata
gi dal suo stretto rapporto col Protreplico al decennio
fra il 350 e il340, ben naturale che in esso possa essere
utilizzata solo la prima Etica. Nel cap. 13 del libro H,
per esempio, riprodotto da esBa un passo abbastanza
ampio circa il giusto rapporto del mezzo con lo scopo
2).
7-
Secondo quanto tutti concedono, la Nicomachea non pu
qui essere considerata quale fonte. Ma neppure lecito
far risalire alla Politica, quale fonte primaria, queste
tesi puramente etiche, che nell' Eudemea si presentano
nel loro originario contesto di pensiero mentre nella
*
Politica appaiono applicate ad hoc, soltanto di paesag-
'} J1 Bendixen (in Philologus, XI, 1856, p. 575 segg.) richiam t
per primo l'attenzione, contro l'attribuzione dell' Eudemea ad Eu- ,|
demo compiuta dallo Spengel, su una serie di luoghi nei quali la |
Politica coincideva in modo sorprendente con l'Eudemea. Da ci
egli non ebbe per il coraggio d' inferire l'insostenibilit dell'afe- "j
tesi dello Spengel. IlVon dcr Miilill, nella citata sua dissertazione
goltingense (1909, p. 19) metteva nuovamente in discussione le os
servazioni del Bendixen, senza peraltro riprendere particolarmente ')
l'indagine da esse iniziata. Ora che la paternit arietotelica del- i
l'Eudemea stata da noi, per altra via, provata con sufficiente cer- :
tezza, e la sua genesi assegnata al periodo della reazione critica di
Aristotele a Platone, il materiale raccolto dal Bendixen esige una
valutazione nuova.
*) Pol., H 13, 1331b26, e cfr. Eth. Sud., B II,1227 b 19. Circa
il fatto in s della derivazione del passo della Politica da quello
dell' Etica nessun dubbio pu sussistere, perch questo stesso capi-
7
tolo si richiama altre due volte, in modo esplicito, agli tfOuol Xro'
(1332 a 8, 21).
'
LA PRIMA POLITICA 383
gio. Parimenti improbabile l'ipotesi che Aristotele
abbia per caso, o per
ricordo, formulato con le stesse
parole la medesima argomentazione in due passi indi
pendenti 1' uno dall' altro. Questa spiegazione esclusa
in quanto
s' incontrano ancora molte altre simili coin
cidenze con 1' Eudemea, le quali, con le loro particola-
rit talora assolutamente
caratteristiche, dimostrano tutte
lo stesso fatto, e cio che Aristotele nella stesura della
parte
pi antica della Politica ha avuto sotto gli occhi,
e ha citato in molti punti, 1' Eudemea. Una prova
deci
siva della giustezza di questa
interpretazione costituita
'
dal fatto che questi singolari prestiti si riferiscono solo
ai libri pi antichi della Politica, cio alle parti perti
nenti al disegno dello stato ideale1). Come la posteriore
redazione della Politica e l'Etica Nicomachea, cos la
prima politica e la prima etica sono sorte in stretta re
lazione reciproca.
Nello stesso cap. 13 la prima etica utilizzata ancora
pi volte : il passo 1332 a 8 troppo generico per trarne
conclusioni determinate J), mentre ilpasso a 21 segg. pu
*} Nel contesto della nostra ricerca questo il punto decisivo,
al quale finora nessuno ha rivolto 1' attenzione. Ai contatti tra la
Politica e l'Eudemea si fatto sinora ricorso solo per sostenere
1' autenticit di quest' ultima, la quale d' altronde non pu esser pro
vata in maniera indubbia con quel solo argomento. Accanto alle
sorprendenti derivazioni dall'Eiufemea che s' incontrano nei libri B,
H e anche T della Politica, in Pol., A 9, 1257 a 5, e cio in una
parte recente, si trova la stessa distinzione di un duplice significato
del concetto della XP*)0'? he appare in Eth. Enti., 1' 3, 1231b33;
e cos in due passi di , che un libro recente, tornano alcuni
motti proverbiali, che si leggono anche nella prima etica (Bendixen,
1. c., p. 580). Ma questi deboli echi non possiedono, per la loro
stessa natura, vera forza probativa e non possono esser messi sullo
stesso piano delle derivazioni che s' incontrano nei libri B, T e H
della Politica. Sono in parte reminiscenze e in parte, come il chia
rimento circa il duplice significato della xPotC> cose debbono
necessariamente
ripetersi.
*) Si tratta della definizione dell'eudemonia, per la quale Ari
stotele s richiama all' Etica. In s essa potrebbe esser desunta da
Eth. Nic., A 6, 1098 a 16, ma gli altri esempi escludono anche per
questo passo che Aristotele abbia potuto ricorrere alla redazione
i
"i
384 CU ANNI DI VIAGGIO
riferirei soltanto alla prima etica, e non alla Nicomo-
chea, perch la sua formulazione letterale rispecchia
esattamente il passo della prima che le sta alla base, e
nessuno invece le corrisponde nella Nicomachea. Ilpasso
di quest'ultima, che stato citato dagli editori accanto
all'altro, non quadra1)1. Che qui si alluda all' Eudemea
provato tanto dalla citazione 1334 a 40 segg., in cui
la storia, estremamente caratteristica, della concezione
spartana dell' ptvfj riportata dall' Eudemea, 1248 b 37
segg., quanto da quella del libro B, 1271 b 4 segg., che
si riferisce allo etesso passo. La distinzione dell'Cudemea
tra la spuria p&'-fj spartana e quella autentica doveva
acquistare per Aristotele particolare importanza quando
egli poneva le fondamenta del suo stato esemplare. Essa
d' altronde cos inscindibilmente connessa col passo
1332 a 21 segg. che ci basta a dimostrare come tutt' e
tre i passi si richiamino idealmente alla stessa tratta
zione dell' Eudemea. In 1332 a 21 detto: '/al yp
tcto ScwpccTai
y.az
xo? Xyou;, Sii toioOti;
law 6 OTtouSalOj, w Sc
rJjv pet-qv ya& Ioti t jtXf?
ya&, e ci corrisponde a Eth. Eud., 1248 b 26 yaft;
|isv o&v law w i cpuast yafr law yaM. Segue
quindi la giustificazione pi particolare, sulla quale
Aristotele si basa nel passo della Politica. Anche nel
terzo libro della Politica, 1278 b 20 segg., s' incontra
una citazione dalla prima Etica. Accanto a queste di
pendenze dei libri antichi della Politica dal!'Eudemea
nicomachea. Un indizio dato dall' accentuazione della ivipfsta }
*ccl
XP*' Spstijs TS?.sa : inEth. Eud., B l,1219b2 s'incontra i;
infatti questa forma collegata con la definizione dell' eMaipovia.
Nella politica pi antica essa permane come definizione costante:
cfr. II 8, 1328 a 38.
\
*) La dipendenza verbale da Eth. Eud., B 3, 1248 b 26 appare (
subito evidente, mentre la corrispondenza con Eth. Nic.. P 6, 1113 a 4
15 segg. non affatto tale da convincere in modo assoluto. |
LA PRIMA POLITICA 385
non d' altronde possibile segnalare neppure
una trac
cia di presupposizione della Nicomachea.
Un'altra parte dell'antico disegno' dello stato ideale
permette di determinare pi esattamente, da un lato del
lutto diverso, l'et della sua genesi. Si tratta del libro
B ,), che contiene la critica dei precedenti utopisti poli
tici greci e la cui particolare attrattiva costituita dalla
critica mossa da- Aristotele allo stato platonico, di gran
lunga la pi estesa fra tutte. Oltre alle vere e proprie
utopie Aristotele esamina le costituzioni statali esaltate
dai teorici greci del quarto secolo come esemplari
(svopoupevat
TroXiaetac), e cio quella di Sparta e di
Creta, alle quali si aggiunge anche quella di Cartagine.
Nella loro forma odierna, questi capitoli sono stati
scritti non molto dopo il 345, perch ilpassaggio a Creta
del capitano di ventura focese Faleco ricordato come
accaduto di recente2). Ma nella loro sostanza essi sono
pi antichi, perch gi ilProtreptico rifiuta nella stessa
') Il libro B nel suo complesso di origine antica: solo il
tanto discusso capitolo finale merita forse un posto a parte anche
dal punto di vista cronologico. Aristotele d qui un catalogo dei
vopofriTat, e riferendosi ad esso determina l'Stov dell'opera legisla
tiva 0 costituzionale di ciascuno 'di essi. Ilnesso del brano col libro
che precede sempre stato trovato fiacco. Quando
Io si voglia con
siderare come originariamente destinato al posto che ora occupa,
non si vede pi per qua! motivo si riprenda a trattare di Platone
e di Falea. Il Wilamowitz (Aristoielcs und Athen, I, p. 64 segg.)
considera perci spurio il passo 1274b9
15. Ma il catalogo dei
legislatori ha avuto senza dubbio una genesi indipendente ed
stato, come ho dimostrato in EnUtehungsgesch. d. Metaph., p. 45,
aggiunto pi tardi al libro. La tendenza a raccogliere tutti isingoli
casi rintracciabili e il metodo della ricerca degli tS:a fanno pensare
che esso sia da ascrivere all' ultimo periodo dell'attivit
aristotelica,
quando metodi
analoghi venivano applicati nel campo della storia
naturale. nota l' importanza clic ha avuta la ricerca
degli ttoi
per la scienza dell'et ellenistica, p. es.
nell'etnografia.
*) Pol.. B 10, 1272b 20, dove nXepo? avt*6; significa, nono-
stante il contrario parere del Newman (1. e-, II, p. 360) la guerra
dei mercenari, e non la guerra estera (cos gi il Fulleborn e
1* Oncken).
Quest'ultimo
significato appartiene a una fase pi tarda
dell' evoluzione
linguistica greca.
25.
W. .Takoee, Aristotele.
336 CM ANNI DI VIAGGIO
maniera di riconoscere le costituzioni di Creta e di Sparta
o di altre di tal genere come esemplari. Col si
allude ad esse con l'espressione di v&pumvat iroXiTSica,
dalla cui imitazione non pu mai risultare altro clie
opera umana, e non qualcosa di divino e di duraturo1).
Anche pt:r quel che concerne il complesso di dati qui
utilizzato da Aristotele, difficile ohe esso sia stato rac
colto solo quando Aristotele si trovava ad Asso e ai Mi
ritene, e dev'essere bens stato messo insieme gi nei
tempi in cui Platone lavorava alle Leggi e le norme
costituzionali di Sparta e di Creta erano volentieri di
scusse nell' Accademia. Le nuovo conoscenze acquisite
circa Creta si manifestano, subito dopo la pubblicazione
delle Storie di Eforo, contemporaneamente nel libro B
della'Politica e nel dialogo pseudoplatonico Minosse, la
cui genesi non dovrebbe esser molto posteriore alla morte
di Platone2).
Quanto
alla costituzione cartaginese, non
sappiamo quale autore abbia servito ad Aristotele come
fonte delle sue conoscenze; ma in ogni caso anch'essa
stata studiata da lui gi molto tempo prima che avesse
J) Jambl., Protr., p. 55, 17.
s) La vecchia controversia circa la dipendenza di Aristotele da
Eforo o viceversa a proposito della tradizione concernente Creta
non pu esser risolta con piena certezza. Che Eforo si eia valso
della descrizione aristotelica della costituzione cretese naturalmente
escluso data l'assai pi tarda redazione della silloge delle iroXvtEtai,
giacch 1' opera di Eforo era gi nota a Callistene, il quale and
in Asia con Alessandro nel 334 (cfr. Wiamowtz, Aristoteles und
Athen, I, p. 305). All'idea, invece, che Aristotele abbia, tra il 345
e il 340, utilizzato Eforo anche nella critica delle condizioni in cui
si trovava Creta (Pol., B 10) nulla in se osta, tanto dal punto di
vista cronologico quanto da quello del contenuto, giacch allora
Aristotele era ancora lontano dal metodo di ricerca erudita proprio
del suo ultimo periodo. Tuttavia in H 34, 1333 b 18 egli parla gi
dello scritto di Tibrone sullo stato spartano e di tcv SUwv Ixgcots?
tv fpafyzwi tioI ncXvtsfxg air <3
'
non quindi escluso che
anche per Creta egli si sia valso di fonti locali. Certo, il tipo meto
dologico delle conclusioni a proposito di Creta tanto simile in
Eforo e in Aristotele, e tanto moderno, che si preferisce pensare
che loro autore s>a piuttosto uno storico come Eforo.
I.A PRIMA POLITICA 387
luogo la raccolta delle costituzioni. Inquesto lavoro cri
terio determinante era il concetto della norma ideale:
come nel Protneptieo, anche qui quel che gl'importava
era di mostrare come lo stato perfetto non s'incontrasse
mai nella- realt. Ilconcetto deli' Spoc, ohe nell'Etica
pi tarda perde d'importanza e di cui riscontrammo in
vece l'influenza nella prima etica, non in alcun luogo
applicato con tanta coerenza logica come nella politica
dello stato ideale, che anche per ci viene a ravvicinarsi
cronologicamente all' Eudemea1).
La critica dello stato platonico, cos importante per
la conoscenza del contrasto che distingueva dalla natura
di Platone quella di Aristotele, invirt della sua libert
da ogni formulazione astrattamente gnoseologica, era
certo gi pronta, -al pari delle parti principali del dise
gno dello stato ideale, quando uscirono leLeggi, al tempo
del soggiorno di Aristotele ad Asso. Ma il saggio aristo
telico fu
portato at termine solo sotto l'immediata im
pressione dell' opera platonica, avvertibile dappertutto.
La vera e propria critica delle Leggi sembra sia stata
composta piuttosto rapidamente: com' noto, essa con
tiene inesattezze di ogni genere, che fanno pensare ad
una lettura frettolosa. Anche delle Leggi, come della
Repubblica, si trovavano abbondanti estratti nelle carte
lasciate da Aristotele: senza dubbio essi erano stali pre-
') Ancora pochi esempi a questo proposito. In molti passi il
senso della parola 5po- oscilla fra quello di necessaria determina
zione dell'essenza (principio essenziale) e quello di fine normativo.
Nel libro H, che contiene il vero e proprio disegno dello stato
ideale, ho raccolto a tale proposito ipassi 2, 1324b4; 4, 1326a 35-36;
1326 b23; 32; I327 a6; 7, 1327 b 19; 13, 1331b 36 (8po? immediata-
mente sinonimo di oxojtg. tXoc); 15, 1334a 12; anche il termine
oxoitg riappare pi volle: 2, 1324 a 34; 13, 1331b27; 31; 14, 1333
b3; 13. Ma anche ilibri B, T e 9 fanno spesso uso di questo
concetto della norma, che dal Bonitz (Index Aristotelicus, s. v.
Spo?1 non stato preso adeguatamente in considerazione tra ivari
significati della parola: cfr. B 6, 1265 a 32; 7, 1267 a 29; 9, 1271a 35;
r 9, 1280 a 7; 13, 1283 b 28; 6 7, 1312 b33 (cfr. anche 6, 1341b 15).
3S8 CU ANNI DI VIAGCIO
parati a scopo critico. Ma per un'esauriente valutazione
delie Leggi mancava ora, ad Aristotele, la pazienza: ad
esse egli opponeva ormai un'opinione alquanto precon
cetta, e pensava di trovarsi gi in una posizione troppo
avanzata per dover pi ascollare con calma la loro voce.
Era consapevole, nonostante le molte coincidenze nel
particolare, della diversit del principio da lui seguito
a paragone di quello platonico. L'energico realismo delle
Leggi lo costrinse perci tanto pi spesso a osservazioni
singole, naturalmente critiche per la massima parte.
Anche la cifra della popolazione proposta ora da Pla
tone (x vv eiprjpvov Xijftos), dice p. es. Aristotele, esi
gerebbe, non c' da illudersi in proposito, un territorio
come quello di Babilonia o un altro paese di estensione
colossale, ohe fosse in grado di nutrire 5000 nullafacenti,
ai quali si aggiungerebbe una folla, pi volte multipla,
di donne e di servi1). Il giudizio complessivo suona:
come tutto quel che dice Platone, anche questo pieno
di spirito, ha sapore rivoluzionario ed agita iproblemi;
ma, che sia giusto, un'altra questione.
Un'obbiezionecaratteristica contro le costruzioni pla
toniche dello stato quella riferentesi al mancato suo
riguardo alla situazione politica estera. Platone edifica
il suo stato nello spazio vuoto : astrae dai contrasti bru
tali della realt politica o, quel che peggio, non pensa
loro affatto. Certo, idea intelligente e realisticamente
pensata quella che Platone esprime quando dice ohe il
legislatore deve sempre aver l'occhio a due cose, al
paese e agli uomini. Ma dove restano ipaesi finitimi?
Dall'esistenza di questi ultimi e dall'impossibilit di una
ideale esistenza in isolamento indisturbato, impossibilit
che sussiste non soltanto per l'individuo nello 6tato ma
parimenti per lo stato nella comunit degli stati, deriva
J) Pol, B 6, 1265 a 13.
LA PRIMA POLITICA 389
la necessit dell'attrezzatura militare, la quale deve con
formarsi oon soltanto alle condizioni del paese proprio,
ma anche allo stato dei paesi esteri1). Lo stato deve to
gliere a tutte le altre potenze il gusto di assalirlo, e non
soltanto, come Platone esige, opporsi valorosamente al
nemico in caso d'invasione. D'accordo con Platone, Ari
stotele esclude nel modo pi netto che si debba glorifi
care la potenza e il dominio come ultimi scopi dello
stato, educare il' popolo esclusivamente alla guerra e
orientare unilateralmente lo spirito dello stalo verso
quest'unica forma di estrinsecazione di energia. Ma pi
caratteristiche per Aristotele sono le novit che egli ag
giunge. La considerazione della politica estera attrae lo
stato nel conflitto di forze costituito dai contrastanti in
teressi dei1 popoli e gl'imprim facilmente un orienta
mento diverso da quello che risulterebbe dalla sua fina
lit etica.
chiaro che a- questa mutazione d'idee il platonico
Aristotele non stato condotto da riflessioni teoretiche
ma da un personale contatto con l' effettiva politica
estera. per difficile che le tempestose orazioni di
Demostene, le quali ebbero inizio prima della partenza
di Aristotele da Atene, abbiano avuto efficacia, in questo
senso, su uno spirito come il suo. Dovette invece essere
il continuo contatto con un politico d'azione come Er-
mia di Atarneo a dare nuovo impulso al suo pensiero
politico, nello stesso modo in cui egli aveva a sua volta
convinto Ermia della necessit di seguire nella politica
finalit etiche. Ilsaggio aristotelico sullo stato ideale
stato compiuto ad Asso e nel tempo
immediatamente
posteriore.
Nessuno stato greco di quell'et era pi dipendente
dai
Y6L~vtG>v'CS
ltto: di quanto fosse quello di Ermia:
') Pol., B 6, 1265 a 18 segg.
390 OLI ANNI DI VIACGIO
il suo labile equilibrio ira l'energica invadenza dello
slato militare di Filippo dal lato europeo dell'Ellesponto
e la gelosia di predominio dell' impero persiano sulla
costa asiatica esigeva un'attenzione continuamente vigile.
sorprendente come l'idea non platonica della neces
sit degli armamenti, e con essa iltimore per il vicinato
di potenti avversari, compenetri l'intero eaggio aristo
telico1). In un passo interessante Aristotele combatte
l'idea, caratteristicamente spartana, di Platone che le
citt non dovessero essere fortificate2). Inconsiderazione
della moderna tecnica ossidionale e dei ritrovati della
nuova artiglieria egli dichiara quell'idea un pregiudizio
vecchio stile, che poteva essere giustificato solo dove non
si avevano attorno, come nella vecchia Sparta, che ne
mici pi deboli, manonnei casi incui si dovevano fron
teggiare avversari di schiacciente preponderanza. Ci
corrisponde alla situazione di Ermia, che aveva appunto
fortificato solidamente Atameo, e che pi tardi fu effet
tivamente assediato senza successo dai Persiani. Ora, a
un assedio di Atarneo fa esplicito accenno l'altro passo
sopra citato8).
Qui, evidentemente, ha servito di fonte
lo stesso Ermia. Dopo aver contestato al disegno dello
stato esposto da Falea e a quello platonico la mancata
considerazione delle esigenze di un' energica politica
estera e di un armamento militare, Aristotele esige anche
per la politica interna, alla quale si rivolge purtroppo
in maniera troppo esclusiva l'interesse della maggior
parte dei teorici dello stato ideale, un continuo accordo
con la direzione degli affari esteri. Soprattutto dev'es
sere evitato l'accumulamento di un possesso che per la
sua grandezza' ecciti all'assalto nemici pi potenti, e
che non possa esser difeso dai suoi possessori-. La giusta
') Pol, B 7, 1267 a 19; B 9, 3269 a 40; II 31, 1330 b 32.
Pol, H 11, 1330 b 32 sino alla fine del capitolo.
') Pol, B 7, 1267 a 19-37.
LA PRIMA POLITICA 391
norma, a questo riguardo, etata secondo Aristotele de
terminata da Eubulo di Atarneo, il predecessore di Er-
*
mia, che prima era stato banchiere. Egli insegnava- che
t per l'avversario non dovrebbe mai valer la pena d'ini
ziare una guerra a causa di quel pi che si possiede e
che egli potrebbe conquistare.
Quando
il satrapo per
siano Autofradate voleva assediarlo in Atarneo, Eubulo
lo invit a- presentargli un preventivo delle speee del
l'assedio, tenuto conto del tempo che si sarebbe dovuto
preveder necessario per esso. E si dichiar pronto ad
abbandonare Atarneo se egli gli pagasse nient'altro che
queste spese, convincendolo cos del fatto- che esse non
sarebbero state affatto proporzionate al valore del loro
oggetto. Autofradate controll ilconto ed effettivamente
abbandon l'assedio.
Nell'antico abbozzo sullo stato ideale si rispecchia
cos l'ambiente locale di Atameoi. Certo, Aristotele po
teva scrivere con tale spirito su quell' argomento solo
prima che il secondo assedio di Atarneo, operato dallo
stesso temibile avversario, avesse oscurato lo scherzoso
ricordo degli stratagemmi- di Eubulo, lo scaltro vecchio
da cui era andato a scuola Ermia, e con la morte di
quest' ultimo avesse disastrosamente influito sulla sua
; sorte personale e su quella della sua famiglia.
Qui
ci
sembra ancora di ascoltare isuoi colloqui con Ermia,
che sospingeva lo sguardo del platonico, aperto ad ogni
: realt, a scendere dalla sfera- degli ideali a quella dei
fatti. Con gli sforzi- di Ermia, che per consiglio dei filo
sofi di Asso aveva mutato spontaneamente
la- sua- tiran
nide in una costituzione pi moderata, coincide l'alta
!
valutazione che lo scritto aristotelico sullo stato ideale
d di questa
forma di stato, e parimenti la sua voluta
limitazione a una citt di ampiezza e territorio non
|i troppo grandi.
.,..
:| Ancora una parola, infine, per caratterizzare il me-
392 GLI ANNI DI VIAGGIO LA PRIMA POLITICA
393
todo seguito da Aristotele nel tratteggiare il suo stato
ideale. A fondamento di quest'ultimo sta il famoso si
stema delle sei costituzioni, contenuto nel libro T, e cio
la partizione delle possibili forme costituzionali in tre
giuste e tre degenerate (;iapex(3a<jets).
Questa
forma nor
mativa di considerazione attintada Aristotele alle opere
politiche del suo periodo accademico, a cui egli si ri
chiama esplicitamente nel passo in cui espone ilsistema
delle sei costituzioni. Icapp. 6 e 7 del terzo libro non
ne sono, nella sostanza, che un estratto.
Qui scorgiamo
ancora, in modo particolarmente chiaro, il processo evo
lutivo. Nelle parti pi tarde della Repubblica Platone
aveva caratterizzato itipi di coetituzionc, e ci l'aveva
pi tardi condotto, nel Politico, a dedurre uno schema
concettualmente sistematico delle forme statali giuste e
di quelle normali. Il motivo metodico e architettonico
proprio della personalit di Aristotele fece s che egli
dovesse riconnettersi al maestro proprio inquesto punto.
A ci si aggiunse il fatto che il Politico era apparso
quando egli era ancora membro dell'Accademia, e alla
sua genesi egli aveva idealmente partecipato nell' et "
pi aperta agli influssi intellettuali. La sua discussione
della teoria platonica dello stato verte perci principal
mente intorno a quest'opera, per quanto sembri che fin
da principio egli abbia accentuato il momento econo
mico e sociale delle diverse forme di stato pi forte
mente che le note formali della divisione logica. L'in
flusso esercitato dal metodo deduttivo e concettualmente
costruttivo del Politico si manifesta soprattutto nel fatto
che Aristotele non fa nascer senz'altro dal nulla il suo
stato ideale, come Platone nella Repubblica e nelle
Leggi, ma lo ricava da una completa valutazione siste
matica delle
costituzioni. Con ci egli reca nella que
stione dell'ottimo stato il rigore apodittico che neces-
sario alla sua essenza, nella misura in cui la materia Io
.{j
concede. Dappertutto egli mira a concetti precisi1). La
struttura del suo stato ideale armatura logica, costru
zione concettuale, rigida riduzione dello st-ato ai con
cetti ed elementi fondamentali. La discussione singola,
condotta con spirito intuitivo-rea!6tico, che d alle Leggi
il loro movimento e la loro energia, gl'interessa poco.
Si veda la trattazione di un punto cos importante come
quello del territorio e della popolazione contenuta nel
settimo libro, in cui data quasi soltanto una nuda
enumerazione delle diverse esigenze necessarie, o il ca
pitolo, sommariamente delineato, che concerne le con
dizioni sine qua non (>v ox vsu) dell'esistenza dello
stato5). L'autonoma genialit creativa, dominante nel
legiferare platonico, diventa in Aristotele deduzione
scientifica condotta con rigorosa coerenza sulla base
delle sue premesse: deduzione che resta pienamente pla
tonica solo nell'unica idea che lo scopo generale della
trattazione costituito dalla conoscenza dell'incondizio
nata norma ideale a cui deve obbedire ogni stato.
La costruzione concettuale vien delineala tenendo
d'occhio 1* esperienza, con l'intento di ottenerne con
ferma; tuttavia il suo metodo resta affatto diverso da
quello empirico proprio dei libri posteriori, contenenti
la pura morfologia dello stato reale. Tale costruzione
') In questa eostruzione del sistema ideale delle costituzioni
ciascuna di esse un concetto fisso, e ancora lontanissima l'idea,
propria dei libri seriori della Politica, che possano esserci parecchie
e assai differenti specie dell' oli garclua e della democrazia, a seconda
della costituzione e della combinazione delle diverse parli dello stato.
Per questo motivo non verosimile che l'esposizione delle varie
forme del dominio regio nella parie finale del libro I' appartenga
al vecchio T cio al saggio sullo slato ideale composto nel decen
nio tra il 350 e il 340, tanto pi che di essa si tien conto anche
in . Un'analisi pi minuta dovrebbe stabilire in che modo Ari
stotele, compiuta l'inserzione dei libri A-Z, abbia pensato che do
vesse attuarsi il passaggio da T a A, e in qual misura la fine di T
sia stata da lui rielaborata a tale scopo.
') Poi, Il 4,
1320 a 5 c II 8, 1328 b 2 segg.
394 GLI ANNI DI VIACCIO
precedente a quest'ultima non soltanto nel senso per cui
il tutto preoede la parte e iltfXog la via' che ad esso
conduce, ma anche in quello che essa costituisce, dal
punto di vista dell'evoluzione tanto problematica quanto
biografica, uno stadio pi antico e meno inarcato della
teoria aristotelica dello 6tato, la cui particolarit e il
cui merito risiedono principalmente, oltre che inmolte
famose tesi singole, nel consapevole metodo di dedu
zione. Lamassima energia creatrice di Aristotele, ilcon
creto senso della forma e "attitudine a scorgere nella
viva vicenda delle cose il mobile eidos, si trova piena
mente sviluppata solo nell' ultimo periodo della sua
evoluzione, in feconda lotta con la materia indetermi
nata dei singoli fenomeni. Ma allora' laforma e ilquadro
generale della1 sua politica eran gi da- lungo tempo
costituiti, e l'elemento nuovo doveva adattarsi ad esso,
anche giungendo quasi a spezzarlo. Non c' quindi da
meravigliarsi se i posteri non si sentirono legati alla
sintesi aristotelica, e adoperarono ciascuno secondo la
propria posizione quel che a loro conveniva. Con tutto
ci non davvero giusta valutazione dell'opera di Ari
stotele quella che ha luogo, tanto di frequente, quando
l'empirico non attinge all'ideale costruzione politica o
etica dello Stagirita nient'altro che la massa del conte
nuto sperimentale, o quando, d'altro lato, ilseguace della
concezione normativa della politica crede di
potersene
valere come di manifestazione di second'ordine insoste
gno del tipo platonico dello stato ideale. La grandezza,
la novit e la comprensivit di Aristotele consistono
nella sintesi del motivo della norma, che lo conduce
alla posizione di un ideale politico nuovo e adeguato
alla realt, oon l'energia del suo senso della forma, do
minante e organizzante la molteplicit dell'effettiva vita
politicai Mentre quest'ultima salva dall'irrigidimento la
tendenza verso la norma assoluta e insegna mille forme
LA PRIMA POLITICA 395
e rimedi della reale vita politica, il rigoroso concetto
dello scopo
ultimo lo difende dal relativismo, a cui tanto
facilmente conduce l'atteggiamento di clii, egualmente
comprendendolo,
si affida a tutto ci che . Da entrambi
ipunti di vista e per l'unificazione di queste due ten
denze, Aristotele in tal modo chiamato a preludere,
inmodo esemplare, alla filosofia e alla scienza dello spi
rito dell'et moderna.
VII.
GENESI DELLA FISICA E COSMOLOGIA
j
SPECULATIVE
,'i
.4
S
Per le opere di scienza naturale scritte da Aristotele
sensibilmente pi difficile il compito di arrivare a in- :
tendere l'evoluzione delle sue vedute, di quanto sia per
quelle in stretto senso filosofiche. Anche la pi pene- S
trante
indagine circa la composizione di questi scritti,
e il confronto di tutte le loro particolarit, non potr
rimediare al danno che ci colpisce in quanto non siamo
in grado di dire che poche cose della particolare evolu
zione del suo pensiero scientifico, pur potendo asserire
con piena certezza che per l'intensit delle sue ricerche
egli ha forse compiuto iprogressi pi sorprendenti pro
prio in
questo campo e che proprio in questo, assai pi
ancora che negli altri, egli dovrebbe esser compreso in
funzione del suo processo evolutivo, quando lo si vo
lesse intendere nella sua pi peculiare natura. Non si
pu assolutamente dire che qui potrebbe comunque trat
tarsi della conoscenza di particolarit d'importanza re
lativamente piccola, cio del progressivo accrescimento
dell'enorme materiale empirico su cui si bas la sua
ricerca e dell'et di composizione di quella casuale forma
di stesura delle sue lezioni, che ci e rimasta. Su impor
tanti divergenze di teoria fisica che distinguono il dia-
I. \
CENF.SI DELLA FISICA E COSMOLOCJA 397
logo IIspl cpcXooocplas dal De caelo abbiamo gi richia
mata l'attenzione (pag. 202). Osservammo col un pro
gressivo affrancamento dai presupposti di quella inter
pretazione mitica della natura, che ha sempre conti
nuato ad esercitare un energico influsso sullo spirito
greco e che aveva ricevuto unnuovo impulso dalla teoria
platonica delle anime astrali. Constatare pi esattamente,
sulla base di numerosi esempi, questo processo sarebbe
certo del pi alto interesse anche per la storia di Ari
stotele filosofo: l'orientamento del suo pensiero verso
l'immanenza ne verrebbe cliiaramente messo inluce. Gi
la vicenda dei suoi interessamenti per idiversi campi
della natura ci si manifesterebbe in una linea la quale
(per uno spirito come quello di Aristotele possiamo
esserne certi a priori) sarebbe tutt'altro che una connes
sione di momenti accidentali della sua biografia. Pur
troppo non abbiamo finora raggiunto tale capacit di
sguardo, e perci ci limitiamo, qui, a quello che ci si
venuto chiarendo nella via finora percorsa.
Anzitutto bisogna mettere in guardia contro itenta
tivi, compiuti a sempre nuove riprese, di determinare la
successione cronologica delle opere di scienza naturale
inbase ai rinvii, inesse contenuti, a quel che segue e a
quel che precede. Tali citazioni hanno valore di cri
terio cronologico solo quando sono reciprocamente con
trastanti o contraddicono al pianocomplessivo di un'ope
ra, queste
contraddizioni aggiungendosi inoltre come
elemento integrativo ad altre osservazioni concernenti il
contenuto. Ora, negli scritti di fisica s'incontra un ser
rato sistema di rinvii, sul quale ancora lo Zeller credeva
di poter costruire la sua ipolesi circa la successione cro
nologica della loro
redazione1). La Fisica poi prevista
') Zeller, Phlosophie der Griecben, II, 2, 3' ed., p. 158; e
efr. L. Spengel, Ueber die Rcihcrtjolge der naturwissenschajtlichen
SchriRcn
des
Aristote.lcs, in Abhandlungen d. Miinchener Akade-
mie, V, p. 150 segg.
398
CU ANNI III viaggio
nell'Analitica: essa non era quindi ancor compiuta al
tempo in cui quest'ultima fu scritta, mentre nella Me
tafisica
e nell'Etico, come nella maggior parte degli altri
scritti' di scienza naturale, essa citata o
presupposta.
Da ci si trae la conclusione clie essa sia stata
composta
;;
tra l'Analitica da un lato e la Metafisica, l'Etica, ecc. ,
dall'altro, risultando questa illazione confermata anche
%
dal fatto che essa etessa non cita n
presuppone alcuna
S
di queste ultimeopere. Lasuccessione
cronologica riau.1-
* terebbe con ci
rappresentata dalla serie: Fisica, De ,
|
caelo, De generatione et corruptione, Meteorologia.
Que-
|
d'ordine sembra confermato anche dalla Meteorologia,
"!
che enumera quegli scritti, come precedenti, nello stesso
ordine1).
Dalle ulteriori illazioni concernenti la Storia v
degli animali, lo scritto SulVanima e le altre
opere sulla
natura organica possiamo per ora prescindere. Ora, ci
troviamo qui di fronte a uno di quei radicati frainten
dimenti, al cui
ineliminabile influsso dovuto il fatto
che per lo pi si sia creduto a priori di poter rinunciare
a una pi precsa ricerca della successione
cronologica.
Quel che 9t ottiene in tal modo , nel migliore dei casi,
solo la successione prevista dallo stesso Aristotele, al
termine della sua attivit letteraria, dal punto di vieta
pedagogico e contenutistico, e non mai invece una no
zione del suo processo evolutivo o anche soltanto della
successione dei singoli scritti
quanto alla loro stesura.
Come da una menzione dell'Etica nella Politica o della
Politica
nell'Etica o dell'Etica nella
Metafisica
non pu
mai esser dedotta la priorit dello scritto citato o del
suo contenuto, quando nonsi
sottopone ad accurata in
dagine la maniera in cui Io scritto adoperato e la
forma della citazione e non si prende in
considerazione
la possibilit che venga citata una redazione pi antica
')
Meteor., A 1, 338 a 20.
GENESI DELLA FISICA E COSMOLOGIA 399
o pi recente di quella superstite, cos non lecito fon
dare un edificio cronologico sulla serie di citazioni che
s'incontra negli scritti fisici. Il presunto ordinamento
cronologico nonrappresenta nient'altro che ilpianocom
plessivo (forse niente affatto originario), nel cui quadro
Aristotele, al termine del suo lavoro di ricerca, ha po
stumamente costretto la massa delle sue singole indagini.
Essa coincide infatti anche con la successione delle opere
qual' attestata dalla migliore tradizione manoscritta1) :
e che questa si riferisca al contenuto e non all'et d'ori
gine degli scritti stessi non stato messo mai1 in dubbio
da nessuno. necessario guardarsi da questo evidente
scambio del Ttptepov genetico con quello sistematico,
come anche dalla parificazione del momento cronolo
gico della stesura letteraria di una concezione con quello
della 6ua genesi nello spirito del filosofo.
In altri tempi tener presente tutto ci avrebbe avuto
unvalore puramente teorico, essendo sconosciuta lastessa
et di composizione della Metafisica, dell'Erica, ecc., e
tutti gli scritti superstiti venendo ascritti infolla, secondo
l'opinione corrente, all'ultimo periodo della vita di Ari
stotele. La situazione mutata dopo le indagini com
piute nei capitoli precedenti. Perci importante ab
bandonare quel modo di procedere, che non ha suscitato
per tanto tempo alcun contrasto solo perch era prati
camente inapplicabile. D'altra parte non si pu fare to
talmente a meno delle citazioni degli scritti fisici nelle
altre opere perch, dato il genere della materia, gl'in
dizi cronologici mancano del tutto o quasi del tutto e
') Sulle pi minute particolarit di questo ordinamento dida
scalico, cfr., per quel che concerne gli scritti di antropologia e
scienza della natura organica che seguono alla Meteorologia, il
mio articolo Dos Pnenma im Lykeion (in Hermes, XLVili, p. 38).
Sulla successione dei singoli scritti nei codici cfr. la mia edizione
del de an. mot. et de an. inc., p. Vili.
400 CLI ANNI DI VIACC10
l'evoluzione del metodo non appare distinta da cosi
nette soluzioni di continuit, quale per esempio , nel
campo dell'etica e della metafsica, l'abbandono del pia-
.!(
toniamo. Perci, quando abbiamo bisogno di tali atte-
:
f
stazioni, dobbiamo anzitutto esaminarle accuratamente.
\
Tra tutte le citazioni che si riferiscono alla Fisica
f
solo un gruppo di esse possiede effettiva importanza ero-
j
nologica, e cio quelle contenute nelle paiti pi antiche a
della
Metafisica.
Dimostrammo gi come illibroA della ;
Metafisica
sia stato scritto poco tempo dopo la morte
$
di Platone, inun'epoca nella quale Aristotele era ancora
platonico. Per la dottrina teleologica dei- quattro prin-
cip, che Aristotele pone a fondamento della metafisica,
questo' libro, in luogo di dimostrare ulteriormente la
completezza di tale partizione, si richiama alle tratta
zioni della Fisica. Non si tratta di una singola citazione,
facilmente eliminabile dal suo contesto e che quindi
potrebbe essere stata aggiunta pi tardi, ma di un'intera
serie di passi, incui Aristotele torna sempre ad asserire
il fatto che la rassegna delle dottrine dei precedenti
pensatori si manifesta da cima a fondo quale una con
ferma storica della teoria delle quattro .pya.1 costruita
nella Fisica1). Tutto il primo libro della
Metafisica
si
basa 6U questo presupposto, e rimarrebbe privo di ogni
consistenza interiore se la teoria delle cause formulata
dalla Fisica non fosse sottintesa in ciascuna delle sue
righe. Con ci inconfutabilmente provato che non sol
tanto ilsecondo libro della Fisica, incui Bvolta questa
dottrina dei principi, ma una completa serie di inda
gini, che vennero raccolte sotto il concetto generale di
'SUCLY., sussisteva gi intorno al 347.
Questo
inoltre
confermato, oltre che dalle singole testimonianze della
') Metaph., A. 3, 983 a 33; 7, 988 a 21; b 16; 8. 989 a24: 10,
993 a 11.
GENESI DELLA FISICA E COSMOLOGIA 401
Metafisica1), soprattutto dalla stessa struttura comples
siva di quest'ultima, presupponendo essa, in tutta la sua
concezione filosofica, la Fisica e nascendo da essa. Ap
partengono alla Fisica due tesi fondamentali dell'aristo
telica prima filosofia , ed anzi le pi importanti fra
tutte: la distinzione di materia e forma e la' teoria del
movimento. Da queste due premesse Aristotele deduce
la necessit del primo motore, ed anche ilbinomio con
cettuale che congiunge ilmoto con la materia e la forma,
quello della potenza e dell'entelechia, ha il suo domi
cilio nella
fisica
L'idea d questa spiegazione teleologica
della natura e la sua esposizione nella fisica nata nel
l'ambiente dell'Accademia, ancora sotto gli ocelli di Pla
tone. Dall'et pi tarda dell'evoluzione aristotelica essa
dev'esser quindi trasferita al suo periodo pi antico2).
Questa
conclusione non per senz'altro valida anche
per la redazione letteraria della Fisica, che oggi posse-
') Tra irichiami della
Metafisica
alla Fisica ipi importanti
per il nostro problema sono naturalmente quelli contenuti negli
strati che si posson dimostrare pi arcaici: p. es. quello che s'in
contra sul principio della pi antica indagine sulla realt del
soprasensibile (M 9, 1086 a 23), e, nel suo complesso, l'esposizione
dei concetti fondamentali della fsica data nei primi cinque capitoli
del libro A.
')
Quando A. Gercfce (in Pauly-Wissowa, Realenzycl. d. klass
Allert., II, col. 1045, 38 s. v. Aristoteles) assegna la Fisica, o al
meno il6uo compimento, a un'et posteriore alla fondazione delia
scuola, e cio all'ultimo periodo della vita di Aristotele, la colpa
solo della sua fretta. Infatti l'uccisione del re Filippo non
per nulla menzionata nel passo della Fisica, II, 23 (sic) citato dai
Gcrcke, anzi questo passo non esiste affatto, ed egli ha scambiato
la Fisica con la Retorica, che in B 29 ricorda Filippo, contami
nando poi ancora questa menzione col noto passo della Politica
(E 10, 1811b2) sulla morte di Filippo. Segnalo questo solo per
ch esso pu, data l'autorit dell'opera in cui si legge, indurre ili
errore parecchi lettori. In s, del resto, giusto che l'odierna
redazione della Fisica appartenga solo all'ultimo periodo, ma gii
argomenti arrecati dal Gercke non lo dimostrano
'(anche il fatto
che la Fisica sia stata composta dopo l'Analitica non pu valere
come prova di una cos tarda sua
genesi), e inoltre questo dato
di fatto concernente l'ultima redazione non contribuisce affatto
all'ulteriore conoscenza dell'evoluzione filosofica di Aristotele.
26.
W. Jaeger, Aristotele,
402 cr.l AVNI DI VIAGGIO
diamo, in tutta la sua estensione. Per questa compre
senza di antico e di recente, clie inessa s'incontra, essa
non si distingue dagli altri scritti aristotelici. Illibro H
p. es. non stato messo da Aristotele al posto che ora
occupa, coincidendo troppo da vicino nel contenuto con
le altre parti della Fisica, che accanto ad esso trattano
ancora del problema del movimento1). pi che vero
simile che esso faccia parte del nucleo antichissimo della
Fisica, e sia nato in un'et in cui Aristotele non con
siderava ancora la dottrina delle idee come senz'altro
superata 2). Al pari della
Metafisica
e dell'Etica, anche
*) Nella sua parafrasi della Fisica Eudemo l'aveva tralasciato
(cfr. l'avvertenza preliminare al libro H nel commentario di Sim
plicio, vol. II, p. 103-6 Diels): esso quindi non apparteneva al
complesso che recava il titolo di Fisica e che lo stesso Aristotele
aveva raccolto e lasciato ai suoi scolari, per quanto ci natural
mente non provi che esso fosse addirittura sconosciuto nel Pcri-
pato. Al pari di certi libri della Metafisica, tramandati in- origine
indipendentemente 'dagli altri, esso venne conservato come im
portante documento storico, che peraltro, accanto ai grandi e
comprensivi teoremi (cosi si esprime Simplicio) del libro finale
della Fisica, non aveva praticamente quasi pi significato. Proba
bilmente esso fu incorporato nella Fisica solo quando la devo
zione erudita della generazione di Andronico avverti l'esigenza
di una raccolta completa degli scritti. Le due redazioni in cui
esso conservato furono confrontate tra loro gi da Simplicio,
senza che egli potesse scoprirvi notevoli differenze di contenuto.
Egli rilev peraltro giustamente come le prove arrecate da H in
favore 'del tepttov xivov fossero di livello inferiore a quelle con
tenute in 9 ; e questo sar ben stato il motivo per cui Aristo
tele sostitu H con 6 Cfr. E, Hoffmann, De Aristolelis Pkysico
rum libri septimi origine et auctoritate (D-iss-, Berlino, 1905).
*) Il passo Phys., H 4, 249 b 19-26 c certo difficile e ha biso
gno di essere interpretato. Da Simplicio in poi nessuno ha tentato
di spiegarlo, se si prescinde dalla traduzione del Prantl (Lipsia,
1854, p. 367), il quale non ha capito l'argomentazione. Nel quarto
capitolo Aristotele mostra l'incommensurabilit delle diverse spe
cie di movimento, p. es. della mutazione qualitativa (iXXoEtooi?)
e della traslazione (fop). Il concetto dell'eguaglianza di velocit
tijsota/;) applicabile solo a movimenti omogenei c commen
surabili. P, es. possono confrontarsi tra loro -moti qualitativi o
moti quantitativi. Nel primo caso si parla 'di una 6|ioiTi)g o
vopoittjs delle mutazioni qualitative, nel secondo di una toxv);
O Svtoixrj; dei movimenti quantitativi. 'L' viofixij; deriva dal
(ietov 1] SXxvxov dei movimenti quantitativi confrontati fra loro,
CENESt DET.I.A FISICA F COSMOl.OCIA 403
la Fisica sorta dalla sintesi di almeno- due parti, eia
scuna delle quali era costituita a sua volta di pi trat
tazioni.
Queste
due parti, Sui principi e Sul movimento
vengono sempre tenute accuratamente distinte non sol
tanto negli scritti Sul cielo e Sulla genesi e distruzione
ma anche nell'ultimo libro della Fisica (0).
Quest'ultimo
sta al di fuori della Fisica, citando passi di entrambe le
parti con la formula come abbiamo dimostrato in pre-
l'
vofiotiris
dal jsSXXov ?) fiov delle due mutazioni qualitative con
frontate. Un'altra specie di movimento quella che concernel'oaiae
non soltanto la qualit o la quantit: cio la -j-iveotg e la 9-opi.
Si possono paragonare due Ysvoeij quanto alla loro pari velocit
solo nel caso che si tratti di dne iposiSi;, per es. uomini. Ma al
linguaggio manca una- categoria che significhi pienamente la spe
cie della differenza onde si distinguono due Ysvfosig, e Aristo
tele si scusa se deve perci ricorrere alla pallida e generica espres
sione di IrspT-ijf, e se neppure in grado di citare un binomio
concettuale di opposti die come jiXXov xal vtov nelle muta
zioni qualitative e (isov xal IXattov nelle traslazioni renda
evidente come in questo caso non si tratti n di differenze inten
sive n di differenze estensive, ma di qualcosa di diverso dalie
une e dalle altre. Segue ora la nota importante ai fini della da
tazione: se l'o&aia della cui ysvsaig si tratta un numero (come
opinavano l'Accademia e Platone), la differenza d movimento
nella Yveatj di "due ostai da considerare come la differenza
aritmetica di due numeri omogenei riguardo al itXov i)
IXa-cxov. Ma una designazione comune della differenza di movi
mento non c'. La frase finale corrotta, ma il suo significato
evidentemente quello che non c'c neppure una denominazione
delle due -|-evcsts confrontate tra loro la quale corrisponda alle
espressioni pSXXov xal ijixov e pstov xat Xcirtov. Che le
o&sfai le cui genesi vengono messe a confronto debbano essere
omogenee, conseguenza di tutta l'argomentazione del quarto ca
pitolo: ma che significa questa esigenza nel caso dei numeri?
Dobbiamo ricordare che una delle principali difficolt della teo
ria dei numeri ideali era costituita, secondo Metapk., M 7, 1080b
37 segg., dalla questione se le monadi, di cui erano composti i
numeri ideali, fossero senz'altro commensurabili come quelle
dell'aritmetica, o se ogni trpxoc ptO-pj (la prima diade, triade,
tetrade ecc.) fosse costituita di -mona-di di satura
speciale caso
per caso, e quindi solo nell'ambito di un dato numero le monadi
fossero oojigXrj-caC e 6fiosi5st; (per questa espressione v. A 9,
991 b 24). La parola SjioeiSi-js dimostra dunque come nel nostro
passo Aristotele prospetti ancora la possibilit che l'o&ola sia
un numero, possibilit che egli altrimenti combatte. Considerata
la cosa in si e per s, si potrebbe infatti pensare che si trattasse
404 CLI ANNI DI VIACCIO
l'
cedenza nella Fisica1). A somiglianza dei libri Sulla
sostanza e sull'esiere, anch'essi
appunto originariamente
estranei, cio precedenti al complesso totale della Meta
fisica, esso costituiva certo uno di quei brani assegnati da
Aristotele per met alla fisica e per met alla metafisica,
che rendevano possibile il trapasso dalla prima alla se
conda4). La posizione cronologica del libro pu esser
determinata riferendosi alla sua trattazione della teoria
dei motori astrali, la quale iiod ancora formulata in
forma cos decisamente unitaria come nella posteriore
rieaborazione contenuta nel libro della
Metafisica
3).
Tuttavia si pu chiaramente riconoscere come illibro 0
debba servire a giustificare nuovamente, e nel modo pi
accurato, la' teoria del primo motore sul piano della
fisica, e a difenderla da obbiezioni di ogni genere gi
sollevate da parte di astronomi (probabilmente di Cal-
lippo) 4). Risulta quindi abbastanza certa la sua appar
solo di u esempio per rendere pi evidente il significato delle
cose dette, allo stesso modo in cui j>. es. Simplicio (1. c., 1102, 17)
dubita se Aristotele alluda al numero ideale o se per l'interpre
tazione si debba ricorrere soltanto all'idea ebe la natura d'ogni cosa
dipenda da una determinata relazione numerica delie sue parti.
Ma quest'ultima concezione esclusa
dall'esigenza che inumeri
debbano essere omogenei. Non essendo ci intrinsecamente con
cepibile, il passo non pu di conseguenza alludere altro che ai
numeri ideali. Il carattere delle dimostrazioni del libro H che
Simplicio (1. c., 1036, 12) chiama naaxcispaL o pi esattamente,
con Alessandro, oyainepai, si spiega quindi nel miglior modo
in quanto Aristotele le ha, nel corso degli anni, sempre pi com
pletate. l'er un ulteriore indizio dell'antichit del libro H, cfr.
sopra, p. 56 n.
*) Cfr. Bonilz, Index Arist-, 98 a 27.
s) Vedi infatti quel che in Phys., 6 1, 251 a 5 detto a pro
posito dell'eternit del movimento: axsirtsov Ji) xepi
toOtoiy
ttris
lsi- Kp S?yoo o pvov Ttpj -tfjv nsol pOosta; -8-stoptav tSstv
cijv SAS-siav, M xal npj ttjv pfroSov vqv ttsp, xi)g pyrjg
TtpCTl};.
*)
La dimostrazione del fatto che l'ottavo capitolo del libro
A della
Metafisica
e la sua teoria dei motori delle sfere sono il
prodotto di un'aggiunta posteriore sar data nel terzo capitolo della :j[
terza parte. '
J
4| Phys., 6 6.
GENESI DELLA FISICA E COSMOLOGIA 405
tenenza all'epoca dell'insegnamento ateniese. E se per
sino allora (cio in un'et in cui Aristotele non era gi
pi in vita), esso non 'apparteneva ancora alla Fisica,
ci significa che quest'ultima non sussisteva ancora af
fatto come opera complessiva, quale oggi la possediamo.
Con ci concorda il fatto che nella
Metafisica
anche 1
due scritti Sul cielo e Sulla genesi e la distruzione ven
gono citati col nome di Fisica.
Questo
vocabolo dunque
non designava ancora la nostra Fisicaxai' oyj)v, ma un
pi ampio complesso di singole indagini indipendenti.
Al nucleo pi antico apparteneva, a giudicarne dal libro
A della Metafisica, la parte
concernente le pXal, e a1
giudicarne dal libro N la teoria della materia e della
forma, cio i- libri A e B. Ma si pu credere che il
nucleo fondamentale di queste opere risalga fino all'et
platonica, anche se certi passi, come quello del libro A
in cui ricordato il Liceo, tradiscono una posteriore
rielaborazione di punti particolari x). Per la storia del
l'evoluzione di Aristotele il momento cronologico del
compimento dell' opera diventa relativamente inessen
ziale quando si sia scoperto come il carattere specula
tivo della Fisica striato sensu dipenda dalla sua imme
diata provenienza platonica. Essa concepita come parte
di un sistema platonico dell'universo, e sta sullo stesso
piano di questo
sistema. Ci risulta particolarmente
chiaro quando si entri nell' ambito delle singole que
stioni concrete, come nei libri Sul ciclo, iquali pari-
menti vengono gi citati nelle parti pi antiche della
Metafsica
8). Il princpio del primo libro deve risalire
nel suo nucleo fondamentale a un'et antica, perch pone
trionfalmente a capo dell'intero corso di lezioni la sco
perta personale del giovane accademico, e cio la teoria
" Phys., A 11, 219
1)
il.
) Cfr. Bonitz, Index Arist.. 1111 a 7.
406 CI.I ANNI DI VIACCIO
del quinto elemento, l'etere. Come gi abbiamo messo in
chiaro, questateoriapi.anticadei libri Ilepi tpO.ocotpCas,
che su di essa si basano, ed necessariamente collegata
con le prime formulazioni della dottrina del motore
immobile e dei corpi celesti 1). L'esposizione dell'ipotesi
dell'etere che Aristotele ha data nei primi capitoli del
l'opera Sul cielo pi recente di quella contenuta nello
scritto essoterico (p. 204). L'opinione, fino ad oggi ac
colta, che Aristotele non avesse espreeeo nel dialogo il
suo vero modo di vedere ma l'avesse piuttosto travestito
con adornamenti poetici insostenibile, perch proprio
ilpresunto elemento poetico, costituito della teoria del
l'animazione dei corpi celesti, da lui- mantenuto fermo
nello scritto Sul cielo *), mentre l'elemento discriminante
appare nella teoria fisica del moto naturale dei corpi
semplici (irX
stipata) e nella connessione di essa con
la teoria della gravit, che nel dialogo giustificata in
modo del tutto divergente.
Qui riconosciamo anche
troppo chiaramente quanto importante sa d che ci
sfugge per la deficienza delle fonti. Ci nonostante
')
Circa l'origine dell'ipotesi dell'etere cfr, ora l'esauriente stu
dio di Eva Sachs, Die fiinj platonischen Korper (Berlino, 1917).
Anch'essa giunge alla conclusione che ilrapido successo della teo
ria dell'etere presso gli scolari di Platone nn indizio del fatto
che essa nacque nell'Accademia: Aristotele deve quindi
averla
elaborata ancora prima della morte di 'Platone. Cfr. quel che si
detto sopra (p. 190, n. 2) a proposito della relazione tra l'Epino-
mide. e il IUfA
s) De caeo, B 12, 292 a 18 iXX' <j aspi
omitcdv atffiv
[vov xal pov3u>v tgiv pv yyiuiv, 'Jjfjyrav Si XK|i7tav, 8ta-
voops&a- Ssr 8' (bg HJTySvtMv
JtoXafiPvsiv npSecop xal iJcu-SJg.
L'espressione richiama alla memoria inoti motti di Platone nelle
Leggi e il IIspl tpiXoooeplaf, ma secondo De cacio, B 8 si muo
vono soltanto le sfere, non le loro stelle, ci che a rigore ricon
duce all'idea di anime delle sfere, o, come in Metapk., A
8, a
quella di motori ideile sfere, e non a quella di anime astrali
come nel ITspt
tflXoooitac. Certo che in De caelo, B 8 Aristo
tele si decide solo dopo lungo esame per la tesi secondo cui si
muovono soltanto le siete e non anche le stelle. Anche qui si
pu dunque
constatare come Aristotele abbia modificato la sua
primitiva concezione,
GENESI DELLA FISICA E COSMOLOGIA 407
ancora possibile osservare almeno, nella disposizione dei
libri Sul cielo, ilmodo incud la cosmologia aristotelica
nasceda quella1 platonica, Quest'ultima
ci notasoltanto
dal Timeo, dietro al quale sta l'estesa speculazione pita-
gorizzante della
scuola
Ed di massima importanza per
la conoscenza dell'evoluzione del pensiero platonico nel
suo ultimo periodo il fatto che merc lo scritto aristo
telico noi possiamo spingere
lo sguardo nelle discussioni
che su questo argomento si agitavano nella
Accademia,
Questa
situazione di cose gi stata chiarita per quel
che concerne il problema dell'etere, il quale si ricollega
direttamente al Timeo e il cui riflesso s'incontra negli
scritti di tutti icondiscepoli di Aristotele. Ma anche la
questione della possibile esistenza di un corpo infinito,
della finit o della infinit del mondo e della sua unit
o pluralit (questione molto importante dal punto di
Vista della metafisica aristotelica, dipendendo da essa
l'esistenza del primo
motore) fu necessariamente trat
tata, gi inet platonica, dagli astronomi dell'Accademia,
e decisa da Aristotele nel proprio senso, cio in quello
dell'unit, eternit e finit dell'universo. Egli cerca di
dimostrare che non soltanto esiste di fatto soltanto un
cielo, ma che una loro pluralit non sarebbe neppure
possibile. Sembra, certo, che le cose stiano altrimenti,
perch ogni forma (slSos), che sia realizzata nella ma
teria, esiste di solito in una molteplicit di esemplari
simili (poeiSij). A questo proposito non c' differenza,
per quel che riguarda il risultato, se si considerano le
forme come trascendenti, cio come idee, o come non
separabili dalla realt. Evidentemente alcuni1 platonici
cercavano di aggrapparsi a questo punto
1). Secondo Ari-
') Il passo interessante, perch la dottrina
platonica delle
idee e la tesi aristotelica dell'immanenza dell'eidos stanno qui an
cora l'una di fronte all'altra come due possibilit parimenti giu
stificate (De cacio, A 9, 278 a 15): wv 8' iati popy xal etoj,
4C8 CU ANNI DI VIAGGIO
stotee in questo problema non si deve affatto partire
dalla forma, bens dalla materia. Giacch ogni materia
compresa nel cosmo, accanto ad esso non possono sus
sistere altri mondi.
Questo argomento sembra alquanto
ingenuo, ma per Aristotele non poi tanto incongruo
perch egli, come dice subito dopo, non intende per
cielo (opavii) soltanto la sfera estrema o la regione
del supremo elemento, incui' si muovono icorpi celesti,
ma il tutto che ogni cotsa comprende, e che da conce
pire in senso corporeo e plastico, ma tuttavia non mai
come actu
infinitum.
In
questo plastico globo la materia
totalmente compresa e risolta, e anzi al di fuori di
esso non c' neppure spazio, n tempo, n
vuoto, e quindi
tanto meno corpi. La realt trascendente (xv.t)
e so
pramondana non si trova quindi nello spazio, n hi un
dato luogo; iltempo non lafa invecchiare, e nessun'altra
alterazione interviene in quel regno che giace al di l
della sfera estrema. Ma lasciamo parlare lo stesso Ari
stotele: nelle sue parole epira qui una solennit incon
sueta nei trattati didattici1).
epavspN fipa iti o5xs xrcog
o5t X'/v OTS Xpivog ioxlv
IiuS-ev SiiKtp o5t" iv trto
xxst
rtY'Jxev
o5te y pvog aita
rtotsl -pjpetaxsiv o' ixxlv oBs-
vg oJejti* [isxa.SoX'q xfflv &Jtip
x9jv egenxu) TSTaY|ivuiv tpopv.
XX" vaXXo iurta -/.al rtaS-yj ti)v
pisxrji Ixovta Jmjjv xal
xf;v
atapxsatTqv BtaxsXsr xv rcav-
xa alfiva' xal yp xoOxo xo-
chiaro, dunque, che al di
fuori del cielo non c' spazio n
vUoto n tempo. Onde tutto ci
che col esiste non connaturato
inmodo da trovarsi nello spazio,
n il tempo lo fa invecchiare;
nessuna variazione interviene in
alcuna delie cose il cui luogo
a! di l dell' orbita estrema, ma
inalterabili e impassibili esse
conducono la vita pi perfetta e
soddisfatta di s per tutto illoro
'i:
!
ijxoi lativ 5j ivSiytxai ttXsieo ysvloS-at x xalX' ixaoxa. efts yp
ixxtv elBr] , xa&rcsp tpaai xivsg, vfxt) xoOxo aop|3avsiv, elxs xal
XWpuxv |irj3-v *cv xo'.o&xov, o-D-v rjfrov. irti
xvrujv
yp o&xcog
6?8>|iev, owv i/
ooia iv DX-jj iaxiv, rtXelto xal rteipa Svia -r nostij.
*) De cado, A 9, 279 a 17.
.
>
-<
GENESI DEI.I.A FISICA E COSMOLOGIA 409
voga
9-sittg iS-syx-tat rtap x&v
pxaiuiv. xyp xXog x> rtspis-
Xov
xv xijg xaxou Coijg
XP4"
vov, c5 ]r/|.Hv lto xax cpotv,
altbv xiotou xixXrjiai. xax
xv axv 5 Xiyov xal t <o5
rcavxg cbpavo xXog xal x
xv nvxa /pvov xal xrjv reet-
piav nspiiy.ov xsXog alcv IotVi
rt xo5 el elvai etXijcpcog xi/v
iu)vo[ilavi
ftvaxog xal &stog.
59-sv xa\ totg &\>.o'.g lp-L-fj-tu.
xotg p.=v xplPoTspov xotg 8'-
paupg,
t elvai te xal v.
xal yp xaxep iv x olg
iYXUxXioig
tptXooorjpao
spi x &Ela
uoXXxig
npoalvsxat
xotg XYo'gt
8ti x vlstov |iex3Xv]XOV vay-
xstov slvat rtv, x rtpiTov xal
xpxaxov [o] o&xug lypi pap-
xupet xotg
g
Ipr; [lvotg.
o5xs Yp
#XXo xpstxxv ioxtv xi
xtvijast (xstvo yP slrj
xepov) oBx'
ixt
tpaXov oiiftiv,
out'
ivSsig xfflv a6xo8 xaXv
o&evsg ioxiv. xal xauoxov 617
xCvrjCiv xtvelxat sXy>S ' tvxa
Yp nasxat x'.vopsva, 6xav
SXlJ slg xv olxstov xnov, xo8
Bs xxXip opaxog axg xnog
88-sv pjaxo xai elg 8v teXsot.
cono: ch questo il divino
nome che l'antica tradizione ci
ha trasmesso. Infatti il limite
che circosccivc la durata di ogni
esistenza, e che l'ordine della na
tura vieta assolutamente di vali
care, si chiama 1' cono di quella
esistenza. Per la stessa ragione
anche illimite dell' intero spazio
celeste e quello che contiene in
s tutto il tempo e l'infinit
un eterno e divino eolie, portan
do questo nome in forza della
sua slessa eternit [ ti= sem
pre, eternamente]. Da esso di
pende l'esistenza e la vita di tut
te le altre realt, per alcune in
modo pi palese e per alcune in
modo difficilmente avvertibile. E
infatti, come negli scrit
ti filosofici da noi
pubblicati intorno al
problema del divino
stala gi pi volte
dimostrata con argo
menti la necessit che ogni
ente divino sia immutabile,
cos la etessa natura del primo
e sommo fra essi viene ad
attestare la verit di
quel che si detto.
Non esiste, per muovere 1' uni
verso, alcun' altra realt pi po
tente (e che sarebbe perci an
che pi divina); n esso ha al
cun difetto, n e privo di alcuna
delle sue perfezioni. Di conse
guenza si muove d'un moto che
non ha mai eosta. Tutti i corpi
infatti cessano di muoversi quan
do siano giunti al luogo ad essi
appropriato: ma per lo sferico
corpo del inondo il punto donde
incomincia ilsuo movimento non
si distingue da quello in cui esso
finisce.
450 GLI ANNI III VICCIO :
1
. ;
. :
Col termine di
filosofemi enciclici si allude qui
ai libri Sulla
filosofia.
Quest'opera l'unico dialogo in
cui veniva trattato il problema
teologico e indagato il ;
suo nesso col problema dell'eterno moto circolare del
?..
firmamento. Le ultime parole sono un estratto, abba-
stanza letterale, dell'argomentazione di quel dialogo, ri- .
\
ferita nella sua forma originale da Simplicio nel suo
, |
commento a questo passo: e il dialogo stesso da lui
|
designato esplicitamente come la fonte a cui si riferisce
la citazione
aristotelica;
curioso che ilBernays, il quale
discute acutamente il passo di Simplicio1), si sia atte
nuto strettamente soltanto alla citazione, e gli sia cos . '
sfuggito come tutto il brano su riferito, e immediata-
"
mente precedente alla citazione stessa, tradisca col suo
7
etile la propria natura di trascrizione di un brano di '
prosa letteraria, parimenti desunta da quel dialogo. An
che l'inizio del cap. 10, che segue subito dopo, d l'im
pressione di non esser composto nello stile proprio del
corso di lezioni, anche ee qui sia possibile segnalare
-
qualche traccia isolata di stile estraneo. In ogni caso
anche nei corsi di fisica, come in quelli di politica, di
metafisica e di etica, dell'et pi antica bisogna preve-
dere la possibilit che vi siano ripetuti liberamente ampi
brani degli scritti letterari. Nei dialoghi, certo, si par
lava di rado di argomenti
fisici;
Invece nel terzo libro
Sulla
filosofia
Aristotele (v. eopra, p. 184) aveva parlato
della questione dell'eternit del cielo e combattuto l'opi
nione platonica secondo la quale ilcielo s imperituro,
ma nato nel tempo. lecito quindi congetturare una pi
stretta dipendenza da questo dialogo proprio nella con
clusione del primo libro, la quale segue alla
citazione.
e al principio del1secondo, essendo qui esaminata la stessa
questione (jcorepov aysvijTo; r) ytVYjzb xat <p&ap~og
*1
*)
Bernays, Die verlorenen Diuloge des Ariiloteles, p. 110.
GENESI DELLA FISICA E COSMOT.OC1A 411
cpfrapT;
xoapos). Nella sostanza questa indagine, al pari
di quella del dialogo, una continua polemica contro
il Timeo platonico, nominato anche esplicitamente1).
E il principio del secondo libro s distingue cosi piena
mente, nello stile e nel metodo, dalla consueta' forma
scolastica di argomentazione, che questa
differenza non
6 pu spiegare se non ammettendo che Aristotele abbia
riferito anche qui brani del terzo libro Hepl cp'.Xoao-La?.
La deficienza del materiale non permette
di darne una
prova diretta, ma dato che ilprocedimento
in se appare
accertato, contro ogni possibile
obbiezione, da numerosi
casi consimili, e che a poca distanza precede un ampio
estratto dallo stesso libro, nessun dubbio pu restare
quanto alla loro provenienza.
"Oli (lv oBv obxs yyovsv
6
jrifg otpccvig 51'
vdxszixi
<p$-a-
xaOixep xivig tpaatv
axiv, 4XX' loxiv et? xal trog,
fiv
xal xsXetnv obx
IXv
xoO -reav-; xt(Bvo,
Si xat TcspixMv v aBx xv
nsipov xpvov,
Ix xs xSi v stpij-
jivaiv
Igeati Xfi0siV
tv xlaxiv
xal 8i t5){ 5Y]; t5)5 itxp xv
SXXutg
Xsfvxutv
xal
fswuivxcov
axv
st yp
cbxutg [lv
Ixs'-v
Ivixsxai,
xaO' 8v 5 xpttov
xitvoi
Ysvg&ctt Xsyoogiv ox
ifiytxai, [nxXrjv v
tr/oi
xal
canto poccr/v
etj
jtioxtv itspl xij?
avaotag aixoS xal xij- lSii-
xr;xo{
ittsp XaX&g ou[i-
JvE'.8-biv auxv xob; pxalov;
xal (iX'.aia
maxpCoog rjp.rv
9;fj stvai Sativ
43vax4v xi xx S-stov tffiv
xiv-
Che dunque l'universo celeste.
non si generalo n pu perire,
come pure affermano alcuni, ed
invece unico ed eterno, senza
fine e senza principio di tutto il
suo eone, contenendo e circoscri
vendo in s stesso l' infinit del
tempo, cosa che si pu ritener
certa in forza di quel che si
detto, ed anche desumere dal
modo di pensare di coloro che
sono di diversa opinne e gli at
tribuiscono una genesi. Gi il fat-
to che esso pu esser costituito
nel modo da noi sostenuto, men
tre non pu essersi generato nel
modo propugnato da quelli, vie
ne ad avere gran peso al fine
del convincimento
della sua im
mortalit ed eternit. Convicn
quindi persuadersi
della verit
delle tradizioni
antiche, e spe
cialmente familiari ai nostri pa
dri, secondo le quali c' qual-
cosa d'immortale e di divino tra
') De cado, A 10, 280 a 28, e cfr. 279 b 32.
412
CLI ANNI DI YIAGCIO
cujv
fiv x!vt]3iy, iyo'/zuit 84
toiatijv Sirs jxyjS-v sXvai nspa;
aijx'rjj, XX piXXov
ta6tr/v
t&v
SXXcflv Rpag. t ts yp npa;
xfljv TCEp[ey_'>iTujv lori, xa't aiti]
v) xuxXocpopf t4Xeto; oioa ics-
pesasi ti;tsXsf; xal ti; iy.d
cii;uipq; ical
itaBXttv, atti) 84
oSspiav o5t* pxv
xouca
C&TS
tsXsuvqv XX' iitauoto; oaa tv
5.-iSipo-t i&y
8'dlXXm ttov
|iiv attia ti); px.ijs tSv Ss s-
Xop-ivi] t)v itaXav- tdv 5' o&oa-
Y'I V.%1 tv 5.VU t~OV Ol ]V'(
pXatoc toTg 3-sot; nvsi|iav d);
Svtct (livov -ivaiov
6 84 vOv
{ixptuptS Xya; ie isBa.ptg; %A
yvljto;, Iti 5"iit;ci;
icaiJS
Hvqti;; Sue/spaia; ictiv, icpi;
Ss totoi.; noYo; St t p.Y|86-
liiSsnpcsSsCo-S-Ki (3taix; vyxi);,
j
xatlxsc xmXuouoa qcpsjS-ai
nsipuxita a&tv SXXco;. ity
yap
t toioivov it7ioyoy, Sotpntp
v ctVScwtspov f), -/ai. Sca-3-aEwj
ri); iptatr;
fifioipoY. Scinsp
cuts xat tv ty
rcaXaiiv
(iB-
S-ov noXipttov Ixs'.v, ot (pccaiY
"tXavtj tivo;
ai-ifi
icpooSsto-
3-ac ti)v ciorqpiav
oixaat yip
xal toBtov ot
o'jatoaYtsg ty
Xyov ri)v tttijv
ixsiv 6tcSXi)i.y
tot; Botspov* <S>; yip icspt gipo;
iy.ittu)Y
xl ysTjpfiv
iitvttoY
tji
Svio acopituiv
nJtijoay
atijS puihxc;
iviyxijv ipox07-
oDtS &7j ToStOY tY tpltCV TCO-
Xrj-ircsov,
o6te i
ti)y 3tv/]oiv
&tTvog
tuyxvovta
cpop;
(Sii) ti);
otxstac orti;s Iti S<$-
?S39-Kl TOOOJtOV
XPYOY, xaMnsp
*B;i7csSoxX'?]s
<?i)oiy. iXXi
|ir/v
quelle
realt che sono animate
da movimento, ma il cui movi.
mento tale da non aver mai
limite e ansi da esser piuttosto
limite delle altre realt: il li-
mite infatti alcunch di com
prensivo, e questo
movimento
circolare
comprende, nella sua
perfezione,
i movimenti imper.
fetti, sottoposti alla limitazione e
all'interruzione, mentre esso non
Ita n .principio n fine e conti
nua senza tregua per tutta I'ini-
nit del
tempo, determinando gli
altri o come causa iniziale o co
me punto d'arrivo,
II ciclo e la
regione superiore fu dagli antichi
attribuita agli dei, in quanto la
considerarono soltanto immorta
le: ma ora il nostre ragionamen
to prova che esso anche indi
struttibile ed
increato, e immune
di ogni difficolt terrena, e oltre
a ci libero da ogni sforzo, non
avendo bisogno di alcuna costri
zione che violentemente lo trat
tenga nei limiti di un movimen
to a cui la sua natura rilutti,
Ogni realt di tal genere in
fatti tanto pi schiava della fati-
ea, quanto pi partecipi di una
eterna durata; e non quindi co
stituita nel modo piperfetto. Di
conseguenza non si deve neppnr
Credere che le cose stiano come
Se le immagina il mitico raccon
to degli antichi, iquali dicono
che, per poter sussistere, esso In
bisogno di unAtlante. Gli auto
ri di questo racconto presuppon
gono evidentemente la stes=n
idea implicita nel pensiero dei
loro moderni successori: credo
no che tutti icorpi celesti abbia
no pesantezza e siano costituiti
nello stesso modo che le cose
terrene, e quindi hanno sottopo
sto mitologicamente all' universo
celeste, rome suo sostegno, un3
CENESI BELLA FISICA E COSMOLOGIA
413
O5" n '-uxJ aXoyov vxyxti-
(ottai); pivsiv ttSiov* oSi yp
tjg 4ioxfls
olv t' elvai tjy
j
Toi-ziojv k>v)v QXuttov xu [la-
;
xccpiccv. ''yxY| y&p
xa\ rr]v
/[
|
vr;<ilv peti jiia; G3KV, etit6p
f
I X'.vstoS-ai
itEipoxtog toB rtpnou
t
'
oipato;
SXXwg xivsi cjis'/wp,
?
SxoXoy slvai xctl r.OYj j r-ijX-
I XafjiYijY faattbvrjj 4]iippovo;,
et
5 ye ili]?' StTtsp xtj iJjoxS T'<i
'tv
d-vr]t)Y CijiiflY sotl vdiitauais
?]
aspi tv dirvov yivojicvy
ro ei-
fiato;
veoi;, XXX'
ivayxatov
'Igiovg two; potpav xatxsiv
atV]Y Xt?iov xai fitpotov. et 6rj
xa&nep e-o|iSY
svSxetai
tv
stpi]]i4yov /eiv
tpoicov nepl ti);
rpitrj; cpop;, oii pvov atoO
rtsp! t?|{ Xfiitijtp; outui; 6to-
Xa'pEY IpiisXotepov,
tXXi xal
ti) iiavtsig;
tf
ittpl tv tfsv
pvw; Xv Ixoipev
oByiu; jio-
XoyoupviDf
-
ffppatvsafrat
sop-
tpiDYO'jg
Xyou;.
XX
tijiv |i5Y toioOtcov X-
ye)Y
Ξ
6stu)
ti vv (').
forza animata. Ma insieme con
questa concezione
bisogna respin
gere anche quella,
professata da
Empedocle, secondo
la quale es
so, avendo ricevuto dai molo
vorticoso un pi veloce impulso,
conserva per cos lungo tempo,
in virt dell'impeto proprio, il
suo movimento. E neppure cre
dibile che la sua eternit sia de
tcrminata dall' azione costrittiva
di un'anima cosmica: che non
dell'anima una vita talmente se
rena c beala. infatti necessario
che questo suo moto, dovendo
usare la forza in quanto costrin
ge il primo corpo (il ciclo) a
muoversi continuamente ili una
maniera non rispondente alla
sua natura, sia senza requie e
senza momento di spirituale sol
lievo, se e pur vero che essa non
pu mai, come l'anima degli es
seri mortali, godere della tregua
costituita dall'abbandono de! cor
po durante il sonno, e deve in
vece necessariamente
sopportare
un eterno e inesauribile destino
d' Issione.
Se dunque a proposito della
prima orbila possibile che la
condizione delle rose sia quella
da noi descritta, aver tale opi
nione circa la sua eternit non
solo pi congruo in s, "ia an
che necessario perch i sia in
grado di fornire una spiegazione
delle cose che in tal modo lo
gicamente consuoni con l'intima
nostra intuizione
di Dio.
Ma, in questo campo di con
siderazioni, basti per ora quel
che s' detto.
') Con queste parole, clic servono di trapasso al normale tono
didattico della lezione, Aristotele stesso dice chiaramente come
quel che precede appartenga
a un iXXo Yvo;, i! quale a rigore
non si accorda eoi freddo stile di trattazione scientifica altrimenti
dominante in
quest'opera.
414
CU ANNI DI VIAGGIO
quasi superfluo
riferirsi a indizi particolari
per
mettere in chiaro come lo 6tile di
questo capitolo si
distingua
totalmente da quello consueto alla prosa scien
tifica di
Aristotele. La scelta di parole solenni, che altri
menti non
s'incontrano in queste trattazioni terra terra,
un'augusta
elevatezza di
espressione, laricchezza di mezzi
retorici in servigio
dell'effetto
artistico, figure eleganti
quali
simmetrie, chiasmi e antitesi, immagini
audaci
come quella della platonica
anima del mondo, legata
come unIssione al moto
incessante della ruota del cielo,
sonori
accoppiamenti di parole come x? Ttspa?
"/.al xaXav, potpav xaxeiv
tiov xa xpuxov,
?
Ttfazcv rcsp xrj? ftavaafa; axo xal zfjs i'Scxyjxo?,
SoXoXov
xal
7to7; 7tr;XXaypvTjv aaxmvijg Ipcppovoj,
SXuTic-v xa
p.axap;av, p/satoi>5 *1 pdXtaxa naxpfou;
fjpbv Xy&dj, Ttt7iovov xal
BiaSiasis XT;? plaxvj? &|xoipov,
e soprattutto una voluta
trasposizione delle parole, si
mile aquella dellaprosa dei pitardi dialoghi platonici,
e
un'accurata eliminazione
dell'urto vocalico tra prin
cipio efine di paroledanno a
questa linguauu
tono, una
misura e uu 'atteggiamento
quali convengono soltanto a
quella dei dialoghi. Specialmente
allafine appar chiaro
come, nel loro originario
contesto, queste concezioni fisi
che fossero orientate verso finalit religioso-metafisiche.
La sinfonia della considerazione fisica dell'incorrut
tibile mondo celeste con quella che Aristotele chiama,
in modo incomparabilmente
hello e platonico, la pro
fezia di Dio nell'intimo nostro, ci gi apparsa come
la sintesi caratteristica
operata dal terzo libro Sulfa
filo
sofia. Anche la formo soltanto dialettica dell'argomen
tazione, il procedere dalle degne opinioni degli antichi,
da tradizioni religiose e da ci che verosimile (soXo-jo'd
denuncia quale sia la fonte.
Risulta con ci fissato un terminus post quem per
l'et di
composizione della redazione da noi posseduta
CENESI DELLA FISICA E COSMOLOGIA 415
dei libri Sul cielo. Essi sono stati elaborati dopo il dia
logo Sulla filosofia,
al pi presto uno o due anni! dopo
la morte di Platone. Ma neppure debbono esser nati
molto pi tardi, perch l'intero ambito visuale quello
della tarda Accademia1). Le teore cosmiche dei Pitago
rici, tanto spesso cieoamente seguite in questo
ambiente;
la forma sferica del cielo e della terra; la teoria delle
sfere e quella della loro armonia, che Aristotele mette
in dubbio nello stesso atto incui seriamente si sforza
di render
comprensibile a s Bteeso fin nel particolare,
da un punto
di vista fisico, ilmodo in cui glil astri pos
sano essere mossi dalle sfere; le questioni avanzate da
Platone circa la forma degli
astri, e la loro rotazione
assiale; la conoscenza, evidentemente
ancora recente, dei
cataloghi astronomici dei Babilonesi e degli Egizi, e
infine ildibattito, divenuto poi di tanta importanza sto
rica, circa la posizione della terra nello spazio cosmico
e circa ilsuo movimento, risolto da Aristotele, per man
canza di prove decisive a favore del* moto terrestre, con
l'adesione all'idea della forma sferica della terra ma col
rifiuto, conforme a ci che' sembravano esigere le opi
nioni allora dominanti circa l'essenza dei fenomeni gra
vitazionali, dell' allontanamento della terra stessa dal
punto
centrale del cosmo; da ultimo, le linee indivisbili
') La teoria
dell'etere, assai divergente da quella esposta nel
Espi e che di per s attribuisce a questo dialogo il
carattere di terminus post quem essendo
comprensibile solo come
correzione e non come stadio precedente della teoria sostenuta
nel dialogo slesso, potrebbe sembrare argomento contro l'ammis
sione 'di un troppo breve intervallo
cronologico fra il flap!
cfi).oooq>tas e il De Cacio. Ma un uso piuttosto
intenso degli
scrtti essoterici stato da noi constatato solo nei trattati didat
tici appartenenti al periodo medio, e quindi ancora assai vicini
cronologicamente a quelli, Per il De eaelo bisogna quindi ritenere
che la sua genesi, o la stesura della prima redazione nel suo com
plesso, cada nel periodo medio dell'attivit
aristotelica, e che
una sua riclaborazione, in parte profonda, abbia avuto luogo nel
periodo tardo.
416 GLI ANNI Ul VIACCIO
di Senocrate, la teoria matematica dei corpuscoli pro
pria della dottrina platonica degli elementi e ilproblema
della gravit, invano affrontato dagli Accademici: tutto
questo ricco ed evoluto mondo di speculazione fisica,
nella sua varia e spesso apparentemente asistematica
composizione risultante da problemi singoli semplice
mente giustapposti, comprensibile solo in funzione
slorica del suo ambiente nativo, cio dell'Accademia. In
questa forma iconcetti aristotelici sono stati esposti solo
dopo il347, ma concepiti essi sono stati gi nel periodo
accademico del filosofo, quando egli
discuteva,
con Pla
tone e coi suoi compagni1)..
') La determinazione della data della Meteorologa difficile.
Ilibri Ilept -j-evloeug xat tp&op?, tra i quali sono da anno
verare anche idue libri Tei del De cucio, si muovono espli
citamente sullo stesso piano speculativo della Fisica e del De caelo.
La polemica si aggira intorno alla riduzione platonica dei quattro
elementi a figure matematiche (Ssttit8a) e all'atomismo di Leu-
cippo e di Democrito. La Meteorologia si addentra invece profon
damente nella ricerca scientifica particolare. Ora, anche se il
principio della divisione in teoria generale e scienza particolare
della natura sta a fondamento dell'intero complesso degli scritti
naturalistici di Aristotele, il quale comprende cos entrambi quegli
aspetti nella loro dualit, tuttavia non c' dubbio, dopo l'esempio
tra l'altro della Politica, che il materiale empirico si venuto
a poco a poco accumulando e aggiungendo solo in et pi tarda,
e ha reagito in vario modo sulla costruzione propriamente filo
sofica. Di conseguenza non dovrebb'cseero lecito assegnare la Me
teorologia a una data troppo alta: gli argomenti arrecati dall'Ide-
ler (Arist, Meteor., I, p. IX) per dimostrare che essa stata
composta prima della spedizione asiatica 'di Alessandro non reg
gono alla prova. Poco dice il fatto che Aristotele consideri an
cora esattamente, con Erodoto, il Mar Caspio come un mare in
terno, mentre la spedizione di Alessandro giunse all'erronea opi
nione, la quale poi tenne il campo fino all'et moderna, che esso
fosse collegato col mare del Nord. Infatti anche nella Storia degli
animali, che certamente di et tarda, Aristotele si vale per la
descrizione di animali egiziani non del racconto di testimoni ocu
lari, ma di Ecateo di Mileto (v. Diel9, in Hermes, XXII: le coin
cidenze della Storia degli animali con Erodoto erano state gi ri
levate dal grande Cuvier, in Histoire des sciences naturelles, I,
1811, p. 236: cfr. A. v. Humboldt, Kosmos, II, 2847, p. 427, n. 95).
La menzione dell'incendio del tempio di Efeso, accaduto nel
356, che la Meteorologia (f 2, 371 a 30) compie con l'espressione
CEKIiM CELLA FISICA E COSMOLOGIA 417
Dobbiamo qui prescindere da una valutazione gene
rale della filosofia aristotelica della natura, che cerche
| remo invece di dare nella conclusione di questo
libro.
Basti per ora aver chiarito nella loro natura i prin
cipali dati di fatto concernenti il processo della sua evo
luzione. IIquadro, storico della genesi antica delle parti
fondamentali, cosmologiche speculative, della teoria
aristotelica della natura, della fisica c della cosmologia
|
con l'annesso scritto circa la genesi e la distruzione, viene
|
integrato dall' intervento, che secondo ogni verosimi-
i|
glianza ha avuto luogo soltanto tardi, dei lavori sulle
parti e sulla generazione degli animali. Essi muovono
dall'osservazione particolare della natura, e rappresen
tano la pi perfetta ed originale creazione di Aristotele
nel campo della scienza naturale. Contro ad essi stanno
la fisica e la cosmologia, con la loro indagine concettuale
dei principi universali della natura e delle grandi linee
del quadro cosmico. Non solo esse sono, dal punto
di
vista del loro contenuto problematico, assai pi pros
sime storicamente a Platone, ma anche nel metodo esse
si mantengono su quello stesso piano di prudente con
tinuazione critica della speculazione accademica che
!
caratterizza l'et di mezzo dell' evoluzione aristotelica,
l'epoca della politica dello stato ideale e dell'etica e
1
della metafisica teologizzanti. La continua polemica con
tro aspetti particolari della teoria platonica della natura
non deve celare come tale critica nasca appunto
dalla
maggior vicinanza all'ambiente ideale di Platone. L'ab-
vov oovpcuve fornisce solo un terminus post quem, perche questo
vv. com' noto, c ili significato assai ampio, e lascia quindi
largo giuoco alla determinazione cronologica. Viceversa l'espres
sione i itsoiv 6ttsp r itzvci/xovxa 51? vstxopav pvov, olle la
Meteorologia (I" 2, 372 a 29) adopera a proposito dell'osserva
zione dell'arcobaleno lunare, non conviene troppo u un uomo an
cora relativamente giovane, anche quando non si voglia prendere
alla lettera la prima persona del verbo.
27.
TV. jAEtmn, Aristotele.
41S CLI ANNI DI VIAGGIO
bandono dell'invisibile mondo delle idee, che inPlatone
fronteggiava il cosmo visibile come suo paradigma, la
fredda scepsi contro certe effusioni d'arbitraria fantasia
cosmologica, alle quali alcuni Accademici erano stati
sedotti dall'adesione alla filosofia pitagorica, e in gene
rale Favversione alla speculazione pura, non fondata
sull'esperienza, sono, s, imotivi che vengono accentuati
da Aristotele con maggior consapevolezza. Ma basta pa
ragonare la fisica di Aristotele a quella del Timeo pla
tonico, sullo sfondo del meccanismo cosmologico di De
mocrito o della teoria astronomica di Eudosso, risolven-
tesi in pura concezione matematica, per scorgere come
le ostruzioni di Aristotele poggino in pieno sulle fon
damenta platoniche e come isuoi scritti di fisica e di
cosmologia rechino l'impronta delle discussioni da cui
nacquero in seno all'Accademia.
PARTE TERZA
L'ET DELL'INSEGNAMENTO
ifl
I.
ARISTOTELE AD ATENE
Nell'anno 335-4, dopo tredici anni di assenza, Ari
stotele torn ad Atene, che egli non aveva pi riveduta
dal tempo della morte del maestro. Con la salita al
trono di Alessandro si era chiuso il periodo della sua
diretta attivit presso la corte macedone. Certamente il
giovane re gli offerse anche allora la possibilit di atten
dere onoratamente, con agio e coi mezzi necessari, alle
sue ricerche; e nessuno creder che, proprio nel mo
mento in cui egli aveva pi bisogno che mai di esperto
consiglio, egli abbia allontanato apposta dalla sua com
pagnia l'uomo che fino al tempo della spedizione asia
tica aveva costantemente lavorato a raffinare la sua co
scienza politica e fino allora lo aveva sorretto nelle
sue decisioni di stato1). Ma il ritmo della loro esistenza
era diventato troppo diverso, fin da quando Alessandro,
per salvare il trono che tornava a vacillare ad ogni
mutazione di chi lo occupava, passava veloce di cam
pagna in campagna e combatteva per la propria fortuna
ora sui Balcani e sul Danubio, ora in Grecia. Non sap-
Pw la supposizione che il Tapi SaotXslaj; sia stalo scri'to
in occasione della salita al trono di Alessandro cfr. sopra, p. 349,
n. 3.
422 l'et df.ll'insecnamento
piamo se Aristotele sia rimasto alla corte fino al suo
ritorno ad Atene o se gi da parecchio tempo egli si
fosse nuovamente ritirato nell'avito possesso di Stagira,
secondo la notizia data da un frammento di lettera in
s molto sospetto,
il cui stile presenta maggior somi
glianza con ifrigidi artifici delle scuole di rettorica che
con la libera forma letteraria di Aristotele, famosa nel
l'antichit come modello d'individuale stile epistolare1).
Favorevole all'idea che egli abbia mantenuto costanti
rapporti con la corte anche il fatto che Aristotele
venne ad Atene solo nell'anno in cui Alessandro pass
in Asia Minore.
Subito dopo la salita al trono di Alessandro (336)
inazionalisti ateniesi, agli ordini di Demostene, ormai
escluso dalla vita politica dopo Cheronea, e isuoi amici
intutta laGrecia si erano sollevati. La rapida repressione
della rivolta, operata da Alessandro, pareva avesse
ristabilito la quiete e la obbedienza, quando, alla voce
che il re era caduto nelle battaglie sul Danubio, il par
tito nazionalista si risollev di nuovo (335), alzando il
grido dell'autonomia e della libert2). Ma ancora una
volta il disinganno fu rapido e completo. Alessandro
assal Tebe e la rase al suolo, esempio ammonitore per
gli altri Greci. Solo a gran fatica Atene riusc a sottrarsi
alla disonorante ingiunzione di consegnare Demostene e
tutti icapi del partito nazionalista. Da allora in poi
essi scomparvero dalla scena politica. La tensione degli
spiriti contro la Macedonia si attenu. Nell'ottobre del
fi
u
ij
"it
1
) Framm. 669 R. iy) ix ]iv A9r;v(5v et; Stdyeipa jjXS-ov Sii
tv
gaoia rv
|iyav,
ix 8 StafeCpwv et; 'AS-ijva; 5: rv yti-
pcva tiv [lifav. In s e per s, la cosa pi naturale che Ari
stotele trascorresse il tempo nelle sue occupazioni scientifiche a
Stagira, tutte le volte che non era richiesta la sua presenza alia
corte: cfr. sopra, p. 150 it, circa ilsoggiorno di Teofrasto a Stagira.
*) Arr,, I, 7, 2 IXsuspiav
te (xal aSrovopCav) Ttpo'ta/-ip.svoi
ttaXaiK xal xa ovipara...,,
. ARISTOTELE AD ATENE
423
335 Alessandro torn indietro; nel maggio del 334, por
tatosi in Asia Minore, sconfisse isatrapi persiani al
Granico.
Di questi tempi Aristotele torn ad Atene. Chi ri
tornava, ora, era il sommo esponente della vita spiri-
tuale ellenica, l'eccellente filosofo, scrittore e maestro,
l'amico del potentissimo dominatore, la cui fama mon
diale aveva, con la sua veloce espansione, innalzato an
che la sua figura nell'opinione degli ambienti pi lon
tani, ignari del suo valore personale. Il progetto di tor
nare col dove egli si era spiritualmente formato si ma
tur probabilmente in lui negli ultimi anni del sog
giorno macedonico, trascorsi nell'intimit della ricerca
scientifica. Fu il ricordo di Platone che gli fece scorgere
nel ritorno qualcosa di pi che un'estrinseca condizione
favorevole per una pi vasta manifestazione della sua
attivit. Assunse cos ora anche pubblicamente, di fronte
a tutto il mondo, la successione del maestro. L'Acca
demia peraltro gli era ormai aliena. In essa, dopo la
morte di Speusippo (339-8), era stato dai membri eletto
scolarco Senocrate1). A un ritorno nell'Accademia, alle
dipendenze dell'antico compagno, ormai di cos diverso
orientamento spirituale, egli non poteva pensare, per
quanto si preoccupasse
di conservare le sue cordiali
relazioni esterne con quel venerando uomo. Non ab
biamo infatti notizie di suoi dissidi con l'Accademia:
e certo molti uditori avranno frequentato le lezioni in
entrambi gli istituti. Ma da questo momento l'Accade
mia perde la sua posizione dominante di fronte alla
nuova ecuoia aperta
da Aristotele prima negli anditi
della palestra del Liceo, e poi probabilmente
in locali
pi adatti in un fondo vicino, fuori della porta di
Diocare ad oriente della citt, cio in un luogo che
*) Ind. Acad. Hercul., col. VI, p. 38 (Mekler).
424 l'et dell'insegnamento
(
5 ARISTOTELE AD ATENE 425
gi da secoli era un punto di ritrovo dei sofisti. Finch
Aristotele rimase fra le mura di Atene, la detronizzata
regina delle citt fu ancora per l'ultima volta il centro
spirituale del mondo ellenistico, la metropoli della
scienza greca. Dopo la morte di Aristotele e di Teofra-
sto questa et si chiude: il centro di gravit si trasfe
risce ad Alessandria. Nella figura di Aristotele, non
ateniese e residente in Atene, salvaguardia dell'influen
za politica dei Macedoni nell'antica capitale dell'impero
attico e insieme maestro spirituale della nazione, il
simbolo dell'et nuova.
Aristotele fond il nuovo centro scientifico con la
protezione del suo potente amico macedone Antipatro,
che Alessandro aveva lasciato in Macedonia e in Gre
cia in qualit di reggente e di supremo comandante
militare. Assai da rimpiangere la perdita del carteg
gio di Aristotele con questo importante personaggio, che
dopo la morte di Ermia sembra abbia avuto con lui
rapporti personali pi stretti che ogni altro. Dato che
Antipatro proveniva da un ambiente totalmente diverso
da quello in cui si era formalo Aristotele, ed era estra
neo alla vita scientifica, la loro amicizia deve certo es
sersi basata su una profonda affinit di carattere. Cos
si spiega come
questa relazione, annodata alla corte di
Filippo quando Aristotele godeva del massimo favore
del re e di Alessandro, abbia sopravvissuto ai mutevoli
umori dello stesso Alessandro e, dopo aver stretto idue
uomini per tutta la vita, abbia legato Antipatro all'ami
co filosofo anche dopo la morte di quest'ultimo. Egli
fu infatti designato da Aristotele, nel suo testamento,
quale esecutore delle sue ultime volont. Nei brevi
frammenti superstiti delle lettere aleggia uno spirito
d'illimitata confidenza, da cui si pu anche dedurre
come Aristotele e il suo ambiente dovessero trovarsi
d'accordo coi
disegni della politica macedone, dato che
i VS
Antipatro, tra il 334 e il 323, amministr con potest
quasi illimitata le faccende interne della Grecia.
Il partito macedonico di Atene, che contava molti
aderenti fra iricchi, poteva
ormai farsi avanti indistur
bato. In seno alla cittadinanza, il processo di dissolvi
mento della fiducia si era esteso inmisura tremenda. Ai
nazionalisti, cerio, era ancora facile di riportare delle
vittorie dimostrative, come quella di Demostene su
Eschine sconfitto nella battaglia oratoria del processo
per la corona, e di conquistare con ci di tanto in tanto
il favore della massa. Ma contro le lancie dei Macedoni
essi erano impotenti, e non avevano pi dalla loro parte
le persone colte, che non erano state scosse dalla loro
indifferenza e inerzia neppure dall'opera di Demostene,
fallita perci nel suo principale intento. Per gli am
bienti intellettuali costituiva una conquista il fatto che
venisse a loro un appoggio morale dalla scuola di Ari
stotele, direttamente collegata col governo macedone.
Contro l'altezza morale e spirituale di questi nuovi uo
mini, che non essendo ateniesi non potevano essere ac
cusati n di tradimento ne di corruzione, oratori popo
lari come Licurgo e Demostene non riuscivano ad aver
successo. A quegli uomini non si poteva ascrivere alcuna
immediata intenzione politica, ed essi influivano sulla
formazione di un nuovo gruppo pi col loro calmo ri
fiuto dell'idea nazionalistica concepita nel senso di De
mostene che con un proprio programma politico.
Col suo fine tatto, Aristotele ha sempre evitato accu
ratamente di toccare il punto sensibile del sentimento
nazionale ateniese e di lasciar cadere anche solo una
parola dura contro Demostene, che senza dubbio gli era
avverso, e contro il suo partito. Solo dopo molti anni,
nelle mordaci espressioni di Teofrasto e di Demetrio di
Falero circa
l'eloquenza e lo stile di Demostene quale
oratore popolare, il giudizio corrente nella chiusa cer-
426 l'et deli.'insecnamento
chia del Liceo si azzarda a venire inluce. Naturalmente
Aristotele non era cos miope da attribuire a Demostene
la colpa della guerra di Cheronea, come facevano Eschi
ne e isuoi seguaci. Nell'unica espressione circa Demo
stene, che di lui possediamo, egli si oppone a questa
idea. Tuttavia nulla sarebbe tanto falso quanto il cre
dere, per questi motivi, che Aristotele abbia avuto om
bra di comprensione per l'orientamento spirituale di
Demostene. La cerchia degli intellettuali che si racco
glieva nel Liceo non era, certo, niente affatto cosmopo
litica, ma era rassegnata, e lo era tanto pi in quanto
non aveva nessuna fiducia nelle nuove creazioni di Ales
sandro, toccanti ilimiti del fantastico, e non voleva sa
perne di affratellamenti di popoli e di fusione col
mondo asiatico. Aristotele stava accanto al letto della
inferma nazione greca nell'atteggiamento di un medico
preoccupato. Inazionalisti che si raccoglievano intomo
a Demostene non capivano questo atteggiamento spiri
tuale, che aveva le sue radici nella volont di conoscere
l'amara verit. Nella scuola di Aristotele non vedevano
che un ufficio di spionaggio al
gervizio
della Mace
donia1).
Di nessuna scuola scientifica possediamo tante noti
zie come di quella del Liceo. Persino le lezioni che in
essa furono tenute ci sono state conservate in massima
parte negli scritti di Aristotele. La legge ateniese proi
biva allo straniero l'acquisto di territorio attico: tutta
via vediamo pitardi che Teofrasto possedeva un fondo,
*)
Questa era certamente l'opinione di Demostene, nonostante
che egli non potesse esprimerla ad alta voce, come viceversa fece
suo nipote Democare nella difesa del decreto di Sofocle (307/6),
con cui, dopo la liberazione di Atene per opera di Demetrio Po-
liorcete, le scuole filosofiche simpatizzanti per la Macedonia fu
rono soppresse (cfr. i vituperi lanciati contro Aristotele e isuoi
seguaci nei frammenti del discorso di Democare in Haiter-Sauppc,
Or. AtU, H, p. 341 segg.).
ARISTOTELE AD ATENE
427
cio un gran giardino, in cui si trovavano un sacello
delle Muse, giusta l'esempio
dell'Accademia, un altare
e vari portici1). In uno di questi portici erano esposte
su tavole
(itvxe{) le carte geografiche della terra
TtEpoSot). E anche il resto del materiale
didattico,
come la biblioteca, si sar trovato col. Una statua di
Aristotele era esposta,
accanto ad altri doni votivi, nel
sacello delle Muse.
Questo
fondo era stato regalato da
Demetrio di Falero al suo maestro Teofrasto, perch re
stasse di sua propriet
(tSiov), e poich la legge non
permetteva
che una simile donazione fosse fatta a un
meteco quale
Teofrasto, dovette essere necessario a tale
scopo uno speciale atto di diritto pubblico. Poich la
scuola, gi fin dal tempo di Aristotele, disponeva di
molto materiale didattico, e in particolare di una rac
colta di libri che poteva essere contenuta solo in un
edifcio di una certa ampiezza, non da respingere la
congettura che oggetto della donazione poi fatta da De
metrio a Teofrasto fosse proprio il bene immobile che
gi aveva servito ad Aristotele come sede per le sue
lezioni. Demetrio l'avr conservato per la sua scuola,
in quanto il ricordo del fondatore era ormai legato a
quel pezzo di terra. Tuttavia la fondazione dev'essere
stata intestata al nome di TeofraBto, perch nel suo te
stamento egli lega il Peripato alla scuola con questa
formula: Lascio il giardino e la passeggiata
(il pe-
ripato), con gli edifici che vi Borgono,
a quelli tra i
nostri amici inscritti che volta per volta vogliano dedi-
carvisi in comune all'insegnamento e alla ricerca scienti
fica, non essendo possibile che ognuno vi rimanga co-
etantemente; e ci a patto
che non sia permesso
di alie
nare o di appropriarsi cosa alcuna, e che essi debbano
s) Diog., V, 39. H tiaso costituito dalla comunit era quindi
dedicato al culto delle Muse.
428 l'et dell'insegnamento
i :
V;
invece possedere tutto ci come un comune santuario, e
servirsene mantenendo reciproci rapporti di camerati- ;
smo e di amicizia, secondo ci clie conveniente e
giusto ').
Queste
belle parole attestano come nella scuola so
pravvivesse lo spirito che Aristotele le aveva infuso. Le
norme fondamentali della vita collettiva erano salda
mente stabilite. Simbolo della comunit erano iconve-
J
gni sociali che avevano luogo regolarmente ogni mese,
le sisBizie e isimposi. L'inventario contenuto nel testa
mento di Stratone enumera, accanto alla biblioteca, sup
pellettili per l'agape, tovaglie e vasellame 1).
Questa
or- :
,J.
ganizzazione dev'essersi sempre pi completata nel corso
*
delle generazioni: e al
tempo dello scolarcato di Licone
si ebbero lamentele per il fatto che gli studenti pi
poveri non potevano partecipare ai conviti, facendosi in
essi troppo lusso. Lo stesso Aristotele redasse un rego
lamento concernente le costumanze da seguire nei sim
posi (vpoi <3opitony.o() ed uno concernente quelle da
seguire nell'agape (vpoc auaot-ttxoJ), cos come avevano
fatto Senocrate e Speusippo per l'Accademia.
Queste
r.orine esercitarono nelle scuole filosofiche una funzione
non indifferente8).
L'ordinamento delle lezioni era saldamente stabilito.
La tradizione racconta che Aristotele dedicava la mat
tina ai corsi pi difficili, di argomento filosofico: nel
pomeriggio faceva lezioni di retorica e di dialettica per
un pubblico pi vasto. Accanto al maestro tenevano i
loro corsi gli scolari pi anziani, come Teofrasto e E'.i-
demo.
Quanto
a nomi di scolari di Aristotele, ne cono-
')
Diog., V, 52.
*) Diog.,
V. 62.
') l'er l'organizzazione
esterna della comunit peripalcliea e
per le suo cariche elettive cfr. Y7ilamowitz, Antigono voti Kory-
stos, p. 254,
ARISTOTELE AD ATENE 429
sciamo redativamente pochi. Ma quale Greco che abbia
scritto su problemi di scienza naturale, di retorica, di
letteratura, di storia della cultura, nonha avuto, intutto
il secolo immediatamente successivo alla vita di Aristo
tele, il nome di peripatetico?
Per quanto prodigo sia
i'uso che igrammatici fanno di questo
titolo, si scorge
facilmente come l'influsso spirituale
della scuola si sia
esteso rapidamente ovunque si parlava greco. Tra ipe-
rpatetici noti non troviamo quasi mai nomi di Ate
niesi: gran parte degli uditori dev'esser venuta di fuori.
Dalia comunanza platonica di vita, dal ooigv, nasce nel
Liceo l'universit nel senso moderno della parola, come
organizzazione delle scienze e dei corsi di studi. Gli sco
lari, che recano ancora il bel nome platonico di ami
ci , vanno e vengono senza tregua, giacch, come dice
Teofrasto con un certo tono di rassegnazione, non
possibile che ognuno vi rimanga costantemente . Con
l'Accademia la nuova scuola ha tuttavia in comune il
carattere che il suo ordinamento interno, come gi
l'idea della comunit platonica di T'ita, stato determi
nato nella sua genesi dagli aspetti pi personali del
temperamento
e dello spirito del suo creatore. L'orga
nizzazione della scuola peripatetica un'immagine della
natura di Aristotele: il risultato del dominio esclusivo
di un'intelligenza, la cui volont vive nelle membra del-
l'organismo dominato.
Per lo pi si suole non tenere abbastanza presente
come Aristotele non sia affatto uno dei grandi scrittori
filosofici che lasciano alla posterit la loro opera lette
rariamente conformata, e che cominciano propriamente
a vivere solo quando muoiono, perch la parola scritta
opera per loro. La serie degli scritti letterari, composti
da Aristotele nello stile di Platone e pubblicati nei suoi
anni giovanili, appare sostanzialmente conclusa con
l'inizio dell'attivit didattica ad Atene. In ogni modo,
430 l'et dell'insegnamento
idialoghi pi importanti appartengono ad un'et molto
anteriore, ed difficilmente ammissibile che ancora in
questi anni Aristotele si sia
occupato della composizione
di piccoli dialoghi, con un'attivit che ormai non avreb
be avuto che il valore di un gioco accessorio. Ormai
la sua attivit si risolve nell'insegnamento, ancor pi
di
quanto prima non fosse. Itrattati didattici superstiti
sono il sostrato di questa viva attivit da lui svolta tra
isuoi scolari. Nel Fedro Platone sostiene l'inutilit della
parola scritta per la
comunicazione di una vera cono
scenza scientifica. Per
troppo tempo si creduto di po
ter trascurare
questa concezione, fondamentale per l'in
terpretazione dei dialoghi; e solo ora si comincia a
vedere come essa fosse fondata sull'effettiva relazione
che nella scuola platonica legava la produzione scritta
all'insegnamento orale, e come ogni considerazione com
plessiva dei dialoghi, che non li contempli sullo sfondo
di quella generale attivit didattica, implichi uno spo
stamento illecito del loro centro di gravit1). Con Ari
stotele la situazione si muta ancora una volta.
Qui
a poco
a poco interviene una completa paralisi della creativit
letteraria, totalmente assorbita dall' attivit didattica.
L'enorme somma d'azione che costituisce la vita d'Ari
stotele non compresa n nei trattati dottrinali n nei
dialoghi, e
soprattutto consiste nella viva efficacia eser
citata sugli scolari, e non radicata nell'eros platonico,
ma nell'impulso a conoscere col proprio sforzo perso
nale e ad insegnare agli altri. Staccati dal loro creatore
e dalla sua parola, itrattati non potevano esercitare in
dipendentemente un' ulteriore efficacia, e non l'hanno
di fatto esercitata. La stessa scuola peripatetica stata
capace di leggervi solo finch c'erano ancora, a com
mentarli, quelli che erano stati personalmente discepoli
') Cfr. la mia F.nlstehungsgeschichle d. Met. d. Arisi., p. 140.
AHISTUTELE AD ATENE 431
di Aristotele. Sul primo ellenismo questa enorme massa
di scienza e di pensiero ha esercitato un influsso straor
dinariamente esiguo. Solo nel primo secolo avanti Cri
sto si trassero nuovamente alla luce itrattati, ma anche
allora iprofessori greci di filosofia, insegnanti
ad Atene,
non li capivano1). Solo quando il faticoso e secolare
lavoro compiuto dalla scuola dei commentatori ebbe fat
to riapparir chiare allo sguardo quelle possenti costru
zioni del suo pensiero, che solo per un capello la posteri
t non aveva perdute per sempre, Aristotele riprese per
la seconda volta ad essere ilmaestro della scuola. Solo
allora si cap come non ci si potesse attenere soltanto
a quegli scritti del filosofo che erano circonfusi dallo
splendore della gloria letteraria, ma si dovesse scorgere
il vero Aristotele nel vivo della sua attivit attraverso
itrattali didattici da lui non pubblicati, per cogliere
un ultimo bagliore di questo spirito, cos avaro verso
la posterit e cos prodigo per coloro che lo circonda
vano. Cos, contro ogni sua intenzione, Aristotele di
venne il maestro di tutte le genti. La sua universale
missione storica riusc diametralmente opposta alla sua
azione e intenzione personale, la quale, con spirito
schiettamente greco, era tutta accentrata nel presente, e
raccoglieva tutte le sue forze per agire nell'ambiente
pi ntimo. L'azione didattica di Aristotele fu un feno
meno unico nella storia del mondo. Per iGreci essa
costitu inoltre qualcosa
di affatto nuovo, che peraltro,
nell'et allora incipiente delle grandi scuole filosofiche,
fece epoca. Stoici, epicurei,
accademici, attribuirono
tutti d'allora in poi maggiore importanza
all'insegna
mento orale che all'esposizione letteraria delle loro dot
trine.
Non possibile seguire sino alla fine irapporti di
') Cicer., top. I, 3.
432 l'et dell'insegnamento
Aristotele con Alessandro. La memoria Sulla colonizza
zione, col titolo tiialogico di Alessandro, dimostra come
essi abbiano durato ininterrotti fino al
tempo
delle fon
dazioni delle citt in Egitto e in Asia. Non pot restar
senza effetto sulle relazioni con Alessandro la catastrofe
di Callistene, accaduta nel 327 1).
Questo nipote di Ari- 'l
stotele, che durante ilsuo soggiorno ad Asso e poi anche >
a Pella era stato suo scolaro e che ancora nell'immi-
?
nenza del passaggio di Alessandro in Asia aveva aiutato
. !
lo zio nella determinazione della lista dei vincitori del- 1
fici, si era, d'accordo con lui, aggregato al quartier ge- .
nerale del re, certamente fin da principio con l'inten
zione di descrivere le sue
gesta. La glorificazione di Ales
sandro, nell'opera a lui dedicata, al pari dell'encomio
di Ermia, manifesta in lui non un'autentica natura di
storico, ma un pi personale interesse al proprio argo
mento, che egli sembra aver approfondito con penetra
zione filosofica senza peraltro coglier dappertutto netta
mente la realt delle cose. Callistene non era un cono
scitore di uomini. Era un dotto di fine educazione let
teraria, non senza talento come oratore e specialmente
come pronto improvvisatore, ed era un filosofo di acuta
intelligenza, ma, secondo il personale giudizio di Ari
stotele, scarso di buon senso, cio di naturale compren
sione delle cose e degli uomini. Per
quanto fautore del
re e, nella sua opera storica, costante difensore di lui
contro l'opposizione della vecchia nobilt macedone, che
disapprovava la politica di Alessandro nei riguardi de
gli Asiatici, egli riusc tuttavia, quando si tratt
della
prosternazione, per un senso intempestivamente
ostentato
di diguit filosofica, a cadere nel disgraziato sospetto di
aver congiurato con quella stessa opposizione, e ad atti-
J Cfr. ora F. Jacoby, artic. Kallislhenes nella
Realenc/cl. d.
class. Allert. del Pauly e Wssowa, X, eoi. 16T4.
ARISTOTELE AD ATENE
433
rarsi cosi lo sfavore del re. La sua posizione alla corte
era invero stata sempre quella di un isolato, non apparte
nendo egli n al partito della nobilt militare macedone
n alla schiera pettegola dei letterati greci del quartier
generale, e appoggiandosi esclusivamente sul favore per
sonale del re.
Quando
questo
gli venne meno, non ebbe
pi difesa, e cadde vittima degli intrighi degli altri.
Che gl'intimi del monarca abbiano pi tardi trovato
qualcosa da nascondere a proposito della rovina di Cal
listene, oggi fuor di dubbio. La colpa non fu affatto
accertata con la normale procedura giuridica, e l'esecu
zione fu uno di
quegli
atti autocratici che Alessandro,
in questo periodo di estrema tensione delle sue forze
psichiche e fisiche, comp, in esplosioni vulcaniche di
atroce furore, anche contro isuoi intimi amici. Per
quanto anche su queste
manifestazioni di umanit infe
riore si potesse stendere il velo della compassione, esse
dovevano oscurare l'immagine del re agli occhi di Ari
stotele, e cancellate dal suo cuore l'affezione che nutriva
per lui. Cerc di conservare il suo equilibrio interiore
usando giustizia, dura giustizia anche nei riguardi delle
debolezze del nipote. La banale opinione degli antichi
non sapeva spiegarsi la precoce morte di Alessandro se
non immaginando che essa fosse stata provocata
dal
veleno fattogli pervenire dal filosofo. Ci non rispon
deva al temperamento morale di un Aristotele. Ma que
sto non toglie che nella coppa della regale amicizia
fosse realmente caduta una goccia di velenosa amarezza.
Certo, anche allora l'esistenza di Aristotele ad Alene
dipese soltanto dalla sorte di Alessandro. Quando
nel
323 venne la notizia della sua morte, nessuno quella
volta voleva crederci; ma quando poi essa fu confer
mata in modo incontrovertibile, per il partito naziona
lista non ci furon pi freni. L'unica difesa degli amici
della Macedonia era stato Antipatro, ma negli ultimi
28.
W. Jaeger, Aristoteli.
434 l'et dell'insilamento
tempi anche questi, al pari di Aristotele, aveva perduto
la fiducia del re, e si trovava proprio in marcia in Asia
Minore, alla volta di Babilonia: aveva ricevuto l'ordine
di risiedere presso la corte, perch il re potesse
averlo
in avvenire sotto gli occhi. Aristotele si sottrasse all'im
provvisa ondata dell'odio nazionalistico e agli assalti del
partito di Demostene fuggendo a Calcide di Euhea. Col
si trovava l'avito possesso della defunta madre, nel quale
egli si trattenne nei mesi seguenti, fino al giorno della
sua morte. Una malattia di stomaco, di cui era affetto,
pose presto termine alla sua vita, nel sessantatreesimo
anno. Sembra che allora egli sentisse prossima la morte,
giacch a Calcide fu scritto il testamento che di lui
ancora possediamo1).
Prima di morire egli dov ancora
vedere come iDelfi, dopo la morte del suo regale pro
tettore, gli rifiutassero le onoranze che gli erano state
concesse in ricompensa della redazione del catalogo dei
Pitionici2). Ma neppure i tumulti di questa et sep
pero scuotere durevolmente l'equilibrio spirituale di
questo filosofo, nonostante la particolare sensibilit del
suo temperamento per le vicende della storia umana.
Ancora una parola circa la sua vita pratica di que
sti ultimi anni. Il suo tutore Prosseno e la sua madre
adottiva erano da lungo tempo defunti. Del figlio di
essa, Nicnore, Aristotele si prese cura paterna e lo
adott. Nicnore risiedeva, col grado di ufficiale, presso
il quartier generale di Alessandro. Nel 324 Alessandro
') Nel testamento si parla solo della scelta di un'abitazione
per Erpillide a Calcide o a Stagira, non ad Atene (Diog., V, 14),
ed anche incerto dove debba essere seppellito Aristotele (V,
16), mentre senza dubbio queste cose sarebbero slate dette altri
menti se le disposizioni testamentarie fossero state date ad Atene
e in tempi tranquilli.
') Framm. 666 R. (lettera ad Antipatro) iircp tv v
(!iTjtfi.a8-vTa)v poi xcct 5>v fjpijpai vv oOttug
ixi *&6 lA15T8 i10'
acpSpa [Xeiv jiip ttTcv pVfTs poi pijSv psiv. 11 frammento
ha tutta l'aria di essere autentico.
ARISTOTELE AD ATENE 435
lo mand in Grecia, latore di una grande ambasciata.
Fu lui quello che dovette annunciare agli Elleni, radu
nati per la festa nazionale ad Olimpia, come Alessandro
pretendesse per s onori divini. A Nicnore Aristotele
aveva destinato, nel suo testamento, la mano dell'ancor
minorenne figlia Pizia, natagli dalla moglie Pizia ormai
da lungo tempo defunta. Dopo molto tempo dalla morte
di costei Aristotele aveva preso in casa una certa Erpil
lide, dalla quale aveva avuto un figlio, di nome Nico-
maco. Nel suo testamento egli si ricorda, con affezio
nata sollecitudine, di tutte queste persone, cme anche
dei suoi scolari. C' qualcosa di commovente nel vedere
come questo esule assesti le faccende della sua casa.
Isuoi pensieri sono dominati dal ricordo della patria
Stagira, della solitaria e lontana casa paterna, delle
figure dei genitori adottivi, dell'unico fratello Arimne-
sto, presto perduto, della madre, che egli aveva innanzi
agli occhi solo nell'aspetto in cui aveva potuto vederla
bambino. Suo desiderio che non si abbiano a separare
isuoi resti mortali dalle osBa della moglie Pizia, se
condo quella che era stata anche l'ultima volont di
lei. Pacate e prive di effusioni sono le disposizioni ma
teriali di questo documento ultimo della vita di Ari
stotele: ma tra le righe esso parla un linguaggio singo
lare, che non ci viene incontro dai testamenti, conser
vati al pari di esso, degli altri scolarchi peripatetici.
il caldo accento di una schietta umanit, ma nello
stesso tempo la manifestazione di un quasi pauroso di
stacco dagli uomini che lo circondano. Sono parole di
un isolato. Una traccia di
questo sentimento si con
servata inuna commovente confessione epistolare di que
sti ultimi tempi, che ha parole d'inimitabile sapore per
sonale. Satp yp aTiTTjg
y.al
poviitT)? eljit, tptXopu'O'Tcpo?
YYova- Nel mezzo della casa rumorosa invecchia un
uomo che vive tutto per s, romito: secondo la sua stessa
436 l'et
dell'insegnamento
espressione, un' individualit ritirata in s medesima,
die nelle sue ore serene si avviluppa nel mondo mera-
viglioso e pur profondo del mito"1). L'aspra e serrata
sua personalit, chiusa a ogni sguardo esterno dietro le
rigide barriere della scienza, qui affiora, svelando il suo
segreto. Anche qui, come per la maggior parte
delle per
sonalit antiche, noi ne sappiamo esattamente quel
tanto, che basta per riconoscere come nella sostanza
non possiamo saperne nulla. Una cosa tuttavia scor
giamo, ed che questa ricca esperienza di vita non si
esaurisce in tutta la sua opera di scienza e d'indagine,
come potrebbe sembrare dopo un'osservazione superfi-
ciale. L'ideale del pio; swp-ctx; affonda le sue radici
in una seconda natura, celata nel profondo della per
sonalit, e attinge ad essa la sua forza. Il ritratto tradi
zionale dell'Aristotele realista, interessato soltanto alle
cose, esattamente il contrario della verit.
Questa
proprio l'et in cui l'Io comincia ad affrancarsi dai
ceppi del contenuto oggettivo della vita, e avverte con
consapevolezza pi che mai chiara come non possa con
tentarsi di un'attivit volta soltanto alle cose. La vita
privata si ritrae dall'attivo concerto della societ nel
suo angolo quieto, erigendovi la sua dimora. Ed anche
nell'anima dell'uomo la vita privata si ridesta, e chiude
. j
la porta
in faccia agli ospiti non desiderati. L'aspetto
di suprema oggettivit, che Aristotele assume costante
mente nelle sue manifestazioni esterne, dipende gi da
*) Framm. 668 R. Per Aristotele (ed eredit platonica) l'e
lemento mitico strettamente collegato con quello filosofico. V.
p. es.
Metaph., A. 2, 982 b17 6 5' xopffiv xat otrcai y-
vostv 5i xai 6 cpiJ.opuS'og (piXaof; ro; low 6 yp pS-og
G-fHsttiu
ex d-aupxoCtov, Ma certo c' differenza fra il ricono
scere clementi filosofici nelle creazioni mitologiche e il tornare
con gioia, al termine di una lunga fatica spesa nella diretta solu-
zione filosofica dei problemi, alla nebulosa forma espressiva del ;V
mito, pi intuitivamente ricca che logicamente chiara, come ap-
1
"5;
punto fa Aristotele nel frammento della sua lettera.
:|i
HI
ARISTOTELE AD ATENE 437
una consapevole distinzione dell'attivit che concerne la
persona da quella che riguarda la cosa ins. Poco tempo
ancora, e la soggettivit, nel possente rigoglio delle sue
forze, spezzer l'argine e trasciner ogni saldo elemento
oggettivo nel ritmo del suo moto interiore. Ilritratto che
le indagini pi recenti hanno riconosciuto come proprio
del filosofo ci mostra una testa di assai singolare strut
tura1). L'elaborazione artistica di essa ha una certa no
bilt convenzionale, ma ciononostante il tratto perso
nale , nel volto, di mia vivacit parlante. Come nella
nota testa di Euripide, lo sforzo del pensiero traspare
dalle rade e fini ciocche di capelli, cadenti sulla fronte
vigorosa. Ma lo sforzo dell'artista, inteso a cogliere l'in
dividuale, non si limitato a fissare tali tratti generici.
Chi guarda la testa di profilo colpito dal contrasto tra
il mento sporgente, con la sua espressione d'inflessibile
energa, sotto la bocca eerrata, e lo sguardo critico ed
osservatore, rivolto a un punto determinato e singolar
mente immune, nella nettezza orizzontale della sua
traiettoria, dall'agitazione passionale della parte infe
riore del volto. L'intensit di questo sguardo penetrante
d quasi un senso di angoscia. L' impressione di alta
spiritualit, risultante dall' intera fisionomia, fin dal
primo momento superata da quella della seria intensit
dell'attenzione, dominante ogni tratto. Tutto disci
plina spirituale. Solo intorno alla Locca ironica giuoca
un'ombra di passionalit, l'unico tratto involontario che
si scopra in questo volto.
A conclusione di tutto ci sia qui riferito il testa
mento di Aristotele, che ci d la sensazione immediata
dell'atmosfera umana in cui egli visse2).
Possa tutto andar bene: ma, per qualsiasi evenien-
Cfr. Studniczka, Ein Dildnis des Arisloteles (Dckanalsprogr.),
Lipsia, 1908.
') Diog, V, 11.
1
438 l'et dell'insegnamento
za, queste sono le ultime disposizioni di Aristotele. Ese
cutore di esse tutte sia, sotto ogni aspetto, Antipatro.
Fino al tempo in cui Nicnore sia in grado di assumere
l'eredit, siano tutori dei piccoli, di Erpillide e di tutte
le sostanze Aristomene, Timarco, Ipparco, Diotele e, se
lo desidera e ne ha la possibilit, Teofrasto. E quando
la fanciulla [la figlia Pizia] sar in et, sia sposata a
Nicnore; se per altro le accadesse qualcosa non ab
bia a succedere, e certo non succeder prima del ma
trimonio, o dopo il matrimonio quando ancora non
avesse figli, Nicnore abbia autorit di disporre circa il
ragazzo e circa tutte le altre cose, secondo ci che ri
chiede la sua e la nostra dignit. Per il resto Nicnore
si occupi della ragazza e del piccolo Nicomaco nel modo
che egli ritenga necessario nel loro interesse, come se
fosse insieme loro padre e loro fratello. Se poi accadesse
prima qualcosa a Nicnore
non abbia ad accadere
o prima che abbia sposato la ragazza o quando l'abbia
sposata, ma senza che ancora ci sia prole, vigano le sue
ultime disposizioni, nel caso che ne abbia lasciate. Al
trimenti, nel caso che Teofrasto voglia prendere per s
la giovane, vigano per lui le stesse disposizioni che per
Nicnore; se no, i tutori soprannominati dispongano,
sentito il consiglio di Antipatro, tanto per la giovane
quanto per il giovane, secondo ci che ad essi sembra
migliore. Itutori e Nicnore si occupino poi, in memo
ria mia, anche di Erpillide, dato che fu brava con me,
per ogni cosa e in particolare nel caso che voglia spo
sarsi, affinch non sia maritata ad uomo indegno di noi.
E, oltre alle donazioni gi fattele, le sia dato un talento
d'argento dai beni da me lasciati
e, se le vuole, tre
ancelle e la giovane servente che ha, e infine, come servo,
Pirreo; e nel caso che voglia abitare a Calcide, le sia
dato
l'appartamento degli ospiti che d sul giardino;
se invece vuole abitare a Stagira, la mia casa paterna.
ARISTOTELE AD ATENE
439
Di queste
due case, quella che essa sceglier per abitare
sar ammobiliata dai tutori nel modo che ad essi sem
bri conveniente e che risponda alle esigenze di Erpil
lide. Nicnore si occupi inoltre anche del piccolo Myr-
mex, affinch egli sia restituito ai suoi in modo degno
di noi, con tutti ibeni che gli appartengono
e che ab
biamo avuto da lui. E anche Ambracide sia libera e le
vengano date, in occasione delle nozze di mia figlia,
cinquecento dracme e l'ancella che ha. A Tale poi, oltre
all'ancella che ha, quella comprata,
siano date mille
dracme e un'altra ancella; e a Simone, oltre il denaro
gi datogli per comprarsi uno schiavo, o si compri un
altro schiavo o si dia il danaro corrispondente. Ticone
sia libero, quando mia figlia si sposa, e cos Filone ed
Olimpio e il bambino di quest'ultimo. Non si venda
nessuno dei figli di coloro che hanno servito presso di
me, ma si mantengano al servizio; e quando siano arri
vati all'et giusta, si mettano in libert a seconda del
loro merito. Si curi poi che iritratti commessi allo scul
tore Grillione siano, appena compiuti, esposti in voto,
quello di Nicnore e quello di Prosseno, che pensavo
ancora di commettere, e quello della madre di Nic
nore; e quello di Arimnesto, gi compiuto, sia esposto
in sua memoria, dato che morto senza figli.
Quello
di
mia madre sia consacrato a Demetra, a Nemea o dove
meglio sembri. Nel luogo in cui io sar seppellito, siano
trasportate
anche le ossa di mia moglie Pizia, secondo
ci che essa stessa dispose. E quando Nicnore sia feli
cemente tornato, dedichi, per
sciogliere il voto da me
fatto per lui, due statue di pietra alte quattro
cubiti,
a
Zeus salvatore e ad Atena salvatrice a Stagira .
II.
L'ORGANIZZAZIONE
DELLA RICERCA SCIENTIFICA
II secondo soggiorno di Aristotele ad Atene costitui
sce il punto culminante della sua evoluzione spirituale.
l'epoca della maturit, quella in cui il pensatore ha
ormai compiuto il suo edificio dottrinale e svolge la sua
attivit come capo di una grande scuola. Essendosi gi
da
tempo esattamente riconosciuta la relazione che lega
gli scritti superstiti alla sua attivit didattica, ma pos
sedendosi d'altronde qualche notizia circa tale attivit
solo per quest'ultimo periodo della sua vita, era spon
tanea l'illazione che tutti itrattati dottrinali avessero
avuta la loro genesi in questa et. La loro redazione
riusciva invero in tal modo costretta nel breve spazio
di tredici anni, ma non si esitava ad aggiungere anche
questa difficolt alla tesi corrente. La quale non pu
esser formulata pi brevemente che con le parole dello
Zeller, ancora considerato come autorit a questo pro
posito: Se poi giusto quello che dalle nostre inda
gini risultato circa la destinazione delle opere aristo
teliche da noi possedute all'uso della scuola, circa il
loro nesso con l'insegnamento del pensatore e circa i
rinvii a scritti precedenti contenuti negli scritti poste
riori, tutte queste opere possono essere state comooste
'
"
I
'!
fk
:.$
L'ORGANIZZAZIONE della SICEf.CA SCIENTIFICA 441
solo ad Atene, durante l'ultimo soggiorno di Aristotele
in questa
citt 1).
Dopo le nostre indagini sul soggiorno di Aristotele
ad Asso non occorre aggiunger altro per dimostrare l'in
sostenibilit di questa tesi. Ma esse ci rendono nello
stesso tempo possbile d' intender pi chiaramente la
posizione peculiare che quest'ultimo periodo della vita
di Aristotele assume nel processo complessivo della sua
evoluzione.
Quando
si riusciti a determinare lo spirito
e la tendenza della sua attivit durante il periodo in
termedio tra idue soggiorni ad Atene, si scorge come
l'ultimo di questi si distacchi molto nettamente dalla
precedente fase evolutiva. Stando all'opinione corrente,
in quest'ultimo periodo dovevano convivere, in breve
spazio, audace spirito speculativo e vasto interesse spe
rimentale. Ora scorgiamo come questi motivi apparten
gano invece ad et distinte. Ifondamenti della filosofa
di Aristotele (nel senso stretto, comune a tutti isuoi
espositori, della parola filosofia, escludente cio tutta
la gigantesca sua attivit di ricercatore nel campo sto
rico della natura e dello spirito) appaiono gi compiuti
nel periodo intermedio della sua vita. Aristotele filosofo
si sviluppa prima seguendo e poi criticando Platone.
Nel terzo periodo egli assume invece un aspetto affatto
nuovo e originale. Egli si volge all'indagine empirica
diventandovi, merc la rigorosa attuazione dei suoi
principi metodici, il creatore di un nuovo tipo di ecien-
*) Ed. Zeller, Philos. d. Griechen, li, 2, 3 ed., p. 153; e
cfr. ernays, Dialogo d. Arist-, p. 128: Tutte le opere superstiti
appartengono all'ultimo periodo della vita di Aristotele; e an-
che e quel poco che si sa circa la loro successione cronologica
dovesse essere una volta accresciuto da fortunate scoperte, la
stessa costituzione intrnseca del loro contenuto esclude ogni spe
ranza di poter far risalire anche l'opera relativamente pi antica
a un'et in cui Aristotele lavorava ancora al suo sistema. Esso ci
si presenta in ogni suo aspetto come un edifcio gi costruito:
in nessun luogo scorgiamo il costruttore ancora all'operai.
442 l'et
dell'insegnamento
-;j
---
?'<,
za. Non poniamoci per ora ilproblema della relazione
che lega questo nuovo indirizzo scientifico alla filosofa
del periodo precedente, e della misura in cui esso costi
tuisce l'attuazione ultima dell'ideale stesso di quella o
in cui invece oltrepassa isuoi limiti. Stabiliamo piutto
sto il dato di fatto che in questa et le discipline filo
sofiche centrali subiscono solo certe modificazioni, ca
ratteristiche per lo spirito intrinseco al nuovo orienta
mento scientifico, mentre la vera e propria attivit pro- t
duttiva di Aristotele si volge al vasto dominio della
natura e della storia.
Questo
anzitutto accertato dalle
1
nuove scoperte papiracee ed epigrafiche, che attendono f
soltanto di essere sfruttate perch se ne traggano le ne- . ;;
cessarie illazioni circa lo sviluppo spirituale di Ari- ; <
Stotele. :
Un'iscrizione onoraria riportata alla luce nel 1895
contiene il decreto dei Delfi di encomiare e coronare
Aristotele e suo nipote Callistene, quale espressione di
./
'
gratitudine per aver redatto una lista completa dei vin
citori dei giuochi pitici, estendentesi dai tempi pi an
tichi fino all'et presente1). Per questo lavoro furono
naturalmente necessarie ricerche d' archivio di entit
considerevole, le quali dovettero acquistare importanza
anche per la storia della cultura e della letteratura. Con
questo lavoro Aristotele, a quanto vediamo, mise piede
su un territorio nuovo. impossibile che questo lavoro .
sia stato da lui compiuto in et molto antica, data la '
collaborazione del nipote, che fu suo scolaro ad Asso e
'
a Pella (v. sopra, p.
432); ma neppure pu essere poste-
;
riore al 334, anno in cui Callistene and con Alessandro
in Asia. probabile che gli archivi dei sacerdoti delfici
siano stati aperti a lui, storico della guerra sacra, nel
l'occasione stessa in cui egli comp le sue ricerche delle
*)
Dittenberger, Sylloge, 3' ed., p. 485.
l'orcamzzazione della ricerca scientifica 443
fonti concernenti le lotte e le trattative con iFocosi,
che non sarebbe stato possibile eseguire in nessun altro
luogo. Ora, che P'AvaypacpV] t>v
Eu&tovixd)V debba esser
stata realmente scritta nel 335-4, poco prima della par
tenza di CalliBtene per l'Asia, risulta da un conto per
l'incisione inpietra di una copia di questa
lista, che si
conservato e che reca la data dell' arconte delfico
Kaphis (331-0). Si tratta di un lavoro di lunga lena:
secondo calcoli moderni, di un pinax di circa sessanta
mila parole. Evidentemente non pu essere stato che
quello di Aristotele e Callistene, la cui incisione in pie
tra si verosimilmente protratta per vari anni1).
L'elenco quindi stato redatto verso la fine del sog
giorno macedonico o sul principio di quello ateniese.
Alla stessa epoca ci riconducono le grandi indagini
antiquarie di Aristotele circa le vittorie aelle Dionisie
urbane e lenee e le Didascalie, cio idocumenti di rap
presentazioni drammatiche ateniesi, che pi tardi for
nirono agli storici alessandrini della letteratura il fon
damento
cronologico per la ricostruzione dello sviluppo
del dramma classico e sui quali si basa tutto ci che
ancor oggi conosciamo circa l'epoca in cui le singole
opere furono rappresentate. Queste
ricerche, fondamen
tali per la storia della letteratura greca, sono state senza
dubbio stimolate dalla trattazione filosofica dei problemi
della poetica.
Rispetto a tale trattazione l'imponente raccolta del
materiale erudito rappresenta mi momento posteriore,
giacch almeno il perduto dialogo Ilepl noivjz&v risale
certo a un'et antecedente. Anche qui la novit consiste
nell'ampliamento della considerazione speculativa mer
c particolari indagini storiche e cronologiche.
Queste
') Cfr. Homollc, Bulletin de correspondence hellnique, XXII,
p. 631.
444 l'et dell'insegnamento
i/
indagini possono essere stale fatte soltanto sul luogo,
nell'archivio dell'arconte: quindi o nel periodo prece
dente la morte di Platone o dopo il 335. Ma l'analogia
con gli altri lavori aristotelici dello stesso tipo assegna
con ogni evidenza le ricerche didascaliche al pe
riodo tardo, e in se anche massimamente plausibile
che ilavori preparativi per tali ricerche, possibili solo
col consenso del governo, siano stati compiuti in con
nessione con la riforma statale del teatro che fu effet-
tuata da Licurgo, il creatore del nuovo teatro in pietra
di Atene, proprio verso la fine del decennio fra il 340
e il 330 1). Come egli fece preparare un esemplare di
stato di tutte le antiche tragedie ed innalzare le statue
dei classici del teatro, curando anche un turno regolare
di rappresentazioni delle loro opere, cos sar stato an
che lui a esporre, incisi in pietra, sulla
parete posteriore
della Stoa dietro al teatro di Dioniso idocumenti degli
agoni drammatici dalla fine del sesto secolo in poi.
Un'opera sui vincitori dei giuochi olimpici, che piut
tosto da porre accanto alla lista dei vincitori pitici e
che procedeva per la via aperta per la prima volta dal
sofista Ippia di Elide col suo elenco dei vincitori, ci
tata nei cataloghi degli scritti di Aristotele; ma nulla
ne rimasto. Probabilmente l'occasione immediata per
la sua composizione fu offerta da quella del catalogo
*) L'interesse per l'evoluzione dei principali sTi} letterari, in
particolare della tragedia e della commedia, che presso iperipa
tetici postaristotelici si estese poi ad altri generi, come risulta da
Orazio, Ars poet., 73, 275, traspare dai resti epigrafici delle Ntxai
(C. I. A., II, 971), in cui menzionata la prima esecuzione di
xfflpoi. Questo scritto non fu generato, come le AiSaaxcttai,
dall'interesse erudito per la storia del teatro, ma solo da quello
ufficiale che lo stato ateniese aveva per la persona dei coreghi
e dei 5i5oxa?.oi vincitori e per la loro cpuXtj. Esso dimostra per
ci nel modo pi evidente il nesso che lega queste ricerche
alla riforma statale del teatro compiuta da Licurgo. Sulle Dida
scalie cfr. G. Jaehmann, De Aristotelis ddascaliis.
Diss., Gottin
ga, 1999.
I.'ORCANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
dei pitionici, ed essa sar quindi parimenti
stata redatta
nel secondo periodo ateniese.
La stessa cosa pu esser dimostrata
verosimile, come
gi si notato, per la gigantesca impresa costituita dalla
silloge delle 158 costituzioni statali. Imezzi esterni e le
forze ausiliarie necessarie per un lavoro cosi esteso, a
cui deve aver collaborato un numero considerevole
di
ricercatori, erano a disposizione di Aristotele solo quan
do dirigeva una grande scuola, in cui poteva addestrare
collaboratori adatti al suo scopo. infatti escluso che
questo lavoro possa esser stato compiuto durante il sog
giorno alla corte di Pella, perch col egli poteva
tro
vare s imezzi finanziari, ma non la necessaria collabo
razione scientifica. La Costituzione degli Ateniesi, che
tornata alla luce agli inizi del secolo scorso e che
costituiva il primo libro, scritto personalmente da Ari
stotele, dell' opera complessiva, fornisce col materiale,
particolarmente copioso, della storia attica un esempio
del metodo che doveva essere seguito in tutta l'opera.
Dalle allusioni cronologiche risulta che questo libro non
stato pubblicato prima del 329-8 1). Di conseguenza
l'elaborazione delle altre Costituzioni, delle quali ci re-
') La questione concernente la data di composizione della
IloXitsia "A-9r|vao)v stata inutilmente dibattuta per vario
tempo dopo la scoperta dello scritto, al pari di quella della sua
autenticit. La soluzione vera era 6tata trovata subito da C. Torr,
The date of
the Constitution of
Athens, in
Athenaeum, nr. 3302
(cfr. Classical Revue, V, 3, p. 119). II terminus post quem c co
stituito dalla menzione dell'arconte Cefisofonte
(329/8), l'ante quem
dal fatto che il cap. 46 ricorda la costruzione di triremi
e
di
quadriremi, ma non di quinqueremi, le quali peraltro in un'iscri
zione del 325 (C. I. A-, II, 809 d 90) sono citate come gi esistenti,
la nuova PooXrj prendendole in consegna dal precedente anno uffi
ciale. Di conseguenza non oltre il 326 dev'essere stata presa quella
decisione di costruire quinqueremi, che Aristotele ancora non cono
sce. La Ilotrsia 'A&rjvaov dunque stata scritta tra il 329/8 e il
327/6 (cfr. ultimamente
Wilamowitz, Aristoteles und Allien, I,
p. 211, n. 43). Rinuncio ad esaminare i tentativi, affatto erronei, di
far risalire lo scritto al decennio fra il '69 e il '50.
l'et dell'insegnamemc
sta un quadro ricco e vario in una serie assai numerosa
di frammenti, cade solo negli ultimi anni della vita di
Aristotele, dato anche che egli ahbia potuto vederla
compiuta. Con questa colossale silloge, nata da un ac
curato lavoro di ricerca singola utilizzante le fonti sto
riche locali, Aristotele raggiunge il punto estremo nel
suo processo di allontanamento dalla filosofia platonica.
La nozione singola diventata quasi scopo a se stessa.
In maniera anche pi chiara partecipano dello stesso
carattere iProblemi omerici, di contenuto puramente I
letterario-filologico, raccolti dagli editori a quanto sem- |
bra in sei libri, iquali anticipano l'esegesi e la critica
f
alessandrina e che in realt, insieme con la creazione .
\
della poetica e della cronologia letteraria e con lo stu-
.
}
dio della personalit dei poeti, hanno fatto di Aristotele
il creatore della filologia, trasferita poi ad Alessan
dria da Demetrio di Falero, scolaro del suo scolaro
Teofrasto. Che a questo ultimo periodo appartengono
anche i Aixauipata rtewv e i Npipa (Sapjtapix
dimostrato per i primi
(e
quindi reso abbastanza
verosimile anche per gli altri) da un frammento men- ;
zionante la spedizione che Alessandro Molosso fece
nell' Italia meridionale e in cui egli trov la morte.
Questa
morte viene citata da Eschine, nel processo
-
per la corona, come avvenimento recentissimo, e cade
perci sulla fine del decennio tra il 440 e il 430, anzi
senz' altro in quest' ultimo anno, secondo l' opinione
pi diffusa1). H metodo scientfico dell'esatta ricerca
empirica, che caratterizza queste opere, nel mondo
greco del tempo qualcosa di affatto nuovo ed originale.
') Cfr. Arisi, frairim. 614 R.; Aesch, Ctes, 212. La spedi
zione di Alessandro il Molosso citala come esempio storico nei
AtxaitpaTa, ed evidentemente non pi una novit. IN6[i'.|ii,
col loro Interesse etnologico, antiquario, mitologico, dovrebbero
appartenere allo stesso periodo erudito di Aristotele. Essi fanno pre
ciso riscontro alle IIovcetai.
L'oitCAMZZAZIONE DELLA RICERCA SCTENTIF1CA 447
Neanche Democrito regge al paragone. Inquesto campo,
in cui egli si muove con maggiore libert rispetto al
metodo speculativo del platonismo, Aristotele diventa
l'archegeta di quella schiera di ricercatori universali,
che s'inizia con la filologia alessandrina di Callimaco e
di Aristarco e che dalla Rinascenza in poi ha sopravvis
suto, a intervalli secolari, in singole figure d'eccezione
del tipo dello Scaligero. Ma certo Aristotele li supera
di gran lunga tutti per l'originalit della metodologia,
cio del principio della forma applicato alla realt sin
gola, con cui idealmente provvede allo sviluppo scienti
fico d' interi millenni, e merc la versatilit del genio,
che gli permette
di abbracciare, insieme con la storia
e la teoria della cultura, anche l'opposto emisfero della
scienza naturale.
Come maestro non tanto dellatptXcaocpla quanto
della
laTOpla nel senso greco di questa parola, secondo cui
essa designa, oltre alla conoscenza storica del mondo
umano, anche la conoscenza empirica della natura e
della vita naturale, egli si manifesta anche attraverso
le indagini naturalistiche di quest'ultimo periodo. Fin
dall'antichit noi riuniamo in un solo complesso isuoi
scritti di scienza naturale come appartenenti ad un ge
nere unitario, e poniamo la Storia degli animali e gli
scritti sulle loro parti e sulla loro generazione
sullo
stesso piano della Fisica, del De cacio e del De genera
tions et corruptione. Quanto
ai Problemi, si dovr certo
esitare a sostenere che essi siano antichi, dato anche
che la silloge che ne abbiamo non identica a quella
che fu di Aristotele, essendo in parte opera dei suoi
scolari, immediati continuatori del lavoro d'indagine
empirica iniziata nel Peripato. Ci significa infatti che
anche gli autentici Problemi di Aristotele cadono con
molta probabilit nel periodo tardo, al quale "oparten-
gono anche per la loro ricchezza di materiali e per la
448 l'et dell'insecnamento
molteplicit e variet del loro interesse scientifico per
le cose singole. gi pienamente plausibile in se clie la
fisica celeste del De caelo e la trattazione speculativa
dei concetti fondamentali della Fisica sia, come gi mo
strammo, di origine accademica; mentre non conviene
a questo periodo speculativo l' approfondimento delle
questioni singole, che in gran parte non hanno alcuna
relazione con la filosofia. Ma dovremo ancora procedere
oltre. Anche la Storia degli animali, considerata nella
sua struttura spirituale, non del tipo ideale della Fi
sica, bens sta sul piano della silloge delle costituzioni.
Essa una raccolta di materiali, che sta agli scritti sulle
parti e sulla generazione degli animali, iquali la ela
borano indagando le ragioni dei fenomeni, esattamente
come la silloge delle costituzioni sta ai libri pi tardi,
ed empiristicamente orientati, della Politica, Essa ne
costituisce il sostrato. Perci vale per la Storia degli
animali quello stesso che per iProblemi: essa reca in
s le tracce pi evidenti di diverse mani, e gii ultimi
libri sono opera di pi giovani membri della scuola,
che si fanno avanti come continuatori, integratori e
perfino correttori e critici del maestro. verosimile che
anche questo lavoro eia stato . organizzato come quello
per la silloge delle costituzioni, e distribuito fin dal
l'inizio tra pi collaboratori. ormai difficile stabilire
esattamente quale parte abbia avuta di persona Aristo
tele nella redazione della Storia degli animali. La bo
tanica, connessa strettamente con la zoologia, fu da lui
affidata a Teofrasto, che ne fece
oggetto di trattazione
indipendente. Difficilmente accettabile l'idea, sostenuta
a questo proposito, che la Storia degli animali si possa
concepire prescindendo dalle ricerche della spedizione
di Alessandro. Gi le notizie circa animali allora ignoti
in Grecia, come gli elefanti, e circa la loro vita presup
pongono le esperienze della spedizione indiana, e certo
I.'ORCANIZZ.IZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA 449
in molti altri paBsi deve essersi conservato l'influsso di
l
questo enorme ampliamento dell' orizzonte conoscitivo
; greco, per quanto oggi non possiamo pi accorgercene.
Quanto
grande sia stato il frutto delle spedizioni asia-
5 tiche per la botanica di Teofrasto stato dimostrato
5 dal bel libro del Bretzl, che pure non esaurisce l'argo
mento1). Tutti gl'indizi sono quindi in favore dell'as
segnazione delle opere zoologiche a un'epoca tarda del
l'evoluzione di Aristotele. Non c lecito, e conduce a
prospettare
le cose in maniera affatto ingannevole, tra
sferire inseno all'Accademia tutta questa organizzazione
della ricerca scientifica particolare. Come si c dimo-
;
strato, gli "O[ioc di Speusippo, che trattavano essenzal-
i mente di piante, non contenevano indagini botaniche
nello stile di Teofrasto, bens materiali per il metodo
: della divisione in generi e specie, raccomandato dal vec-
. chio Platone nel
Sofista
e nel Politico e adottato nel-
: l'Accademia soltanto ai fini della logica classificatoria,
non gi per interesse a quei singoli esseri e alle loro
; condizioni di vita 2). Lo schematismo di questo metodo
*) M. Bretzl, Botanische Forschungen des Alexanderzuges,
Lipsia, 3903.
*) II primo libro Sulle parti degli animali, che contiene
una generale introduzione metodologica la cui importanza per
Ja conoscenza degl'ideali scientifici dominanti nell'ultimo periodo
dell'attivit aristotelica sar pi oltre messa in rilievo, prende
ampiamente posizione (capp. 24), dal punto di vista tipico del
vecchio Aristotele, rispetto a tale metodo accademico della di
visione. Egli critica severamente, tanto sotto l'aspetto logico quanto
per la sua inservibilit ai fini di una scienza
zoologica degna del
nome, che non voglia strappare a forza l'uria dall'altra le specie
animali tra loro coerenti, il principio della dicotomia, teorizzato
da Platone nel Sofista e nel Politico e poi applicato dai suoi di
scepoli, e particolarmente da Speusippo, alle
singole specie natu
rali. Certe esteriorit del procedimento accademico della divisione
erano slate gi da lui criticate, dal punto di vista logico, nella
giovanile Topica (Z 6, 144 b 32); ma,
com'egli
stesso
riferisce, la
contraddizione col rilevala era gi venuta in luce in seno allo
stesso ambiente accademico. Del tutto indipendente da questi in
flussi, e derivata dall'esperienza da lui personalmente compiuta
29.
W. Jaio8, Aristoteli.
450 l'it
dell'insegnamento
manifesta chiaramente il suo influsso anche nella zoo
logia e nella botanica di Aristotele e di Teofrasto: ma
non giusto considerare la classificazione del regno ani
male e vegetale come un vero e proprio portato di esso.
Molto maggior peso, in confronto, ebbe per lo sviluppo
della scienza naturale il fatto che qui, per la prima
volta, ci si preoccup seriamente di osservare e descri
vere il singolo essere e il suo (Sfo?. Proprio in questo
campo Aristotele e la sua scuola compirono un'opera
imponente, nonostante qualche errore, inevitabile agli
inizi di tali ricerche e data la molteplicit e il diverso
valore delle fonti a cui dovettero attingere. Anche la
Meteorologia sar, nel suo complesso, un'opera di que
sto periodoJ). Inquesto campo, un caso particolarmente
interessante di trattazione di un problema singolo co
stituito dallo scritto sulla causa della piena del Nilo,
l'autenticit del quale non pu ormai esser messa pi
in dubbio.
Questo
scritto ci riporta quasi in presenza
del metodo di lavoro seguito da Aristotele in questo
periodo, quando egli comunica ai suoi collaboratori i
risultati delle osservazioni pi recenti compiute nel
corso superiore del Nilo, e alla fine dell' esposizione
esclama: La piena del Nilo non c pi un problema,
perch ormai stato osservato che il fiume si gonfia a
causa delle piogge 2).
nei lunghi studi intorno al regno animale, invece la critica
che s' incontra nel De parlibus animalium e in altri passi degli
a>ix. Essa il risultato degli sforai da lui eseguiti per giungere
a un nuovo tipo di divisione, conformato secondo le esigenze
della realt oggettiva. L'incompiutezza di questo sistema, la
quale spesso ha indotto a negare la sua stessa esistenza, dipende
dalla sua tarda genesi in seno all'evoluzione scientifica di Aristo
tele. Cfr. Jurgcn Bona Meyer, Aristoteles' Tierkunde. Ein Beitrag
zur Geschickte der Zoologie, l'hysiologe und alien Philosophic,
Berlino, 1855, p. 53 e 70 segg.
*) Cfr. sopra, p. 415, n. 1.
*)
Convincente sembra a me l'ottima trattazione di J. Partsch,
Des Aristoteles Buck Vcber das Steigen des Nil, in Abhandlun-
L'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTxKICA 451
Con le ricerche sulla natura organica e sugli esseri
viventi strettamente connesso il gruppo d'indagini a
cui Aristotele dedica lo scritto Sull'anima e il complesso
delle singole trattazioni antropologiche e fisiologiche che
ad esso si ricollega. Gi nella connessione della psico
logia con le teorie della percezione e dei colori, della
memoria e della reminiscenza, del sonno e della veglia,
del sogno, della respirazione, del moto degli esseri vi
venti, della brevit e longevit della vita, della giovi
nezza e della vecchiaia, della vita e della morte, si ma
nifesta una comune intonazione fisiologica: la psicolo
gia la conclusione necessaria di questa serie d'inda
gini, in quanto
l'anima vien concepita come principio
della vita, studiata ora in tutte le sue manifestazioni
caratteristiche. Secondo quanto
attestano indizi di ogni
genere, questa serie di scritti giunta solo progressiva
mente allo stato di completezza in cui ci si presenta
oggi1). La sintesi odierna di queste ricerche preliminari,
di carattere pi generalmente fisiologico, con gli iwr/.
in un solo quadro complessivo del mondo organico non
che un'artificiosa costruzione pedagogica, determina
tasi in tale forma solo nell'ultimo periodo dell'evolu
zione aristotelica. Si tratta ora di vedere in che misura
la psicologia stessa partecipi al generale processo evo
lutivo da noi descritto, e se sia possibile trovare punti
di riferimento cronologici per essa e per i cosiddetti
Parvo naturalia.
Carattere spiccatamente platonico e poco naturali*
gen d. schsischen Gesellsckaft
d. Wissenschaften, Phil. Histor.
Klasse, XXVH, Lipsia, 1910, p. 553. La sopra citata conclusione
del libro, il cui testo greco superstite in Fozio (Partsch, p. 574:
ox-ci npi(3Xv]|i iotiv. iipS-T) y&p -javspij) 6ti ig OcT'iv aSE'.)
caratteristica di Aristotele: cfr. infatti Metaph., H 6, 1045 a 24
o&xi-ci inopi* Sgetsv Sv etvai t Cqtofuvov, ecc.
')
Cfr. Brandis, Griechisch-rmiscke Philosophic, II b 2, pa
gine 1192 segg., e il mio articolo Das Pneuma m Lykeion, in
Hermes, XLVili, p. 42.
452 l'et
dell'insegnamento
..1
stico manifesta a questo proposito il terzo libro del
De anima, contenente la teoria del votk.
Questa
teoria
uno degli elementi pi antichi e costanti della filo
sofia aristotelica, e uno dei principali fondamenti della
sua metafisica. Anche la trattazione che ne data nel
De anima
penetra profondamente nella sfera metafisica.
La dottrina psicofisica dell'anima fu costruita posterior
mente, a quanto sembra, intorno ad essa e su di essa,
senza che per ci risaltasse colmata la lacuna che di
stingue queste due parti dell'opera, nate da due diversi
momenti spirituali. Si potrebbe obiettare che questo du
plice carattere domina l'intera filosofia di Aristotele, e
pu bene esserle stato peculiare fin dai suoi primordi.
Contro questa obiezione sta peraltro il fatto che la teo
ria del vo; risale alla tradizione platonica, mentre in
Platone non si trovano, o si trovano solo deboli accenni
a una psicofisica, e il fatto che anche in quelli tra i .;)!
primi scritti di Aristotele che riescono pi accessibili J
alla nostra conoscenza s'incontra una elaborata teoria v
del vo; inquadrata nel sistema speculativo del suo pia-
toniamo giovanile, mentre non dato scoprirvi ancora '
traccia di una psicologia empirica.
Quest'ultima
, per
intero, creazione originale di Aristotele.
Quindi
non
certo un caso se, per esempio, l'etica si basa su una :v:;
psicologia ancora molto primitiva, cio sulla teoria del-
le parti razionali ed irrazionali dell'anima.
Questa
con
cezione antiquata, che appare gi nel Protreptico, non
altro che quella platonica. Per ragioni pratiche, Ari
stotele la lasci immutata anche pi tardi, non ostante
che nel frattempo egli fosse proceduto molto pi in
nanzi nel campo psicologico e non riconoscesse pi, in
generale, una distinzione dell'anima inparti (ppi) 4>uy y,;).
Nell'etica si poteva operare comodamente con le anti
che formulazioni, senza che ne risultassero errori es
senziali, tali da compromettere il risultato stesso della
l'organizzazione
della ricerca scientifica 453
teoria morale: e gli antichi schemi platonici erano or
mai troppo saldamente collegati coi concetti fondamen
tali della sua etica. Aristotele sentiva tuttavia di dover
chiedere venia per questa semplificazione del proble
ma1). La costruzione dell'etica sarebbe riuscita proba
bilmente diversa se al tempo dell'elaborazione dei suoi
principi fondamentali la psicologia aristotelica avesse
gi raggiunto quel grado di evoluzione in cui essa ora
ci si presenta. Questo
contrasto dei diversi stadi evolu
tivi pu ancora esser constatato in qualche punto. La
rielaborazione della teoria platonica della reminiscenza,
data nell' Eudemo, e la fede nell'immortalit indivi
duale, che s'incontra in quell'opera ed anche nel dia
logo Ikpl tptXoaocpta;, cio ancora sul principio dell'et
media dell'evoluzione aristotelica, non sono conciliabili
con la psicofisica del De anima. Esse presuppongono che
dopo la morte continui a sussistere proprio quella parte
della coscienza umana, che secondo la posteriore opi
nione di Aristotele invece legata al corpo5). Inoltre
non si pu negare che l'etica dell'et media, con la sua
concezione teologica della chiaroveggenza e della man-
tica, sta sullo stesso piano del Espi cpiXooocpfas, mentre
*) Nell'Eliciemea (B 1, 1219 b 28) Aristotele pone, ancora
senza preoccupazione alcuna, la vecchia partizione schematica del
l'anima in Suo ppr; uxfls va you
i-wtxovta
a fondamento
della teoria dell' psttj, allo stesso modo che nel Protreplico, che
egli qui segue alla lettera (cfr. sopra, p. 335). 11 passo corrispon
dente nella redazione posteriore (Elh Nic., A 13, 1102 a 23 segg.)
rileva invece, con aria di scusa, come gli uomini politici e pra
tici, quando vogliono giudicare esattamente le questioni dell' pmj,
abbiano bisogno di un minimo i(non pi) di scienza psico
logica: t fp Irci
jislov ifaxpigov pytoSazspov lato?
atlv tSv
ttpOKStfivcov. XsYetz'.
5 nepl a-trjg xal iv zolf
4(OTepiKoT{ iyoig
pxotivvtog Svia, xat
XP'JO-ciov
a-rotg. E segue la teoria, consueta in
tale contesto, delle parti razionale e irrazionale dell'anima con un
breve accenno alle difficolt implicite nel concetto dei (lpt; 4UX?-
S'intendc quindi come in ci che segue Aristotele eviti con inten
zione questo termine.
*) Cfr. sopra, p. 64 segg.
454 l'et
dell'insegnamento
lo scritto sulla divinazione per mezzo dei sogni, che
appartiene alla serie delle indagini fisiologiche aggiunte
in appendice al De anima, implica un distacco assoluto
ila quelle concezioni platonizzanti. La
forma
mentis qui
puramente naturalistica, e del tutto aliena da preoc
cupazioni per il problema etico; e pi importante del
/atto che Aristotele rigetti la sua precedente opinione
qui il metodo che tale rigetto giustifica. Egli ricorre
persino a riflessioni di psicologia degli animali: che
un chiaro sintomo del mutato spirito di
questa nuova
considerazione delle cose, ormai del tutto spogliata d'in
tenzione mistica1).
Questo spirito, d'altronde, compene
tra per intero idue primi, classici, libri del De anima,
con la loro teoria della percezione sensibile e con la
concezione dell'anima quale entelechia del corpo orga
nico, che ad essa si riconnette. Dalla dottrina del
\o0?
questa non avrebbe mai potuto nascere. Parimenti de
cisive nella loro novit sono le indagini degli opuscoli
fisiologici. Non affatto un'illazione audace, ma anzi
cosa di semplice evidenza che essi
appartengano allo
stesso tardo stadio evolutivo a cui risale lo scritto sulla
divinazione per mezzo dei sogni, tra essi inserito come
studio speciale su quel vecchio problema platonico2).
3)
In questo interessantissimo saggio Aristotele tenta di dare
Una spiegazione naturale, per via psicofisiologica, del fenomeno dei
sogni veridici. Egli non esclude inlatti che si diano casi di pre
visione del futuro durante il sogno, ma nega ormai che tale pre
visione discenda da sfere metafisiche. Contro la fede nei sogni
inviati dalla divinit sta il fatto che tali sogni non sogliono pre
sentarsi n ai saggi n ai buoni, ma anzi spesso a uomini di
scansa levatura morale, che per ci possiedono una speciale pre
disposizione psichica, e il fatto che anche gii animali sognano (ac
cenno, questo, alla Storia degli ammali, A 10, 536 b 28). Aristotele
dimostra la connessione del contenuto onirico con impressioni sub
conscie o conscie della veglia, e indaga
minutamente i motivi
della deformazione delle immagini nel sogno. Cfr., a proposito
della mantica nel Ilepl
cpiXoocuptag, sopra, p. 214 segg.; nella
prima etica, sopra, p. 323.
*) Non plausibile l'idea che Aristotele, anche nell'et in cui
tuttavia professava quella
concezione mistica della mantica, po-
li
?
l'orcnizzazione della ricerca scientifica 455
Tutto questo complesso di ricerche si ricollega tanto
intrinsecamente, dal punto
di vista del metodo e del
l'inquadramento speculativo, quanto
cronologicamente
alle grandi opere sulle parti e sulla generazione degli
animali. Anche se, dunque, la redazione superstite del
terzo libro del De anima e quella degli altri due libri
e dei Parva naturalia costituiscono un tutto unico for
malmente e cronologicamente (quesito a cui io non oso
rispondere n in un senso n nell'altro, mancando ap
pigli per poterlo fare), indiscusso resta il fatto che le
concezioni circa il
vo?
sono pi antiche e la metodo
logia e la costruzione delle altre parti sono pi recenti,
appartenendo a un diverso stadio evolutivo, anzi a un
diverso atteggiamento
della mentalit aristotelicaI).
Non meno ricca di conseguenze, tra le opere com
piute da Aristotele nell'ultima fase della sua attivit
scientifica, fu la fondazione della storia della filosofia
e di quella delle singole scienze: grande opera d'in
sieme, di mole enciclopedica ma d'ispirazione unitaria,
nella cui monumentale struttura acquista per la prima
volta figura sensibile quella unit delle scienze che effet
tivamente rispondeva
alla vita scientifica del Peripato.
Per una concezione dello sviluppo cosmico del tipo di
quella di Aristotele la storia del sapere umano, nel gra
duale processo del suo perfezionamento,
costituisce il
grande tema finale della scienza. Con ci essa attinge
lesse trovarsi per tutto il resto gi sul piano della sua psicologia
naturalistica, e che quindi un'eredit platonica persistente solo in
quel punto l'avesse tuttavia indotto ad un compromesso. La mu
tata opinione circa la mantica piuttosto solo la logica conse
guenza di una mutata forma di considerazione della realt psi
chica in generale.
') Nonostante che i Parva naturalia trattino
degli esseri vi
venti solo dal punto di vista delle loro generali condizioni fisio
logiche, senza entrare in particolari, la ripetuta menzione dei
principi di classificazione
degli animali adottati negli_ i>ixd mo
stra chiaro come quete partizioni, nate dalla diretta ricerca scien
tifica, stiano gi alla base dei Parva naturalia.
456 l'et dell'insegnamento
fi
______
'<!$
-,|-
il grado in cui impara a comprendere geneticamente ft
a stessa, nella sua finalit interiore, come una pianta i-
o un essere vivente. L'esecuzione di
questo compito, che *
soverchiava di gran lunga le forze di un individuo e
doveva perci, come la descrizione del mondo delle
forme politiche o quella della natura organica, esser ',1
ripartita tra pi collaboratori, mirabile. Teofrasto fu
incaricato di scrivere la storia dei sistemi fisici e meta
fisici (nel senso moderno di quest'ultima parola), a cui
egli dedic un'esposizione in diciotto libri. In essa egli
espose l'evoluzione di entrambe quelle forme scientifi
che, nell'et pi antica collegate in maniera indissolu
bile, ordinando sistematicamente i diversi problemi e
procedendo da Talete e dai fisiologi fino ai suoi con- 2
temporanei. Iframmenti superstiti, e specialmente quelli ?
che si sono potuti ricavare dall'analisi delle opere dei '
dossografi della tarda antichit, ci permettono ancora
"
oggi di valutare l'ampio lavoro di silloge e di compa-
razione storica compiuto da Teofrasto. Esso
poteva es- , :j
ser condotto a termine solo col sussidio della biblioteca
di Aristotele, cio della prima collezione libraria di
mole considerevole di cui si possa dimostrare l'esistenza
in Europa; e per la sicurezza documentaria delle ricer
che, personalmente condotte, su cui si fondava ebbe per
tutta l'antichit importanza definitiva. In seguito que
st opera fu pi di ima volta ampliata, la sua esposi-
zione fu proseguita volta per volta fino all'et contem
poranea, ne furono compilati estratti e il suo contenuto
:
fu rifuso nelle pi diverse forme, finche nella tarda
{
antichit, estremamente meccanizzato e impoverito, fu
ridotto a compendio scolastico per iprincipianti. Ma '
accanto alle <E>uatx>v Sat erano anche le opere storiche
'.?
di Eudemo, concernenti l' evoluzione dell' aritmetica, '
della geometria,
dell'astronomia, forse anche della teo-
logia, tra le quali specialmente la prima fece testo per
!
l'organizzazione della ricerca scientifica 457
tutta l'antichit, risalendo ad essa la maggior parte
delle
posteriori testimonianze classiche sulla storia della ma
tematica pi antica; inoltre, la storia della medicina
scritta da Menone per incarico di Aristotele, e della
quale un ritrovamento papiraceo ci ha di recente resti
tuito un estratto. Tutto questo lavoro di storia delle
scienze pu esser stato compiuto solo nell'ultimo pe
riodo dell'evoluzione aristotelica, nel quale iprimi saggi
di storia della filosofa, che s'incontrano nel primo libro
della Metafisica, vennero proseguiti secondo il pi vasto
disegno adottato con la silloge delle costituzioni, e le
ricerche particolari nel campo della natura organica
ebbero avvicinato anche la medicina alla sfera degl'in
teressi scientifici della scuola.
Sotto la direzione di Teofrasto furono ulteriormente
curate le relazioni della scuola peripatetica
con le pi
famose scuole contemporanee di medicina, come quella
di Cnido e pi tardi quella di Alessandria. Ilmatrimo
nio di Pizia, figlia di Aristotele, con Metrodoro, rappre
sentante della scuola di medicina di Cnido, che insegn
in Atene (senza dubbio nel Liceo) dove fu 'suo scolaro
il grande medico Erasistrato, consolid queste
relazioni
con un rapporto che potrebbe dirsi dinastico. L'uso che
gli scritti aristotelici fanno, come si pu continuamente
constatare, delle opere d medicina, e non solo d quelle
della tendenza ippocratica di Coo ma ancora pi di
quelle dei medici pneumatici dell' indirizzo siciliano
(Filistione, Diocle), attesta che questi studi erano col
tivati nel Liceo, in connessione con le ricerche fisiolo
giche e antropologiche. Anche il materiale d'insegna
mento che si trovava elaborato nell'opera
medica delle
'AvccTOpaf, e a cui Aristotele rimanda spesso nei suoi
scritti zoologici, fu messo insieme allora. Era un'opera
illustrata, una specie di atlante, perch s'incontrano ac
cenni espliciti alle figure e ai disegni che vi si trova-
/
I
458 l'et
dell'insegnamento
vano. La necessit di tale materiale didattico per l'in
segnamento prova che nel Liceo, a differenza di ci che
avveniva nell' Accademia platonica, eran tenuti corsi
regolari di anatomia e fisiologia. Nel caso di Platone, le
conoscenze mediche che egli presuppone nel Timeo e
isuoi rapporti con Filistione sono piuttosto un fatto
isolato. Anche in questo campo il vero organizzatore,
quello che fa posto definitivamente alla ricerca empi
rica considerandola come fine in s, Aristotele.
Per noi moderni la ricerca scientifica particolare non
ha pi nulla d'insolito: il fertile grembo dell'espe
rienza, sola capace di generare l'autentica conoscenza
della realt. perci necessario un vivace, anzi eccezio
nale, senso storico per sentire concretamente quanto
aliena e urtante per la media coscienza greca del quarto
secolo fosse invece questo procedimento scientifico, e
quanto rivoluzionaria apparisse allora quella innova
zione. Solo a poco a poco il pensiero scientifico pot
crearsi imetodi che oggi gli sono familiari come il pi
comune strumento. A istituire esperienze particolari, me
todicamente regolate e proseguite, aveva insegnato la
pi recente e rigorosa scienza medica dell' uscente
quinto secolo, e poi, nel quarto secolo, l'astronomia de
gli Orientali coi suoi cataloghi e con le sue registrazioni
continuate per secoli. Ipi antichi filosofi della natura
sapevano soltanto interpretare, in modo divinatorio, sin
goli fenomeni sorprendenti. Il contributo dell'Accade
mia, come si detto, non era stato quello della silloge
e della descrizione particolare, bens quello della divi
sione logica in generi e specie universali. Certo, nei suoi
ultimi anni, Platone aveva insistito vivamente sull'esi
genza di non arrestarsi a mezza strada nel processo della
divisione, ma di dividere fino all'indivisibile, per amore
di quella compiutezza esauriente che sola poteva ren
dere sicuro un tale metodo. Ci si riferiva tuttavia an-
I.'ORCANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA 459
cora alle specie, e non ai fenomeni sensibili. L'indivi-
sibile di Platone restava pur sempre un universale. Ari-
stotele fu il primo che pass a studiare la realt
sensibile come portatrice dell'universale (IvuXov e!So$).
Anche rispetto alla precedente empiria dei medici e
degli astronomi, questo
ideale scientifico costituiva qual
cosa di nuovo.
Con fatica e pazienza indicibili egli dov condurre
isuoi ascoltatori sulla nuova via, e gli occorse pi d'una
parola di persuasione e di rimprovero per educare i
giovani,
abituati all'astratto giuoco concettuale dell'ora
toria attica e che per educazione liberale intendevano
la capacit di dominare retoricamente e logicamente i
problemi politici, o tutt'al pi, nel migliore dei casi,
la scienza delle alte cose {exujpa), a studiare con in
teressamento obbiettivo insetti e lombrichi o a conside
rare senza ripugnanza
estetica, in occasione di sezioni
anatomiche, le viscere degli animali. Nell'introduzione
dell'opera Sulle parti degli animali egli indirizza a que
sto genere di ricerca isuoi ascoltatori con sottili chia
rimenti metodologici, esprimendo insieme, in forma
energicamente suggestiva, la gioia che arreca la scoperta
di questo
nuovo mondo di misteriose leggi, in cui si
rivela l'arte della natura1). Trascriviamo queste parole,
affinch esse, quale confessione della nuova fede scient
fica di Aristotele, siano valutate come ad esse spetta
nella storia dello spirito. Egli parla dell'attrattiva, assai
diversa, della speculazione platonicamente concepita e
dell'empiria raccomandata da lui. Sebbene egli cerchi di
render ragione ad entrambe, tuttavia si avverte verso
guai lato inclini, se non il suo cuore, certo almeno il
suo interesse scientifico, quand' egli cerca d' infondere
queste
idee nell'animo dei suoi scolari.
Queste
pagine
') De part, anim A 5, 644 b 22.
460 l'et dell'insegnamento
sono state scritte in un'et in cui lo spirito metafisico
*
e speculativo della sua cultura giovanile costituiva an- i
cora l'armatura strutturale della sua visione del mondo, |
ma era ormai
passato affatto in seconda linea nell'effet-
tiva sua produzione scientifica.
:
j
Delle sostanze che si trovano nella
natura, le une ]
sono ingenerate e imperiture per tutta l'eternit, le altre
,
partecipano della nascita e della morte. Accade, ora,
V
che di quelle prime realt, venerande e divine, noi ab
biamo minori nozioni (e infatti per le indagini che
intorno ad esse si potrebbero fare, e in cui noi deside
reremmo di conoscere la verit, pochissimi sono ipunti
di
partenza che alla nostra percezione appaiano evi
denti), mentre a proposito delle realt
transeunti, vege- ;"'
tali e animali, noi abbiamo maggiori possibilit di co-
noscenza, crescendo noi nello stesso loro ambiente.
Ognuno pu infatti acquistare molte nozioni a propo-
sito di ciascuna di tali specie viventi, solo che
abbia la
buona volont di lavorarvi assiduamente attorno. En
trambe le forme di studio hanno la loro
attrattiva. Se i
attingiamo col nostro sapere anche una minima
parte
di quelle superiori realt, tuttavia, per la sua intrinseca
importanza, questa conoscenza, ci pi cara che quella
di tutto il nostro mondo emprico, nello stesso modo
che quando capita di scorgere anche una piccola
parte
,
dell'essere di cui si innamorati, ci riesce pi dolce
che la precisa visione di molte altre cose, anche impor
tanti. Le realt inferiori, essendo pi e meglio
accessi
bili alla conoscenza, vengono d'altronde ad avere il so
pravvento nel campo scientifico, e giacch esse sono pi
vicine a noi e pi conformi alla nostra natura, la loro
scienza finisce
per costituir quasi un equivalente di
quella filosofia, che studia le realt divine. Ora, poich
di
queste ultime abbiamo gi trattato, ed a loro
riguardo i
abbiamo
esposto la nostra opinione, ci resta da
parlare
;
l'organizzazione della ricerca scientifica
461
dell'altra natura, di quella
vivente, possibilmente senza
tralasciare alcuna cosa, pi o meno importante
che essa
sia. Infatti anche nel caso degli esseri meno
favoriti dal
punto di vista dell'apparenza sensibile la natura che li
ha creati d gioie indicibili a coloro che, consideran
doli scientificamente, sanno comprenderne le cause, e
sono schiette nature di ricercatori. Del resto sarebbe
inconcepibile ed assurdo se, pur godendo nella contem
plazione delle riproduzioni
artistiche in quanto
in essa
implicita anche la contemplazione dell'arte che le ha
prodotte, p. es. della pittura e della plastica, non pre
diligessimo assai di pi la considerazione delle stesse
realt naturali che di quelle riproduzioni sono l'oggetto,
specie essendo in grado di conoscerne le cause.
Non ci si deve quindi aunoiare infantilmente quan
do si studiano gii animali di minore importanza.
In
tutte le realt della natura c' qualcosa di meraviglioso.
E giusta il motto clie si racconta Eraclito abbia rivolto
agli stranieri iquali volevano parlare con lui, ed en
trando si erano fermati perch l'avevano visto riscal
darsi alla stufa (grid infatti loro che si facessero co
raggio ed entrassero, perch anche col esistevano
iddii),
conviene che chi si accinge allo studio di una singola
specie animale non lo faccia di malavoglia, bens pen
sando che in ogni
realt compreso un elemento del
l'universa natura e bellezza. Nelle opere della natura, e
anzi massimamente in esse, vige infatti non il caso ma
la finalit: e questa finalit, per cui si viene
all'esistenza,
ha la natura e la funzione della bellezza. Che se qual
cuno si invece convinto che lo studio degli altri esseri
viventi non ha importanza,
deve pensare la stessa cosa
anche a proposito
dello studio di s medesimo: ed
pur vero che, allora, neppure le parti d cui composta
la specie umana, sangue carne ossa vene e simili, si
possono guardare senza avvertire sensazioni spiacevoli.
?;
462 l'et dell'insegnamento
--
.1
Si deve inoltre tener presente clie clii discute di una .
qualsiasi parte od elemento della realt non fa men-
zione del suo aspetto materiale Ji ha interesse per que
sto, bens mira alla forma (poctp) nella sua totalit.
Quel
che importa la casa, non imattoni la calce e le
travi: cos, nello studio della natura, quel che interessa
la realt complessiva e totale di un dato essere, e non
quelle sue parti, che separate dall'essere di cui sono
|
costituenti neppure esistono.
Queste
parole fanno l'effetto di unprogramma scien
tifico e didattico della scuola peripatetica. Esse ci spie
gano lo spirito che anima le opere degli scolari di Ari
stotele, pei quali la metafsica fa certo ancora un passo
indietro rispetto a quello che gi compie qui, finch
poi nella seconda generazione, quella d Stratone, viene
senz'altro messa alla porta.
Questa
ulteriore evoluzione
della scuola s' intende solo in funzione dell' interesse
quasi esclusivamente empiristico, che qui esprime ilvec
chio Aristotele, e che rivive nei suoi discepoli cos come
negli Accademici si erano perpetuati gl'ideali del vecchio
Platone. Certo, in Aristotele non si tratta di ima com
pleta esclusione della metafisica e della fisica celeste,
ch anzi questo passo dimostra proprio come il corso
su tali argomenti abbia preceduto quello sul regno ani
male. Ma innegabile la
completa mutazione del suo
atteggiamento spirituale e lo
spostamento del centro di
gravit del suo mondo interiore rispetto al tempo in
cui egli si era sentito anzitutto come il rinnovatore
della filosofia platonica del
soprasensibile e come ini
ziatore di una nuova teologia speculativa. Nella Meta
fisica quest'ultima appare ancora, in forma affatto pla
tonica, come l'unica scienza esatta, perch basata solo
sul puro V0D5; c se Aristotele, quando ne scriveva la
pi antica redazione, la chiamava una scienza concessa |j
soltanto alla conoscenza divina, egli manifestava tutta-
l'organizzazione della ricerca scientifica
463
via nello stesso tempo l'orgogliosa certezza che niente
nella realt fosse impervio allo sguardo della
ragione e
che della potenza
di questa non s potesse
mai avere
un'idea abbastanza alta.
Quanto
diverso il linguaggio
dei suoi ultimi anni! Egli non parla pi del mondo
fenomenico come di quello che pi conoscibile per
noi, a cui si deve contrapporre
l'essenza della realt
come quella che pi conoscibile di sua natura ; giu
stifica la metafisica solo richiamandosi all'eterno deside
rio che l'animo umano ha di penetrare
isegreti del
mondo invisibile e incorruttibile, ed disposto a conten
tarsi anche di unsolo frammento di questa celata
verit,
mentre assegna con chiare parole la priorit scientifica
(?]
'jKspoy) alla ricerca empirica. la
lode della devozione per le cose piccole: la confessione
di questa fede
scientifica, che nella zoologia e nella sil
loge delle costituzioni, nella storia del teatro e nella
cronaca dei vincitori pitici giunge alle sue pi alte
creazioni.
Ilnesso ideale che lega il metodo e le finalit scien
tifiche di questi ultimi anni col platonismo riformato
del decennio che intercorre fra il350 e il 340 costituito
dal concetto della forma, cio dell' ivoXov
sISog, tipico
di Aristotele e da lui elevato, anche nel passo che si
visto, a vero termine ideale della ricerca naturalistica.
Di anno in anno questo
concetto gli
si sempre pi
trasformato da oggetto di gnoseologia
ontologica in
vivo strumento di ricerca, diretta nelle pi diverse di
rezioni. Non si presenta quindi pi
nell'aspetto di prin
cipio metafisico
(quando s'intenda questo
termine non
nel senso nostro ma in quello
aristotelico) bens come
immediato oggetto
dell'esperienza
concettualmente in
terpretata.
Del resto anche ilconcetto della finalit, con
cui esso legato, non affatto per Aristotele un con
cetto intrinsecamente
metafisico, potendo anzi risultare
464 l'et dell'insegnamento
soltanto dall' esperienza. Il campo d* applicazione del
concetto della forma si estende quindi molto al di l
dell'ambito delle essenze immanenti clie appaiono nella
metafisica aristotelica, e che a rigore sono limitate al
numero delle entelechie, cio degli organismi, del mon
do naturale. Nel passo sopra citato Aristotele spiega
tale concetto merc l' analogia della forma artistica.
Quest'ultima
offre l'appiglio per applicare il concetto
della forma anche ai prodotti della civilt umana, i
quali sono in
parte di natura puramente
tecnico-arti
stica e in parte stanno al confine tra la creazione spiri
tuale consapevole e la spontanea formazione naturale,
come lo stato e tutti gli aspetti della vita sociale e mo
rale. Col concetto della forma Aristotele concilia l'an
titesi opponente il pensiero puro alla ricerea empirica,
la yGi<z
alla
~xvi5-
La sua empiria non consiste nel
l'accumulamento meccanico di materiali morti, ma nella
determinazione della gerarchia morfologica della realt.
Egli organizza e vince l'illimitatezza fenomenica, su cui
Platone sorvola, salendo dalle pi minute e impercet
tibili tracce di forma e di costituzione organica a pi
comprensive unit formali. Cos sul fondamento del
l'esperienza si eleva l'edificio di un universale sistema
del mondo, la cui ultima causa motrice e finale a sua
volta una suprema forma, la forma di tutte le forme,
il pensiero nella sua creativit. Per Platone lo scopo
della spiritualizzazione totale della vita poteva esser
raggiunto solo merc il ritorno dello spirito dalle appa
renze all'esemplare: per Aristotele essa in conclusione
coincide con la specializzazione della scienza, intesa nel
modo che si detto. Infatti ogni scoperta di una nuova
forma, fosse anche quella dell'ultimo insetto od anfibio
o quella della pi piccola parte dell'arte o della lingua
umana, rappresenta un passo innanzi nel progressivo
dominio dello spirito sulla materia, e con ci nella tra-
l'organizzazione della nicruCA scientifica 465
duzione del reale in razionale. Niente esiste nella na
tura, fosse anche la cosa pi insignificante e spregevole,
che non contenga in e qualcosa di mirabile: e colui,
che con gioiosa meraviglia lo scopre, un fratello spi
rituale di Aristotele.
30
TV. J-ikOEH, Ari'/'tcll.
in.
LA TRASFORMAZIONE DELLA TEORIA
DEL PRIMO MOTORE
La teologia di Aristotele ha subito, ancora nell'ul
timo periodo dell'evoluzione spirituale del suo autore,
una modificazione importante, evidentemente collegata
con la pi tarda rielaborazione della
Metafisica.
In que
sta occasione stato infatti trasformato il nucleo pi
antico di tale scienza, nella quale si conservava pi te
nace l'eredit platonica J), cio la teoria del motore im
mobile e della sua relazione coi moti circolari degli
astri. Nell'ultima redazione, come si mostrato2), la
vera e propria rielaborazione della parte principale
della teologia non fu portata a compimento: tuttavia si
conservato un ampio brano ch'era destinato ad essa,
e che gli editori hanno pi tardi inserito nel libro A,
a cui esso si ricollegava dal punto di vista del con
tenuto.
Gi ilBonitz aveva dedotto, dall'apparente mancanza
di ogni relazione esterna del libro col resto della Meta
fisica, che esso non apparteneva alla conclusione del-
3) Cfr. sopra, p, 186 segg.
') Cfr. sopra, p. 300.
fi'
LA TEORIA DEL PRIMO MOTORE 467
l'opera, ma costituiva una trattazione indipendente, la
quale egli pensava di dover far risalire a un'et ante
riore1); e questa determinazione cronologica ci ri
sultata altrimenti confermata dalla segnalazione dei
rapporti che legano illibro A alla redazione pi antica
della
Metafisica
e alle sue formulazioni teoriche2). Al
l'attribuzione dello scritto a un'et antica si oppone pe
raltro la menzione di Callippo, scolaro di Eudosso, che
s'incontra nell'ottavo capitolo3). Per quanto scarsa 6a
la nostra conoscenza del famoso astronomo e dei dati
cronologici della sua biografia, tuttavia secondo ogni
verosimiglianza egli si incontrato con Aristotele solo
durante il secondo soggiorno di quest'ultimo ad Atene.
L'unico
punto fermo per la cronologia di Callippo
dato dalla grande riforma del calendario attico, a com
piere la quale egli era stato invitato dal governo ate
niese4). La nuova era, che suole prender nome da lui,
s'inizia nell'anno 330-29. in questa epoca, quindi, che
Callippo deve aver lavorato per un certo tempo
ad
Atene, e naturalmente aver ripreso le relazioni con gli
ambienti dotti del luogo, determinate dalla sua cono
scenza di Eudosso. Ci risulta, con tutta la certezza che
si pu desiderare, gi dalla maniera in cui Aristotele
parla di lui inA 8. Egli poteva infatti riferire in quella
forma circa le modificazioni che nei riguardi del sistema
delle sfere di Eudosso proponeva Callippo solo nel caso
') Bonitz, Comm. in Arst. Metapk., p. 25; e cfr. sopra, p. 294.
Cfr. sopra, p. 294 segg.
*) V. per ci gi O. Apelt, nella sua recensione della mia
Entstekungsgesck. d. Metaph. d. Arist., in Berliner Philolog. 1To-
cfvcriscfirift, 1912, col- 159Q.
4) Dell'et di Callippo tratt brevemente il Boeckb, Vierjihr-
liche Sonnenkreise d. Alt., p. 155, senza per tener conto dei passi
della
Metafisica. Circa l'era stabilita da Callippo cfr. ora l'articolo
nella Real-EncyclopSdie del Pauly e Wissowa, s. v. Kallippische Pe-
riode, dove peraltro manca per errore Farlicolo su Callippo in
generale. 'Esso merita uno studio a parte,
e anche le reliquie delle
sue dottrine sono ancora da raccogliere.
468 l'et
dell'insecp:amento
che avesse discusso personalmente questi problemi con
l' astronomo, nell' ambito della scuola. E in generale,
come risulter chiaro in seguito, furono proprio queste
discussioni, e gli stimoli intellettuali che cosi egli ri
cevette da parte delle ricerche astronomiche, che co
strinsero Aristotele a trasformare la sua teoria dei mo
tori astrali. La forma verbale dell'imperfetto, di cui egli
si serve quando parla della modificazione apportata da
Callippo al sistema di Eudosso, non si spiega che in due
modi: o significa soltanto che Aristotele aveva attinto
la sua conoscenza di tale ipotesi da precedenti conver
sazioni con Callippo, o implica, oltre a ci, che Callippo
inquel tempo
non era pi in vita. E giacch Aristotele,
nello stesso contesto, usa l'imperfetto anche parlando
di Eudosso, il quale com' noto era gi morto da lungo
tempo e parimenti aveva conosciuto di persona Aristo
tele, la cosa pi verosimile che entrambe queste con
tingenze valgano anche per Callippo1). Tanto pi tarda
vien quindi ad esser l'et dell'ottavo capitolo, che pu
3) Metaph., A 8, 1073 b 17: E&SoSo; [lv o5v
Y/Xfou
xal
xatpou xv tpopv iv xptslv x '. !)
sx ' evai cr'paipaij.... KXXixrcos
5 xv [lv tMoiv xfflv ctfaip&v xv axv Ixi&txo ESdjjq)....
x 8 Jttj&og T<>
|iv
xofj 4ig xal x<p xoO Kpvou x a&x xelvcp
nsSCSo, x 8 Ctp xal xg asXvjvg 8o
<sxo
ixv TtpOjO-sxag
etvai otpaEpaf, x cpaivpsva st pXXti
xi
ttoStiiosiv. La stessa forma
verbale dell'imperfetto usata da Aristotele quando parla di con
cezioni esposte oralmente da Platone, p. cs. in A 9, 992 a 20
xoxcp [lv
O'jv xip
Yvst
xal cspdx.szo HXtfov ( 5vtt [-ea)(is-
xpix Sfpaxi, kXe i &pfp>
TFal1tl5S'
toOxo 8 itoXXxig
x Itisi x{ xpous ypajijijic
-
D'importanza decisiva per la com
prensione dell'imperfetto il noXXxtg che qui gli esplicita
mente aggiunto, e che quindi da sottintendere anche nell'altro
passo concernente Eudosso e Callippo. Per questo imperfetto come
tempo designante la tradizione orale della scuola cfr. p. es. IIspl
ijjoug III, 5 (su cui Wilamowitz, in Hermes, XXXV, p. 49 n. 2).
Simile forma hanno le reminiscenze dell'et accademica, p. es. in
Metaph., Z 11, 1036 b 25 (Socrate
il giovane) e iti Eth. Nicom.,
K 2, 1172b9-20 (Eudosso).
Quel che nell'antichit si sapeva circa
i motivi delle modificazioni arrecate da Callippo al sistema di
Eudosso risaliva alla tradizione orale trasmessa al Liceo da Eu-
demo: cfr. Eutfemo, frainm. 97, p. 142 Spenge!.
LA TEORIA DEL PRIMO MOTORE 469
esser stato scritto solo durante l'ultimo soggiorno di Ari
stotele ad Atene, probabilmente dopo il 330 *). La de
terminazione di questa data di estrema importanza
per la conoscenza dell'evoluzione intellettuale di Ari
stotele. Infatti o il capitolo nato contemporaneamente
all'intero libro A e in questo caso diventerebbe dubbio
tutto quello che si
argomentato per provare l'anti
chit della dottrina contenuta in tale libro (v. sopra,
p. 298). Oppure la nostra dimostrazione dell'esistenza
di una specifica forma dottrinale, propria della meta
fisica pi antica, vale anche per il libro A e allora l'ot
tavo capitolo non pu avere originariamente fatto parte
del libro, ma stato aggiunto soltanto pi tardi nel
luogo che occupa.
Ora, tanto inconfutabile la corrispondenza della
dottrina esposta nel libro :A alla concezione pi an
tica della metafisica, tanto d'altro lato sicuro per chi
ben guardi (e cori stato fin dall'antichit) che l'ottavo
capitolo non s'inquadra organicamente nel suo contesto,
essendo invece un corpo estraneo. Resta tuttava ancora
da arrecare la vera e propria dimostrazione della realt
di questo stato delle cose, sospettato da gran tempo da
') Secondo Simplicio (in Arist. de cacio, p. 493, 5 Heihcrg)
Callippo, venuto ad Atene, fu collaboratore di Aristotele: KX-
Xtwtog 8 4 Koixt;v IIoXepApxf
aoo/oXaoaf
x$
E)8ou
yvtopiiitp
xal [iex* Ixstvov (scil. E55oov)
sic
"Afrfivag X-iov x$
"AptoxotXet
ctip<aTs|5I<o x bn zoS Eviigoo epeSHvza cv
x$
"AptoxoxXst
Biop&opsvij xs xal -npooavartXv]p(5v. Che ci non possa essere
accaduto nell'et accademica, ma solo in quella in cui Ari
stotele dirigeva gi la sua scuola, risulta non soltanto dall'espli
cita distinzione di questo soggiorno di Callippo dal noto soggiorno
ateniese di Eudosso (367), ma anche dal fatto che egli vien detto
scolaro di Polemarco, quindi scolaro di uno scolaro di Eudosso.
Inolttc se le cose non stessero cosi non sarebbe citato Aristotele
come eolui col quale Callippo collabor, ma piuttosto
Platone.
Tutto ci rimanda al tempo in cui Callippo compi la sua riforma.
Le notizia di Simplicio risale a una tradizione erudita (la
Storia
dell'astronomia di Eudenio, utilizzata a quanto sembra di seconda
mano, attraverso Sosigene: cfr. Simpl., 1. c., p. 488, 19), non po
tendo essere stuta ricavata soltanto dal passo della
Metafisica.
y
470 l'et dell'insegnamento
sngoli critici. Ma mentre a questo proposito ei finora
sempre partiti dal contenuto astronomico del capitolo,
noi muoviamo invece dallo stile.
Il libro A (cfr. sopra, p. 295) la minuta di un
discorso, non destinata affatto all' uso altrui. Contiene il
soltanto accenni fondamentali, messi insieme in forma |[
schematica, talora giustapposti solo con un ripetuto
pst lauta Stt...., senza che ai periodi sia stata data
stilisticamente l'ultima mano1). Difficile a decifrare
anzitutto la prima parte, fisica, che espone i presup
posti della teoria del primo motore. Ma anche la se
conda parte, che contiene questa teoria, presenta diffi
colt non molto minori: ci che sempre stato lamen
tato, data la fondamentale importanza dell'argomento.
Ogni spiegazione evidentemente riservata all'esposi
zione orale. Non c' da avere il minimo timore che
Aristotele abbia usato in una conferenza un greco di
tal genere, nonostante che qualche lettore, non cono
scendo di lui altro che questi brani, possa venerarli, con
sacro orrore, come esemplari di autentica laconicit ari
stotelica.
Quale
fosse il suo vero modo di parlare risulta
dal capitolo ottavo, il quale, a differenza di tutto ilresto
del libro, ci si presenta completamente rifinito. Tale
diversit linguistica lo differenzia cos nettamente dal
suo contesto, che dobbiamo ricercare un motivo di tale
fenomeno.
In questo capitolo Aristotele discute la questione se
sussista solo un'unica entit del tipo del motore immo
bile, o se ce ne sia un numero maggiore, onde tali en
tit vengano a costituire un genere. Fa alcune osserva
zioni sulla preistoria del problema concernente l'esatta
*) Cfr. Melaph., A 3, 1069 b 35 e 1070 a 5, e la giustapposi
zione di argomenti con Iti, y.b.1, Spa 8i, poirns S o xa[
specialmente nei primi capitoli, ma anche per es. in cap. 9, 1074
b21; 25; 36; 38; 1075 a
5; 7; cap. 10, 1075 a 34; bli; 16; 28; 34.
LA TEORIA DEL PRIMO MOTORE
471
determinazione matematica del numero delle apai. In
fine egli espone la tesi secondo la quale, come al cielo
delle stelle fisse occorre per il suo movimento un eterno
motore immobile, cos anche gli altri moti composti,
che nel cielo compiono ipianeti, esigono caso per caso
un motore immobile. La natura degli astri infatti
etema, e presuppone per il suo moto un'altra realt
eterna, la quale al pari degli altri deve possedere un
essere indipendente, giusta il principio che ci che pre
cede la sostanza (oca) non pu essere che a sua volta
una sostanza. Per ogni astro devono essere ammessi
tanti motori quanti sono imovimenti che esso compie,
e cio, dato che nel sistema di Eudosso, a cui Aristotele
aderisce, per ogni movimento presupposta una parti
colare sfera, debbono esserci esattamente tanti motori
immobili quante sfere. Ilcalcolo del numero delle sfere
di competenza
dell'astronomia e non della metafisica:
ci che naturalmente non significa che l' astronomia
abbia poi in alcun modo a che fare con l'ipotesi del
motore immobile in s considerata. L'origine di questa
ipotesi infatti puramente
metafisica. Ilimiti della
metafsica vengono per altro valicati da Aristotele quan
do egli (e questo
lo scopo principale della sua tratta
zione) interviene nei calcoli degli astronomi e cerca di
dimostrare come n il sistema di Eudosso, n il perfe
zionamento operatone
da Callippo bastino a spiegare
tutte le forme dei moti planetari. Eudosso aveva calco
lato 26 sfere, con Callippo il numero era salito a 33.
Aristotele con la sua ipotesi delle &vsXtftouaai acpaTpai
le aument rispettivamente a 47 e a 55.
Questo
sguardo d'insieme sul contenuto del capitolo
astronomico basta per far vedere come esso non soltanto
per ilsuo stile linguistico ma anche per il suo stile me
todologico non quadri col suo contesto. Totalmente di
verso lo spirito della teologia dei due capitoli prece-
472 l'et dell'insecnamento
') Mutaph., A 7, 1072 a 24, cfr. Pkys-, 8 5, 236 b 14 segg.
.
denti. 11 motore immobile, di cui col si parla, muove
da solo il cielo, e servendosi di esso, cio del semovente,
come di paov muove il mondo delle cose, il cui moto :,',C
deriva soltanto dall'esterno1). Ilsettimo capitolo studia
la costituzione e l'essenza del principio supremo: esso j.'i-'1
spirito immateriale, atto puro, vita serena e beata
senza alcuna interruzione. Ad esso attribuita ima oafa
la quale eterna, immobile e trascendente rispetto ad
ogni realt percepibile per mezzo dei sensi. Non pu
avere n grandezza n estensione, bens unit indivi
sibile, impassibile e immutabile. Sulla base di queste
sue qualit essenziali il principio supremo riceve il pre
dicato di freg. Nel concetto di Dio infatti per noi
contenuta l'idea di un essere eterno, vivente, perfettis
simo. Ma tutti questi predicati convengono per Aristo-
tele al vo0$, giacch non soltanto esso la cosa pi
perfetta ed eterna, ma l'attivit dello spirito vita .
'
;*
Ora, questa deduzione dell'assoluto tanto scarna e
tanto poco esauriente, da suscitare immediatamente una
serie di domande che Aristotele lascia senza risposta:
ma ilsuo impeto argomentativo di energia trascinante,
:,r-
sotto la spinta dell'afflato religioso. Irresistibilmente esso j;
procede verso la questione posta dal nono capitolo: :
qual il contenuto di questa attivit del
ve?
e quale
relazione sussiste tra il contenuto del suo pensiero e la .
sua perfezione? Se non pensa nulla, riposa, ed quindi
tutt'al pi potenza, ma non pura attivit; se pensa una
realt diversa da s medesimo, pensa qualcosa che
meno perfetto di lui, e diminuisce con ci la sua per
fezione. Cos Aristotele trae d'un balzo isuoi ascoltatori
fino alla determinazione ideale che necessariamente se- ,
x'
gne dal concetto dell'essere divino, cio perfettissimo:
;
i
i; '
:;;V
V
(,A TEORIA DEL PRtMO MOTORE 473
il pensiero pensa s stesso, ed eternamente gode, in que
sto atto creativo, la sua assoluta perfezione.
Ora, in questo
ininterrotto processo di pensiero s'in
serisce l'ottavo capitolo, spezzandolo in due parti. Se lo
si toglie, tra icapitoli settimo e nono non risulta alcuna
soluzione di continuit. Dopo la lettura del capitolo ot
tavo riesce invece impossibile ripigliare l' argomenta
zione speculativa
interrotta col capitolo settimo. Dalle
tempestose
altezze della speculazione e della religiosit
platonica cadiamo improvvisamente
sul piatto terreno
delle sottigliezze calcolatorie, proprie della sofisticheria
degli specialisti. Simplicio aveva ragione quando osser
vava come una simile indagine convenisse piuttosto alla
fisica e all'astronomia che alla teologia1), perdendosi
essa in questioni
affatto accessorie c dimostrando assai
maggior interesse per 1' esatta determinazione del nu
mero delle sfere che non comprensione del fatto che
la barocca moltiplicazione del tipxov xtvov nell'eser
cito dei 47 o 55 motori astrali pregiudicava necessaria
mente la posizione divina del supremo motore e ridu
ceva l'intera
frsoXofta
a semplice questione di meccanica
celeste. Cos Simplicio accolse l'interpretazione di que
sto brano astronomico nel commentario al De caelo, e
da Sosigene a Ideler esso rimasto un tema prediletto
degli
astronomi2).
Quando
per Valentino Rose volle
trasferire l'intero libro A dalla
Metafisica
alla Fisica,
egli si bas a torto, oltre che sull'ottavo capitolo, sul
carattere egualmente fisico dei cinque capitoli della pri
ma parte8). E gli sfugg come Aristotele avesse bisogno
J) Simpl, in Arist. de caelo, p. 510, 31.
') Sosigene presso Simpl., I. c., p. 498, 2 segg.
') Val. Rose, De Aristotelis librorum ordine et auctoritale,
p. 160. Il Rose considera la costruzione della dottrina teologica
direttamente sulla base della precedente trattazione fisica (costru
zione che, per tale
immediatezza, egli giustamente trova caratte
ristica) come opera di un peripatetico di et posteriore a Teo-
474 l'et dell'insegnamento
di una base per la teoria del primo motore, e come
in origine la
ffsoXoffa
fosse costruita, in forma imme
diata e affatto estrinseca, sul fondamento della dottrina
dell'oofa fisica. In funzione di pietra dello scandalo
resta quindi soltanto il capitolo astronomico, e in luogo
di eliminare per causa sua l'intero libro pi ovvio
controllare la provenienza del capitolo stesso. Molto pi
giusto era il procedimento del Lasson, il quale trasfer
l'intero brano astronomico dal testo nelle
note, e restitu
cos il nesso tra il settimo e il nono capitolo1). Di fatto
esso un'aggiunta, che pu essere stata compiuta solo
dai postumi editori degli scritti aristotelici. Nel suo con
tenuto, certo, esso strettamente connesso col problema
del Tcprtov xivoOv, Ma gi l'ampiezza, affatto smisurata,
con la quale trattato un problema accessorio in seno
a una conferenza che dappertutto si limita a tracciare
le grandi linee d a divedere come questa trattazione
debba essere stata scritta per un diverso e pi ampio
contesto. Data dunque la concordanza degl'indizi costi
tuiti dall'interruzione del procedimento logico, dal cri
terio stilistico e dall'intimo contrasto tra la tarda ge
nesi della
parte astronomica e il carattere arcaico del
frasto, che aveva gi il falso %
concetto della metafisica come
scienza [isti z
90
aud. Naturalmente egli ritiene che autentica
dotteina aristotelica sia soltanto la metafisica dell' osta. La si
tuazione storica delle cose quindi da lui addirittura capovolta:
in realt lo stadio evolutivo rappresentato dal libro A precede
la metafisica dell'oftata.
*) Aristotele' Metaphysik. ins Deutsche iibertragen von Ad.
Lasson (Jena, 1907), pp. 17S-76. Il Lasson si contenta peraltro di
separare dal testo solo la parte centrale del capitolo (1073 b8-
1074a 17), cio quella che propriamente contiene il calcolo del
numero delle sfere, lasciandovi invece il principio e la fine del
capitolo stesso: 0 che significa che non si accorto dell'inscindi
bile unit del brano tanto dal punto di vista dello stile quanto
da quello del contenuto. Il tratto centrale porla necessariamente
con s anche gli altri due. Col suo espediente il Lasson voleva
del resto venire incontro solo a una sua esigenza personale, non
avendo egli scorta la ragione storica delia soluzione di conti
nuit che qui si presenta.
LA TEOK1A DEL PRIMO MOTORE 475
libro
A estremamente plausibile la congettura che
l'inserzione non sia stata compiuta da
Aristotele1). Si
tratta dello stesso metodo che gli editori della Metafi
sica hanno seguito anche in altri casi. Ora, giacche Ari
stotele,
elaborando, la posteriore redazione della Meta
fisica, giunto proprio fino alla soglia della
teologia,
nell'ottavo capitolo del libro abbiamo evidentemente
innanzi a noi un brano della rielaborazione di questa
parte
finale, il quale ci mostra quanto poco Aristotele
fosse rimasto pago, anche in questo
caso, della sua pri
mitiva opinione. Egli ricostru infatti ancora una
volta,
durante l'ultima
rielaborazione, la teoria dei motori
astrali.
La teologia del pi antico stadio evolutivo, da noi
incontrata nel IIspl cpiXoaolas, non conosceva ancora la
teoria dei motori astrali. Giacch in tale opera l'etere
non ancora l'elemento che per natura si muove
circolarmente, e le stelle son mosse solo dalla volont
delle loro anime, bisogna ammettere che allora Aristo
tele pensasse ancora semplicemente all'animazione degli
stessi corpi celesti senza ritener necessario per ciascuno
di essi un certo numero di motori, corrispondenti al
numero delle sfere (cfr. sopra, pag. 186). Dalla conce
zione platonica egli si era allora allontanato solo in
quanto ammetteva al di sopra del Jtpcxos opavcg un
motore immobile, il quale, eterno in s, provocava
l'eterno moto del mondo. Con questa teoria egli supe
rava la concezione dell'anima cosmica, la quale muove
s stessa e il cui moto, come quello di tutti gli esseri
semoventi che l'esperienza ci fa conoscere, ha avuto
!) Con ci non peraltro allatto provata la non autenticit
del capitolo, seconde, quanto da gran tempo credevano invece di
dover ammettere
singoli critici, che avevano riconosciuta l'incon
gruenza di questo brano: come p. es. J. L. Ideler (figlio), Arstot.
Meteor., I, p. 318 segg- (Non cos, invece, Ideler padre, Ueber
Endoxos, in bhandlungett d- Berliner Akademie, hist.-phiJ, Zelas
se, p. 49 Begg.),
$
I
476 l'et dell'insegnamento
j?<
_______ __
una volta inizio. Ma questa' teoria del motore celeste li
implicava giacch Aristotele, a quanto sembra, aveva 4;
sempre ammesso 2) con Eudosso l'esistenza di sfere per
ipianeti che anche per ciascuna di queste orbite
(cpopai) svolgentisi al disotto del cielo venisse postulato
un motore speciale, per analogia col motore immobile.
Infatti se esisteva soltanto il motore supremo, ci si do
veva aspettare che tanto la sfera delle stelle fisse quanto ''A
le altre sfere si muovessero nella stessa direzione.
Que-
: ?
sta l'obiezione che muove Teofrasto, nel cui fram-
S
mento metafisico iproblemi della meccanica celeste 1
1
hanno una posizione centrale2). Anche allora c'erano ?'
aristotelici iquali tenevan fermo all'idea dell'unico mo- t
tore; e quale fosse la ragione ce lo insegna ancora Teo
frasto, giacche prosegue: Ma se per ogni sfera sussiste
un diverso motore, e si ha quindi una pluralit di prin
cipi, non si capisce pi come dalla cosiddetta tendenza
perfettissima pioi) di ciascuna di esse possa
') Cfr. De caelo, B 9, 12 e specialmente 293 a 5-8. Qui Ari
stotele afferma esplicitamente ohe i corpi celesti sono animati
(essi hanno npSi
S e : v. 292 a 18-21), ma l'animazione non
un attributo delle sfere, bens degli stessi corpi celesti, che
'
'
noi erroneamente consideriamo come semplici corpi e come mo
nadi inanimate esistenti nello spazio.
Qui non si parla dunque
dei motori delle sfere, ma della teoria platonica delle anime
astrali, condivisa da Aristotele nel suo periodo giovanile, come
fi dimostrato in base al Hapl qpiXooixpiaj. Che il nucleo fon
damentale dei libri De caelo sia di genesi antica stato gi pro
vato (cfr. sopra, p. 40 1 segg.). Anche l'ammissione di una ~pftg
e u>ij degli astri connessa con la concezione platonica.
3) Theophr., Melaph., p, 310 Br. t 84 jim laESi'
X-fou
Servai rrXsiovog mspl rpcstuj, nota xal ttvtov, itmSrj trXstro
t
xoxXix, xal at tpopal -pxov tiv Oitevavriai, xal -t vvoxov
xal o5 yjipii cpavg. et ts yp v t xivoSv, fixonov t TcdvTa
tv
aTijv (scil. xivstoOai xtvrjuiv)- et ts xaO" Ixaatov liepov
(sci!,
t xivoSv ijTiv) at t* &pxl nXsiouj,
(Sa
ts t opfiovov
aTjv
eg Jpegiv tvxiov t
v p(OT>;v o68ap(5g avtpv. t 84 xat
t JtXijOog twv acpaipSv atxtag [istova CjtsI Xoyov. o fp 8
Tiv sTpoXi-iflv (scil.
X-fo; txavg ativ). Segue la critica ,'i
del concetto della irpeaig o 5ps|ic; pisTij, eredit platonica
che -A
Aristotele aveva sempre conservata (cfr. sopra, p. 200 segg.),
anche
dopo aver abbandonato la teoria delle anime astrali.
(>v
'
1
LA TEORIA DEL PRIMO MOTORE 477
risultare il loro accordo generale. Anche la questione
del numero delle sfere esge una pi profonda
tratta
zione che ne indaghi la causa, giacche quella che ne
dnno gli astronomi non soddisfacente.
Egli segnala
poi la difficolt implicita nel concetto aristotelico della
8pe!;iS e della Icpeoij, in
quanto
essa presuppone una
in senso vero e proprio, e critica l'esclusione della
terra dal sistema delle forze determinanti imovimenti
cosmici. Ammesso infatti che il movimento circolare
il pi perfetto, appare pur strano che la terra non ne
partecipi affatto. Tale opinione presuppone che la forza
del primo motore non giunga fino alla terra, o che que
sta non sia capace di subirne l'effetto. Inogni caso Teo
frasto, che qui rasenta fortemente la concezione mo
derna, respinge il problema dichiarandolo questione
trascendente (olov wrp(JaT(Sv ti xal TTjxov). InA 8
noi troviamo il tentativo di trarre effettivamente la con
seguenza
del trasferimento del motore immobile a tutte
c
le sfere. Lo scritto di Teofrasto un'eco di questa nuova
teoria, la cui discussione cade negli anni della vecchiaia
di Aristotele. Esso concorda con A 8 anche in quanto
concepisce la teoria del primo motore piuttosto come
ipotesi fisica, ma rispecchia ancora pi chiaramente le
difficolt in cui la moltiplicazione del primo principio
faceva cadere la metafisica aristotelica.
InA 8 Aristotele stesso si scusa di entrare in un
campo in cui vien meno non solo la vera e propria
filosofia, ma anche la forza apodittica della dimostra
zione. Preferisce non parlare dell'vayxafov,
ma solo di
un EXoyov 2).
Questo
carattere di mera verosimiglianza
*) Metaph., A 8, 1074 a 11: t |iv ov xXf/dag twv ocpaipiv
Sotcb ToaoTov, >3ts xal t&c oafa; xal Tg px; tj xivrjToo?
xal Tg alafbjTg
Tooa-ag
bXofov noXaPeiv.
t yp*
vafxaov
AcpsiaOo Totg loxupoTipoi?
Xfeiv.
Cfr. anche 1074a 24 tqOto 84
sSXofov
4x T(uv cp6pc[ivu)v OitoXapsv Circa l'esattezza della scienza
dell'immateriale c/r. a 3, 995 a 15 segg.
478 l'et dell'insegna
mento '
contraddice d'altronde al concetto originario della me- j
tafisica quale scienza che in fatto di esaltezza supera
di gran lunga la fsica. E Aristotele non riesce che a
rendere ancora pi sensibile
questa contraddizione
quando si scusa osservando come l'astronomia sia inogni
modo la disciplina matematica pi affine alla filosofia 1).
Quanto
grande sia la distanza che separa il metodo em
pirico dell'excursus sui 55 motori da quello dell'antica
!
metafisica risulta particolarmente chiaro quando Aristo
tele osserva come occorra lasciare il controllo di queste i.
tesi alla scienza che specificamente se ne occupa. Tutta t
la trattazione serve quindi soltanto allo scopo di fornire
'
un'idea generale della cosa (yvoLcl; yp'.v).
Questa
espressione ha tutta l'aria di voler spostare la questione
sul piano della finzione ipotetica. Infatti la formula al
fine di un'idea generale non ha significato diverso da
quello che essa ha quando Aristotele dice dei platonici
che essi ammettevano la genesi dei numeri solo, secondo
la loro stessa espressione, xo frswpflaac gvsxsv,
dunque
non come giudizio circa una qualsiasi realt effettiva.
Presupposta, cio, l'esattezza della teoria delle sfere e
del calcolo concernente il loro numero, egli vuol mo
strare come il numero dei principi debba essere esatta
mente limitato e determinabile. Evidentemente stata
la scienza specifica, cio l'astronomia, a dare l'impulso
per la rielaborazione della teoria del 7tpwTOV xtvoOv. Essa
ha insegnato ad Aristotele che l'ipotesi di un unico ed
uniforme movimento primordiale
troppo primitivo
per spiegare la complicazione dei reali moti celesti, e
che nei calcoli della scuola di Callippo concernenti il
') Melaph., A8, 1073 b 3 t 8 fjSt; ifflv cpopfflv in. xtj j
cpiXoooepta tjv
[iKS-jjfiauxffiv ituctr,|if5v Set cxoirstv,
ix itpoXo-fCa?. Egli giustifica
questa affermazione con l'ar
gomento che l'astronomia, in antitesi alle altre discipline
mate
matiche, tratta di una realt effettiva e nello stesso tempo anche
eterna. Ma questa giustificazione ha la debolezza del ripiego.
LA TEORIA BEL PRIMO MOTORE
479
numero delle sfere si offre una possibilit di determi
nare esattamente il numero dei principi.
Mettendosi per questa
nuova via, che faceva onore al
suo inflessibile realismo, devoto soltanto ai fatti, Aristo
tele si avviluppava d'altronde in inestricabili contraddi
zioni.
Queste
risultano cos evidenti al primo sguardo,
che vien meno l'opportunit di ogni tentativo di atte
nuazione. Nell'antichit pi tarda, che spese molta fa
tica e acume nell'interpretazione della filosofa aristo
telica, Plotino rivolse contro questa teoria una critica
decisiva, la quale svolgeva obiezioni gi sollevate da Teo-
frasto1). Plotino critica anzitutto il metodo della mera
verosimiglianza (t G'v), che Aristotele deve am
mettere in quanto non pu giungere fino alla necessit
apodittica. Ma anche la verosimiglianza tutt'altro che
tale. Infatti se tutte le sfere debbono convenire in un
unico sistema cosmico imolti motori immbili sono
costretti, invece che a pensar B stessi, a tener d'occhio
un unico scopo, cio il primo motore. Invece la rela
zione che lega imolti motori al primo motore non
affatto chiara. O tutte queste essenze intelligibili deb
bono derivare dalla realt prima: e allora, come le sfere
da loro mosse s'inserirebbero nella sfera estrema e sa
rebbero dominate da essa, cos anche imotori dovreb
bero esser contenuti come V07)t nel supremo vo?, e
dovrebbe quindi esistere un mondo intelligibile, come
in Platone. Oppure ciascuno dei motori un principio
indipendente, e in tal caso non sussiste tra iprincipi
alcun ordine e gerarchia, ed impossibile dedurre da
essi la sinfonia del cosmo.
Ma Plotino muove ancora un'altra obiezione. Se tutti
imotori delle sfere sono incorporei, come possono essere
molti, mancando ad essi ogni
"j
Xrj, quale principio d'in-
') Plotin., Enncad-, V, 1, 9.
480 l'et
dell'insegnamento
dividuazione?
Questa
obiezione desunta dalle premesse
dello stesso Aristotele ed stata gi presente alla co-
scienza di quest'ultimo. Inmezzo all'ottavo capitolo di
si trova infatti un passo singolare, che per il suo con
tenuto teoretico non quadra col contesto. Basta leggerlo
anche superficialmente per accorgersi come esso debba
per forza escludere tutto quello che detto in A 8 sulla
;
molteplicit dei motori immobili (1074 a 31): Su Ss si; i,
opay;, cpavspv. zi yp tiXsiou; opavoi &anzp icvUpwTici,
|
lutaieTSet pia y) rcspl fxauxov pyi\, dpiO-ptj) S ye rcoXXal. {
XX'Soa piO-p xoXXd, uXvjv
i/si.
si; yp Xyo;
'/.ai, |
ait; ttoXXi&v, olov vO-pwnou, Scoxp-n); Ss si;, ih S ti |
;
fjv slvai ox iei OXyjv t npcbtov' vtsXysia yip. Sv
!
pa xal Xytp v.aX piD-pw t itpjtov xivov xivrjTOV 8v
xal t
xivoupevov pa atei xal auvsX&; sv pvov si; apa
opav; pvo;.
Qui
indirettamente dimostrata l'unit del cielo.
Se infatti ci fossero pi cieli, il principio di ciascuno
di essi sarebbe uno e identico coi principi degli altri
cieli solo sul piano dell'universale (sISsi pia), mentre
dal punto di vista individuale (piO-pcp) essi sarebbero
distinti l'uno dall'altro, come per esempio accade nella
specie uomo, in cui isingoli uomini coincidono, s, e
si unificano eISsi, ma dal
punto di vista numerico sono
molti. Perch il concetto di uomo inerisce s comune
mente a tutti gli individui di tale specie, ma Socrate e
gli altri individui costituiscono poi, ciascuno per s,
una particolare imita esistente. E ogni volta che il con
cetto di uomo si unisce, come eISo;, con la materia,
nasce un nuovo individuo. La prima essenza (t ti 7jv
elvai t JtpfTOv), il supremo motore, che dirige il mo
vimento del cielo, fa eccezione, essendo pura entelechia,
scevra di materia. Con ci detto che questa suprema
forma non una specie la quale si presenti in molte
plici esemplari. Manca ad essa il contatto con la ma-
LA TEORIA DEL PHIMO MOTORE 481
teria, il principio d'individuazione. Nella pi alta di
tutte le forme l'unit dell' elo; coincide con l'unit
numerica dell'esistente. Di conseguenza anche ci che
da essa mosso, il cielo, non pu esser che unico.
Anzitutto chiaro come l'argomento di Plotino con
tro la molteplicit dei motori non sia altro che un'ap
plicazione di
questo principio aristotelico alla questione
degli spiriti astrali. Se la materia il principio indivi
duante, giusta la teoria professata da Aristotele qui e
altrove, o imotori delle sfere non possono essere im
materiali, in quanto costituiscono una molteplicit di
esemplari di una specie, o, se Aristotele tien fermo al
l'asserzione dell'immaterialit, egli si contraddice, per
ch. quella esclude la molteplicit individuale. In en
trambi i casi egli viene in contrasto coi presupposti
della sua filosofia. La forma delle forme, il motore im
mobile pure, in origine, un essere assolutamente unico:
dotato di propriet talmente singolari, che ogni mol
tiplicazione lo rende inconcepibile. La stessa conclu
sione deriva dalle dimostrazioni della Fisica, in cui Ari
stotele deduce l'unit del motore immobile dalla conti
nuit e unit del movimento cosmico. Anche icommen
tatori riconoscono di non esser capaci di risolvere que
sta difficolt 1).
') Bonitz, 1. c., p. 512; Schwegler, Die Melaphysik d. Aristot.,
IV, p. 280. II Rose -(I. c., p. 161) considera il passo come ag
giunta di uno scolaro, perch in De caelo, A 9 Aristotele 'di
mostra l'unicit del cielo con argomenti fisici. Ma nel medesimo
libro (8, 277 b9-10) Aristotele stesso dice che la dimostrazione
pu darsi anche muovendo dalla metafisica, e noi dovremmo la
mentare la mancanza di questa argomentazione nella
Metafisica
stessa, se essa non ci fosse conservata nel citato passo A 8, 1074a
31-39. Essa quadra peraltro solo con la metafisica pi antica, che
non conosceva ancora alcun motore delle sfere, come al tempo
in cui fu scritto il De caelo ; e non si accorda pi, invece, con la
dottrina esposta in Metuph.. A 8. Neppure in altri punti della
Metafisica
del resto possibile dimostrare l'esistenza di aggiunte
compiute da scolari.
Si.
IV. Jaeoiil Aristotele.
'I
V
432 i.'f.ta dell'insecnamento
'!
Ma se ora consideriamo il paBso dal punto di vista
linguistico, vediamo subito come esso si distacchi dal
'
suo contesto. Con le prime parole 8xi Ss e
Is
cipctvq,
cpavspv, ci troviamo in presenza di un diverso stile, che
perdura tale fino a ili
opavj |xvo;, ultima parola
del brano inserito. lo stesso stile abbreviato, che do- ;
mina nelle altre parti del libro: nettissima la sua
j
differenza dall'impeccabile compiutezza espositiva del-
l'ottavo capitolo. Che il passo sia stato inserito poste-
|
riormente dimostrato anche dal fatto che esso rompe
f
il nesso grammaticale del contesto. Nel periodo che se- i
gue subito dopo rcapaS5oxai S rcap xv p-/a(wv '/.ai I
TtapixaXahov v puftou vyjcm
xaxaXeXeLppsva xot?
uaxepov
8xi x' efov o&xot xal ntpdyi x x'/jv
8
Xr/V
epuaiv
non si vede a chi si riferisca il plurale della subordinata
8xi f-zol x'sl'iv ouxoi J). Chi siano questi ouxot s'in
tende solo tornando dieci righe indietro, dov' detto
che il xeXoj di ogni orbita ciascuno dei corpi divini
muoventisi nel cielo. Alle parole 5-sfwv aiopatwv
si ricol
lega immediatamente l'idea (1074 b 1) che gli antichi
ebbero perci ragione a considerar questi come divinit,
e a credere che il divino fosse qualcosa di circoscrivente
l'intera natura. L'argomentazione interposta, che deduce
l'unit del cielo dall'immaterialit e unit del primo
motore, un' aggiunta pi tarda, di carattere critico
rispetto alla stessa dottrina qui sostenuta, in quanto
contiene implicitamente l'opposta dimostrazione esclu
dente la tesi di una molteplicit di motori. Aristotele
l'aggiunse certo in nota a questa trattazione come obie
zione mossasi da s stesso, e il fedele zelo dei redattori
l'inser nel testo. D'allora in poi ipi acuti pensatori
della posterit si stillarono il cervello, per capire come
un Aristotele avesse potuto impigliarsi in simili conlrad-
1
dizioni.
*) Ci fu gi notato da V. Rose, I. c., p. 161.
LA TEORIA DEL PRIMO MOTORE 483
In origine l'idea del motore immobile aveva preso
forma in una concezione unitaria e scevra di contraddi
zioni; e cos anche la posteriore applicazione di questo
principio alle altre sfere era nata organicamente, tutta
d'un getto. Ma essa non quadrava col vecchio sistema.
S'intende quindi come, dopo ci, sorgessero ad Aristo
tele, in forza delle stesse premesse che erano in origine
state a fondamento dell'idea dell'unico motore immo
bile, ancora dubbi circa la nuova forma della sua dot
trina. Ora noi vediamo come proprio questa parte, cio
la teoria dei principi materiali, manchi nell'ultima re
dazione della Metafisica, e come, in luogo di essa, noi
possediamo soltanto un surrogato, cio 1' antica confe
renza che costituisce il libro A e un singolo brano della
redazione nuova, cio l'ottavo capitolo, il quale ci mo
stra ancora chiaramente come Aristotele, proprio nel
l'ultimo periodo della sua vita, si affaticasse di nuovo
su questi problemi, senza riuscire a risolverli definiti
vamente.
Questo
stato della tradizione manoscritta a noi
nota non dovr dunque esser pi considerata come sem
plice portato occasionale degli eventi storici, risultando
ora palese come la crescente tendenza a una trattazione
strettamente scientifica dei problemi filosofici, unita col
fermento delle nuove idee cosmologiche da noi incon
trate in Teofrasto, abbia scosso la baldanza speculativa
della teologia ancora semiplatonica di Aristotele e spinto
quest'ultimo ad attenersi sempre pi rigorosamente alia
scienza empirica. La dedizione della metafisica nelle
mani della ricerca empirica significava d'altronde l'ini
zio di una nuova era. La volont di essere coerente dal
lato sperimentale lo conduceva ad essere incoerente ri
spetto ai suoi principi speculativi.
Questa
contraddizione
del suo pensiero, che egli non aveva pi la forza di
superare, non era che la conseguenza della profonda e
inesorabile logica della sua complessiva evoluzione spi-
;?
484 l'et dell'insecnamento ?
----- -----
. };
rituale: nel che era, insieme, la sua giustificazione. Del
|
resto Aristotele, giusta l'opinione degli astronomi, calco
lando il numero delle sfere incorse in un errore, in . -i
quanto
ottenne un risultato di due sfere in meno. Ci
-
significa che egli si muoveva qui in un campo che non
,
gli era troppo familiare. Anche questo errore rende ;
verosimile che l'ottavo capitolo rappresenti soltanto una |
stesura provvisoria, venuta alla luce di tra le carte di
l'
Aristotele. Che sia stata scritta da lui non pu invece
esser messo in dubbio. Di Teofrasto esso non , perch
egli designava le sfere retrograde non con l'attributo di
veXTTOuaai ma con qnello di vrava'-ppoucat, mentre
nel nostro capitolo s'incontra solo la prima di queste
due espressioni. E Eudemo, nella sua storia dell'astro
nomia, presuppone l'esistenza del problema come nota
negli ambienti peripatetici1).
Inoltre noi possediamo ancora due scritti, che ci per
mettono di osservare come la scuola aristotelica proce
desse nel suo lavoro intorno al problema del primo mo
tore. Ilprimo il saggio Sul movimento degli animali,
la cui autenticit ho dimostrata minutamente altra volta,
dopoch per lungo tempo avevano tenuto il campo i
dubbi elevati in proposito 2). In esso 6pecialmente stu
diata la meccanica del moto animale. Per il moto di
traslazione ogni essere vivente ha bisogno di un saldo
punto di appoggio, su cui punta l'arto che compie il
movimento. Se si muove solo una delle membra, p. es.
l'avambraccio o lo stinco, questo punto d'appoggio pu
essere interno al corpo, e soltanto dev'essere esterno al
*) Con ci tolta di mezzo la congettura del Rose, loc. cit.,
p. 161. Per l'espressione vcavapsoiat otpatoca cfr. Simplicio,
comm. in Arist. de caelo, p. 504, 6 Heiberg. L'errore di calcolo
compiuto da Aristotele rilevato da Ps. Alex., in Arisi,
melaph.,
p. 705, 39 - 706, 15 Haydtick, clic seguiva l'astronomo Sosigene.
Eudemo riferisce le argomentazioni di Callippo in favore del
l'aumento del numero delle sfere: v. framtn. 97, p. 143 SpengeL
2) Das Pneuma im Lykcion, in Hermes, XLVIII, p. 31 segg.
LA TEORIA DEL PRIMO MOTORE 485
membro in moto come, nel caso dell'esempio, il gomito
o il ginocchio. Se si muove invece l'intero corpo, ha
bisogno di un punto saldo che giaccia al di fuori di lui,
per far su di esso leva ed allontanarsene. Agli animali
terrestri serve di appoggio, direttamente o indirettamen
te, la terra, agli acquatici l'acqua, agli alati l'aria. Nei
capitoli secondo, terzo e quarto Aristotele studia la
stessa questione in
rapporto al problema del movimento
cosmico, e discute un'ipotesi recente, con l'autore della
quale egli d'accordo nell'esigenza di tin principio im
moto, che non possa in nessun caso far parte
della se
movente volta celeste ne essere interno ad esBa1). Intal
caBo, infatti, il cielo dovrebbe o restare totalmente im
mobile o spezzarsi. Aristotele si oppone, d'altra parte,
all'opinione di quel dotto, il quale aveva di conseguenza
attribuito ima certa forza ai poli dell'asse cosmico, in
quanto essi soli fra tutti ipensabili punti della sfera
celeste stavano fermi, e soli sembravano quindi appro
priati a valere quale punto stabile, del genere necessa
rio per l'interpretazione meccanica del moto cosmico.
A ci Aristotele oppone che nessun punto matematico
possiede, come tale, realt fisica o estensione, e tanto
meno pu essere portatore di una forza. Inoltre idue
punti, dato che realmente possedessero una forza, non
potrebbero mai produrre un moto unico ed unitario
come quello dell' opav?; e che l'autore di quella ipo
tesi abbia ammesso l'esistenza di due poli, da lui
esplicitamente dichiarato. La questione connessa col
problema della possibile distruzione del cielo 2). Se per
*)
De animalium mola, 3, 699 a 17. Si noti la distinzione che
Aristotele fa tra isostenitori di (jnestn tesi e gli autori del mito
di Atlante. Egli non combatte entrambe le volte la stessa opinione,
c piuttosto cita la forma mitica solo per mostrare come quella
concezione modrna abbia gi avuto isuoi precursori.
s) De im'mah'tim. motu, 4, specialmente 699 b28 segg., e in
sieme 3, 699 a 31 segg.
486 l'et dell'insegnamento
esempio si ammettesse che la
terra, in quanto punto
centrale del cosmo, fosse il punto d'appoggio in que
stione, anche prescindendo dal fatto che questo non
potrebbe giacere nell'interno del corpo in movimento
(cio, in questo caso, dell'universo) si avrebbe qui l'ul
teriore difficolt di dover spiegare come la terra potesse
equilibrare con la sua forza d'inerzia, la cui quantit
dovrebbe pensarsi necessariamente limitata, la forza del
l'asse cosmico che su di essa farebbe perno.
Quest'ul
tima dovrebbe infatti necessariamente superare la forza
della terra, e quindi spostarla dalla posizione che essa
ha nel centro dell'universo. Tutte queste difficolt sono
risolte dall'ipotesi di una causa motrice immobile esi
stente al di fuori dell'orbita celeste, giusta l'idea che
Omero ha avuta di Zeus quando gli fa dire agli Dei
(II.,
Vili, 21-22; 20):
SJ.' oOx &v ipaait' Sg oipavOev neSlcvs
Z5jv" Onatov jtvTMV, oM' si (la reo xagoits
itdrcsj d'gnTia&s 8-sol rcSaal te S-iaivat.
caratteristico per Aristotele come anche qui, trat
tando di questioni filosofiche, egli ricorra al mito. Non
solo egli fa risalire, in questo scritto e nel libro A della
Metafisica, il proprio motivo teoretico a Omero, ma
cerca anche di ritrovare nel mito di Atlante l'opinione,
qui combattuta, secondo la quale la terra il punto
d'appoggio dell'asse cosmico1).
L'ipotesi che il moto cosmico abbia bisogno di un
immobile punto di appoggio, che tale funzione possa
essere compiuta dai due poli e che questi quindi costi
tuiscano il principio immobile del movimento celeste,
evidentemente di provenienza astronomica. Essa tien
gi conto dell'esigenza aristotelica di un Ttpfijrov xtvov,
') Cfr. Mrtnph., A 8, 1074h1-M; 10, 1076 a 4. Per il jnito di
Atlante v. De anim. motu, 3, 699 a 27 segg., e cfr. la nota pe
nultima.
LA TEORIA DEL PRIMO MOTORE 4S7
ma evita con intenzione ogni ipotesi metafisica e cerca
piuttosto di ottenere la spiegazione dei fenomeni nel
l'ambito del mondo dell'esperienza, per via puramente
matematica. Si potrebbe immaginare che un astronomo
di tendenza eudossiana come Callippo avesse preso in
tal modo posizione rispetto alle deduzioni audaci che
Aristotele credeva di dover trarre per la metafisica dalla
teoria eudossiana delle sfere. L'ignoto astronomo cer
cava di farsi, per la prima volta, un'idea chiara dei
presupposti meccanici del moto celeste, muovendo dalle
forme note del movimento e dalle loro leggi. Senza
dubbio questa forma di considerazione riusc nuova ad
Aristotele. Il suo motore immobile era concepito teleo-
logicamente e muoveva il mondo col puro pensiero.
cosa tanto pi significativa per l'oscillazione che in
quest'ultimo periodo si manifesta nella soluzione che
Aristotele d al problema fondamentale della metafisica
il fatto che egli si appropri anche qui, come nella que
stione del numero dei motori, l'impostazione data al
problema dalla pi recente scienza naturale. Nello scrit
to Sul moto degli animali egli cerca di dimostrare come
l'oltremondano motore immobile si presenti, anche dal
punto di vista della moderna meccanica celeste, come
l'unica pensabile soluzione del problema. Certo, nean
che con ci il suo motore diventa una forza di na
tura fisica, ma egli parla di un contatto del
rtejxov
xtvov *) col cosmo semovente come se realmente si
J) De animalium motu, 3, 699 a 15 iv-fw] Tivg Sx'.vrjtoo S-iy-
ydvov xivstv, c analogamente 4, 700 a 2 Ttdvcsg KJiTeaOe -3-sol xaal
ce S-saivca, dove la comparazione ei riferisce, oltre che all'im
mobilit di Zeus, a questo SstasJI-eu. Tuttavia questo punto
rimasto sempre incerto. In De gener. et corr., A 6, 323 a 31,
dove si parla del contatto fisico lifi}) Aristotele dice &sze et ti xivs
xivrjTOV v, xsivo pv v Sir-coiro to5 xivyjtoO, sxe ivoo 8' o58iv.
Questa intuizione contraddittoria (cfr. Zeller, Philos. d. Grie-
chert, II, 2, 3' ed., p. 377) sembra sia stata pi tardi abbandonata
da lui.
438 l'et dell'insegnamento
trattasse di una relazione spaziale e fisica delle due
realt, pur smussando poi la punta del problema, cos
acutamente formulato, con la
pe~aJ3at nell'intelligi
bile, cio con la rappieaentazione del princpio che
muove il mondo soltanto come
Votjtv. Teofrasto, nel
suo frammento metafisico, si riferisce gi anche a que
sto
tentativo, e cita o presuppone come noti perfino gli
stessi versi
omerici nel
medesimo inquadramento
ideale1).
Mentre nello scritto Sul
movimento degli animali
non si fa menzione della teoria dei motori delle sfere,
nel libro Vili della Fisica abbiamo un documento del
l'et in cui Aristotele, preso dal
dubbio, prospettava da
unlato seriamente la possibilit di estendere il principio
del primo motore alle sfere dei pianeti, ma tuttavia in
dietreggiava di fronte a tale conclusione. Il libro, come
gi abbiamo dimostrato, una delle parti pi recenti
della Fisica2). Per ilsuo contenuto esso occupa una posi
zione
intermedia tra la fisica e la metafisica, perch
espone la teoria del principio immobile, nella misura
in cui ci possibile sul piano e coi mezzi della fisica.
Nel sesto capitolo Aristotele dimostra la necessit del
l'ipotesi del primo motore. A
questo proposito appare
vagamente
prospettata, nello sfondo, la possibilit del
l'ammissione di un maggior numero di tali motori, ma
si evita con intenzione di fondere questo problema con
la
dimostrazione del primo motore, giacche
questa non
risulta
naturalmente semplificata dalla conseguenza dei
55 motori dei pianeti, che essa trae con s. Ilprincipio
del capitolo sesto si limita quindi a dire, in modo ra-
')
In De anim. motu, 4, 699 b 36 segg- Aristotele cita versi
21-22 e 20
dell'ottavo libro dell'Iliade; in Metaph., p. SII, II Bran-
dis
Teofrasto cita il verso 24 dello stesso libro inserendolo nel
medesimo conlesto ideale.
-) CIr. sopra, pp. 401-5.
la teoria del ratino motore 489
pido ed allusivo (258 b 10): 7tsl S Set -/.{vfjatv
el
slvat xal [i/l]
SiaXeutsiv, ivy/.rj
itvaC ri 8 rcpfdrov
xivsl,
elrs ' v sirs rt X e 1to, xal r Ttpwrov xivoCv xivrjxov.
Lo schema verbale sirs. . . . sire consueto ad Ari
stotele quando egli vuol significare come dietro la sua
formulazione
si celi un ulteriore problema,
che egli
presuppone
come noto ma da cui per ilmomento vuol
prescindere1).
Si tratta per lo pi, in questi casi, delle
controversie dibattute nella scuola. Dal passo della Fi
sica apprendiamo
dunque con certezza ci che gi ave
vamo potuto stabilire in base a Teofrasto: nel Peripato
c'erano ncora seguaci dell'ipotesi di un unico prin
cipio motore anche quando era gi cominciala la di
scussione circa imotori dei pianeti.
Ci confermato
anche da quel che segue, e in cui risulla chiaro come
non sia stato Aristotele a spingere all'ampliamento della
sua primitiva
teoria, ma come anzi egli abbia dovuto
adattarsi, piuttosto contro voglia, agli argomenti altrui.
Consideriamo anzitutto il passo nel suo complesso
(258 b 12 segg.).
Se anche esistono certi principi motori immobili, e
certi esseri semoventi di durata non eterna, ci non
prova
nulla, per Aristotele, contro la necessit del pri
mo motore assolutamente immoto ed eterno. Ci dev'es
sere infatti una causa del
movimento, la quale deter
mini la continuit della genesi e della dissoluzione di
quegli esseri immoti ma non eterni, come in genere
di
') p
es. nel Proireptico
(JainblicK., Protr., p. 39, 4
Pislelli):
tua -r&p JtDp sU'
i.r<P
stxs pips sUe SUc xivie
tpbasi?
xal itptbtac rfflv SUuiv. Con quest'ultima espressione egli allude
alle idee: cpieste parole sono slate scritte
quando
la dottrina delle
idee era ancora argomento di discussione nell'Accademia. Cfr.
inoltre
Metaph., A 9, 991b18 xal a&Tovptoitos, elle piSfig me
fov sire
uri-
6pu? oxai
TS
iv Ttvffiv. La parentesi si
riferisce alla questione, dibattulissima al tempo della stesura del
libro A, se le idee fossero numeri o no. In entrambi i casi si
allude a discussioni orali, svolgenti! in seno alla scuola.
490 l'et DELL'INSEGNAMENTO
tutto il divenire; e questo principio non pu essere
identico ad alcuno degli altri motori per s considerato,
in quanto invece trascendente e li comprende nella
loro totalit. Trascriviamo qui le parole pi importanti
(259 a 3 segg.) :&XX* o65v fjxxov lati xi &
KEpiiyji,xa xo-
to nxp' 'xaaxav, 5 laxiv atriov rorip.v tlvai r51
y.al
t)j psTarjfoAffc' xa coltro
fisv zovzoiq, txtcc S zc-Ig
&XXoi
altea
xivrjaetcj. eltusp ouv fSioc
-fj x(vv) ai?, 'ioiov
xa r xivov eatai npSrov, s 5v s S TtXsfco,
nXe(e)
r t'Sia. <Lv Si p&XXov ?) xxoXX xa
nercepacpva i) &7ceipa Set vopeiv. xfiv arSv
yp cri>|j.(3aivvTO)V dei x nsTispaapva pSXXov Xixxov.
v
yp rol? cpuosi Sei r nsTtepaopvov xa r (jXxtov, v
ivSiyrjxai,
ttpyiv pXXov. Iv. av bv Si xa s iv, 8
7tpwTov x>v
xivr/Tiiiv
fSiov 5v lata: pyjj xoc; SXXoi;
xtya(i>. pavepv S xa 4x zoe, Sz
&v&-(xrj zlvxi re
v xa l'Seov r Ttpxov xivcv.
Nelle parole spaziate Aristotele torna all'alternativa
ette ev (x
ttpfixov xivov) etxs reXeiio lasciata aperta
nel primo periodo del
capitolo. Ma non dice recisa
mente, come nell'ottavo capitolo del libro A della Me
tafisica, ebe si debba applicare il principio a tutte le
singole sfere, bens aggiunge dubbiosamente: e 'v
" s S
nXsw,
TiXeco xi fSia. L'unico accenno a una possibilit
di decisione contenuto nell'avvertenza che l'ammet
tere un unico motore sia preferibile all' ammetterne
molti, e in quest'ultimo caso convenga ritenere che il
loro numero sia finito piuttosto che infinito. Conforme
alla concezione teleologica della natura propria di Ari
stotele e al parere di Platone, che egli stesso condivide,
la determinatezza e delimitazione matematica la qua
lit suprema che si deve esigere dal sommo essere e
dai suoi principi. Ma Aristotele non osa trarne senz'al
tro la conclusione che possa esistere solo un unico prin
cipio di tal genere. Dice soltanto che la tesi dell'unit
L TEORIA DEL PRIMO MOTORE
491
da preferire
a
quella
della pluralit; ma se, nonostante
questo, esista davvero una molteplicit di motori, cosa
che egli non si sente di decdere. La conclusione del
l'excursus ha l'aria di un conforto che Aristotele
rivolge
a s stesso, e insieme manifesta a quale delle due ipo
tesi egli fosse piuttosto incline quando la scriveva:
gi sufficiente che esista un solo principio, il quale, pri
mo dei principi
immobili, in forza della sua eternit
per gli altri (cio per le anime degli esseri terrestri)
causa del movimento . L'eternit diventa qui il carat
tere distintivo del primo motore, e su di essa si fonda
ilsuo aspetto
di priorit
e di causalit rispetto agli altri.
Come Aristotele abbia concepito, nel caso dell'am
missione di un maggior numero di motori, la loro rela
zione col moto circolare del cielo delle stelle fisse,
difficile dire. Tutti gli accenni che a tale proposito
s'in-
contrano in questo capitolo hanno aspetto piuttosto
provvisorio. Nel passo 259b1-20 era spiegato per qual
motivo non si potesse porre (come nel sistema di Pla
tone, che peraltro non nominato) al vertice del movi
mento cosmico una realt semovente, in modo analogo
a quel che accade agli esseri animati, e cio l'anima
del mondo. H moto di tutti gli esseri viventi e semo
venti a noi noti attraverso l'esperienza ha, comunque,
un suo inizio nel tempo: del moto cosmico non si pu
invece immaginare che abbia principio in un determi
nato' momento del tempo, perch esso dovrebbe allora
esser passato dalla potenza
all'attualit, ma tutto ci
che esiste soltanto potenzialmente potrebbe anche ad
egual diritto non esistere affatto. Se quindi si ammette
che il cielo sia una realt semovente del tipo a cui pen
sava Platone, nasce la necessit che al di fuori di esso
esista, come principio motore, un ente assolutamente
immoto. Inoltre una realt semovente per accidens
sempre mossa, anche se nella sua natura sostanziale
492 l'et dell'insegnamento
immota come l'anima del corpo: mentre il supremo
principio non pu esser mosso neppure per accidens.
Successivamente sembra che ad Aristotele sia venuta
in mente l'obiezione (259 b28) che anche imotori dei
pianeti non sarebbero esattamente
analoghi al primo
motore, perch essi restano s immobili in s medesimi
in quanto muovono ciascuno la propria sfera, ma, in
quanto le sfere sono
spostate dal loro movimento pecu
liare per opera della sfera delle stelle fisse e cosi tratte
nell'orbita del moto celeste, anche imotori debbono es
sere accidentalmente mossi, cio spostati dalla loro sede.
In una frase conclusiva, buttata gi rapidamente, egli
stabilisce allora la distinzione onde gli esseri viventi
terrestri, che pure essendo immoti si muovono acciden
talmente per la traslazione del corpo, si contrappon
gono agli esseri delle sfere celesti, in
quanto questi ul
timi non si muovono accidentalmente da s, bens ven
gono mossi
da una diversa realt, il cielo. Non si vede
a che questa distinzione giovi nei riguardi della loro
immobilit: probabilmente soltanto un tentativo di
segnare in generale una distinzione specifica tra imo
tori celesti e imotori terrestri. D'altra parte non per
ci diminuita la lacuna che separa il supremo motore
dai motori dei pianeti, perch so questi ultimi per l'in
terferire delle loro sfere nell'orbita della rivoluzione ce
leste sono anch' essi mossi nata
cp'
tfou,
questa rappresentazione
spaziale presuppone necessaria
mente che essi non siano, come il sommo motore oltre
mondano, trascendenti rispetto alla loro sfera, bens le
siano immanenti come anime. Simplicio combatte, senza
spiegare imotivi, questa conclusione, che Alessandro
di Afrodisia aveva logicamente tratto1). Ma certo ba
sandosi su
questo passo della Fisica non si pu giungere
') Simpl., in Arisi, phys., II, p. 1261, 301262, 5 Diela.
LA TEORIA DEL PRIMO MOTORE
493
ad altra interpretazione. La teoria delle anime delle
sfere verrebbe cosi a costituire una posizione dottrinale
intermedia fra la dottrina originaria, e ancora total
mente platonica, delle anime astrali professata nel dia
logo llep yO.ozGtplcic,
e quella dei motori trascendenti
delle sfere che s'incontra nell'ottavo capitolo del libro
A della Metafisica.
Infatti nonostante che anche in que
sto capitolo (la cui genesi seriore risulta gi anche dal
grado di determinatezza eon cui Aristotele vi espone
la
nuova teoria) imotori delle sfere non vengano esplici
tamente chiamati lapicua
cosa che colpisce tanto pi
in quanto
ad essi sono sotto ogni altro aspetto assegnate
lestesse propriet del primo motore
,si deve tuttavia
pensare che Aristotele li abbia qui considerati come
esistenti per s, giacch egli dice che essi sono un prius
rispetto all'
oo(
delle sfere, e debbono perci essi
stessi avere il carattere dell' oaCa1). Un'espressione
si
mile non conviene al rapporto che lega il corpo al
l'anima, giacch per Aristotele l'anima non una oola
Tpoipa ~Yji xo at'ojiato;
oatag.
Quindi
chiaro che
egli non pot, alla lunga, sentirsi soddisfatto del moto
accidentale che il cielo determina nei motori delle sfere,
e che perci si decise a dichiarare trascendenti anche
questi ultimi. Le contraddizioni esteriori venivano cos,
per un lato, eliminate. Ma nello stesso tempo egli ca
deva nel mare di difficolt che portava con s la nuova
determinazione del rapporto collegante i motori dei
pianeti al sommo vo?, e che finivano per infirmare il
concetto fondamentale della sua teologia.
') Metaph., A 8, 1073 a 32 iw&yy.r,
y.al toxidv
xsxJ/v
tojv
tpop&v tire* xivrjxou xs xivsCaS-ai xa8-" auxv xal l'.ou of>o[ag.
"ts yp xffiv ficTpiuv cp-jutj tSiog, osia xig oGaa, xal x xivcv
itiov xal stpizepsv zo y.tve-jpsvao, xal x npxspov ohzlav
vayxatov
slvai. cpavapv xolvuv 8xi xoaaxac [x*] o&clx vxyxatov
stvcu
T15V
xs civ tSJou?
xal Sxivijxo'j; xa9-' a&x; xal fiveu |is-
8'. xrjv spr)|i.sY7]v alxiav rcpxepoy.
494
l'et dell'insegnamento
Le allusioni del capitolo della Fisica a una pluralit
d motori immobili delle stelle non
sono del resto evi
dentemente, che aggiunte posteriori. Aristotele le ap
port quando l'ampliamento della sua teoria del motore
immobile cominci ad essere discusso nella scuola, e
non c'era ormai quad pi che la pura possibilit di de
cidersi per l'ammissione di un maggior numero di pia-
neti. Tre sono ipassi di questo genere.
D primo a p. 258 b 10. Ragioni grammaticali im
pongono qui di considerare come aggiunta le parole
parentetiche eite iv site rcXelo. Se le si considerano
come appartenenti fin da
principio al testo, le parole
seguenti che ora ciascuno degli esseri, i quali senza
muoversi muovono un'altra realt, sia eterno, non cosa
necessaria se di esseri di questa specie ce n' uno solo
si riferiscono ai motori astrali, ai quali allude l'aggiunta
exe ette ttAeicu. Ma ci non d alcun senso, come
stato notato gi da Simplicio, il quale
sottintende ta
citamente come
soggetto le anime degli esseri terrestri
tcov Ctptav), Che imotori immobili non eterni, la
cui esistenza Aristotele concede, possano essere soltanto
queste ultime, non soltanto
un'evidente conseguenza
di ci che segue1), ma anche in s
logicamente neces
sario, perch i
motori astrali, una volta ammessi, deb
bono essere imperituri al pari degli astri stessi. Ilcon
trasto tra l'unico motore eterno e imolti motori tran
seunti, che qui interessa Aristotele, dalla parentesi ad
dirittura distrutto. Inoltre le parole si adattano anche
male al periodo in cui sono inserite: infatti difficile
comprendere come dalla continuit del moto celeste (e
')
In ci che segue
Aristotele li designa
spesso col nome di
esseri semoventi i(p.
es. 258 L 24; 259 a 1; 259 b 2 segg.; b 17),
ed usa questa espressione come sinonma del termine tecnico
xfvijta [lv xivoQvca Si- In 259b2 egli
li chiama poi esplici
tamente 2|i<Jn>xa e cj)iov pivog.
LA TEORIA DEL PRIMO MOTORE
495
d questo
soltanto si parla tanto qui quanto
in quel
che
precede e in quel che segue) si possa inferire l'esistenza
d un eterno motore
immobile, sia esso uno o siano
pi. Quest'ultima
frase si pu capire tutt'al pi
come
nota marginalo, mentre nel testo essa disturba
l'esatto
processo
dell'argomentazione.
Non meno postuma
ed incidentale l'allusione
alla
possibile molteplicit dei motori nel secondo
passo,
259 a 7-13. Se il moto eterno, anche il primo motore
dev'essere
eterno (se ce n' imo: se invece ne esistono
molti, allora ci sono molte realt eterne) . Prese alla
lettera, queste
parole sono singolarmente
tautologiche,
potendo significare solo che, se ci sono pi
motori, esi
ste pi di un principio
eterno. Ma se Aristotele
avesse
voluto soltanto enunciare il principio generale che
ogni
eterno e continuo moto
circolare, sia del cielo sia di
un'altra
sfera, presuppone un eterno motore
immobile,
senza toccare la questione del numero di tali orbite e
motori, egli si sarebbe espresso all'incirca nel modo se
guente:
se c' una molteplicit di moti circolari conti
nui, c' anche per ciascuno
di essi un motore di tal
genere. Invece proprio contro questa
conseguenza
egli
ancora rilutta qui, come dimostra
la fine del brano in
serito: ma basta certo che ci sia un solo motore.
Ora, nell'ottavo capitolo del libro A della Metafisica
s tratta solo della determinazione
del numero delle
sfere e con ci dei motori, mentre
il principio
generale
gi stabilito: per ogni sfera c' un motore. Qui
invece
ancora da risolvere proprio tale questione
di princi
pio, se possa esser sufficiente un solo motore in luogo
di molti. Perci Aristotele parla, con
intenzione, in ma
niera cos poco chiara e convincente: se c' l'eterna
continuit del movimento, c' necessariamente anche un
eterno motore, nel caso che ce ne sia solo uno, ma se
ci sono molti motori, allora ci sono anche molte realt
m l'et dell'insecnamento
eterne, cio essi debbono naturalmente essere parimenti
eterni.... Per basta anche che ce ne sia uno solo . An
che dal punto di vista stilistico il passo, da el Iv in
poi, fa l'impressione dell'aggiunta posteriore. Inline
ben difficile che Aristotele avesse potuto procedere nel
modo in cui procede, se le parole sospettate si fossero
trovate sempre al posto che occupano adesso {259 a 15):
stato dimostrato come debba esserci sempre movi
mento; ma dato ci esso dev'essere continuo, perch
l'eternit continua, mentre la semplice successione
discontinua. Se per il movimento continuo, esso
uno: ma unico, soltanto se compiuto da una
sola realt motrice e da una sola realt mossa .
Ci pu esser etato scritto solo quando Aristotele, conclu
dendo dalla continuit del moto alla natura del motore,
non aveva ancora pensato al moto cosmico nella sua to
talit. Se infatti ci non dovesse significare nient'altro
che quanti sono imoti continui tanti sono imotori, la
questione precedente, se ci debba essere un solo o pi
motori, sarebbe priva di contenuto, e dovrebbe sempli
cemente esser detto : il numero dei motori immobili ri
sulta con ci corrispondente al numero delle sfere.
Il terzo passo aggiunto a p. 259 b 28
31, al ter
mine della serie argomentativa. In origine l'intenzione
di Aristotele era stata quella di accentuare il pi possi
bile l'antitesi tra le singole anime del mondo terrestre
e lo spirito cosmico. L'idea di quest'ultimo era stata in
negabilmente ricavata per deduzione analogica degli
esseri viventi: la sua posizione di eccezionale superio
rit aveva quindi tanto pi bisogno di essere adeguata
mente messa in luce. Prescindendo dalle sue propriet
spirituali essa si manifesta anche nella sua immobilit
assoluta. Le anime e gli esseri viventi sono invero
anch'esse ins immote, ma, in quanto muovono il corpo
e quest'ultimo si sposta nello spazio, esse muovono in-
LA TEORIA BEL PRIMO MOTORE
497
direttamente anche s stesse. Ci non vale per ilsupremo
motore, che dobbiamo ammettere come causa del con
tinuo ed eterno moto del Tutto: nella sua assoluta tra
scendenza egli resta infatti immobile tanto per se quanto
per accidens. Ora, quando Aristotele avanz la teoria
delle anime delle sfere, non pot considerar queste
come
prive di qualsiasi movimento al pari del supremo mo
tore, perch esse, pure immobili in s, erano, insieme
con le loro sfere, coinvolte nell'universale moto cele
ste. Affinch per esse non si abbassassero al grado delle
anime terrestri, Aristotele inser 1' aggiunta 259 b
28-31, la quale tuttavia, come sopra abbiamo dimostrato
(p. 492), non poteva
dissimulare il fatto che -qui veniva
introdotto un nuovo principio, il quale non quadrava
con la contrapposizione delle semoventi anime terrestri
all' assolutamente immobile spirito del mondo. L ag
giunta aveva del resto, al pari delle due altre, valore
soltanto ipotetico: doveva solo tener conto della pos
sibilit dell'esistenza dei motori delle sfere, e nul
la pi.
Iperipatetici d' et posteriore, che conoscevano la
teoria dei motori delle sfere nella sua forma definitiva
quale risultava dall'ottavo capitolo del libro A della
Metafisica, dovettero interpretare le aggiunte del capi
tolo della Fisica in conformit a questa
teoria. Essi do
vettero credere che Aristotele si ponesse anche qui dallo
stesso punto
di vista, e trasferirono quella teoria nel
l'interpretazione di questo capitolo. Ingenerale essi po
terono ricorrere, a questo scopo, all'idea che Aristotele
avesse qui voluto esporre soltanto il principio fonda
mentale della relazione tra moto circolare continuo e
motore immobile, senza porre il problema speciale della
natura e del numero dei motori delle sfere. Inun passo
tuttavia questa
loro interpretazione doveva mostrare la
propria insufficienza. Al termine della serie delle argo-
82.
W.
Jaeger. Aristotele.
V'
1
4?8 l'eia
dell'inseckamejiio
lueatazioni detto (259 b 20): in base a questi fatti
ci si pu convincere che nessuno degli esseri, iquali
. |
senza muoversi muovono un'altra realt e per ci stesso fc.
muovono accidentalmente anche s medesimi, pu es-
sere causa di mi moto continuo. Se dunque esiste neces
sariamente una continuit nel movimento, il primo mo
tore deve essere una realt immobile anche
in senso accidentale, se vero che, come si )
detto, deve esistere nel mondo un movimento incessante
'<
e immortale. Che la lezione giusta fosse elvatxt Sst x
ttpGxov xtvov y.fvrjTov xa xax atte- ?
stato da Simplicio, il quale pone a fondamento della
sua interpretazione del passo questo testo, a noi traman
dato solo in un manoscritto poco pregiato1). Immobile ;
tanto per se quanto per accidens solo il supremo mo
tore trascendente, non le anime delle sfere, come dice
Aristotele stesso nell'aggiunta 259 b 28-31. Ma allora il
discorso si riferiva solo a quest'ultimo: e come potevano
gl'interpreti trovarvi esposta la teoria dei motori e delle
sfere? Essi erano peraltro cos lontani dall'idea che Ari
stotele potesse
mai aver pensato altrimenti, che corres
sero senz'altro il passo e, inserendovi una negazione, ne
ricavarono il senso esattamente opposto.
In tutti imi
gliori manoscritti cos penetrata la falsa lezione -/.al
xax aijjj.pepvjxs nonostante che essa fosse incom
prensibile anche dal punto di vista linguistico e
che la lezione vera avesse un esatto corrispondente in
258 b 15 s).
') Sirapl., in phys., II, p. 1260, 11 Dlels: cfr. l'apparato critico
e Diels, Zur Textgeschichte der Arislotel. Physik, in Silzungsbc-
richle d. Berliner Akademie, 1882.
) Cfr. 258 b 13 5xt B'vsyxatov etvai ti x xivijxov pv ain
Ttiai;; xxg (cos giustamente Simplicio, xfjj v-tg codd.)
psxa-
goXflg xal xk xax aupgspvixs, xtvvjTixv 5' xpou,
5rj).ov 65=
axojtoaiv.
Queste
parole corrispondono a quelle
che si leggono alla fine dell'intera argomentazione (259 b 20-28),
j
LA TEOH1A DEL PRIMO MOTRE 499
Per felice combinazione ci stato tramandato come
si comport la pi antica generazione degli scolari di
Aristotele di fronte all'enigma offerto dal capitolo della
Fisica. Eudemo ha in
parte riprodotto letteralmente e
in parte parafrasato la Fisica in una grande opera in
pi libri, destinata probabilmente alle lezioni. In essa
egli ba spesso formulato pi esattamente l'espressione
di passi dubbi, talvolta aggiunto nuovi argomenti o com
piuto altre integrazioni, le quali non possono assoluta
mente esser considerate come rispecchianti soltanto la
sua personale opinione scientifica. Con tale opera egli
non ba fatto molto spesso che adeguare la Fisica allo
stato in cui si trovavano iproblemi al tempo della
morte di Aristotele. Nel nostro caso ci chiarissimo.
Negli ultimi tempi precedenti alla morte del maestro
la teoria del primo motore era stata ampliata in ama
teoria dei motori delle sfere. Eudemo lamentava che nel
capitolo della Fisica mancasse la precisa spiegazione
dell'esistenza di una pluralit di motori immobili. L'ul
timo degli argomenti a favore dell'esistenza di tm mo
tore immobile escludeva piuttosto senz'altro, come ve
demmo, la possibilit di una moltiplicazione di
questo
principio. Nella sua parafrasi, Eudemo inser quindi
nell'argomentazione aristotelica se dunque dev'esserci
necessariamente un moto continuo, deve esistere un pri
mo motore immobile le parole per ogni moto circo
lare, cio per ognuna delle sfere 1). Egli intendeva cos
e insieme con esse inquadrano l'argomentazione stessa, dimo
strando con ci come tutto questo capitolo tratti soltanto del su
premo principio motore. La falsa lezione |ii) xax aoppegrjxg
di 259 b 24 si trova in lutti imanoscritti fuori che in H: tut
tavia nel cod. E (Parisinus) la mano di un ignoto lia cancellato
il
pi], o che egli avesse visto il commentario di Simplicio
o
che per riflessione propria avesse notato come la logica
dell'ar
gomento richiedesse tale cancellazione.
') Simply 1. c., II, p. 1262, 16 Diels (Eudemo,
framm. 80,
p. 105, 5 Spengel) 6si|ag npitov, x, oxt xivr;jis ti, xt oDxs
ysyoy nsxs xlvijuig ap-tpot pi? chaa cCxe tp&e-ipexai
ncxa, axs
500 l'et dell'insecnamento
's
le parole di Aristotele come se si riferissero alla dot-
trina che questi aveva da ultimo riconosciuta come
1
esatta. Eudemo aveva un motivo di ragione nel consi-
'
i
derare quella come la dottrina autentica, e nelle parole J
della Fisica vedeva una formulazione che non corrispon- ?
deva pi alla concezione aristotelica, nello stadio pi ,1
avanzato a cui essa era giunta. Naturalmente egli do- .V
veva riconoscere come in questo passo isolenni accenti ' ,
del movimento immortale e infaticabile rendessero
'
sostanzialmente impossibile di pensare ad altro che al ;
moto celeste e alla divinit motrice: la piramide di di-
|
mostrazioni costituita da tutto l'ultimo libro della Fi
sico culminava infatti in questa idea. Tali formulazioni
della Fisica, al pari di molte altre, sono infatti unindizio
della relativa antichit della sua stesura. Eudemo e i
suoi condiscepoli avevano dunque ancora nozione di
questo carattere dell'opera, quando vi aggiungevano la
loro interpretazione autentica: ma la coscienza che le
carte superstiti di Aristotele fossero ildocumento di una
evoluzione and evidentemente smarrita presto.
|i>>) stvat xlvijoiv, stia 8s(sa{, 8ti ti npiTujj xivov x a-D-"
xfvigciv,
(I)
c
6 EB8Y)|i0g it po ox 0tv , 4xi-
vyjtov slvai
XPV
*al
xa"*
T xal xa-c ou[igspvj*8S
Questa
ricapitolazione del contenuto del cap. 6 dell'ottavo libro della Fi
sica si riferisce, per quel che concerne le parole d Eudemo, alle
parole del testo 259 b 22-24 Sor' strcsp v-j-xv] evai
xtvTjoiv,
stva(
-ti Set t (!) rcpciov xivov xivrov (xal xaO-' ait)
xal xa-c aopgsptixg. Non chiaro poi come Eudemo rimediasse
all'aperta contraddizione, che la sua aggiunta veniva a costituire
rispetto all'esplicita asserzione aristotelica secondo cui l'attributo
(li
ixivijcoy xal xafr' aiti xal xat aunffstjxii convenivi
soltanto al supremo motore, e non alle sfere.
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
Al nome di Aristotele legato un certo carattere
d'impersonalit e di~estratemporiRt:_
oggetto_d'idola-
tria scolastica, esso simboleggia il dominio spiritualedel
puro pensi su vaste epoche" storiche. Per inserirlo
totalmente nel proprio mondo, if Medioevo cancell i
'lineamenti individuali del pensatore e ne fece senz'altro
il rappresentante della filosofa. Non si pu negare la
grandezza di ria* simile posizione rispetto all'ideale da
lui stesso propugnato: anch'egli mirava alle cose e non
alle persone, voleva la verit eterna e non l'erudizione
storicarMr
tempi in cui il suo pensiero s'identificava
con la"~verit stessa sono trascorsi. H significato storico
di Aristotele come condottiero spirituale dell'Occidente
non certo diminuito dal fatto che il processo verso
un'esperienza filosofica propria si sia svolto, nel mondo
culturale europeo, nella forma di una lotta cinque volte
secolare contro di lui. Ma considerato dal punto di vista
jmoderno egli non ormai che il rappresentante della
tradizione, non un simbolo dlia nostra ansia critica
e deTlibro e creativo progresso della conoscenza. A un
contatto fecondo col suo pensiero noi perveniamo solo
:
passando attraverso la nozione storica del significato che
'
esso ebbe in seno alla cultura e alla filosofia greca c
: del particolare compito a cui ademp nel suo secolo.
i Ogni grandezza spirituale, che sopravvive nella storia,
502 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
subisce questo destino. Deve anzitutto lasciarsi staccare
dalle sue radici storielle e perdere ie sue determinazioni . ?
empiriche, per poter diventare una ricchezza accessibile
alla posterit.__Solo la storia pu allora rispondere al- . -
l'ulteriore questione, del momento in cui questo vivo
y
influsso si trasforma nel suo
opposto, e in cui solo il '!
ritorno dalla tradizione alle fonti e al vero significato
storico di quel fenomeno di cultura pu salvar questo
atesso dalla morte spirituale. Certo, ancora oggi non
sar facile esser d'accordo nel decidere se questo mo-
-
mento per Aristotele sia giunto, dato che lafilosofia sco-
|
lastica, come un mondo in s conchiuso, sopravvive tut-
'1
tor fra noi.
Questo
libro comunque nato da una con- s
siderazione slorica di Aristotele, che non deve renderlo
'
necessariamente inservibile per coloro che in linea di
principio sono di diverso avviso. E infatti solo quando
si sia adeguatamente compresa la figura storica di Ari-
Istotele possibile comprendere pienamente anche il
11
particolare aspetto e vigore del suo posteriore influsso.
Irisultati che questo libro ha raggiunto nella con
siderazione della storia spirituale di Aristotele debbono
ora essere utilizzati per fornire un quadro conclusivo
della sua posizione in seno al movimento spirituale del
quarto secolo. Il nesso interiore della sua costruzione
filosofica col grande problema che Platone aveva posto
alla coscienza scientifica del mondo ellenico stato fino
ra posto in luce principalmente per ci che concerne la
critica della dottrina delle idee e l'evoluzione dei sin- -
goli concetti.
Questa
particolare considerazione dei con
cetti costituisce il compito specifico che incombe all'in
terpretazione filosofica di Platone e di Aristotele. La
storia filologica della loro evoluzione ha invero bisogno
anche dell'interpretazione filosofica e insieme la pro
muove, ma suo scopo ultimo non quello della storia
dei problemi in s e per s, perch essa considera solo
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 503
la forma particolare in cui l'universale spiritualit
della
nazione si determina nel campo filosofico. ima que
stione oziosa quella che si pone quando si domanda in
che misura la filosofia, in tale giuoco di influssi
storici,
sia stata attiva o passiva. Ad essa difficile rispondere,
anche se a tale scopo si tien conto di tutta la vita cul
turale di un'epoca, perch in tal caso si considera erro
neamente come essenziale il semplice contenuto della
consapevolezza,
e non si comprende l'importanza del
modo in cui esso viene filosoficamente formulato. Inci
che segue cercheremo
d'intendere il significato organico
della filosofia aristotelica in seno alla cultura greca
muovendo soltanto da essa stessa e dal suo ambiente
storico; e a tale scopo prescinderemo dal contenuto
materiale delle sue singole discipline, per rivolgere lo
sguardo solo alla fisionomia essenziale che la problema
tica aristotelica e le sue forme logiche assumono in seno
alla storia dello spirito.
a) La mentalit analitica.
L'opera imponente compiuta da Aristotele nel campo
delle ricerche logiche va qui considerata solo in quanto
esprime in forma tipica lo spirito che universalmente
compenetra la sua filosofia. L'energia analitica..del .
suo
pensiero si creata in essa la classica forma di espres
sione. Essa era preparata dalle scoperte,.di
logica ele
mentare contenute nella dottrina delle idee, e da tutto.
Patteggiamento gnoseologico e metodologico
della filo-
sofia di Flatqr. Tuttavia l'analitica e la dottrina delle
categorie non sono nate, in Aristotele, dal costante at
teggiamento intuitivo ed oggettivistico del pensiero pla
tonico, ma da una diversa radice. Le indagini moderne
504 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
A hanno provato e sono riuscite, s, a dimostrare che un
gran numero di principi logici, iquali si incontrano in
S opere indubbiamente antiche, come per esempio nella
\Topica e nella dottrina delle categorie (v. sopra, p. 59),
fu teorizzato gi nell' ambiente dell'
Accademia--
e- da
Aristotele semplicemente trasferito nei suoi. scritti. .
, Un'analisi dei dialoghi platonici, che li confrontasse dal
|
punto di vista degli elementi logici in essi impliciti,
i!
potrebbe, spinta fino ai minimi particolari, confermare
1
e approfondire ancora questa nozione, come ci ha dimo
strato l'analisi deVEudemo. Ma solo in Aristotele in
contriamo il vero e
proprio processo
dell'strazionei-
Questa
ha preso possesso di tutto il suo pensiero. Non
qui il luogo di seguire la genesi del concetto astratto
e il suo progressivo districarsi dalla realt empirica nel
corso del pensiero greco, e dimostrare come esso si venga
sempre pi chiaramente svolgendo dall' involucro del
l'idea platonica. Cogliere il concetto astratto nella sua
purezza e nella particolare costituzione delle leggi che
lo determinano era compito riservato all'acutezza inda
gatrice di Aristotele. Nella sua infaticabile ricerca delle
propriet e relazioni logiche dei concetti di ogni cate
goria e delle forme e premesse dell'argomentare scien
tifico possibile riconoscere gi l'indagatore dell'epoca
pi tarda, intento a comprendere nella sua totalit l'am
bito dei fatti logici. Egli costruisce la nuova disciplina
con una tecnica puramente .ffml;'""e""afferma esplici
tamente come la logica non sia per lui, al pari della
rettfica,"una' teora di realt oggettive e quindi
jina
scienza (cptXotfocpfa), ma' solo una capacit (ouvapts) e una
tecnica. Esclude da essa la questione
della genesi del
concetto e del pensiero nell'anima, e cio la psicologia,
_e_cohcpisce
l logica' slo cme strumento "dlla"coho-
.scenza, pur connettendo, "a~pp'imto~perci",~la~tm:i"a"dl
sillogismo con la sua dottiin-dirbggettivit inrun'auto-
tA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 505
noma gnoseologia del sapere scientifico, il.,
cui. sostrato
costituito dall'indagine sui cosiddetti assiomi.
Jngiu-
stificato parlar perci di ima logica metafisica,. Unesso
collegante gli elementi
Xps e
v nella cui dualit egli
aveva definitivamente risolto l'antica ontologia (cio
l'unica formai che la_ logica aveva avuto nella filosofia
prearistotelica), doveva comunque esser restaurato, e
ci accadde merc il concetto della causa formale,,.che
era nello stesso tempo concetto e realtj.ro'io
C'Orno-
scendi e ratio essendi. J.utto ci storicamente condi
zionato dal realismo di Aristotele, e pu non apparire
soddisfacente come soluzione, ma comunque lontanis
simo dalla proiezione hegeliana dei momenti logici, con
cetto, giudizio e sillogismo, nella sfera ontologica.
necessario farsi un'idea chiara dell'enorme influsso
f che la mentalit analitica esercita sulla struttura spiri-
!tuale della filosofia di Aristotele, giacch essa effettiva-
*
mente determina ogni passo che questi compie. Tutto
nei suoi scritti perfetta, raffinatissima arte logica,_non_
Toz?(T~a
alto""agli .argomenti, ,nellq,,istile_ di,..serti.,pen
satori e dotti moderni, itpiali
.mescolano.
spesB.oJl,p.rp-,
cesso deiFsservazione con quello dell'argomentazione
e hanno scarsissima consapevolezza delle fini e precise ,
"
sFtimtufe lgiche. (Proprio perch per quest' arte noi
i non aSKiamo ormai n disposizione n tempo, e siamo
; pi o meno privi di quella pi raffinata educazione che
al pensiero imponeva l' antica dialettica, g' interpreti
moderni non ce ne fanno capir troppo,
anche nei loro
commentari. A questo riguardo avremmo parecchio da
imparare dai commentatori antichi, iquali
almeno
in quanto non appartengono all'et della decadenza
seguono ogni scritto metodologico con l'interesse pro
prio del conoscitore di quest'arte del pensiero. Il pen
siero del quarto secolo si trova, da questo punto di vista,
inuna situazione non diversa da quella del suo linguag-
505 L POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
gio, che per l'uomo comune della nostra et resta pari
menti un mondo chiuso, del quale egli pu tutt'al pi
avere una volta un pallido barlume d'intuizione. Ri
spetto a questo consapevole tecnicismo si pu assumere
la posizione che si crede, ma certo che in esso noi
cogliamo un aspetto della natura del quarto secolo, a
cui pure ci lega spiritualmente la massima affinit sen
timentale, per il senso immediato che hanno per noi i
nomi di Platone e di Aristotele. Ma per giungere da
questa esperienza all'effettiva comprensione la via an
cora lunga.
L'importanza che l'atteggiamento analitico del pen
siero ha per la trattazione stessa dei problemi pu esser
constatata dappertutto, come per esempio nell'etica,
nella quale, dopo le equazioni e le coazioni concettuali,
tanto fruttuose quanto problematiche, della speculazio
ne pi antica (p. es. pex-irciaxTi)), si giunge ora per
la prima volta a una vera analisi della giustificazione
etica e delle forme della volont e dell'azione morale.
Ci non affatto ima semplice traduzione dell'etica in
termini di psicologia; bens, caso per caso, il punto di
partenza costituito da un'esatta indagine logica circa
il significato dei singoli vocaboli e concetti e da una
netta delimitazione dell'ambito in cui debbono essere
usati. Un esempio offerto dalle ricerche del sesto libro
dell' Elica Nicomachea sui termini aocptx, cppvrjou;, vo;,
rucxttj, liyyt], ouvsoi?, e&pouXia, Seivxt)?. La finezza
psicologica, con la quale qui sciolto nei suoi compo
nenti il nodo concettuale della platonica 'ppvTjat?, de
termina uno dei maggiori progressi che siano stati com
piuti sulla via che dalla pura idea del bene conduce
a un' etica della volont e dell'intenzione consapevole.
Quella
penetrazione psicologica per altro determinata
dall'analitica concettuale, che anzitutto, muovendo dal
linguaggio, si crea una teoria dei significati dei termini,
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 507
a cui poi si appiglia, con la sua sensibile pieghevolezza,
l'interpretazione psicologica.
L'esempio mostra subito chiaro come di fronte a tale
forma di considerazione iconcetti platonici si dis
solvano subito analiticamente nelle loro parti costitutive,
smarrendo quindi irrevocabilmente la loro natura. Che
cosa non comprendeva il concetto platonico della eppo-
vrjoi?
! L'idea come oggettivit e la contemplazione del
l'idea come processo conoscitivo, la tendenza teoretica
alla conoscenza del bene e l'attuazione pratica dell'in
tenzione e dell'azione merc questo stesso contemplare,
in breve l'intero yiXaoqoc, 05 era implicito in quel
concetto. InAristotele la :ppvrjac; ricondotta al signi
ficato che essa possiede nell'uso linguistico, torna ad
essere la saggezza morale e non costituisce ormai che
uno solo degli elementi tra imolti in cui si scinde ana
liticamente l'froc-Il pensiero aristotelico rielabora nello
stesso modo, differenziandone ivari aspetti, anche l'on
tologia e la gnoseologia platonica. L' idea, cio l'unit
intuitiva ed intelligibile del molteplice, che nello stesso
tempo era ideale etico, forma estetica, concetto logico
e realt essenziale in unit ancora indistinta, si spezza
nei vari aspetti rappresentati dai termini xaWXou,
oa(a
popcpT), xi rjv rivai, 8po? e xXoj, senza che alcuno di
questi concetti la eguagli, sia pur da lontano, in com
prensione logica. L' zloaq aristotelico 1'
lia, intellet
tualizzata, e sta ad essa come la ppvtjot; aristotelica
sta a quella platonica. Tutto ci che venuto a contatto
dello spirito di Platone possiede una certa rotondit
plastica, ma niente contrasta pi dell' fSla alla tendenza
analitica del pensiero aristotelico, il quale sta al pen
siero platonico come lo studio anatomico della figura
umana sta alla sua rappresentazione artistica. A chi si
ponga dal punto
di vista estetico e religioso pu darsi
che questo faccia spavento: ma ci non toglie che esso
503 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
costituisca un dato tipico della mentalit aristotelica.
L'applicazione di questo principio metodologico si
gnific la nascita della scienza nel senso moderno della
parola. Bisogna peraltro tener presente che tale fatto
culturale non ha soltanto questo significato essoterico,
ma un sintomo della complessiva evoluzione spirituale
del mondo ellenico. In seno alla storia del pensiero
greco la posizione di Aristotele d'importanza decisiva.
Dopo l'enorme sforzo della filosofia platonica, in cui
l'energia mitopoietica si fondeva con la genialit del
pensiero logico in misura di cui non si era ancora avuto
l'esempio, la creativit speculativa dell'et antica comin
cia evidentemente a venir meno e a sottostare al soprav
vento del metodo scientifico, in cui l'analisi concettuale
si collega con la ricerca empirica. Aristotele, il fonda
tore della filosofia scientifica, il realizzatore di questa
grande esigenza storica. caratteristico per la filosofia,
o almeno per la filosofia greca, come questo fatto non
sia divenuto il
punto di partenza di una nuova e feconda
evoluzione filosofica, ma abbia costituito solo un mo
mento di culminazione e transizione, che rimasto le
gato al nome di Aristotele. Certo, la tecnica intellettua
listica della sua analitica fu ripresa dalla filosofa elle
nistica, e anzi continuata a coltivare fmo alla scolastica,
ma lo spirito analitico di Aristotele non si trasfer in
essa, cercando piuttosto il suo nutrimento nel campo
della scienza positiva. L' inaugurazione della filosofia
scientifica divenne la causa immediata della definitiva
separazione della scienza dalla filosofia, perch la ten
denza speculativa dei Greci non toller alla lunga la
vicinanza dello spirito scientifico.
La forma peculiare nella quale il pensiero analitico
della filosofa scientifica s'impadroniva tanto della realt
quanto della tradizione spirituale era rappresentata dal
metodo della divisione logica, dell' argomentazione e
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 519
della dialettica. Accanto a queste l'ipotesi aveva ima
funzione subordinata, e veniva costantemente
applicata
solo in collegamento con la divisione logica. Per un
uso fruttuoso di questo mezzo logico mancavano ancora
alla scienza greca le premesse pratiche, e tra queste
so
pratutto
l'esperimento. Ogni divisione logica aveva, ac
canto alla sua funzione distintiva, una funzione ordina
trice, in quanto
delimitava l'estensione e la compren
sione dei concetti e il campo di applicazione
dei metodi,
conducendo con ci a poco a poco a quell'ordinamento
concettuale delle cose nella loro totalit, che noi chia
miamo sistema. Aristotele sempre stato considerato
come il sistematico xat'i|oxv, perch sotto l'influsso
del suo pensiero la filosofia si suddivisa in una serie
di discipline indipendenti
e pur collegate in unit da
comuni motivi teoretici. Iprimi tentativi di una siste
matizzazione della filosofa in questo senso apparten
gono, certo, gi all'Accademia e all'attivit speculativa
del vecchio Platone, che nel Filebo distingue la fisica
come Sswpx cpdoaocpcc dalla scienza delle idee, pi
tardi chiamata da Aristotele Kp&xij <pdoaocp{a. Che
anche l'etica abbia assunto una posizione indipendente
gi nell'Accademia dimostrato dalla nota tripartizione
di Senocrate, la quale distinguendo la filosofia in logica
fisica ed etica esercit influsso decisivo su tutto il pen
siero ellenistico.
Ma proprio i sistemi degli stoici e degli epicurei
mostrano chiaramente come ad Aristotele e a Platone
manchi, per rispondere all'esigenza della sistematicit,
il dato fondamentale, cio l'organicit definitiva e con
clusiva: e non un caso che ad essi sia ancora estraneo
anche il termine tecnico ouaxTjpa,
il quale caratterizza
esattamente il carattere costruttivo e totalitario e l'auto.-
sufficienza, allena dalla perenne vita dell'indagine, di
quelle concezioni ellenistiche dell'universo. Lo spirito
510 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
del pensiero aristotelico non nel auvtoxavat ma nel
Staipscv, considerato non come motivo di costruzioni
dialettiche ma come strumento di viva ricerca scienti
fica. Perci ilsuo sistema resta provvisorio, ed aperto
in ogni direzione. impossibile citare un solo passo
aristotelico in cui siano stabiliti in modo chiaro e defi
nitivo i limiti delle discipline scientifiche, anche sol
tanto di quelle fondamentali; ed anzi gli ammiratori
dell'ordinamento sistematico della filosofia aristotelica
non sanno neppure dire in quali parti essa propriamente
si divida. La famosa partizione della filosofia in teore
tica, pratica e poietica, e quella della filosofa teoretica
in teologia, matematica e fisica non mai messa in atto
da Aristotele e non comprende in s il suo effettivo si
stema, essendo soltanto un'astratta divisione concettuale.
Tenuto conto dello stadio evolutivo in cui Aristotele si
trovava quando scriveva queste parole, tale suddivi
sione serviva soltanto a giustificare genericamente la po
sizione dominante della metafisica in seno alla filosofia.
Anche le singole discipline, in s considerate, hanno
sempre opposto le massime difficolt al tentativo di un
approfondito ordinamento sistematico: cosa che si com
prende oggi anche troppo bene, dato il modo in cui si
vennero generando gli scritti aristotelici. Nati come
frutto di un progressivo e infaticabile lavoro condotto
nell'ambito di singoli problemi particolari, essi presen
tano sempre un aspetto disarmonico a chi ne voglia
controllare minutamente la costruzione sistematica. Ci
accade per la Storia degli animali non altrimenti che
per la
Metafisica
e per la Politica. Abbozzi di ordina
mento sistematico, spesso inseriti solo durante il
poste
riore lavoro di fusione, restano senz'alcuna applicazione
o vengono applicati soltanto a met.
Quella
della siste
mazione esteriore non stata un'idea originaria di que
sto architetto, e quindi neppure tale sistema si pu ri-
LA rOSIZIONC STORICA DI ARISTOTELE 511
costruire , nello stesso modo in cui impossibile tra
sformare in complessi letterariamente armonici, merc
semplici trasposizioni, le varie stratificazioni sovrappo
ste che costituiscono itrattati didattici.
Se prescindiamo da questo significato che il termine
sistema possiede in quanto designa l'edificio dogmatico,
resta soltanto quello che indica la forza ordinatrice e
discriminatrice dell'analisi, la quale ha pure una fun
zione sistematica, per quanto in senso assai diverso. Si
stema significa in questo caso non la costruzione di un
organismo scientifico in quanto risultante dalla molte
plicit delle singole conoscenze e discipline, nella sua
dogmatica e superficiale rigidit, visibile da lontano
come la facciata di un edificioT), bens l'interiore e pro
fonda gerarchia dei concetti fondamentali, portata
da
Aristotele per la prima volta alla luce. La maniera in
cui egli anzitutto getta sulla realt la rete delle catego
rie, quindi estrae dal complesso di queste l'indipen
dente xs
xt,
vede in esso 1' ocfa del pensiero filosofico
e infine discende nella profondit di questo concetto
per portare
alla luce l'uno dopo l'altro gli strati ideali
della materia, della forma, del concetto essenziale, del
l'universale, della potenza e dell'atto, costituisce senza
dubbio il procedimento di un pensiero sistematico. Mer
c questa analisi il puro xSs xc si differenzia dalla
forma che determina la materia e in cui il pensiero
concettuale coglie l'essenza del reale, la quale a sua
volta sta alla materia come l'atto alla potenza.
Questi
stessi concetti fondamentali permeano, come strati sot
terranei, molte discipline: il concetto della forma inter-
')
Questo
concetto ellenistico del gocnjfiaTtxiv teorizzato
incisivamente da Sesto Empirico (adv. log.,
L
p. 198, 3 segg.) in base
alle sue fonti, principalmente stoiche. La verit qui presentata
come saldo sistema scientifico ci,; v
tuoty'
|ii}
xaS-sottlxuta
auaTTjjiatixi}) e quest'ultimo caratterizzato come 28-poicpa x
rtXsivuv.
512 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
viene per esempio tanto nella psicologia, nella logica e
in tutte le scienze particolari quanto nella fisica e nella
metafisica, cio nella filosofia teoretica, a cui pi pro*
priamente appartiene. La teoria del
voO?
manifesta il
suo influsso nella metafisica, nell'etica, nella psicologia
e nell'analitica. Tali comuni motivi teoretici determi
nano dall'interno l'unit delle varie discipline: e que
sta non sorge per opera di una parificazione estrinseca
delle diverse trattazioni, bens il principio originario
da cui si genera la stessa molteplicit di quelle. L'idea
platonica era ancora oggetto dell'etica, dell'ontologia e
della gnoseologia nello stesso tempo. La oiafpsai? scinde
la sua teoria in pi discipline, ma Aristotele, animato
dall'intento platonico dell'unit, fornisce ad esse il co
mune fondamento di un concetto della realt e della
conoscenza corrispondente a quello dell'idea, nel quale
la molteplicit trova la sua unica radice.
Ci nonostante ogni particolare dominio scientifico
conserva il carattere della ricerca problematica, la quale
non trova mai il suo
appagamento nella forma esterna
della costruzione esatta e definitiva, ma si perfeziona
di continuo, abbatte quel che prima aveva edificato, e
cerca nuove vie. Se c' una totalit a cui Aristotele mira,
questa non la totalit della conoscenza compiuta, ma
la totalit dei problemi. Ci pu esser reso evidente dai
risultati delle nostre indagini a proposito dell'etica. Giu
sta la posizione platonica del problema, l'eudemonia
consisteva o nell' ccpexrj o nell'Sovfj o nella cppvtjcrts. Il
Filebo mostra come nel corso dell'indagine filosofica il
problema dell' f/5ovr; assumesse in Platone una posizione
in certa misura indipendente e 6 costituisse cos un pro
prio campo teoretico, che col problema della cppvTjaig,
dell'pe-rq e dell' s'jaipovCa aveva un contatto solo tan
genziale. Lo stesso accadeva ai nuclei teorici costituiti
dai problemi della cppvTjoi;, dell' psrfp della piXfa e
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 513
dell' sSaipovfa. Tutti questi problemi erano dibattuti
di frequente nell'Accademia e prendevano sempre corpo
in trattazioni relativamente autonome, come appare dai
titoli degli scritti dedicati a tali argomenti dagli Acca
demici. Idialoghi di Platone offrono un quadro fedele
di questi nuclei problematici divenuti indipendenti.
Ora, Aristotele ricomprende in unit tutti i problemi
concernenti l'etica (t V)lh%) e, senza limitare la libert
di movimento in seno a ciascuno di questi gruppi di
problemi, giunge a poco a poco a un loro pi rigoroso
inquadramento metodologico in seno a tale unit, che
in origine era soltanto generica e debole. Ilprocesso di
unificazione non si spinge per mai tanto innanzi, da
render per esempio possibile di giustificare da un punto
di vista sistematico la posizione del complesso dei
problemi Ilep epiXfa? nei libri Vili e IX dell'Etica Ni-
comachea, o di spiegare altrimenti che per motivi reda
zionali la duplice trattazione del problema Ilepl VjSovfJ;
nei libri VII e X. Nei casi in cui, come nella
Metafisica
e nella Fisica, possiamo spingere lo sguardo pi pro
fondamente nel processo genetico degli scritti, vediamo
come verso la fine di tale processo si faccia sempre pi
vivo l'intento di giungere a un generale ordinamento
sistematico, senza peraltro che quest'ultimo venga mai
condotto a termine. Solo la storia dell'evoluzione intel
lettuale di Aristotele mette chiaramente inluce le radici
e il significato di ci che possiamo chiamare il suo si
stema . Isistemi ellenistici si ricollegano alla filosofia
aristotelica dell'ultimo periodo, ma in ci muovono dal
l'impressione esterna e rendono primario ci che in
Aristotele era secondario. Partendo da premesse va
lide costruiscono dogmaticamente un rigido quadro
dell'universo, e cercano in questo sicuro edificio un ri
paro dalle tempeste
della vita.
83.
\V. Jaeohr. ArUtolele.
*
I
514 LA POSIZIONE STORICA RI ARISTOTELE
e)
Speculazione e scienza.
Nella metafisica convergono tutti imotivi della filo
sofia di Aristotele, mentre essa a sua volta
invade..
il .
camp di tutte l altre discipline. Essa l'espressione
delle ragioni ultime della sua filosofia, e qualsiasi con
siderazione di una"singola parte
della sua dottrina, che |
. non muova da questo organo centrale, condannata a $
| passare innanzi al nucleo essenziale del suo contenuto
| senza penetrarvi dentro. Non facile giungere a un gi- ,f
I
dizio esatto circa l'essenza e la funzione della metafisica,
:j
-,
gi per l'impedimento provocato dal pregiudizio intrin- V
seco al suo nome. Il periodo dell'influsso dogmatico .
|
della filosofia aristotelica si concluso con la dissolu*
j
zione della metafisica come scienza, e quindi con la
?
distruzione dell'edificio costruito da Aristotele. D'allora
in poi lo si considera involontariamente come l'ere del
%
dogmatismo e come il diretto e sfortunato antagonista
di Kant, e si crede di rendergli un servigio preferendo
..le partinon metafisiche della sua
.filosofia
e facendolo :
'
;
apparire in una luce tendenzialmente positivistica. Ma ;
Aristotele non mai stato positivista, neppure nei tempi j
in cui.prevalse inlui l'interesse, per la ricerca empirica.
i
I
II vivo significato della sua metafisica non pu essere
; valutato dal punto di vista del criticismo moderno, ma
solo in connessione storica coi problemi del suo tempo. '.
Da questo angolo visuale si vedr come l'intento, di essa j
meriti a maggior ragione il nome di
critico che quello \
di dogmatico. Lo scopo a cui mirava Aristotele era
quello "della catarsi~"dellT'cscienza filosofica dai suoi
elementi mitici e metaforici,.Ja quale gli permettesse
di determinare nella loro rigorosa nettezza scientifica i
fondamenti della visione del mondo che nelle linee ge-
5
nerali egli aveva attinta a Platone. In.gtre parole, era
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 515
un interesse metodologico quello che lo conduceva a
questa nuova costruzione
_
speculativa, di
.tanta
impor
tanza per.il-futuro.
La metafisica nasce dall' intima tensione provocata
i dall'antitesi tra lo spirito del razionalismo logico e
J
quello della speculazione religiosa, antitesi che costitu-
/
see l'elemento nuovo e problematico della personalit
filosofica di Aristotele. PTeipi antichi sistemi cosmici
dei fisici greci l'elemento-mitico e
.l'elemento
razionale
sono ancora fusi in unit indistinta. Considerata la cosa
dal punto di vista storico, un abuso, a cui la frequenza
non accresce giustificazione, quello che ai compie quan
do si considerano queste filosofie come sistemi metafisici,
perch contengono elementi metafisici nel senso nostro
clella parola. In"
questo senso sarebbe naturalmente da
chiamare, metafisica' anche la fisica di Aristotele, per
quanto proprio questo esempio mostri evidente l'assur
dit storica di tale anacronistica designazione. Nel caso
dei presocratici essa avrebbe senso solo quando dovesse
significare che la teorizzazione della metafisica quale
scienza indipendente ebbe in Aristotele lo scopo di tra
sferire con intenzione nel centro del pensiero filosofico
questi elementi dogmatici e mitici, che nella cosmologia
dei suoi predecessori si erano sino allora inseriti in
forma soltanto inconsapevole. Alquanto pi giustificato
l'uso clie si fa del termine quando lo si riferisce al
mondo platonico delle idee. In tal caso esso designa
l'intervnto dell'invisibile e dell'intelligibile nell'ambito
della consapevolezza filosofica, e in particolare l'aspetto
oggettivistico che le idee hanno in quanto .
superiore
forma dell' essere, non percepibile nell'esperienza.
Con ci si collega, nella pi tarda fase dell'evoluzione
j
,
platonica, il problema religioso della teologia finalistica, /
'
divenuto punto di partenza della metafisica aristotelica.
'
Ma anche questo uso del termine nel suo significato mo-
516 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
derno a rigore antistorico (per quanto esso torni sem
pre involontariamente alle labbra) ed ostacola l'esatto
intendimento dell' opera cbe Aristotele propriamente
comp. Solo injui nasce
.yeramente
la
metafisica, dal'
conflitto delle convinzioni religiose e speculative, attinte
a Platone, cl" pensiero analitico della scienza. Platone
non conosce ancora questo
intimo dissidio. Esso nasce
dal crollo della costruzione scientifica con cui Platone :
aveva teorizzato la nuova realt del sovrasensibile, e in
\
cui per un momento era parso che la pi entusiastica
esperienza dell'inattingibile venisse senza residui a coin- 'r
cidere con la scienza esatta. Dalla dissoluzione di que-
1
t
sta imita intuitiva e mitico-logica Aristotele riport, (
quasi come deposition fidei, l'incrollabile certezza che ; |
nella fede platonica dei suoi giovani anni dovesse pur . ;
esserci un profondo nucleo di verit. La metafisica il
grandioso tentativo di rendere accessibile all'intelletto
1
critico qusta realt cbe trascendeva ilimiti d.elpespe*. .
rienza umana. questa profonda, e finora miscono
sciuta, comunanza di problemi coi filosofi religiosi del .. i
medioevo cristiano, ebraico ed islamico, e non la mera
contingenza della tradizione, che ha portato
Aristotele
a diventare la guida spirituale dei secoli postagostniani,
il cui mondo interiore era stato portato dal contrasto
della fede con la scienza a varcare di gran lunga ilimiti
della spiritualit ellenica. La storia della sua evoluzione
intellettuale mostra come acche nello sfondo della sua
metafisica sussista gi il credo ut intelligam.
;
Lo studio storico dell'evoluzione di Aristotele mette
d'altronde in pi chiara luce anche iprincipi metodo
logici su cui s basa la sua nuova filosofia. Finora si
credeva, per lo pi, che la parola metafisica dovesse la
sua origine solo al casuale ordinamento degli
scritti
ari-
stflci' in un'edizione complessiva dell'et ellenistica
(si pensava anzitutto a quella di Andronico), non es*
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 517
sendo aristotelica neppure dal punto di vista del conte-
nuto. In reah~questa"parola, coniata certo da un peri-
patetico anteriore ad Andronico, rispecchia con piena /
esattezza il motivo fondamentale della prima
filoso
fia nel suo significato originario. Mentre lo sguardodi
Platone rivolto fin da principio al culmine supremo
del mond delle idee,_e. scorge ogni certezza immediata-
mente radicata nella conoscenza della realt invisibile e
intelligbile, la metafisica
'
aristotelica"s'innalza sul fon
damento della fisica, e muove quindi da un punto di
partenza opposto a'quello platnico. La monade supre
ma, che per Platone la norma pi esatta e il pi certo
oggetto dello spirito, diventa per Aristotele l'ultimo e
pi difficile dei problmi L
designazione della nuova
disciplina, che in lui s'incontra pi spesso e che pure
sfugge alla maggior parte dei critici, quella..di_scien
za cbe oggetto della ricerca. In
anttesi.
a,.,tutta,le
altre scienze, essa non muove da un dato oggetto, .nia
anzi parte dal problema dell' esistenza stessa _di_qu;_
st'ultimo. Essa ha quindi anzitutto da dimostrare la sua
"possibilit di essere una scienza, e di fatto viene .esau
rirsi del tutto in questo problema introduttivo.
~Pef~A'ristotele a priori indiscusso cbe la scienza
in questione possibile solo se esistono le idee o qual
che altro essere intelligibile e separato ad esse cor
rispondente. Nonostante il suo atteggiamento critico
rispetto a. Platone,
""
egli
.
resta cioJegato all' idea che
ogni effettivo sapere presuppone un oggetto esistente al
di fuon~deIIa coscinza
'
(iu) Sv xal copioriv),
che esBo
comunque attinge, copia o rispecchia in s. Come si
detto, questo realismo non affatto specificamente ari
stotelico, ma generalmente greco, n pensiero dell'anti
chit non ha superato l'oscura intuizione .del rapporto
tra conoscenza ed oggetto,
che si manifesta in quelle
espressioni metaforiche. In seno a questi limiti storici,
1
513 LA POSIZIONE STORICA III ARISTOTELE
la metafisica di Aristotele
rappresenta rispetto all'onto
logia platonica una posizione del problema che corri
sponde abbastanza esattamente a quella di Kant di
fronte al razionalismo dogmatico del Settecento. Ilpro
blema se sia possibile la scienza in questione assume
in Aristotele l'aspetto oggettivistico dell' esistenza del
presunto essere soprasensibile, mentre in Kant assume
invece quello metodologico dell' esistenza dei giudizi
sintetici a priori, senza iquali non possibile pensare
la metafsica tradizionale. Che il criticismo
sit venia
3
verbo dell'antichit sia caratterizzato dalla nota rea-
V;.:
Ustica e quello dell'et moderna dalla nota idealistica,
non cosa che non debba far riconoscere l'intima somi
glianza delle due situazioni storiche. Entrambi ipensa
tori stanno al termine dei processi evolutivi a cui ap
partengono, e non hanno quindi avuto nessun vero suc
cessore, nonostante che dopo lunghi periodi d'incom
prensione abbiano avuto momenti di sopravvivenza, de
generati poi nel formalismo. La vita effettiva della filo
sofia si svolge dopo di essi o nella direzione del sensismo
o in quella del razionalismo o in quella del misticismo,
e abbandona cos, nella sua unilateralit, quel livello
di finezza e di acume scientifico che la trattazione dei
problemi aveva raggiunto in entrambi ipensatori, o la
sciandoseli alle 6palle nella foga metafisica o ritornando
a uno stadio evolutivo pi arretrato. Aristotele perci
l'unico pensatore greco, con cui Kant poteva discutere
da pari a pari e che poteva proporsi di superare. D'ai-
'
:
tra parte la posizione kantiana presuppone come base
soltanto la critica trascendentale della consapevolezza
conoscitiva, mentre il realismo critico di Aristotele ha
per fondamento il suo sistema fisico e un'analisi critica
'*'
del concetto dell'essere, la quale muove dagli oggetti
dell'esperienza.
Sulla fsica la metafisica si fonda anzitutto in quanto
i
1
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 519
essa non , secondo l'intenzione di Aristotele, altro che
la necessaria conclusione del sistema teoretico deldiye-
hire naturale, costruito sul fondamento dell'esperienza.
Ta fisica .deve..spiegare anzitutto il movimento. Che la
dottrina delle idee non lo spieghi, per Aristotele ima
delle obiezioni principali a cui essa va incontro. Inque
sta critica egli ha dinanzi agli occhi, quale modello clas
sico, un tipo determinato di scienza naturalistica, e cio
il metodo ipotetico di Eudosso, il quale interpretava un
insieme complesso di fenomeni facendoli risalire ai prin
cipi pi semplici (in questo caso, alla costruzione ma
tematica dell'intero moto planetario da semplici orbite
circolari). L'ideale metodologico della metafisica quello
del giustificare fenomeni, ou>etv t tpaivpsva. Essa
deve ricavare le ragioni ultime del mondo empirico
dai fenomeni stessi e dalla loro legge interiore. A que
llo scopo, certo, essa" deve valicare, "in un dato punto, i
confini dell' esperienza immediata, ma non pu avere
altra intenrin~clie quella di porre hi
luce. le.
premesse
implicite negli stessi. fenomeni, esattamente interpretati.
LT~riduzione del moto animale all'eterno moto cosmico
e di quest'ultimo a quello dell'orbita estrema era.,per
Aristotele un dato di fatto, che la scienza eudossiana
dlia'natura aveva sottratto ad ogni dubbio. In essa la
scienza sperimentale "raggiungeva un grado di esattezza
matematica, a cui non si era fino allora potuti mai per
venire in quel campo. Secondo le premesse della fisica
aristotelica, questo sistema cinetico poteva
avere la sua
"cfiiav"di volta solo inuna causa ultima. La conclusione
dell' esistenza del primo motore era .quindi suggerita
dalla natura stessa.
~~
Questa
nozione da Aristotele ancorata anche pi
profondamente nella fisica in forza della sua analisi del
concetto dell' oc'.a.. questa analisi che conferisce al
l'idea di una somma causa di ogni movimento l'aspetto
520 ti POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
pi determinato onde essa si presenta, nel regno delle
. forme naturali, come forma suprema e conclusiva. La
;teoria aristotelica dell'essere ha il suo punto di par-
lenza nel mondo della realt sensibile, nella cosa sin
gola quale se la rappresenta la coscienza ingenuamente
realistica. C'era una via per giungere alla conoscenza di
quest'essere individuale? La fisica antica non era stata
capace di trovarla. La sua teoria degli elemnti' e'del
moto aveva invero molte nozioni circa icomponenti di
tutte le cose e circa le forze agenti nel loro interno,
ma queste nozioni erano ricavate con procedimenti sol
tanto speculativi. La scissione sperimentale, operata con
mezzi tecnici nel modo in cui vien compiuta dalla scien
za moderna, della cosa singola nei suoi elementi mate
riali era anche per l'evoluto atomismo democriteo non
meno irrealizzabile di quanto fosse per ifisici pi an
tichi e pi primitivi. Al culmine e al termine del suo
sviluppo, la filosofia di Platone comprendeva, quale og
getto del sapere scientifico (iTcwnfipj), l'intera gerar
chia, determinata dalla divisione dialettica, degli elSij,
dal genere pi universale alla specie pi bassa, non ul
teriormente divisibile (-ropov e!8o{). Ma ci che rima
neva al di qua di tale confine del mondo delle idee col
mondo dell'esperienza era Sireipov : non essere
verace,
ma oggetto di meraoja. L'topov platonico non era an
cora l'individuo connesso con la materia, la forma imma
nente (SvuXov sTSoc) di Aristotele. Per quanto seriamente
Platone, nel suo ultimo periodo, si occupasse del pro
blema della 5 egli non
poteva, partendo dall'idea,
cogliere l'essere individuale dell' esperienza. La fisica
non era per lui che un cumulo di
exxe? p.ud'OU
A questo punto interviene Aristotele con la sua cri
tica. Fin dal principio egli mira a rendere l'eidos atto
alla conoscenza dei fenomeni.
Questa esigenza per lui
equivalente a quella di rendere accessibili al concetto
v
$
i
i:
?r
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 521
le cose sensibili, perch, filosofo platonico, egli consi
dera il sapere e la scienza come possibili solo merc
l'universale. Suo ambiente storico il processo evolutivo
che la teoria delle idee aveva cominciato a percorrere
nella pi tarda fase dell'attivit platonica, e merc la
quale l'aspetto logico dell'eidos come universale e come
concetto e la sua importanza per la conoscenza erano
stati per la prima volta messi in chiara luce. Ma per
ci stesso era divenuto problematico l'aspetto ontologico
dell'idea. Per Aristotele principio indiscusso che niente
di universale possiede un' esistenza indipendente. Da
questo punto
di vista egli vede nella dottrina delle idee
del vecchio Platone ima materializzazione dell'univer
sale, alla quale egli contrappone la sua teoria della de
terminazione della materia per mezzo della forma. In
forza di essa egli supera di fatto le cose del realismo
ingenuo, e le rende concettuali. Tutto ci che oggetto
di esperienza sensibile viene a conoscenza del soggetto
pensante in quanto
diventa forma concettuale: ma an
che la sua esistenza dipende da questo
suo esser forma.
L'universale determinazione della realt per opera del
l'intelletto e la molteplicit predicativa della sua gerar
chia concettuale fondata non in una costituzione tra
scendentale della coscienza conoscente, bens nella strut
tura etessa di ci che esiste. Qui, non si pu negare, resta
implicito un grave problema: ma quel che interessa
Aristotele soltanto di cogliere la realt singola merc
l'eidos, e ci per lui pensabile solo nel senso che con
l'eidos si colga nella cosa ci che essa propriamente
(x t elvai)- La 5Xr; il residuo irrazionale, e in s
inconoscibile, che resta al termine di questo processo di
riduzione della cosa a forma e a concetto: il non ente.
Ma di questo non ente, se non si pu dire che sia, nep
pure si pu dire che non sia: esso infatti non an
cora, cio acquista realt solo in quanto diviene il
,
522 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
portatore di qualche determinazione concettuale. Nes
suna materia quindi soltanto materia, nel senso in cui
ifisici pensavano che fosse: materia di questa deter
minata forma, ma, anche astratta da essa e considerata
per s, gi una realtinqualche misuraformata. Nulla
infatti , che sia assolutamente informe e indetermi
nato. Il concetto di una materia ultima, affatto informe
e indeterminata, s un concetto limite del nostro pen
siero, ma non designa alcuna realt effettiva. Tutto
forma, ma la forma stessa diventa alla sua volta materia
di una forma superiore. La concezione aristotelica del
l'essere si orienta quindi verso una forma conclusiva, la
quale determina ogni altra realt senza essere determi
nata da nessun' altra. La fisica delle forme immanenti
giunge cos al suo termine ideale solo nella forma tra
scendente della metafsica.
Con ci la forma diviene insieme il principio d'in
terpretazione del movimento, che n Democrito n Pla
tone avevano
potuto, dal loro punto di vista, concepire
scientificamente. Scopo della teoria aristotelica del mo
vimento la creazione di una logica di quest' ultimo.
Aristotele cerca di renderlo accessibile al concetto al
pari della singola cosa materiale, cio di scoprire inesso
la determinazione formale in base alla quale possa es
ser compreso. Inquadra perci il movimento in un si
stema stabile, ch dovunque c' solo mobilit e divenire,
e non stabilit e
costanza, la scienza ha perduto isuoi
diritti. La fisica di Aristotele trova questa realt stabile
non nell'elemento quantitativo, ma in quello qualitativo
e formale che appare come scopo del
movimento. Man
cano, da un lato, le possibilit tecniche
d'intraprendere
esatte misurazioni quantitative o di controllare le con
dizioni quantitative delle stesse qualit, e ci rende im
possibile un progresso della ricerca scientifica in
questa
direzione. Ma quel che soprattutto avverte
Aristotele
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
523
come nel cosmo il movimento si realizzi sempre in
forme fisse ed entro limiti stabili. II grandioso quadro
offerto dalla parte superiore dell'universo non pu es
sere infirmato dall'apparente arbitrio e irregolarit del
movimento dominante
nel mondo della nostra esistenza
terrena, esigua a paragone della totalit cosmica. La
teoria eudossiana delle sfere assume importanza fonda
mentale anche per questo aspetto
della concezione del
l'universo. La costanza e regolarit dell'eterno moto cir
colare degli astri, assunta da quella ipotesi astronomica
come fondamento dei fenomeni celesti visibili, aveva in
s qualcosa di finale e formale, che non era possibile
dedurre dai presupposti meccanici della teoria della
gravit allora corrente. Ifisici erano per lo pi ricorei
all'idea di un vortice cosmogonico, che avesse messo in
moto
l'universo; ma di fronte alla sempre crescente per
suasione della regolarit e inalterabilit dei fenomeni
l'idea di una cosmogonia meccanica perdeva sempre pi
terreno, anzi appariva come un assurdo. Aristotele pro
cede in ci ancora oltre Platone, che pure aveva fatto
almeno il tentativo di concepire la creazione cosmica in
base al presupposto dell'astronomia
eudossiana, ponendo
al suo principio la ragione ordinatrice inluogo del caos.
Da questa anassagorea Siaxa|iY}Crc<; per opera dello spi
rito Aristotele si stacca completamente quando dichiara
eterni e ingenerati icorpi celesti e 1' opav?, e fa risa
lire illoro moto a cause interne, formali e finali.
Considerato in rapporto
al movimento, l'eidos pren
de il nome di iv-Te-asta, in quanto esso , per ogni
cosa, il tXo?
realizzato del suo divenire. Nei corpi ce
lesti questo xXo; consiste nell' eterno corso circolare.
Ma Aristotele trasferisce questo principio anche alle cose
terrene, e applica con ci il finalismo platonico in tutta
l'estensione del suo mondo delle forme, nonostante che
il movimento degli esseri terreni sia apparentemente,
524 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
in termini platonici, una Csxa.Toj xtvrjct Ma ad una
considerazione pi approfondita il principio fondamen
tale del divenire si manifesta nel mondo organico iden
tico a quello che vige pei corpi celesti, cio quale moto
di traslazione, a cui sono da ricondurre tutte le altre
specie di movimento.
Qui
esso entra in servigio delle
speciali leggi del divenire organico, che a loro volta
hanno la ragion d'essere nella forma. Per gli esseri che
nascono e muoiono l'entelechia costituisce il momento
culminante
dell'evoluzione organica. In essi l'eidos si
manifesta come quella regolarit e determinazione for-
|
male, che agisce dall'interno con energia creativa e si , v
sviluppa dalla materia come da un germe. .
j,
Si sempre considerato quest'ultimo
aspetto dell'en- ."g
telechia come quello originario, e si quindi creduto
che il
concetto sia stato inizialmente formulato in rap
porto alla vita organica e poi trasferito, con generaliz
zazione illecita, ad altri campi: esso avrebbe cos pos
seduto anzitutto un significato vitalistco e biologico, al*
l'incirca come quello della moderna forza vitale .
A questo proposito si presupponeva che Aristotele fosse
stato fin da principio quel perfetto maestro nel campo
zoologico e biologico, che esso ,
appare nella Storio degli
animalit
e che avesse
scoperto quel principio quasi in
tuitivamente, nel corso delle sue indagini empiriche.
E in conclusione si considerava proprio il concetto bio
logico dello sviluppo come la sua pi veta creazione.
Ma questo era il peggior modo di far moderno Ari
stotele. L' v-teX-ysia ha un significato logico-ontolo
gico, ma non biologico. In ogni specie di movimento lo
sguardo di Aristotele mira al "eXo-;.
Quel
che suscita il
suo interesse non il fatto che qualcosa divenga, ma
che quel che diviene sia qualcosa, cio che al termine
del divenire si traduca in realt la norma direttiva del
divenire stesso, Veidos.
v
.1,
LA F0SIZ10NE STORICA DI ARISTOTELE 525
Das Werdende, das ewig wirkt und leLt,
Umfass'euch roit der Iiebe hoLden Schranken,
Und was in sebwankender Erscheinung schwebt,
Befestiget ait dauernden Gedanken (').
Certo, iconcetti della potenza
e dell'atto, che per lo
pi vengon parimenti fatti risalire al processo della vita
organica, sono da Aristotele chiariti,
occasionalmente,
con l'esempio del seme e del prodotto sviluppato. Ma
quei concetti non possono provenire dalla conoscenza
dell'evoluzione organica, e sono piuttosto attinti all'idea
della capacit umana (Suvajtij),
che ora giace latente,
ora si traduce in atto (Ipyov) e solo in questa
attivit
(vpyeta)
raggiunge il suo fine (vreXeia). Ancora
pi antistorico ilvedere nella teoria delle anime astrali
una conseguenza dell'estensione della
forma
substantia-
lis, ritenuta vitalistica o addirittura psichica, a tutta la
realt: e del resto alcuni commentatori, procedendo
coerentemente in questa direzione, hanno attribuito in
Aristotele un'anima anche alla realt inorganica e hanno
fatto di lui nn pampsichista.
Quanto
pi in alto si sale nel cosmo, tanto pi pura
l'espressione che della forma costituente il suo scopo
compie il movimento. Considerato nella sua totalit, il
moto cosmico effetto ed espressione di ima forma as
soluta, libera da ogni materia. Nell'idea di quest'ultima
giunge a manifestazione completa l'antitesi rispetto alla
fisica preplatonica, che spiegava
il modo inbase a cause
meccaniche e lo faceva nascere dalla materia caotica.
Nella sua determinazione
formale e nella sua essenza,
la realt necessariamente quella che . Non possi
bile dedurla dalla pura possibilit
o dal caso, perch
*) [La realt diveniente, clie opera e vive eterna, |abbracci
voi coi vincoli pii dell' amore, |e ci che fluttua nell'ondeggiante
apparizione | aia da voi fermato nella costante saldezza del pen
siero (Goethe, Faust, Prologo in cielo)].
526 LA POSIZIONE STORICA ni ARISTOTELE
allora essa potrebbe anche non essere o essere altrimenti.
Al culmine del divenire dev'esser posta la forma, e la
forma suprema dev'essere puro atto, cio determinatezza
e idealit senz'altro residuo. Ma il pensiero non
pu
pensar nulla di pi perfetto che s
stesso, perch, es
sendo lo scopo di tutto ildivenire cosmico e tutto ten
dendo verso di
esso,
necessariamente la cosa pi per
fetta che esista. IL pensiero che
pensa e stesso non
per altro
un'autocoscienza
puramente formale e vuota
di
contenuto, un Io assoluto nel senso di Fichte. Per la
teleologia di
Aristotele
e!5o? e xXo; sono una cosa
sola, e il fine supremo insieme la pi determinata
realt che ci sia.
Questo pensiero, che insieme essenza
ed esistenza, ha in s la
massima idealit platonica e
nello stesso tempo la ricca e complessa
determinatezza
dell'individuo, ed perci vita e beatitudine etema.
L'unit di Dio col mondo non determinata nel senso
che esso lo compenetri, o che contenga ins come mon
do intelligibile latotalit delle forme di quello, secondo
quanto pure si creduto. Il mondo bens pende
(rjpTYjrai) da lui: Dio la sua unit, pur non essendo
in esso. In quanto ogni essere realizza, nello sforzo del
suo
divenire, la propria forma, realizza per la sua parte
quella infinita perfezione, che Dio nella sua totalit.
L'intento
aristotelico di rendere fecondo per la co
noscenza del mondo sensibile l'eidos e il concetto, cio
il pensiero logicamente
esatto
scoperto da Platone, po
teva prender forma solo in una
considerazione concet
tuale della natura e della sua essenza, dalla quale non
riceveva invece immediato impulso la cognizione delle
cause materiali.
Questa considerazione portava cosi a
una filosofia della natura basata su fondamenti meta
fisici , nel senso odierno di questa parola. Ma l'inten
zione di
Aristotele era in realt del tutto opposta. Egli
poteva credere di aver superato con la sua interpreta-
LA POSIZIONE STORICA RI ARISTOTELE 527
zione teleologica della natura la fisica pi antica, che
deduceva ogni accadere da cause meccaniche e mate
riali.
Queste
cause inferiori erano invero riconosciute
da lui nella loro realt, ma subordinate alla causa for
male e finale. Materia e forza non sono la natura :
questa l'architetto, che procede secondo un piano e
un'idea interiore, mentre quelle sono soltanto imano
vali. La necessit naturale concepita nel senso degli ato
misti s la condizione indispensabile per l'azione della
natura allo stesso modo che per la tecnica dell'uomo:
ma per l'interprete della natura, come gi aveva inse
gnato Platone, essa resta un mero aovataov.
Quanto
pi, nel corso della sua vita scientifica, Aristotele s'in
teress della ricerca positiva, tanto pi profondamente
egli dovette immergersi nello studio della particolare
costituzione materiale delle cose singole; mentre sinch
la sua fisica si tenne nel campo dell'indagine concet
tuale, la relazione del covaliiov con la causa finale pre
sent per essa poche difficolt. Ilquarto libro della Me
teorologia, che non autentico e che contiene il primo
tentativo antico di costruire una chimica, mostra chiaro
quanto diventasse problematica quella relazione appena
la scuola di Aristotele cominci a studiare iproblemi
della costituzione della materia. Nello stesso istante
riaffiora, come ipotesi utile al lavoro scientifico e senza
immediatamente mettere in pericolo il fondamentale
carattere teleologico della fisica, 1' atomismo di Demo
crito e la sua concezione del vuoto. L'autore del quarto
libro della Meteorologia un rappresentante
di questo
stadio di transizione1). Ma gi Stratone lascia cadere la
teleologia e con essa la metafisica, e ricostruisce la fisica
aristotelica su fondamento democriteo. L'elemento crea-
*) Cfr. per ci che segue J. Hammer-Jensen, in Hermes, L,
p. 113 segg.
-
'
523 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
Ilvo, artistico , della natura da lui trasferito nella
materia e nelle sue propriet. Si anche pensato
che
lui stesso sia l'autore di quel libro, il quale in tal caso
dovrebbe certo essere un lavoro giovanile, in cui la con
cezione del maestro sopravvive ancora, in conflitto con
tesi atomistiche. Ma non necessario ricorrere al nome
famoso di Stratone per comprendere la tendenza che si ;
?
manifesta in questo interessante scritto. La fisica teleo
logica si trasferisce dal tardo platonismo al primo pe
riodo dell'attivit di Aristotele, e diviene il fondamento
della sua filosofia. Il suo principio trova un terreno fe
condo nell'indagine del mondo animale e vegetale. Per .
,
lo studio della materia inorganica il principio della for
ma si dimostra invece alla fine insufficiente, e la consi-
v
derazione atomistica si fa di nuovo avanti da s. i
L'interesse metodologico resta predominante per Ari- ;'
stotele anche nelle fasi seguenti della sua evoluzione
spirituale, come per esempio quando egli pi tardi in-
f:
6erisce tra fisica e metafisica, come elemento d congiun
zione, una speciale indagine sulla continuit ed eternit
'
del moto cosmico e sul movimento circolare, la quale
conduce fino sulla porta della metafsica e mostra come
senza quest'ultima la fisica non sia che un tronco mu
tili).
Dominato dall'interesse metodologico anche il
concetto fondamentale della metafsica pi tarda, se
condo il quale alla teologia va premessa la teoria gene
rale dell' oca, c la metafisica va trasformata in una
scienza dei molteplici significati dell'ente. Dalla dottrina
dell'essere soprasensibile, che ha un oggetto diverso da
quello della fisica, nasce ora una scienza la quale con
sidera dal punto di vista del suo contenuto ontologico
lo stesso oggetto che la fisica studia dal punto di vista
del movimento. Entrambi imotivi originari della me
tafsica, quello fisico del primo motore e quello metafi
sico del soprasensibile, passano perci in seconda linea,
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 529
e si fa avanti il nuovo motivo della morfologia d ogni
specie di essere. Si avverte in ci l'influsso dell'atteggia
mento spirituale del vecchio Aristotele, orientato verso
l'ideale di una scienza universale della realt, la quale
comincia a reagire sulla metafisica e vien fornita da Ari
stotele di un sostrato ontologico e assiomatico. Questa
vittoria dell'indagine empirica sulla speculazione filoso
fica ha lasciato le sue traccie, come vedemmo, anche
nella posteriore trattazione del problema del primo mo
tore. La conclusione logicamente necessaria dell'edificio
dottrinale della fisica, e cio il principio da cui tutto
dipende, tende ora a presentarsi quale semplice ipotesi
cosmologica: e l'impossibilit di confermare con l'espe
rienza tale ipotesi, al pari di altre dello stesso genere,
vien subito sentita come un male insanabile.
Di fronte all'interesse metodologico, il momento in
tuitivo perde terreno nel pensiero di Aristotele. Alla
forma
mentis dello Stagirita non era concesso di con
cretare il contenuto speculativo della sua filosofa in
simboli suggestivi, come aveva fatto Platone coi suoi
miti e colle sue comparazioni. Egli stesso ne ebbe senza
dubbio la sensazione, e una volta, nello scritto program
matico Ilep yiXoGotfi&Z, che la prima esposizione del
suo pensiero filosofico, cerc perfino di raffigurare pla
sticamente la sua nuova intuizione dell'universo, dando
nuova forma al paragone della caverna contenuto nella
Repubblica platonica (cfr. sopra, pp.
216-17). L'imma
gine dell'ascesa degli uomini sotterranei alla contempla
zione delle leggi e forme eterne del cosmo ci si presenta
come una fine e caratteristica variante dell' originale
platonico, dal quale essa resta in ultima analisi dipen
dente: ed eguale l'impressione che proviamo conside
rando l'intuizione cosmica di Aristotele in relazione a
quella platonica. come se Aristotele presupponesse que
st'ultima come data senz'altro, e si volgesse subito alla
34. W. Jatoeb, Aristotele.
530 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
sua giustificazione ed analisi metodica. Solo in qualche
singolo passo avvertiamo, quasi con spavento, come dietro
la sottile rete di concetti si celi laviva presenza di un'uni
versale concezione del mondo. Essa rimane latente come
l'impulso religioso che implicito nella metafisica, ma
che non assume mai in essa l'aspetto immediato del
l'aperta confessione. Accade cos che l'uno e l'altra ci
si manifestino solo nella forma indiretta del concetto e
del metodo, caratteristica dell'attivit di Aristotele, e
che la forza religiosa e speculativa della sua filosofa
eserciti viva efficacia nei momenti storici in cui non si
cercano soltanto intuizioni estetiche, ma si ha un'espe
rienza diretta di questo duro sforzo intellettuale. Cer
chiamo, tuttavia, di farci un'idea chiara della conce
zione cosmica di Aristotele anche sul piano della raffi
gurazione intuitiva.
Il carattere di logica discriminazione che in Platone
ha il mondo delle idee vien trasferito in Aristotele al
mondo delle cose visibili. L'universale flusso eracliteo,
in cui ancora Platone aveva scorto il simbolo pi cal
zante del mondo fenomenico, per lui interrotto da
punti stabili, da isole. La natura non pi un semplice
flusso: un cosmo, in cui ogni movimento fa perno sul
saldo centro della forma costante. Aristotele peraltro
non sovrappone alla realt vivente, come s potrebbe
pensare, la rigida gerarchia di un astratto mondo con
cettuale. Le forme sono intrinseche al divenire, in quan
to agiscono come leggi costitutive. Tuttavia avvertiamo
in esse anzitutto il carattere per cui si distinguono l'ima
dall'altra, come unit ben delimitate logicamente. L'im
magine in cui Aristotele raffigura il suo mondo quella
della non quella della aupepwvfa. Non gl'interessa
la consonanza polifonica, per familiare che fosse questo
concetto ai Greci dell'et ellenistica, bens la collabo
razione organizzata di tutte le forme per l'attuazione
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 531
di un concetto gerarchicamente superiore. La felice com
parazione che Aristotele ha, in via eccezionale, coniata
per questa concezione cosmica, quella che la paragona
ai movimenti tattici dei combattenti di un esercito, re
cante in atto il piano di uno stratego invisibile. Parago
nato col 7tvet}pa Ttavta Slxov del monismo stoico, que
sto un mondo classico, pieno di figure plasticamente
determinate. Scarso, tra le membra di questo organismo,
il contatto, lo scambio delle energie. Dal punto di
vista della filosofa dell'et imperiale e della sua conce
zione del mondo armonicamente collegato ci do
veva apparire alquanto alieno: e tale l'impressione
che ne ha Plotino quando lamenta che tra le forme dei
motori delle sfere e il primo motore manchi il contatto.
Ma la stessa cosa vale, in generale, per tutto il regno
delle forme nel cosmo aristotelico, la cui legge incar
nata nel modo pi puro e bello dal mondo delle sfere.
Le cose mutevoli imitano quelle imperiture. Come
il moto degli astri, anche il nascere e il perire degli
esseri terrestri , per cos dire, un movimento circolare
intorno allo stesso centro. Nonostante il suo ininterrotto
divenire, la natura di Aristotele priva di storia, per
ch lo sviluppo organico dalla costanza delle forme
costretto in un ritmo che permane eternamente iden
tico. Ed anche il mondo umano, nei suoi aspetti poli
tici sociali e spirituali, parimenti veduto da Aristotele
non nell'aspetto dell'incalcolabile mobilit della sorte
storica, che mai non si ripete, n in quello della vita
delle personalit, dei popoli e delle culture: la sua ra
dice e il suo valore infatti per lui costituito dal con
tenuto immutabile delle sue forme, che si modificano
in seno a certi limiti, ma nell'essenza e nel fine riman
gono uguali.
Questa
visione della vita ha il suo simbolo
nel grande anno cosmico, al tarmine del quale gli astri
sono tornati al loro punto di partenza
ed iniziano di
532 I.A POSIZIONE STORICA DI AMST0T5S.-
nuovo il loro corso. Nello stesso modo, sulla terra, le
civilt nascono e periscono nella vicenda delle grandi
catastrofi naturali, causalmente connesse con le regolari
variazioni celesti. Ci che mille volte gi stato cono
sciuto, pensa Aristotele, toma in questo
istante storico
ad esser conosciuto da noi, per andar poi di nuovo per
duto e in seguito riaffiorare di nuovo alla conoscenza.
Ilmito l'ultima eco, che ci d notizia di una filosofia
di trascorsi periodi cosmici, equivalente alla filosofia
nostra: e un giorno anche tutta la nostra scienza non
sar pi che un pallido mito. Il filosofo, stando sulla
terra, nel centro dell' universo, circoscrive coi saldi
confini del suo pensiero il cosmo, nettamente delimi
tato nella sua finit e circondato dal cielo delle 6telle
fisse nella sua eterea sfera. Nella contemplazione del
l'universo e del suo ritmo etemo il voj filosofico,
giunto al culmine della conoscenza umana, giunge alle
soglie di quella pura e inviolata beatitudine che pro
pria dello spirito del mondo, immobile nella pensante
considerazione di s stesso.
La concezione aristotelica dell' universo introduce
distinzioni nel quadro geometrico del cosmo proprio
degli antichi Greci, senza tuttavia spezzarlo. Le nuove
idee del quarto secolo sono inserite nei tipici lineamenti
di quello. La realt considerata dall'interno: di fronte
allo sguardo della scienza essa non si presenta pi con
la compattezza
della cosa, ma in certo senso come en
tit trasparente. Aristotele compie il processo d'inser
zione del platonismo in seno alla comune concezione
greca del cosmo. Tanto nello spazio quanto nel tempo
la prospettiva stata infinitamente ampliata dall'astro
nomia e dalla storia del quarto secolo. Ilmondo aristo
telico partecipa della stessa finit del mondo platonico:
ma l' antitesi del mondano e dell' oltremondano, che
dava a quest'ultimo il tono caratteristico e la viva ani-
IA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 533
mazione, venuta meno, e lo stesso mondo visibile ha
acquistato lo splendore dei colori platonici. La conce
zione greca del mondo giunta a una suprema misura
di armonia e di organicit. Eppure tutto ci non com
muove lo spirito del filosofo dal punto di vista estetico
e sentimentale, ma solo in quanto esso dimostrabile
col rigoroso metodo razionale della scienza. Ancora
oggi, quando da tanto tempo si dissolto quel quadro
cosmico di singolare bellezza, la scienza si affatica in
torno ai problemi e ai metodi che Aristotele elabor
tracciandolo. In questi, non nella concezione cosmica in
s considerata, la vera e propria vpyeia del suo
genio.
c) L'analisi dell' uomo.
Per l'elevazione dell'etica al grado di scienza ebbe
massima importanza il fatto che Socrate avesse portato
in primo piano la questione del sapere morale e
che Platone avesse ulteriormente avanzato in questa
direzione. Noi siamo abituati a considerare come pro
blema essenziale dell'etica quello della coscienza e del
l'intenzione soggettiva, e siamo quindi inclini a scorgere
nell'impostazione socratica del problema, per noi incon
sueta, l'effetto di una dipendenza del suo pensiero dal
l'ambiente storico, e a pensare che dietro tale imposta
zione si celi in realt il problema della coscienza.
Per quanto giustificato possa essere in s il rendere evi-
if
denti le grandi manifestazioni della storia dello spi-
rito greco col tradurle nelle categorie corrispondenti
dell'et nostra, tale procedimento presenta tuttavia il
pericolo che cos sfugga al pensiero ci che specifica
mente caratterizza quelle creazioni elleniche.
Questa
nota caratteristica non costituita da una profezia reli
giosa o dal semplice avvento di un radicalismo nell' or-
534 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
:
ganizzazione morale della vita, bens dalla nozione del
l'essenza oggettiva dei valori morali e della loro ogget
tiva posizione inseno alla totalit dell'universo. Socrate,
certo, non era un teorico dell'etica, bens cercava la
via per giungere all' pEzrj e per uscire dalla sua aporia
del non sapere: ma in tale punto di partenza
era
gi in germe lo scopo finale, a cui doveva mirare il
processo speculativo da lui inaugurato, e cio la fonda
zione dell'* etica . La domanda che cosa il buono
o il giusto? non quella di un profeta, ma quella di 1
un problematico. Nonostante tutta la passionalit della
|
sua asserzione dell' esistenza del bene tale domanda
f
pone in prima linea la scienza concernente la natura
J
di ci che si dice bene, e l'angoscia che pi propria- : |
mente essa manifesta quella dell' ignoranza. Che il |
massimo rinnovatore morale del mondo ellenico tenda
in tale misura a una conoscenza oggettivistica della ma-
. -
ralit, prova come iGreci potessero compiere la loro
\
pi alta creazione morale solo creando una filosofia
della morale. Cos si spiega come il problema dell'in* ,j
tenzione soggettiva, dell'educazione della volont, del-
l'effettuare stia per Socrate in seconda linea, e come
la sua soluzione (si dica quel che si vuole) non possa
soddisfarci. Tanto in Socrate quanto in Platone que
st'ultimo problema piuttosto la premessa della que- .1
stione, cos vivamente sentita, dell'essenza del bene, che j
non l'unico scopo decisivo di tutta la ricerca morale.
Lunga per essi la via che porta al sapere, mentre il
*x
passaggio dal sapere al fare si presenta quasi come ov-
vio, come una cosa che accade da se.
L'evoluzione storica che da Socrate porta ad Aristo-
tele stata rappresentata come un processo di progres
siva traduzione in teoria del pratico contenuto morale
della socratica, e di crescente allontanamento da So
crate: e tale appare di fatto quando si veda in Socrate
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 535
l'indagatore delle coscienze e il predicatore di un van
gelo della libert morale, cio quando si trasformi la
sua figura dandole tratti moderni, protestanti e kan
tiani1). Considerata la cosa dal nostro punto di vista,
quell'evoluzione storica appare come il necessario pro
cesso di oggettivazione della moralit, radicato nell'es
senza dello spirito greco e non nella contingenza delle
persone dei pensatori.
Questo
processo riesce finalmente
a superare l'antica tradizione morale, che si veniva
decomponendo senza rimedio, e nello
gtesso
tempo an
che il puro soggettivismo che accompagnava
tale de
composizione. Certo, la tendenza verso l'oggettivazione
nasceva dal dubbio etico, dall' incertezza pratica in cui
era venuta a trovarsi una possente e combattiva perso
nalit morale: ma, in forza della sua stessa natura,
tale tendenza non poteva svolgersi se non nel senso che
la portava a ricollegarsi al pensiero filosofico, nel quale
trovava imezzi per il raggiungimento del suo scopo;
o, pi esattamente, doveva provocare
essa stessa un
nuovo movimento filosofico, che si sarebbe creati ipro
pri mezzi logici.
Questo
movimento si svolse in modo
diverso presso isingoli socratici a seconda del diverso
atteggiamento
che essi assunsero di fronte a Socrate, o
accostandosi estrinsecamente a lui con mentalit gi
orientata in senso sofistico e sfruttando soltanto il con
tenuto della sua esperienza senza coglierne
la sostanza
problematica nel suo superiore significato, o, come Pla
tone, riconoscendo in lui quel che era veramente nuovo
e originale, e proseguendo sotto tale aspetto
la sua opera
con la viva forza del loro pensiero.
Condizionato dalle contingenze dell'ambiente storico
si suole inoltre ritenere anche il fatto che Platone abbia
3) Cfr. Heinrich Maier, Sokrates, sein Werk und seine g-
schichtliche
Stellung, p. 516 segg-, 577 segg.
536 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
compiuto la sua grande
scoperta del dovere morale (per
usar termini moderni) nella forma dell'idea, cio in
quella di un essere soprasensibile di realt superiore, e
si spiegato questo procedimento indiretto scusandolo
con le esigenze artistiche dello spirito greco. Ma anche
qui la semplice presunzione di chi, sentendo di aver
raggiunto un
punto di vista pi evoluto, lo presuppone
nel suo giudizio storico non serve a nulla. Proprio
quello che a noi sembra giro vizioso o errore costituisce
la necessaria premessa storica della conoscenza che si
i
rivolga all'essenza slessa della cosa. La
scoperta dei va*
. '
lori spirituali oggettivi, morale estetico e logico, e la
loro netta enucleazione dal caos delle mille esperienze
morali estetiche e logiche che avevano luogo nell'animo
dell'uomo, era possibile solo alla considerazione
ogget-
tivante, plastica, formale che il greco opponeva a tutte i
le cose, anche a quelle spirituali, e alla quale egli fu
debitore del proprio tipo di filosofia e d'arto. Anche
:
altri
popoli ebbero momenti di altissima
elevazione mo*
if
rale. Ma per dare la prima raffigurazione filosofica del |
valore inorale nella sua forma
pura dovevano venire al
mondo i
Greci e Platone.
Quando
l' ESscc si present allo ;
spirito greco, questo vide
necessariamente in essa una 1
realt oggettiva,
indipendente dalla coscienza in cui si J
rispecchiava.
E poich gli era risultata da una ricerca ']
metodica, come risposta alla domanda socratica ~.l
criv, j
cos essa conteneva in 6e nello stesso
tempo le caratte* :*
ristiche della realt logica e
concettuale. Solo in tal
modo era possibile
riconoscere, in quello stadio del pen-
siero ancora privo dell'arma dell'astrazione, due qualit
essenziali della realt etica : la sua
irrevocabilit e la
sua
incondizionatezza.
Quando scoperse l'
ISx, Platone
dovette credere di aver raggiunto solo allora il pieno
intendimento della sostanza di tutto Io sforzo socratico:
la costruzione di un superiore mondo spirituale di in-
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
537
crollabili fini e scopi (xiXog, Spog). Nella contempla
zione trascendente del bene in s, non deducibile
da
alcuna esperienza dei sensi, l'esigenza socratica era final
mente appagata.
La conoscenza filosofica del puro bene come dell'uni
co motivo moralmente valido dell'azione umana assume
in Platone di preferenza la forma del problema, pro
prio della coscienza popolare
ellenica, concernente
il
bene supremo o la vita migliore. Alle molte risposte
elie erano state date a quel problema e che compren
devano, pi o meno, tutti ibeni del mondo, Platone
contrappose
la sua: dig fx&q xs xai iSafpwv apa
yiyvETxi vrjp. Solo chi buono sa adoperare giusta
mente ibeni del mondo, iquali sono dunque beni, in
senso proprio, soltanto per lui, cio sono mezzi per la
realizzazione del bene. Cbi bnono d'altronde indi
pendente
da essi, recando ins stesso la sua eudemonia.
Con ci Platone supera l'eudemonismo e l'etica dei beni,
fondamenti di ogni concezione della vita del popolo
greco. Ma, profondamente greco anche lui, riapre loro
nello stesso momento le porte, sia pure trasformandole
in un aspetto superiore. La contemplazione del bene in
s il risultato di una fatica aspra, che dura tutta la
vita. Essa presuppone la progressiva assimilazione del
l'anima col bene in s , e si concede solo a chi cerca
veracemente la sapienza, al termine di ima difficile via
spirituale, procedente attraverso ogni pe'iioSog Xywv.
Non pu essere trasmessa, come una nozione meccanica,
da un uomo a un altro. La vita migliore perci il
ipiXcotpog Jjog, e il bene supremo consiste nell'interiore
eudemonia di chi veracemente conosce
il bene.
Cobi Platone diviene non soltanto Io scopritore teo
rico del valore morale, ma anche il creatore di unnuovo
ideale di vita, anche se ammette.che accanto aVpcz-q
filosofica la morale popolare possa continuare ad aver
538 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 53<5
valore, in un piano pi basso. Il filosofico assume,
nel pi tardo corso dell'evoluzione del pensiero plato
nico, tratti sempre pi religiosi, il posto dell'idea del
bene venendo occupato dall'idea di Dio quale misura
di tutte le misure. Ma attraverso tutte le fasi della sua
evoluzione il problema dei valori e delle norme ogget
tive resta la sua preoccupazione principale. Il vivere
in vista dello scopo > implica in s l'impulso di ten
dere ad esso. Platone sempre sotto il prepotente in
flusso della nuova forma di sapere, concernente ilmondo
oggettivo dei puri valori, e della nuova certezza che da
essa si riflette sulle azioni della vita.
Idialoghi del giovane Aristotele sono colmi dell'ec
cezionale empito interno del platonico cpiXaotpo; (ho?,
ma un libro come ilProlreptico mostra anche gi chiari
ilimiti che la realt borghese opponeva alla penetra
zione di questo esclusivo, e spiritualmente aristocratico,
ideale di vita. Il tentativo d'infonderlo in tutta la vita
della nazione doveva condurre al completo abbandono
della realt, dimostratasi incapace di accoglierlo. La
tendenza all'abbandono del mondo, il cupo pessimismo
rispetto ai suoi beni e la critica spietata della sua so
ciet priva di spirito sono tratti estremamente decisi
del
temperamento giovanile di Aristotele. Su questo
sfondo spicca tanto pi chiaro l'ottimismo religioso-
metafisico, rischiarante ogni disvalore ed ogni sofferenza
di questo mondo: ottimismo sorretto dall'ideale della
vita eterna, che al di l del mondo fenomenico splende
come termine del suo puro sforzo spirituale. La tenacia
degl'influssi che Aristotele sub da parte di questa con
cezione platonica dell'universo non pu esser messa in
dubbio da chiunque abbia constatato come la loro effi
cacia continui a manifestarsi anche nelle fasi pi tarde
della sua evoluzione: ma necessario tener d'occhio
anche gli altri elementi che si celano dietro
questa con
cezione cosmica ufficialmente professata
dalla scuola
platonica. Gi nell'Accademia s'inizia il movimento che
sbocca nell'etica aristotelica, e i dialoghi di Aristotele
tradiscono gi qualcosa di quella penetrante
analisi con
cettuale, che ad essa conduce. Si cerca d'intendere l'alto
scopo del <piXcro:po$ (Jfo? in funzione della natura stessa
dello spirito umano, e ci si trova per ci, anche se il
primato dello spirito conoscitivo sulle altre parti del
l'anima risulta in un primo tempo
confermato in forza
della stessa mancanza di una psicologia analitica, di
fronte al problema delle diverse parti dell'anima e
al compito di venire a capo anche delle sue parti irrazio
nali, cio d'inserire anch'esse nel processo della spiri
tuale assimilazione a Dio. Tanto nel Filebo quanto
nel
I Prolreptico accanto al jito? filosofico si presentano
altri
I
e si cerca di risolvere il problema della loro com-
! rpatihilit. Una questione come quella concernente la
I parte
che ha l'vjSsvq nella vita puramente
filosofica porta
J
j a indagare imotivi dell' azione morale, e il concetto
1
pedagogico del vecchio Platone, di educare igiovani al
!
bene educandoli precocemente
al gusto del bene e al
disgusto del male, si avvicina gi all'etica di Aristotele,
che riconosce come buona un'azione solo quando essa c
v
accompagnata dalla gioia del bene. Anche il problema
}
dell'ethos dev'essere gi stato studiato in seno all'Ac
cademia, se Senocrate pot dividere la filosofa in lo
gica, fisica ed etica. Nei pi tardi dialoglii di Platone
si trovano accenni a teorie della volont e della respon
sabilit, iquali dimostrano come Aristotele non sia stato
il primo a dominare filosoficamente questi problemi,
molto dibattuti dal diritto penale greco. Le definizioni
della npoulptoi(, dell' sSaipovla, dell' Sovfj, discusse e
rigettate da Aristotele, derivano certo per intero dai
dibattiti scolastici dell'Accademia. In essa era gi in
pieno corso la traduzione degli antichi simboli piato-
i
)
540 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
V _
____
ilici in termini intellettuali e l'elaborazione dell'etica
quale disciplina indipendente. Aristotele non fu che il
platonico il quale port innanzi tale opera con decisione
maggiore.
Egli non era affatto un legislatore morale del
tipo
di Platone. Non era nella sua natura, e non lo permet
teva pi l'evoluzione dei problemi. Nonostante clie la
pi antica etica aristotelica sia ancora compenetrata
dall'idea della norma divina e concepisca l'intera vita !
come servizio e conoscenza di Dio, ci che in essa
i
nuovo manifesta gi una diversa tendenza. Essa in-
fatti costituita dall'analisi delle forme della vita morale
,
J
quali si presentano nella realt. La teoria
platonica
J
della virt abbandonata, e sostituita da una tipologia
satura di vita, la quale tien conto di ogni manifesta-
,'|
zione della vita morale in tutte le possibili situazioni
pratiche, non escluse quelle economiche, sociali, corpo- '..i
rative, giuridiche,
commerciali. Tra questa considera-
zione realistica del mondo borghese e le alte idee reli-
giose ereditate dalla filosofa platonica, in cui tutto il
complesso s'inquadra, l'antitesi forte. Anche se Ari- . I
stotele interpreta itipi del giusto, del coraggioso, del
2
magnanimo, del generoso, del pretensioso in funzione
ir
di un unico concetto formale della virt, cio del prin
cipio del giusto mezzo, e determina itipi non sempli-
1
cernente descrivendoli ma
costruendoli dialetticamente,
cio legando ogni loro singolo aspetto inun complessivo
sistema logico, il contenuto di questa sua costruzione
deriva tuttavia dall'esperienza, e itipi nascono dall'espe
rienza della vita pratica nella 6ua realt contingente. La
fondamentale discussione circa l'essenza dell' p&zrj, che
precede
questa trattazione tipologica, orientata verso
il problema
dell'intenzione morale e della sua educa
zione. Con ci fatto un decisivo passo innanzi: l'es-
senza del valore morale studiata dal
punto di vista
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 541
dell'interiorit
soggettiva, e la sfera del dovere
defi
nita quale suo vero e proprio dominio. L' prc*} del
l'ethos acquista con ci ima preminenza
di fatto rispetto
all' pstrj dello spirito, e ad essa quindi dedicata la
parte principale della trattazione, nonostante che Ari
stotele sia ancora molto lontano dal segnare tra esse
una distinzione di principio. La teoria dell' p&xfj mo
rale diventa ora, per cos dire, l'etica nell'etica, e d
il suo nome a tutto il complesso della dottrina. Muo
vendo solo da Aristotele, non si capirebbe pi per qual
motivo compaia nell'etica la teoria dell' ptxfj dello spi
rito, se non si sapesse come in Platone (e ancora nel
giovane Aristotele) essa avesse costituito addirittura il
punto centrale dell'intera
trattazione, in quanto
scienza
del supremo valore oggettivo. Anche nell'Aristotele del
l'et pi matura il supremo scopo della vita umana
connesso col divino fine del mondo, e l'etica culmina di
conseguenza nella metafisica teoretica. Ma l'accento fon
damentale non batte sulla conoscenza di questa norma
eterna, ma sulla questione del modo in cui la volont
e l'azione degli uomini possa riuscire ad adegnarsi a
questa norma. Come nella teoria aristotelica dell'essere
l'eidos platonico
vien reso fecondo per la conoscenza
del mondo
fenomenico, cosi nell'etica la norma trascen
dente viene accolta in seno alla volont dell'individuo
morale, e questa
volont vien per ci oggettivata. Que
sta norma, fatta in tal modo interna all'anima dell'in
dividuo, perde, certo, il carattere della validit univer
sale, perch non esiste un imperativo egualmente
ob
bligatorio per tutti gli uomini, e per ottenerlo biso
gnerebbe generalizzarlo, privando la sua forma di ogni
contenuto. Aristotele mira a unificare l'idea della pi
profonda obbligatoriet normativa con quello della mas
sima
molteplicit individuale. La personalit morale
c legge a s stessa . In questa
forma il concetto del-
542 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
l'autonomia morale della personalit, clie a Platone era I
ancora alieno, affiora per la prima volta nella coscienza
del mondo greco.
Idue elementi fondamentali dell'etica, la dottrina
morale dell' eticit dipendente dalla volont buona e
quella metafisica della contemplazione della norma di
vina, manifestano l'interna tendenza a staccarsi sempre
pi l'una dall'altra, nel corso della loro evoluzione. La
vera e propria teoria dell'ethos, che nella prima etica
era ancora collegata con la sua conclusione teologica,
si rende pi tardi indipendente, e trova il proprio prin
cipio nell' idea della intelligenza pratica moralmente
orientata. Da ultimo Aristotele rinuncia totalmente a
dimostrare il primato platonico della ragion teoretica
anche nell'ambito dell'etica borghese. Certo, solo in Ari
stotele la
GO'-fla.
e il voi); di Platone si rarefanno in una |
pura ragion teoretica : la necessit del taglio netto
;
t.
tra etica borghese ed elica metafisica una conseguenza
'
immediata della traduzione in termini intellettualistici
4
di quella aoyia. e di quel vo;, che in
Platone signifi-
cavano nello stesso tempo la bont dell'anima e la sua
conoscenza del bene. Cos Aristotele conserva anche
nell'etica il fondamentale atteggiamento critico della sua
filosofia. Ci che ne risulta un enorme approfondi-
'l
mento e raffinamento della comprensione psicologica
dell'intimo mondo morale, di fronte alla quale l'ele
mento metafisico e intellettualistico viene compresso v
in piccolissimo spazio. Tuttavia, come nella metafisica,
cos anche nell'etica Aristotele rimane in ultima analisi
platonico. Nella metafisica lo in quanto interpreta te-
leologicamente il mondo dell' esperienza riferendolo a
un supremo e metempirico tXo; ; nell'etica, in quanto
al di sopra della comune morale borghese e della sfera
della volont e dell'azione pratica fa posto all'ideale
di una vita dedita alla contemplazione dell'eterno, la
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
543
quale, nella valutazione del filosofo, supera incondizio
natamente l'altra, ed anche dal punto
di vista morale
rappresenta
uno stadio superiore. Ma nell'Etica Nico
machea Aristotele non fa pi dipendere da questa teo
logia la morale della vita
borghese. Sono mondi distinti,
di diverso valore. La collocazione del [he; &<j)prjw.i
alla fine dell' Etica non significa pi, ora, che ogni vi
cenda terrena debba risolversi nella teologia, ma solo
che al di sopra del mondo etico-pratico ne sussiste uno
superiore. Cos Aristotele inserisce nel sistema della
realt il mondo ideale della sua giovinezza platonica,
assegnandogli il posto supremo, cio quello attraverso
il quale la luce dell'eterno discende sul mondo. Ihque
sta connessione dei due (Slot si sempre avvertito qual
cosa di personale, dipendente dalla viva esperienza
di
Aristotele. Essa non ha il rigore consequenziario
di
Platone, che trova degno di esser vissuto solo il cpiX-
oocpo; [ho;, n quello di Kant, che esclude definitiva
mente il primato della ragion teoretica e proclama la
volont morale supremo valore del mondo. Tanto nel
l'etica come nella metafisica Aristotele si avvicina per
un certo tratto a Kant, ma c' in lui qualcosa che lo
fa indietreggiare di fronte alle conseguenze estreme. N
l'autarchia della pura scienza empirica n la fede pra
tica del puro dovere morale basta al suo senso della
realt e della vita. Il sopramondo platonico non lo ab
bandona, ed egli ha la coscienza di aver inserito con
esso un nuovo elemento di realt nella cosmologia della
tradizione ellenica. Soltanto cos si spiega come il vo;
aristotelico assuma, nella parte teologica della metafisica
e dell' etica, uno splendore quasi mistico. Questo
mo
mento culminante della fteiapta si trasferisce dal mondo
platonico dello spirito in quello aristotelico dei fatti,
fornendo a questa intuizione della vita quell'originale
tengione
dualistica che le propria.
514 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
Anche nella politica, a cui qui possiamo soltanto
accennare, la formazione interna identica a quella
dell'etica e della metafisica: il processo evolutivo si ma
nifesta anzi in essa con chiarezza particolare. Il pro
blema fondamentale che la politica platonica presenta
in seno alla storia dello spirito costituito dalla rigo
rosa, incondizionata subordinazione dell'individuo allo
stato, con la quale Platone restaura la forma di vita
propria dell' autentica tradizione ellenica. Nel quarto 'j|
secolo essa appariva da lungo tempo decomposta dal |
sopravvento delle forze e degli interessi economici nello i
stato e nella vita dei partiti e dall'individualismo spi-
J
rituale, che per la prima volta in questa et ei presen-
tava come fenomeno di masse. Che un risanamento dello
stato fosse possibile solo quando si fosse presentato il
modo di vincere l'individualismo nella sua forma pi
f
rozza, quella dell'egoismo illimitato dei singoli, era cosa
''<
che ogni persona ragionevole vedeva chiara; ma era
difficile bandire quell'individualismo, dal momento che /;
lo stato stesso era animato da questo spirito, anzi aveva '.!
fatto di esso il principio della sua attivit. Nel corso :
della politica avventuriera della fine del quinto secolo
esso aveva a poco a poco attirato icittadini nella nuova V
orbita ideale, e diveniva ora vittima esso stesso di questa , ,)
mentalit egoistica elevata a principio, che Tucidide =
descrive in modo tragicamente suggestivo. Lo stato an-
'
tico, con le sue leggi, aveva insieme costituito per i :
cittadini l'ideale sintesi di ogni norma morale. Vi-
vere secondo le leggi era nell'antica Grecia la suprema :;
legge, se anche non scritta in nessun codice, come il ;
Critone platonico dice dolorosamente ancora una volta,
l'ultima volta. H tragico conflitto interiore del quarto \
secolo gi in tale opera accentuato fino all'assurdo: v:
secondo le leggi di questo stato il pi giusto e il pi
puro di tutti iGreci deve bere la cicuta. La morte di .
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 545
Socrate la riduzione all'assurdo di un intero stato, non
soltanto di coloro che per il momento lo governano.
Nel
Gorgia Platone giudica lo stato di Pericle e dei suoi
pi deboli successori col criterio dell'assoluta legge mo
rale, e giunge a un'incondizionata condanna dello stato
quale si manifesta nella realt storica. Di conseguenza,
quando nella Repubblica egli subordina totalmente allo
stato la vita dell'individuo, con un rigore unilaterale e
intollerabile per il comune sentimento del suo secolo,
egli si sente autorizzato a questo passo solo in quanto
lo spirito del suo nuovo stato affatto diverso. Il sole
che su esso risplende l'idea del bene, che l'illumina
sin negli angoli pi remoti. La subordinazione di tutti
gli individui allo stato, la loro restituzione a veri cit
tadini dopo l'et del dissolvimento, non quindi che
una diversa manifestazione del fatto storico onde la
realt morale si libera definitivamente dalla realt po
litica e dai vpot dello stato storico, e la coscienza auto
noma dell' individuo continua a giudicare in suprema
istanza anche delle questioni statali. Conflitti di questa
natura si erano verificati anche per il passato: la novit
che questo stato di cose viene ora dichiarato neces
sario. L'esigenza platonica dello stato filosofico, difesa
finn all'ultimo senza modificazioni, significa la totale
traduzione della politica sul piano dell'etica. Essa mo
stra come le personalit di pi alto livello spirituale
avessero gi abbandonato il terreno della politica di
fatto. Lo stato che essi sognavano non aveva infatti in
quell'epoca capacit di vita, e forse non l'avrebbe avu
ta mai.
Aristotele mantiene l'esteriore subordinazione plato
nica dell' etica alla politica, ma anche in lui la vera
forza ideale tutta della prima. Da essa egli deriva la
norma del perfetto stato e il contenuto della vita mi
gliore. Tuttavia questo punto di partenza fa s che al
35, W. Jaeger. Aristotele.
546 L POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
suo concreto senso della realt si presentino difficolt
insolubili, le quali gi sul principio del pi antico sag
gio circa lo stato ideale conducono alla prima chiara
formulazione del conditto implicito nello stato plato
nico. Anche nella politica Aristotele non vive soltanto
dell'ideale, ma dell'antitesi tra l'ideale e il reale. Ma
l'effettiva vita politica del suo tempo non gli permette
di trovare alcuna soluzione di questo contrasto. Tanto
nella metafisica quanto nell'etica egli, nonostante il suo
punto di vista immanentistico, non si preclude l'accesso
al trascendente mondo platonico, e pu farlo perch
realmente lo porta nel cuore. Nella politica invece il
perfetto stato resta una mera utopia, la quale mostra
anche troppo chiaramente come per tal via si possa
giungere tutt'al pi a un ideale educativo di etato, o
pi esattamente a una pedagogia. Accanto a questo pro
blema Aristotele ha chiaramente formulato quello della
forza: ed esso diventa una specie di punto interroga
tivo segnato accanto all'idea platonica dello stato. Ari
stotele spiega anche come non ogni signoria sia di
propria natura cattiva, ma non giunge a ima soluzione
soddisfacente, e senza dubbio non c'era alcuna possibi
lit di soluzione pratica, in. quello stadio gi evoluto
dell'intera cultura ellenica.
Il problema dello stato era qualcosa d'irrisolubile,
un jixavov. Il momento culminante della riflessione
teoretica sulla vita politica cade, al pari di quello del
l'ideologia nazionalista capeggiata da Demostene, nel
l'et in cui l'organizzazione statale della polis greca era
gi decaduta dalla sua altezza. Era una forma soprav
vissuta, la cui successione toccava insorte ad altre forme
di etato ancora vitali, ma di specie pi rozza. Ilprimi
tivo saggio aristotelico sullo stato ideale si occupa subito
della significativa questione, se la fuga dallo stato non
sia 1' unico fine a cui si possa tendere, e 1' analisi del
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 547
mondo politico effettivo s' inizia con la constatazione
che, di fronte alla realt, al filosofo non resta altro da
fare se non contribuire caso per caso all' esatta cura
delle malattie dello stato, in virt della sua superiore
conoscenza delle condizioni di vita necessarie ad ogni
particolare
costituzione politica. Tale atteggiamento ras
segnato tipico delle personalit
intellettuali di questa
et, persino di quelle che appartenevano
alla politica
militante, e che senza eccezione stavano di fronte allo
stato con un certo distacco spirituale ed esercitavano
la politica come una sorta di esperimento. InAristotele
questo distacco, e la consapevolezza di esso, sono estre
mamente progrediti, in quanto egli stesso vive quale
osservatore oggettivo, senza appartenervi, in un grande
stato tutto preso dalla propria crisi, e in quanto
domina
col suo sguardo sovrano l'enorme folla delle diverse
forme e possibilit statali. L'unico legame comune che
ancora manifesta viva efficacia sui Greci del suo tempo
quello della societ borghese, con le sue salde idee
concernenti l'educazione, il contegno, la cortesia. Ari
stotele non annovera questo legame sociale tra le forze
politiche, ma lo comprende, in maniera significativa,
tra ci che costituisce stabilmente la struttura morale
della personalit. Egli ne tratta per ci nell'etica, di
stinguendolo in diverse virt. Come la morale antica
derivava la sua consistenza interna ed esterna dalle leggi
dello stato, cos la morale moderna l'attinge dalle forme
oggettive della societ. Aristotele non conosce un astratto
individualismo morale, e del resto anche la Stoa col
suo cosmopolitismo e gli Epicurei con illoro ideale del
l'amicizia si tengono lontani da tale estremo. Ma la
Politica mostra con realistica durezza come la stessa
societ non sia che una piccola schiera di privilegiati,
sbattuta di qua e di l nel generale tumulto di chi lotta
per la ricchezza e per la potenza e costantemente in
548 L4 POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
pericolo di vita. L'etica dell'ellenismo trova quindi alla
fine il suo punto fermo nel concetto della libert inte
riore, che in Aristotele affiora soltanto in qualche caso.
Tale libert consacra definitivamente l'indipendenza
dell'individuo dallo stato e dalla societ. Inseno all'etica
aristotelica questa autosufficienza sussiste solo per chi
partecipa al jh'og frecopYjiixs e non incondizionata
neppure in questo caso. Ma proprio nell'accentuato av
vertimento della dipendenza della vita umana dalle cir
costanze esteme e dalla si manifesta quel desiderio
della libert interiore e quel senso della dignit morale
della personalit, che caratteristico di tutta questa
epoca.
d) La filosofia come scienza universale.
Nella sua filosofa, Aristotele innalza al grado su-
premo della tecnica metodologica il complesso dei pio- :;9
blemi speculativi della sua et. Ma nella sua opera di J
particolare indagine scientifica egli fa di pi, superando
|
di gran lunga ilimiti del suo ambiente. anche troppo
facile vedere sotto falsa luce questo aspetto
della sua .?
opera, bastando per ci applicare ad essa, come criterio .
di misura, l'mbito di conoscenze proprio della scienza ; |
moderna: e questo un fatto che si sempre ripetuto, ',
tutte le volte che irappresentanti di discipline scienti-
..f
fiche o gli storici delle scienze positive si sono occupati ,
5
di lui. Ma forse non si desidera nulla di troppo immo-
desto quando si esprime la speranza che l'ingenuit di :i
simili paragoni riesca oggi chiara anche a coloro la cui
mentalit non abbia ricevuto una specifica educazione .[
storica: e noi non abbiamo quindi l'obbligo di esami
nar particolarmente questi paragoni. Possiamo qui la-
:
sciar da parte, di conseguenza, non solo la questione
dell'esattezza dei singoli risultati scientifici raggiunti da
POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 549
Aristotele, ma anche rinunciare a una determinazione
pi precisa nel decisivo influsso che la sua opera esercit
nel campo metodologico, dato che a noi importa sol-
tanto di valutare il significato che la sua ricerca scien
tifica ebbe come sintomo della generale evoluzione
filo
sofica.
L'ampliamento della filosofia platonica
a scienza
universale fu per Aristotele un trapasso necessario, de
terminato dalla sua alta valutazione dell'esperienza e
dall'atteggiamento della sua Bpeculazione, ricollegantesi
decisamente alla realt sensibile. Cronologicamente esso
fu, certo, un processo graduale, perch se anche Ari
stotele aveva fin dagli inizi il temperamento
del dotto
e tra iplatonici, inclini all'astrazione, appariva come
il gran lettore (l'aneddoto secondo cui Platone gli diede
quel nomq risponde, vero o falso che sia, alla realt
storica), tuttavia l'atteggiamento spirituale del suo pri
mo periodo, volto alla speculazione trascendente, non
era compatibile con la posteriore dedizione assoluta
all'immenso mondo dei fatti empirici. Lunga era ancora
la via che separava la nozione teoretica della necessit
d'inserire l'esperienza nell'ambito del pensiero filosofico,
e la giustificazione logica di un concetto dell'essere che
meglio si adeguasse al mondo fenomenico, dalla raccolta
e dalla elaborazione di una gigantesca massa di mate
riale empirico, compiuta come fine a s stessa. E nei
casi in cui riusciamo a cogliere pi esattamente il pro
cesso evolutivo di Aristotele vediamo ancora bene come
egli, una volta presa quella direzione, abbia poi avan-
zato soltanto passo passo. Ancora un esempio a questo
proposito. Il famoso sguardo d'insieme sull'evoluzione
filosofica da Talete a Platone contenuto nel primo libro
della
Metafisica
orientato in senso strettamente filoso
fico: serve alla deduzione dei quattro principi che Ari
stotele pone a fondamento della metafisica e non ha,
J
550 LA POSIZIONE STORICA Di ARISTOTELE
come si spesso creduto, un intento storico, bens un
intento sistematico. Con serrata laconicit, Aristotele vi
interroga ifatti preoccupandosi soltanto di ci che vuol
ricavarne. Nella fase pi tarda della sua attivit, que
sta forma di considerazione si amplia invece in una
storia universale delle scienze: esorbita largamente dal
l'originario schema sistematico ed assume l'aspetto di
disciplina autonoma, dominata soltanto dalla preoccu
pazione della sua materia. Nel caso della silloge delle
costituzioni le cose stanno diversamente: la sua grande
opera di ricerca empirica resta infatti, almeno ideal
mente, collegata alla scienza politica, con la quale del /.
resto ha rapporto pi stretto di quanto
la storia delle
.?
scienze abbia con la metafisica. Ma anche nella politica
la transizione dall'erudizione pura e dalla metodica os-
servanone del mondo empirico all'elaborazione
di tutto
il materiale concernente le costituzioni elleniche un 5*
g
passo di grande portata,
che varca iconfini della filo- /T
sofia vera e propria.
Ogni esempio contribuisce cos a convincer del fatto . |
che, nonostante tutto l'interno rigore logico di questa |
evoluzione spirituale, essa ha comunque portato con s
|
uno spostamento decisivo del centro di gravit dal lato
della ricerca positiva. Ilfilosofo e l'elaboratore di con-
celti diventato un interprete scientifico della realt, .
icui interessi sono universali, e per cui filosofia or- /
mai il nome dell'intero sistema delle scienze singole.
'*
Quando
cominci ad essere usata, la parola filosofa j
significava ogni forma di studio e d'interessamento spi-
rituale, nel senso pi specifico della ricerca conoscitiva
della verit. Ilprimo stabile valore terminologico le fu
dato da Platone, che design con essa il suo tipo di
conoscenza, in quanto tale parola esprimeva insieme ,
l'irraggiungibilit dello scopo trascendente del sapere e
l'eternit dello sforzo che mirava a raggiungerlo, l'oscil-
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 551
laute situazione di mediet tra l'dpaiHa e la oo<pt<x. La
ben connessa unit e la totalit presente
di ogni sapere
non era stata invece mai designata da quella parola,
anzi un'idea simile non si era mai presentata a mente
d'uomo.
Questa
fu l'idea di Aristotele, che per altro non
la concep nel senso dell' organizzazione scolastica di
tutte le scienze allora esistenti merc un tentativo di
sistemazione esteriore. Egli non era un enciclopedico,
com' dimostrato anche dal solo fatto che le singole
scienze che gi avevano un'esistenza indipendente, quali
la matematica, l'ottica, l'astronomia, la geografia, furono
da lui comprese idealmente, ma non effettivamente,
nella sua iXoaocpa. Solo la medicina vi entr, e fu stu
diata con profondo interesse, ma solo in quanto offriva
un fecondo campo di azione alla sua indagine morfo
logica.
Questa
circostanza non si presentava nel caso di
quelle altre discipline, e il fatto stesso che esse siano
state escluse dal sistema aristotelico dello scibile mostra
chiaro come la mirabile universalit di quest'ultimo si
sia organicamente generata dal punto
centrale della sua
filosofia, cio dal concetto stesso della forma. in fun
zione di tale concetto che sono stati determinati icon
fini del dominio scientifico di Aristotele. Nell'evoluzione
spirituale di quest'ultimo, l'idea della forma passa da
concetto teoretico dell'essere a strumento della scienza
applicata, cio a principio della concezione morfologica
e fenomenologica di tutte le cose. Con ci Aristotele
mette la filosofia in grado di dominare scientificamente
la realt: donde la signoria che essa viene ad esercitare
su tutte le provincie della conoscenza, e che in tale
ampiezza essa non ha mai pi avuta. Bisogna per insi
stere sempre nell'avvertimento che questo fatto ha le
sue radici nella creativit scientifica della filosofia ari
stotelica, dal cui grembo vengono alla luce sempre nuove
scienze, come quelle appartenenti all'indagine bialogica,
552 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
morfologica e fisiologica della natura e allo studio bio
grafico e morfologico del mondo culturale.
Quando
si
parta soltanto dalla logica o dalla sistematica formal
mente intesa, una simile posizione della filosofia in seno
alla scienza non pu essere giustificata, e tanto meno
pu essere giustificata da un'intuizione speculativa del
l'universo, che venga proclamata dogmaticamente dal
l'alto.
Il rapporto tra scienza e speculazione costituisce il
punto critico della filosofia di Aristotele. Tale rapporto
ha un duplice aspetto, in quanto da un lato la scienza
si basa su principi la cui giustificazione spetta non ad
/
essa, ma alla filosofia, e d'altro Iato l'edificio della filo-
sofia sorge sul fondamento dell'esperienza scientifica dei |
fatti. Con questa eintesi del pensiero con l'esperienza :
J
Aristotele pensa di trasformare la filosofia di Platone
in una scienza critica. Infatti anche se egli non distin-
gue verbalmente la filosofia dalla scienza, comunque
unsaldo concetto della natura ideale della scienza quello
1
1
che costituisce il punto di partenza della sua critica di |
ogni precedente filosofia. Anche in seno alla sua stessa I
filosofia egli riconosce al sapere empirico delle scienze . -)<
particolari un grado maggiore di scientificit, non in
f
forza di una maggiore esattezza, che anzi piuttosto
da ascrivere al pensiero concettuale, ma in forza del-
l'incontestabile evidenza dei suoi dati di fatto: e del
resto proprio il problema della reale esistenza del so- (
prasensibile era la fonte di ogni incertezza a questo |
riguardo. Considerato dall'esterno, il mondo spirituale ;;
di Aristotele appare unitario, ma nella sua intima con
sapevolezza scisso dall'idea fondamentale del neces- I
sario divergere della filosofa dalla scienza, per quanto k
Aristotele si sforzi di concepire la filosofia, nel senso
pi rigoroso ed alto della parola, come la conclusione
necessaria della scienza empirica della realt, e di avvi-
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE 553
cinare cos reciprocamente le due sfere ideali. La scienza
greca aveva fin dalle sue origini ricevuto impulsi deci
sivi dalla forza motrice della speculazione
filosofica, e
ciascuna aveva promosso l'evoluzione dell'altra. Ma,
giunte al culmine, esse si trovarono in contrasto. Aristo
tele le ricondusse di nuovo a un labile equilibrio. Que
sto momento rappresent il culmine di quel tratto del
loro processo evolutivo, che esse poterono percorrere in
comune.
Nell'et postaristotelica n la filosofa n la scienza
riusc a mantenersi a tale altezza. La scienza aveva bi
sogno di un campo d'azione pi vasto di quello che po
teva assicurarle la filosofia. Coi suoi risultati metteva
spesso in questione imetodi e iprincipi d'interpre
tazione che aveva attinto a quella. L'esigenza specu
lativa degli ambienti culturali areligiosi allettava da
un lato la filosofia a tentar di nuovo audaci voli specu
lativi, e si deve concedere che anch'essa obbediva sol
tanto all'istinto di conservazione quando tentava di sod
disfare questo desiderio. A paragone dell'atteggiamento
critico di Aristotele, la Stoa e l'epicureismo sono, nel
loro aspetto dogmatico, manifestazioni di decadenza
della filosofia scientifica. In queste scuole ci si valeva
estrinsecamente della tecnica logica gi creata dal pen
siero precedente, si rielaboravano certe intuizioni meta
fisiche mescolandole con idee pi antiche e primitive,
o si richiamava a nuova vita la fisica presocratica, come
faceva Epicuro con Democrito, e si costruiva su questo
fondamento un ideale etico della vita. D centro di gra
vit giaceva nella metafisica e nell'etica, e a vere e
proprie ricerche scientifiche non si pensava nemmeno.
A questa tendenza pratica ader, dopo la terza genera
zione, anche il Peripato, nonostante che a tale ri
guardo eBso non potesse far concorrenza agli stoici e
agli epicurei: donde la penosa decadenza della scuola,
A
i
554 LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
da Stratone in poi. Nella grande figura di questo ricer
catore si manifesta per altro cliiara la via che non po
teva non prendere, date le condizioni del tempo, il mo
vimento iniziato da Aristotele. In questa et la scienza
peripatetica gi in connessione con Alessandria, che J
all'evoluzione delle scienze positive offre un terreno pi
|
propizio che non l'Attica, e un'atmosfera schiettamente
,|
realistica. La scienza alessandrina continua spiritual-
mente l'ultima fase dell'attivit aristotelica. Ilnesso tra . I
scienza e filosofia si spezza definitivamente: il metodo
di ricerca dei dotti dell'et tolemaica, tanto pi raffi- ;
nato dal punto di vista tecnico, privo dell'ideale pun-
to fermo, che la scienza empirica di Aristotele aveva V
avuto nella sua grande concezione spiritualistica della
realt. Ma d'altra parte si debbono a questa separazione,
che rappresenta ima liberazione necessaria per la ri-
cerca, le pi importanti scoperte che la scienza comp }
nell'antichit. La medicina e la scienza naturale, al pari '
della filologia condotta con metodo rigoroso, giungono
ora al loro massimo fiore, venendo rappresentate da
figure della statura di Aristarco, Aristofane, Ipparco,
Eratostene, Archimede. Dal punto di vista della filoso-
1
fia e della scienza aristotelica tutto questo complesso
di verit, , certo, solo una mezza verit. Ma la sintesi
dello spirito speculativo e del rigore scientifico non si
realizz pi nell'antichit. In tale sintesi consiste la
tarda classicit di Aristotele, anche se l'interprete e il
ricercatore soverchiano gi in lui il creatore di sistemi
speculativi.
Per quanto alto sia in s l'ideale di Aristotele, an
cora pi meraviglioso 0 fatto che esso si sia realiz
zato nello spirito di un solo uomo.
Questo
fatto resta
un miracolo psicologico, nella cui profondit non pos
siamo penetrare. La parola universalit caratterizza solo
la sorprendente capacit di dominio su tutti i regni
LA POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
555
della realt e l'enorme energia ricettiva rispetto al ma
teriale empirico. Entrambe le cose erano raggiungibili
soltanto inun'et di consapevolezza tecnica. Ma quel che
assai pi grande la vastit del suo spirito, che com
prende insieme la contemplazione delle essenze sopra
sensibili nel puro
vog, la tagliente acutezza dell'intel
letto logico e la precisione microscopica dell'esperienza
sensibile.
Questo
fenomeno ci riesce pi comprensibile
quando, in base al processo
dell'evoluzione intellettuale
di Aristotele, riconosciamo come in essa si equilibrino
originalit e ricettivit: ma anche con ci resta singola
rissimo che tanta ricchezza di vita interiore e tanta
inclinazione metafisica sia stata posseduta da un tem
peramento nettamente orientato verBo l'indagine e la
scoperta
scientifica. Le molteplici articolazioni di questo
mondo interiore sono tuttavia permeate
da un energico
spirito di unit, in quanto
tutti questi diversi atteggia
menti spirituali si attuano in Aristotele solo nella mi
sura in cui gli servono come strumenti della considera
zione oggettiva della realt. Al suo voj manca la forza
rivoluzionaria di quello platonico, al suo abito critico
il robusto impeto pratico del dogmatismo, alla sua ca
pacit d'osservazione l'istinto della tecnica e dell'inven
zione: tutte quelle doti si riuniscono in lui in servigio
di un unico compito, la conoscenza di ci che . La
sua attivit creatrice si risolve per intero nel porre sem
pre nuovi strumenti a servizio di quell'ideale.
Il presupposto
di questa piena dedizione allo studio
del mondo quello spirito di oggettivit, a noi inacces
sibile nei suoi ultimi motivi psichici, che permea tutto
ci che di mano di Aristotele e che questi ha tra
smesso in eredit alla scienza ellenistica. Abbiamo gi
notato come questa oggettivit non sia da scambiare con
l'impersonalit, ma sia bens ima forma di spiritualit
soprapersonale. Essa egualmente lontana dall'ogget-
550 I.A POSIZIONE STORICA DI ARISTOTELE
tivit artistica di cui la passionalit spirituale e rivolu
zionaria di Platone si riveste nelle sue opere, come da
quella tucididea, che si affranca dal dolore di un tre
mendo destino storico in quanto lo considera come ri
sultato necessario dello svolgimento delle cose e lo tra
duce in esperienza teorica della politica. In entrambi
questi scrittori attici la tendenza verso l'oggettivit rap
presenta la reazione a un'interiorit, che partecipa assi
duamente ai casi della vita e ai concentra nel dominio
di certi criteri di valore. Piuttosto che di oggettivit
senz'altro si dovrebbe parlare, nel loro caso, di oggetti
vazione. In Aristotele l'oggettivit invece qualcosa
di primario, ed l'espressione di ima grande pacatezza
rispetto al mondo e alla vita, quale invano cerchiamo
nell'Attica da Solone ad Epicuro. La troviamo piut
tosto in Ecateo, in Erodoto, in Anassagora, in Eudosso,
in Democrito, per quanto diversi essi siano tra loro. In
tutti un eerto spirito di contemplazione, un'assenza di
drammaticit. Ma l'orizzonte di Aristotele possedeva an
che l'ampiezza cosmica della speculazione ionica, della
cui inlima e catartica vastit nessuno dei cogitabondi
pensatori attici ebbe la pi lontana idea. D'altro lato
l'interiorit accentratrice dello spirito attico, che aveva
gi agito su Erodoto, esercit profonda influenza anche
su Aristotele e forn alla sua itrtoplct, che si estendeva a
tutto il mondo, il rigore metodico e l'unit costitutiva.
Grazie ad essa egli divenne quello che a nessuno dei co
smologi ionici era stato concesso di essere, vittorioso
organizzatore della realt e della scienza.
APPENDICE
GENESI
E RICORSO
DELL'IDEALE
FILOSOFICO DELLA VITA
t
Dai Sitzunpsbcrichte (ter
preussischen. Akcf
dcmie der Wiasenschajen. Phil.-hist. Klas*,
1928, pp. 390-121.
1
1
J;
,
:=
Ilricordo dei pi antichi pensatori greci sopravvive
nella letteratura dei secoli successivi in quanto il loro
nome resta legato a determinate dottrine e problemi,
mentre iloro scritti, nel caso in cui essi ne abbiano la
sciati, vanno incontro a ima fine precoce. Accanto a
questa tradizione, cosiddetta dossografica, che venne re
gistrata e controllata nei lavori di storia della filosofia
compiuti dalla scuola aristotelica e anzitutto nella grande
opera
di Teofrasto intitolata
<>uaix)V
,ai,
peraltro
sopravvissuta
anche ima diversa forma di ricordo, che ri
sale a una fonte affatto distinta. Per
questa
ipiantichi
protagonisti della storia della filosofia non sono idifen
sori di concezioni pio meno primitive, e ormai da lungo
tempo superate,
circa ipi diversi e singolari problemi,
bens irappresentanti augusti ed esemplari di quellaforma
spirituale di vita, che caratteristica dell' uomo filoso
fico di ogni et, e che appare impersonata inmodo par
ticolarmente netto ed efficace dai suoi pi antichi asser
tori.
Questa
tradizione, certo, non sa attribuire a quegli
antichi pensatori altro che lineamenti vaghi, corrispon
denti a un tipo generico : ed significativo che si sia
perci manifestata informa aneddotica e apoftegmatica.
Ma in quanto questi lineamenti generici furono collegati
coi nomi d'individui tanto noti e determinati, si venie
560 APPENDICE
formando, accanto alla tradizione delle dottrine, un' ini-
magine dei filosofi pi antichi che nei secoli posteriori
.-j<
ovvi alla mancanza di qualsiasi tradizione circa la loro
;
personalit umana, e fu anzi spesso considerata come
autentico dato storico.
Queste
narrazioni ci vengono ri- , 4
ferite, con ammirata venerazione, da filosofi di et pi
tarda, a cominciare da Platone. Vero che, in origine,
esse nascono in gran parte
da un motivo affatto diverso,
e cio dalla sorpresa del popolo nei riguardi del nuovo
tipo umano dell' indagatore e del dotto, alieno dal mondo
e dal vivere comune: tipo che, con isuoi paradossi e
con le sue bizzarre originalit, si fa avanti inquesti aned
doti. Cos della storia, riferita da Platone, di Talete
che osservando il cielo cadde inun pozzo, e si ebbe per
ci le beffe dell'arguta ancella di Tracia (cio da
quanto
di meno colto potesse immaginarsi un Elleno) : voler sco
prire quel che si trova lass nel cielo, e non veder nep
pure quel che sta davanti ai piedi! I). Mandre di be
stiame saccheggiavano, pascolando, icampi di Demo
crito, racconta Orazio nelle Epistole, mentre ilsuo alacre
spirito, dispiccatosi dal corpo, vagava lontano 2). Nella
partizione della ricca eredit paterna isuoi fratelli sfrut
tarono la situazione, perch egli voleva ricevere il suo
in contanti per poter intraprendere lunghi viaggi. Non
gli diedero quel che effettivamente valeva la sua parte,
ed anche questa somma fu da lui consumata nei viaggi
in Egitto e presso iCaldei.
Quando
ancora il padre vi
veva, egli usava rinchiudersi, per lavorare, in una ca
setta campestre,
che di tanto in tanto serviva anche di
stalla. E una volta egli non not affatto che il padre
1) Plat., Thcoct., 174 A (Diels, Vorsokr. 4, 1A 9).
2) Horat.. e[.isl, I12, 12 (coi luoghi paralleli in Diels, Vorsokr 4,
55 A 15).
l'ideale filosofico della VITA 561
vi aveva legato un bue destinato al sacrificio, e rimase
tranquillamente sotto lo stesso tetto con l'animale, finch
esso fu condotto alla morte ed egli fu fatto accorto della
singolare compagnia che aveva avuto J). Che questo
tipo
di aneddoti non esprima affatto la semplice ammirazione
che l'intenditoreprova per un' inconsueta concentrazione
spirituale, ma bens manifesti l'opinione canzonatoria che
il volgo ha del sapiente distratto, dimostrato in modo
palmare, nel caso di Talete, dalla narrazione che in Ari
stotele fa riscontro all'aneddoto dell'astronomo caduto
nel pozzo. il racconto di una manovra commerciale,
compiuta da Talete con splendido
successo per mostrare
ai dispregiatori della scienza come si possa guadagnare
molto danaro anche con la meteorologia, quando
si miri
a tale scopo. Prevedendo ima raccolta di ulive insolita
mente abbondante, egli prese per tempo
in affitto tutti
ifrantoi della regione e, quando venne il gran raccolto
e nessuno disponeva di frantoi, lisubaffitt, per unprezzo
superiore, a quelli stessi che ne erano gli effettivi pos
sessori 2). A questo proposito gi Aristotele, col consueto
suo fiuto critico, nota come evidentemente si tratti di
un aneddoto rispondente a un tipo generale, riferito
a Talete solo a causa della sua ben nota sapienza ;e
caratterizza con esattezza anche l' intento di tale attri
buzione, la quale doveva infatti mettere inevidenza come
la scienza non fosse inutile, e come bens agli scienziati
non importasse di adoperarla per arricchirsi. Ilcarattere
generico di molte di queste
storie dimostrato anzitutto
dal fatto che esse sono riferite a diversi protagonisti.
Cos anche di Anassagora, al pari di Democrito, si dice
l) Demetr,, v 'Opwvipoi;, presso Diog. Laert., IX, 35-36 {Diels,
Vorsokr. 4, 55 A 1).
2) Arisi., Polii., A 11, 1259 a 6 (Vorsokr. 4, 1A 10).
36.
W. Jaeger, Aristotele.
562 APPENDICE
che trascur la sua eredit, e che, quando iparenti gliene
'
chiesero conto, rispose che se ne occupassero loro, ce- ,1
dendo con ci ad essi volontariamente ogni avere, per
potersi occupare soltanto delle sue ricerche scienti!!-
:
che 1). Inquesta forma, certo, l'aneddoto ha gi assunto
un colorito pi patetico a paragone dello spirito di bo- :
naria canzonatura che pervade l'aneddoto democriteo.
La figura del filosofo attonito che, nella sua assenza di
spirito, lascia che il suo bestiame pascoli nei suoi stessi
coltivati, si trasforma in quella di uno spirito indipen
dente, che, nella sua grandezza, dispregia con piena co
scienza ibeni esterni e li rigetta eroicamente da s.
Animato dello stesso spirito un altro apoftegma : Anas
sagora, interrogato circa lo scopo della sua vita, risponde
orgogliosamente di vivere per contemplare e studiare
il sole, la luna e il cielo2). Tono eroico hanno anche
imotti che la tradizione gli attribuisce inoccasione della
sua condanna da
parte
dei giudici ateniesi e in quella
della morte di suo figlio : motti che debbono mostrare
come l'animo del vero scienziato non sia legato alle realt
transeunti, e neppure ai massimi beni umani, l'esistenza
civile, la moglie, il figlio 3). Ad attestare il completo alie
narsi del filosofo dalla vita politica, a cui il Greco del
l'et classica dava tutto s stesso,
mira l'aneddoto se
condo cui Anassagora, achi gli rinfacciava che non gl' im
portava nulla della sua patria, ribatt :
Della mia pa-
!) Diog-, II, 7 (Vorsakr.
4
45 A 1).
2) Diog., II, 10 (Vorsoltr. 4, 46 1). Inaltra forma, il motto
6' incontra in Arist., Eth. Eud., A 5, 1216 a II. Nel senso indicato
da queste parole da intendere anclic il motto, volutamente oscuro,
con cui Anassagora risponde alla domanda circa chi sia la persona
pi felice: oBslg
fi)v
cu vo|il(i;, 4M.' 4ro7tog 5v tig ooi pavsit],
cfr. Arist., Eth. Eud., A 4, 1215 b 6 (Vorsokr.4, 46 A 30).
3) Diog., II, 13 (Vorsokr.4, 46 A 1).
l'ideale filosofico della vita 563
tria m' importamoltissimoindicando nello stessotempo
con la mano il cielo x).
L'et e il luogo d'origine di questi aneddoti sono in
certi, e per quelli che, come la storia dell'astronomo di
stratto, esprimono piuttosto isentimenti della massa che
l'opinione di una persona singola, siamo assolutamente
privi di qualsiasi punto di riferimento. Alquanto diversa
la situazione per quel che concerne gli altri aneddoti,
iquali, nel complesso, sono stati coniati da uomini di
una determinata categoria, permeati essi stessi dall'ethos
di quello che pitardi sarebbe stato detto S-Eiopyjtix? pio?
e intenti perci a crearsi una sorta di simbolo nei sug
gestivi motti degli antichi sapienti. Ci presuppone quindi
che, al
tempo
della genesi degli aneddoti, questo pio?
non fosse soltanto vissuto da singole personalit d'ec
cezione, le quali seguissero in ci solo un loro istinto
naturale, bens fosse gi diventato un consapevole ideale
filosofico. Ma non si pu dire che questo valga proprio
nel caso dei pi antichi naturalisti presocratici.
L'ideale
del pio? consacrato alla conoscenza deve la sua genesi
a Platone, la cui etica determina e
contrappone pi tipi
di vita e culmina nella scelta della vita migliore8).
Certo, per s perfettamente concepibile che uno scien
ziato come Anassagora, il quale viveva in un ambiente
sociale cos esclusivamente orientato verso la vita po-
1) Diog., II, 7 (Vorsokr. 4, 46 A I).
2) Nel suo bello e appassionato discorso accademico Vita Con
templativa (inBerichui der Heidelberger AkademU, 1920, 8) Franz Boll
ha determinato una serie di rappresentanti di questo [5Cog, la quale
b' inizia con Talete, Eraclito e Anassagora. A Platone e ad Aristo
tele egli accenna appena, mentre nella considerazione dell' influsso
da essi esercitato sull'et posteriore si avvicina di pi alla valuta
zione che essa merita. Ma il problema da cui prende le mosse la
nostra indagine non era ancora avvertito dal Boll. In che misura
le notizie pervenuteci circa ipensatori pi antichi e il loro gicg
i
'
a!
b
564 APPENDICE ,
<
litica com'era quello dell'Atene di Pericle, abbia acqui-
stato consapevolezza della singolarit della sua esistenza,
avulsa dal terreno in cui affondava le radici il vivere
altrui. E gi Euripide esalta la vita tranquilla del na
turalista che si ritirato dalle faccende politiche 1), e
tratteggia nell'Antipe il tragico conflitto dell'uomo de
dito al culto delle Muse con quello legato agli interessi
-
pratici 2). Ma Platone il primo a portare nell'mbito
della filosofia il problema morale dell'uomo teoretico,
e a giustificare e trasfigurare eticamente la sua vita. Con
siderata quindi la cosa dal
punto
di vista di Platone,
l'esistenza di questo tipo umano nell'et anteriore do
veva apparire come una semplice stranezza, una biz
zarria della natura umana, priva ancora di ogni giusti
ficazione morale;oppure si doveva attribuire
post
factum
ai pi antichi rappresentanti di tale tipo, come Talete
e Anassagora, la giustificazione del &5e)p'y)Tix; |5foc; che,
tanto sul piano della teoria quanto su quello della sua
.
i
risalgono a un'effettiva tradizione storica ? 11 fatto clie gi ai filo
sofi presocratici venga ascritto l' ideale consapevole del freuiprjTixs :
pioj va considerato come attestazione storica degna di fede o come
mero rispecchiamento di nna posteriore etica del (Stoj? L'intera
tradizione va nuovamente esaminata da questo punto di vista, ora
che l'evoluzione dell'etica filosofica e della teoria del (SCoj da Pla
tone ad Aristotele e ai suoi scolari stata posta nella giusta luce.
In quest' ultima noi troviamo un punto fermo, che insieme un
punto cruciale per la genesi della tradizione concernente la storia
della filosofia : di qui, dunque, che occorre prendere le mosse.
*) Eurip., fr. 910.
2) Gi Platone (Gorgia, 464 Ee 485 E segg.) fa citare a Calli
de, nella sua polemica contro un tipo unilateralmente filosofico di
vita, versi dell'Antiope. Certo, Amfione era caratterizzato da Euri
pide come uomo dedito piuttosto al culto delle Muse che a quello
della scienza..
Ma la somiglianza era data dalla comune estraneit
alla vita politica, e perci Platone poteva far dirigere a Callide
contro Socrate iversi pronunciati da Zeto contro Amfione (nono
stante la propria idea della missione politica di Socrate, Platone
non neg mai che, dal punto di vista della corrente politica di par
tito, il suo maestro fosse un uomo apolitico).
l'ideale filosofico della vita 565
simpatia morale, aveva dato Platone stesso. Com' pos
sibile dimostrare, fu
appunto quest'ultima cosa che ac
cadde. Tutte le narrazioni che attribuiscono ai filosofi
pi antichi la professione consapevole dell' ideale del
D'etapr/ttxirS (ilo; o derivano immediatamente dalla scuola
platonica o sono nate, sotto l'influsso dello stesso ideale
platonico, in et di poco posteriore. L' influenza che sul
formarsi della tradizione ha esercitato la filosofia pla
tonica e la sua diretta erede, la scuola peripatetica, me
riterebbe del resto un' indagine complessiva. Il risul
tato che se ne ricaverebbe peraltro indubbio a priori :
quello che tutta la raffigurazione della pi antica sto
ria della filosofia trasmessaci dalla tradizione ha acqui
stato la sua forma nelle due o tre generazioni inter
corse tra Platone e idiretti scolari di Aristotele. La filo
sofia di queste
due scuole rimasta come una pietra
angolare nell'edificio storico della nostra cultura : ma
imo degli esempi pi istruttivi della validit di tale prin
cipio costituito dal modo in cui l'ideale di vita di
questa et culminante della filosofia greca viene a riflet
tersi nell' immagine dei pi antichi pensatori presocra
tici e del loro pio;. Siamo anzi persino in condizione di
poter ancora comprendere i grandi
e apparentemente
inconciliabili contrasti, a cui va incontro la tradizione
a noi nota nella sua raffigurazione
dei pensatori pi
antichi, come conseguenza necessaria delle oscillazioni a
cui va soggetta l'idea della vita ottima nell'et che
da Platone giunge fino ad Aristotele e ai suoi scolari.
Comprendere l'evoluzione del problema
etico, e in par
ticolare di
quello del pio;, durante questo periodo signi
fica nello stesso tempo chiarire ilmodo incui si formata
la tradizione delle notizie a noi giunte circa la vita dei
filosofi pi antichi. Dobbiamo perci prendere le mosse
dal significato che il problema del pio; ha nella filosofia
566
APPENDICE
platonica e
seguire con maggior precisione ilsuo processo l'
evolutivo. Desumo anzitutto alcuni
punti fondamentali ;
j
dalla mia precedente trattazione su Aristotele, per ap
profondirli ulteriormente.
La pura freiepfa dei naturalisti pi antichi ebbe la
sua genesi nella Ionia. Fu uno dei pi singolari prodotti
della tarda cultura ionica, che per la preponderanza
ii
dello spirito commerciale e poi per il dominio straniero
aveva sempre pi smarrito l'interesse politico e facili
tava, con.la gran libert concessa all' indivduo, l'avvento
;
di quel tipo di vita in seno al complesso sociale della
polis. Lo spirito attico, col suo attaccamento alla terra
e con la netta politicit del suo regime di vita, non la
sciava invece adito a simili attivit particolari dei
singoli.
Ancheoltrel'etplatonica essoconsiderava lapura scienza
con
'
animo con meno alieno e diffidente di quello che
poi a Roma
fu proprio della classe senatoria. Su
questo
aspro terreno doveva nascere il dramma civile, per la
prima volta rivelato .da Euripide, dell'uomo apoli
tico. Il contrasto fra il dovere del cittadino e l'ozio
del ricercatore scientifico, tra l'agire e il conoscere,1do
veva qui
conseguentemente elevarsi ad ostilit verso la
;
scienza da
parte degli uomini dediti alla pura vita po
litica e a ripudio dello stato da
parte dei filosofi. auche '
vro, peraltro, che soltanto sul suolo attico Platone
po
teva arrischiare il suo profondo tentativo di conciliare
senza compromessi il &eo)pr)ttxg (Sto; col
TtoXmx? j3og,
dando alla scienza e alla filosofia, quale nuovo conte
nuto, lo
stato, e facendo delle supreme norme e leggi
dell'agire civile il loro problema sommo, dalla cui solu
zione dipendeva la salvezza dello stato stesso, cio
dello stato in s. Certo, nei suoi scritti pi giovanili,
in cui egli presenta i suoi contemporanei Socrate come
l'unico vero uomo politico di cui essi hanno
bisogno,
l'ideale filosofico della vita 567
in quanto
egli ha indirizzato iloro occhi alla decisiva
questione
della conoscenza della norma suprema -1), non
si trova ancora nessuna traccia di quell' ideale di vita
contemplativa
che da lui professato pi tardi. Inquel
l'epoca
il suo ideale e del Xyoj e del
105
era ancora
impersonato
esclusivamente
da Socrate ;
e salta agli ac-
chi il contrasto di questo
Socrate rispetto al tipo del
puro indagatore alieno dal mondo, della Stvota aipo-
vopouca xal YewjuTpoaa, in cui la sua stessa per
sona viene trasfigurata e ipostatizzata dalla famosa di
gressione del Tceteto platonico 2). Ma per Platone il pro
blema morale di Socrate era stato fin dall' inizio un
problema
di conoscenza. La questione del retto intuito
morale, della cppvrjais,
Per
adoperare il nome che So
crate aveva attinto all'uso corrente della lingua greca,
celava in s Vanoor pi profondo problema dell'essenza
del conoscere
ingenerale e della vera natura dell'essere ;
e il giro attraverso tali questioni
fondamentali, che
Platone credette di dover compiere per risolvere il pro
blema
socratico, lo condusse sempre pi a una teoria
generale della conoscenza e dell'essere e Io costrnse ad
accogliere
nel suo edificio scientifico anche le discipline
della matematica e dell'astronomia, le quali gi avevano
una loro esistenza. La pvTjots 62 riempi in tal modo
del contenuto
di
questa
aocp(a, e dall' dnopev ed Xy-
yetv di Socrate si svilupp un 0,(i)pr]Tixs (jloj, dedito
*) Cfr. ichiarimenti da me dati inPlalos Stellung im
Aufbau
der grchischen Bildung (Berlino, 1928), p. 40 dell'estratto.
2) Certo, Socrate non manca affatto di tratti teoretici, per
quanto egli prediliga aggirarsi soprattutto col dove gli uomini si
affollano, nella palestra e nell'agora. Ma al Boll, il quale si richiama
(L c., p. 9) alla sua trascuratezza per l'economia domestica e alla
sua astensione dalla politica quotidiana, o all' 06 pij itaooptti cpio-
oorpfiv dell'.4pologio (29 D), va osservato che ungran distacco separa
questo suo tipo di concentrazione meditativa da quello del dotto
raffigurato nel Tceteto (173 E): cfr. su ci sopra, pp. 17-18.
568 APPENDICE
alla pura ricerca scientifica. Nel Teeteto, dove il nesso
della filosofia con la matematica viene particolarmente
in luce, Socrate canta un vero e proprio inno alla vita
dello scienziato e ne tratteggia l' immagino ideale con
colori desunti dal tipo dell'astronomo e del matematico.
appunto in tale contesto che vien ricordato Talete
quale tipo esemplare di filosofo immune di ogni preoc
cupazione pratica e politica, ed raccontato l'aneddoto
della sua caduta nel pozzo mentre osservava le stelle.
singolare che le lodi della geometria e dell'astronomia
siano qui intonate proprio da Socrate, a cui Platone
aveva fatto dire una volta, nell'Apologia, che di tali
alti argomenti egli non capiva n molto n poco,
perch non se n'intendeva affatto 1). evidente che Pla
tone stesso era conscio di aver raggiunto, con questa
tardissima rappresentazione di Socrate data nel Teeteto,
il limite estremo di quella libert di trasfigurazione ar-
tistica che gli poteva essere concessa nei riguardi della
persona storica del maestro. Il nuovo ideale del
frscopi'j-ctxs e il tipo di scienza puramente speculativa
che gli stava a fondamento esigeva altro simbolo, altro
archegeta che Socrate, il quale fino allora era stato il
protagonista dei dialoghi platonici ; e cos, nelle due
opere composte dopo il Teeteto e ad esso ricollegantisi,
il
Sofista
e il Politico, troviamo introdotti a presiedere
alla discussione idue augusti rappresentanti della dia-
lettica eleatica, Parmenide e Zenone, mentre Socrate
deve accontentarsi di una funzione subordinata. Pari
menti, nel Timeo l'esposizione della cosmologia plato
nica affidata al filosofo pitagorico dello stesso nome.
L' ideale del d-sitpTjttxs quale allora era realiz
zato nell'Accademia platonica, solennemente proda-
-1) Plat. Apol., 19 D.
l'ideale filosofico della vita 569
mato da Aristotele inun suo scritto giovanile, da me al
trove ampiamente studiato, il Prolreptico1). Della mu
tata posizione dell'Accademia rispetto
a Socrate e all'am
bito dei suoi problemi prova
ilfatto che lametafisica,
la quale costituiva allora per la scuola platonica il pro
blema centrale e non aveva ancora un proprio nome
adeguato, vien designata nel Protreptico con la circon
locuzione : la scienza della verit, quale stata inau
gurata da Anassagora e da Parmenide .
Qui
chiaro
come inomi dei due antichi pensatori tengano soltanto
il posto
dell' idea della filosofia
puramente
teoretica, di
cui erano considerati, in quell' ambiente, rappresen
tanti2). Come pure altra volta dimostrai, creazione del
l'ambiente accademico anche il tipo ideale di Pitagora,
che tanto influsso esercita sulla tarda antichit, e che
noi vediamo formato per
la prima volta nella nota nar
razione dello scolaro di Platone Eraclide Pontico. Se
condo essa, Pitagora sarebbe stato il primo ad adoperare
le denominazioni di filosofia e di filosofo e a chiarire l'es
senza di quest'ultimo merc il famoso paragone con
coloro che ai giuochi olimpici sono puri contempla
tori.
Questo
paragone si fonda sul doppio senso della
parola &ewpetv, che significa tanto contemplare quanto
considerare e indagare nel senso che appunto
si dice
teoretico . Giacch anche Aristotele paragona nel Pro
lreptico l'attivit dell' indagatore dedito alla pura scienza
con la contemplazione dei frewpoi ad Olimpia, evidente
che tale termine di comparazione del D-scopTjTix; (lo?
era gi divenuto classico nell'Accademia. L'attribuzione
di questo
ideale filosofico di vita a Pitagora, che veniva
perci considerato come suo iniziatore, connessa con
1) Cfr., sopra, il capitolo sul Protreptico, pp. 69-152.
2) Aiist., fr. 52, p. 59, 3 Rose.
570
APPENDICE
l'alta valutazione che
proprio di
Pitagora e dei
pitago- ')
rici si faceva nell'Accademia, la quale vedeva
sempre l
pi in essi l'esatto
esemplare storico della sua
stessa
filosofia
matematizzante. vano sforzo da
innamorati
voler salvare,
considerandolo
conveniente al Pitagora
storico, anche soltanto questo bel
racconto, dal momento
che nella stessa et si veniva attribuendo alla figura
di
quel pensatore una quantit di tratti e di
aneddoti ape
crifi, e circa la sua vita e isuoi
apoftegmi si
formava ra
pidamente un' intera letteratura di
carattere leggen
dario 1). pi
opportuno seguire
l'esempio di
Aristotele,
,
1}
50p,ra' ppl.
127-28- 11 (Die
Anfange der griechi
-
schen Philosophie, tiz. tedesca, p. 86) saznhra incide a cdnside-
rare storica la
narrazione di Eraclide e a far parimente
risalire a
Pitagora la teoria dei tre gio (iiteXaua-cixi
j, iroXituc e 8eo>-
pijTwos) che essa presuppone e che s' incontra in
entrambe le Eli-
? ?T|St<'1i
Ma taat0 la
Dar"zione in s considerala quanto
1 indole del suo autore, proverbiale per la sua fantasia romanze
sca, non costituiscono certo prove infavore di tale tesi. La teoria dei
\w CTUne /
?rade
e ad
itotele, che
l'attingono entrambi
da11Accademia (cfr. Plat
Resp., IX, 581 C
segg.) ;e anche per il
resto la narrazione erachdea non contiene il minimo elemento pi
tagorico che nnvua un'et
antecedente a quella platonica.
Quando
Cicerone (JW" V, 9 : altrimenti Diogene Vili, 8 e Giambico,
Vita Pyth., 58) attcsta come nell'esposizione
di Eraclide gli
uomini
apparissero quali stranieri giunti in questa vita da
un'altra esi-
stenza, al pan da coloro che venendo dalle pi diverse citt greche
partecipavano alia grande itsvijyupis ellenica, facile vedere come
in cid non sia altro che la ben nota teoria platonica
dell'anima.
Non s. pu inferirne che sia stata pitagorica anche la dottrina dei
tregCoi, anche se di provata pitagorici quella della metempsi
cosi. Sussisteva, certo, un
EoHr nello stesso senso in
cui sussisteva un Opgwg p;os : ma ci non toghe che nna suddi
visione e classificazione
sistematica dei pio:, come quella che s'in
contra m Piatone e mAristotele, fosse cosa affatto diversa. La tri-
rnt dei plot deriva da quella dei fini della vita
incui, secondo
Platone e Aristotele, diversi uomini fanno consistere l'eudemonia
veduta nifatti o nella r,Sovtj o nell' o nella apynotc Non
quindi un caso che gio siano tre, e proprio questi tre, pcr-
fATiiMm!pwOM
esattamente ai tre pilastri su cui si basa I'edi-
licio dell etica platomco-aristotelica.
Ci espresso in
maniera chia
rissima da Aristotele nell'Edi. Eud., A 1, 1214 a 30 : t B'sBtv-
fiovsrv
"/.at r r)v pxxapCog xxl
xaXfis sin v ;
tplol piXisTZ
l'ideale filosofico della vita 571
il quale evita di citare il nome di Pitagora e preferisce
parlar soltanto dei cosiddetti Pitagorici suoi contem
poranei, non credendo che si possa pi giungere a cono
scenze sicure circa il Pitagora storico. Viceversa lo stesso
Aristotele, nel dialogo Ilepl cptXoaocpCaj, ha tenuto
conto, per la preistoria della filosofia, dei sette savi :
infatti difficile interpretare altrimenti la notizia rife
rita dalla tradizione, secondo la quale egli li consider
inquell'opera come sofisti, naturalmente nel senso buono
della parola1). Nell'Accademia si estendeva del resto
il concetto del S'&toprj'uy.s jBEoc; fino a comprendervi an
che isacerdoti egiziani, dei quali Aristotele, nel primo
libro, di et relativamente antica, della sua
Metafisica,
dice che sarebbero stati iprimi a dedicarsi alla pura
scienza, avendone avuto l'agio per la loro stessa profes-
to; elva1. Soxsoiv cripsTuivToi?. 1% (lv yp ttjv cppvijaiv |i-j-1-
otoy eTvaC tpaoiv yav, o? B "cr]v &prci}v, ot 8 rqv iovrjv
(e cos Arist., Protr., ptesso Jamb]., Prolr.. cap. VII segg. : cr.
sopra, p. 85). Ea questo sistema triplice degli edps-c Aristotele si
riferisce esplicitamente (Etk. Eud., A 2, 1215 a 3S) per fondare su
di esso quello corrispondente dei
fiioi.
A sua volta, la trinit della
fjSortj, dell'ccpetr) e della cfpvTjsis; deriva dalla dottrina platonica
delle tre parti dell'anima, da cui lo stesso suo autore deduce, nella
Repubblica (IX, 580 D sgg.) ,itre gio e le tre specie della vjBor/j.
Naturalmente la letteratura pseudo-pitagorica rifer pi tardi a
Pitagora o ai suoi seguaci anche la tripartizione dell'anima, al pari
di quasi ogni altro motivo : e persino uomini come Posidonio (per
non dire di gente corno Giamblico e Porfirio, che accettavano tutto
senza alcun discernimento) credettero all'autenticit di simili fal
sificazioni. Nel mio Nemesios (p. 63 segg.) io non ero ancora giunto
a una chiara visione complessiva di tale specie di letteratura :
altrimenti non mi sarei attardato a sollevare tante difficolt circa
queste testimonianze dell'origine pitagorica della tripartizione del
l'anima. Mi rallegra comunque il fatto che fin da allora io non cre
dessi ciecamente ad esse. Ultimamente A. E. Taylor, nel suo com
mentario al Timeo (p. 497), tornato a sostenere l'origine pitago
rica della tripartizione dell'anima.
l) Arist., fr. 3 Kosc prova che isette saggi comparivano nel
dialogo nepl qiXooojplas. Il Rose ha perci certamente ragione
quando riferisce a tale dialogo V indicazione data dallo Elymol. Ma
gnum s. v. ooqxof/)s, secondo cui Aristotele chiam con questo
nome i sette saggi.
572
APPENDICE
sione. E VEpinomide
del platonico
Filippo d'Opunte,
che si propone di inserire il&swpijTtxs fsioj nella costru
zione politica delle
Leggi lasciate dal
maestro, vede ne
gli astrologi caldaici gl' immediati predecessori dell' ideale
da esse
propugnato. Da tal modo l'Accademia, negli ul
timi decenni dell'attivit di Platone, procura al proprio
[05 la conveniente cornice storica 1).
L'Epinomide pervasa dall'energica e
rassegnata con
vinzione che tale
JJfcs
sia peraltro riservato solo a
po
chissimi uomini d'eccezione ;ed uguale lo
spirito della
settima lettera
platonica, che
cronologicamente le di
poco anteriore e che il grande
testamento spirituale
del maestro, in cui egli prende per l'ultima volta posi
zione
rispetto a quel problema del
rapporto tra la
po
litica e laconoscenza filosofica che lo aveva agitato tutta
la vita. Certo, la radicale disposizione
interiore a tra
durre iconcetti della filosofia in azione
creatrice e a
intervenire cos nella vita dello stato rimase in Platone,
anche in questi suoi ultimi anni, quella stessa che era
stataall' inizio dellasua evoluzionespirituale, nonostante
lo spettacolo del
naufragio a cui era andato incontro, a
Siracusa, il suo prediletto scolaro Dione nel primo serio
tentativo di dar vita reale agi' ideali
platonici. Ma tut
tavia era ormai manifesto come tra
questo programma,
che in origine aveva dominato tutto il suo filosofare 2),
e l'effettiva realt del suo ultimo periodo di vita, dedi
cato soltanto alla pura indagine
teoretica, sussistesse
un forte
contrasto3). Da
questa situazione si
svilupp
a poco a poco un complesso di problemi, che con tutto
1) Arist., Mefnph., A 1, 981 b
23;
jPl&t.], Epinom., 986 E.
2) Cfx. il mio discorso (tenuto
all'universit di Berlinoil18gen
naio 1924 per l'anniversario della fondazione del Reich) Die grie-
chische Slaatsethik im Zeilalter des Pialo, p. 10 e Plclos Stellung
im
Au/t.au
da griethischen
Bildung, p, 39 segg.
3) Cr. "Wilamowitz, Platon, vol. I, cap. 14.
l'ideale filosofico della vita 573
il suo peso pass
in eredit ad Aristotele e mise inperi
colo quell'essenziale
unit del conoscere scientifico e del
l'agire pratico che per Platone, fin dal suo periodo
so
cratico, era stata la premessa di tutta la sua ricerca e
quindi
anche uno dei fondamenti della sua idea del frsw
p-t]wx.oc,
Nello stesso senso in cui agiva l'evoluzione
personale
di Platone operava poi
la tendenza interna
della scienza platonica
in s considerata. Il calore pas
sionale dell'impulso socratico verso la conoscenza aveva
avuto ragion d'essere, per parlare
in termini platonici,
solo in vista della contemplazione
dell'idea del bene,
e l'agireaveva avuto per Socratelo stesso significato che
il conoscere l'ya&v. Laprima
filosofia platonica aveva
quindi
mirato, con decisione anche maggiore, a par
tecipare alla vita pratica
e politica.
Ma, durante ilpro
cesso evolutivo, l'esigenza del conoscere aveva in Pla
tone ampliato smisuratamente ilsuo dominio.
Sembrava,
s, che la scienza del pi tardo periodo
platonico si fosse
sviluppata
in modo affatto organico
dal primo germe
socratico, accogliendo in s complessi sempre pi ricchi
di sapere teoretico ; ma in realt il suo campo non era
pi
limitato esclusivamente
all'ambito etico-politico, co
m'era negli scritti fino alla Repubblica. L'etica era di
venuta una semplice
parte della filosofia, accanto alla
logica
e alla fisica 1), e quando ilvecchio Platone faceva
lezionesul Lene, egli comprendeva
sotto questo
titolo
anche la matematica e la metafisica
e ogni altra scienza,
e non soltanto ima dottrina dei beni della vita umana,
secondo quanto
Aristotele, giusta
il noto racconto che
ce ne ha lasciato iltestimone diretto
Aristosseno, usava
pi tardi narrare ai suoi scolari. Assurge a simbolo del
*) V. perci la nota partizione della filosofia in Senocrate, fr. 1
Hcinze: partizione gi valida anche per il vecchio Platone. Aristo
tele non stato il primo a dividere in tal modo la filosofa.
574 APPENDICE
trapasso della filosofia platonica dal suo originale inte
resse per la vita pratica al suo atteggiamento puramente
teoretico il fatto che l'annuncio dell'antico tema Ttspl
Tyao attirasse fitte schiere di uditori, e che poi inter
venisse una generale delusione appena Platone incomin
ciava a parlare di numeri e di linee e di quella suprema
unit con cui s' identificava il bene 1).
In apparenza, l' ideale del S-U)pT]Tixg (jfog non
era immediatamente minacciato da
questa evoluzione :
anzi la scienza pura, nel senso in cui l'aveva intesa il
vecchio Platone, sembrava trionfare della tendenza uni
lateralmente pratica del socratismo. La piena vittoria fu
assicurata ad essa da Aristotele, che ampli la plato
nica dottrina delle idee in scienza universale, ed em
piricamente fondata, dell'essere. In certo senso, egli fu
un
rappresentante del xkiopTjTtx; pio; anche pischietto
di Platone. Ma per questa nuova scienza la difficolt
consisteva nel non perdere, ad onta dell'evoluzione, in
cui essa non incontrava ostacoli, verso la pura teoria,
il collegamento originario con l'etica socratico-platonica,
giacch proprio in
quanto serviva alla vita effettiva il
{t-ewprjTixg pio; aveva conquistato in Platone la sua di
gnit morale e il suo sacro diritto. Anche dopo l'abban
dono della teoria delle idee, la vita filosofica di Aristo
tele era ancora
troppo saldamente radicata nell'epos
di
quell'ambiente accademico in cui essa si era venuta for
mando fin da principio, perch egli potesse mutare pur
*) Aristoxenos, Harmon., 30 Mcibom. (p. 44, 5 Marq.) xaMnsp
'ApioxoxXv;; SnjYetxo tgis tuXsEgtods t&v xouovtMv uopi
Ittttavos
v ixspt T-j-ccOoO xpaoiv saO-stv. npooivai [lv fp
fy.asTOV
unoXajipivovta vj'jjsoOaC ti xiv vojniJojivojv xotwv v-
Opu)it[vu)v dyaS-uiv olov itXoxov
fEsiav
tuiy_i>v t 8Xov sMiupovlav
uva
#aopao&i;v' xe 84 (paveErjaav ol Xyo'. ruspi pa&[i4x<uv xal
dpiO-pcv xai Y8U)[is-tp(a{ xzl &axpo\oyla.i; xal x Jipccj 8ti ya&v
-Tttv tv, tcavxsX&g oljiau rcapSoJv ti t'paivsxo afjxxtg. elO'ol [lv
&~oxate<pp8vouv toO icp&yiiaTO; xateppepovro.
i,'ideale filosofico della vita 575
di una sola virgola la platonica professione
di fede nella
missione educativa e morale della scienza, quale egli
stesso aveva proclamata nel Protreptico. Certo egli se
para, in quanto disciplina particolare, l'etica dalla me
tafisica ;ma tuttavia la connette con essa, al pari di Pla
tone, nel punto decisivo, in quanto
tien fermo all' im
portanza
dell'educazione e della conoscenza intellettiva
per la cultura morale della personalit. Anche nel suo
stato 1), come nella gerarchia del mondo morale, egli
assegna al Q-sopYjTtx; [ito; il posto supremo ; e se
condo la sua concezione la felicit individuale dell'uomo,
lo scopo finale di ogni suo sforzo non si compie nella
perfezione morale o comunque non soltanto in essa, ma
solo nella piena esplicazione delle forze spirituali della
sua natura2) :ed anzi egli considera, esattamente come
Platone, la capacit specifica della discriminazione mo
rale come dipendente in ultima analisi della conoscenza
del supremo principio dell'essere. Del primato della ra
gion teoretica rispettoalla ragionpratica egliresta sempre
platonicamente
convinto, non solo perch l'attivit spi
rituale (vo vfpyeia) indipendente dal lato sensibile
t) Nella Politica, H 2-3.
Aristotele ricerea il fine a cui debba
mirare il perfetto stato e l'educazione dei suoi cittadini, e discute
la questione se ilmiglior PEo; eia ilitoXm-/; o il Ttpccxxixj o un al
tro"(cio, com' sottinteso, il &ea)pt]Ttv.;). Egli respinge entrambe
le concezioni estreme: tanto quella per cui solo il pio? itoXeuxg
degno di un uomo e di un uomo libero, quanto quella che rigetta
a priori qualsiasi forma di potere e di dominio giudicandola mera
tirannide, e rifiuta perci radicalmente di partecipare alla vita po
litica. Per Aristotele, il Pio; 5-eo)pi)ttx{ non equivale affatto a
questo gCof; gevixg, giacch insieme anche pratico nel senso
pi alto della parola : anche ifilosofi e gli scienziati sono dei rea
lizzatori inquanto ol rat; SiavoEea; pxixxtovsc (cfr. specialmente
132S b 14-23).
2) L'eudemonia nel senso supremo e garantita solo dal pio;
3-ect)p7)Tix8s (Etk. Nic., K 7): 5suxp<i> 8'6 xari tfjv XXi;v psxv
(scil. pio;).
Questa
subordinazione gerarchica dell'ikx psx; alla
Biavovjtix psTTj pi minutamente giustificata in K 8.
576 APPENDICE
della natura umana e dalle necessit esterne e perch
noi possediamo in essa un frammento dell'eterna beati
tudine di Dio, cio della sua sopratemporale conoscenza
assoluta di s medesimo, ma anche perch la conoscenza
morale anch'essa positivamente
compenetrata e
diretta
dalla concezione metafisica di chi pensa scientifica
mente J).
Ma, a questo punto, sorge per Aristotele un problema
che a Platone non s' imponeva ancora con la stessa ne
cessit. Esso mette decisamente in luce le difficolt in
terne con cui si trova qui a lottare il platonismo aristo
telico. La sfera morale e quella scientifica sono, s, in
contatto, e questa interviene in quella, ma tuttavia solo
in un
punto, mentre in Platone la seconda comprende
ancora totalmente in s la prima. Da allora la Bcienza
si suddivisa innumerose discipline, ciascuna delle quali
tende a raggiungere ima sua autonomia nei riguardi del
complesso totale dello scibile. Anche la metafisica od
ontologia, che in Platone era l'organo complessivo della
considerazione filosofica del mondo, si separata dalle
altre scienze, e ne ora soltanto la regina, detta anche
teologia (ikoXoycv.fj). E ad essa, che scienza come
intuizione del mondo, pensa principalmente Aristotele
tutte le volte che pone la sfera etica in contatto con
quella teoretica. In nessun luogo ci espresso tanto
chiaramente
quanto nella formulazione pi antica, che
I) Sul fatto che l'attivit del
voti?
sia indipendente dalla na
tura sensibile dell' uomo, mentre la virt etica trae la sua ragion
d'essere proprio dalla relazione e dall'antitesi delle esigenze pratiche
della vita alla legge dalla ragione, insiste Aristotele inEth. Nicom.,
K 8, 1178 a 16-22. Da ci deriva che anche il {t-sroprjxixs plog
dispone, a paragone del npaxtix; (ilop, di un' indipendenza rela
tivamente maggiore da ogni xxj cfr. 1178 a 24 segg.
sino alla fine del capitolo.
Quanto
alla compenetrazione del pen
sare e dell'agire etico-pratico per parte della oo-pla e della 8supC
cfr., in ci che segue, le differenze tra le due Etklie.
l'ideale filosofico della tllA 57?
ci sia rimasta, dell'etica aristotelica, e cio nella reda
zione edita da Eudemo, al
punto
della conclusione in
cui detto come ibeni naturali della vita siano per gli
uomini beni morali solo nella misura in cui essi li aiutano
a servire e a conoscere Iddio. La conoscenza di Dio
quindi la via che conduce al vero servizio di Dio, ed
il criterio di misura dei valori terreni, che in tanto sono
tali inquanto sono stati investiti del valore di quello 1).
Ma, ora, bisogna pensare che in questa premessa sia com
preso tutto ilgigantesco sistema del sapereteoretico parti
colare, costruito da Aristotele nel suo edificio scientifico e
culminante nella freoXofw/}, e che quindi esso sia conside
rato come condizione imprescindibile
di una giusta con
dotta morale della vita ? Porrela questione significa com
prendere come questo
caso si avveri, s, in certo senso
per il filosofo, il quale sa connettere in unit, nella sua
complessiva intuizione metafisica, la totalit del sapere,
ma difficilmente possa verificarsi per lo scienziato che in
daga solo nell'mbito di una disciplina speciale e il cui
sguardo non supera quindi unlimitato dominio ; e come,
infine, 1' uomo che agisce moralmente pur restando nel
l'mbito della vita pratica
nonpossa pensarsi dipendente,
nelle sue decisioni, da una condizione simile. Ogni tenta
tivo di delimitare in particolare il dominio della ragion
teoretica sul senso morale, della
ootfitx
sulla cpfvrjccs, in
modo pi esatto di quanto
fosse stato compiuto in quel
passo decisivo dell'Etico Exidemea, doveva necessaria
mente condurre ad attenuare questo
dominio e a raffor-
1) Arist., Eth. End., e 3, 1249 b 16 f,tt ov atpscig xal xxijai;
tfijv
cfosi aYafrffiv
xovtjoEi
fidXicxa
x-qv to 3-soB fkstupiav, ?) oi-
paxoj T| xpijpxiov y[ <pi>.cflv twv
SMujv iyaoiv, cc&tt; iptox'i) xal
oixos
6 6po xiU'.oxos-
7jx(.s rj Si' 4v8svav
%
Si' ESpgoWjv xuAsi
xv O'Ev 8-spaxssiv xal -stupstv, axrj S) <paXi)_:
e cfr. sopra.
p. 326, e tutto ci che precede circa la primitiva
etica aristotelica,
H7,
_
jAxnfcft, ArithUle.
578 APPENDICE
zare la relativa autonomia della morale nei riguardi della
freopta.
Platone aveva collegato il senso morale, la cppvrjccs
di Socrate, con la fi-scopia dell' idea del bene. L' uno e
l'altra si erano fusi insieme sino al
punto cbe il concetto
della ppvrjsis, che secondo il consueto uso linguistico
avevaunsignificato puramente etico-pratico, avevafinito
per comprendere in s costantemente, in Platone, la co
noscenza teoretica dell' idea, e infine era diventato addi
rittura sinonimo di espressioni designanti fin dall'origine
solo un puro conoscere e prive di ogni rapporto ideale
con la sfera pratica, quali ootpfa, vog,
ftse)-
pi e simili.
Questo significato platonico della parola
ppvvjcn; s' incontra ancora nell'Aristotele delle opere gio
vanili, e cos nel Protreptico,dove designa la scienza teo
retica dell'essere, ossia la metafisica, e dove Anassagora e
Parmenide sono citati come tipici rappresentantidi que
sta cppvvjat? *). Anche VElica Eudemea continua spesso
a indicare col termine ippvijatg l'organo spirituale del
jifoj d-eiapijwis e cita Anassagora come primo esempioi
una vita dedita alla pura ippvrjai;, in quanto egli atten
deva soltanto alla considerazione astronomica del cielo 2).
Viceversa, nel sesto libro dell'Etico Nicomachea, che
la redazione pi tarda dell'etica aristotelica, troviamo
questo concetto platonico della cppvrjca? criticamente ri
solto nei suoi elementi originari : 1' uso dell'espressione
vien ristretto all'mbito dell' intelligenza etico
pratica,
ed tolto ad essa ogni contenuto teoretico.
Quale
de
signazione conveniente della conoscenza propria della ra
gion teoretica Aristotele raccomanda qui il termine oo-
1) Sull'evoluzione del concetto di cppivijeis cfr. sopra, p. 106 segg.
2) Cfr. Etk. Eud., A 4, 1215 b 1e
(
;A 5, 1216 a 11 segg. Sul
concetto di (ppvrjaij e sul suo significato nell'tico Eudemea cfr.
sopra, p. 317 segg., e specialmente 321 segg.
l'ideale filosofico della vita 579
cpa, e spiega
come la <ppvv)Ot abbia a che fare solo
con le cose umane, mentre la cccpia si estende anche
alle divine e a tutto il cosmo : e perci, osserva, anche
ilnostro uso linguistico ci porta a chiamare Anassagora,
Talete e simili personaggi ooyol, Pericle e uomini del
suo tipo cppvipoi 2). La oocpa, egli dice, ha per oggetto,
come ogni altra vera scienza, solo l'universale, mentre
la cppvTjots si occupa
anche dell'applicazione delle no
zioni etiche generali al singolo caso pratico 2). La poli
tica, che in Platone era stata, un tempo,
non solo la
scienza dominante, ma addirittura quella che aveva com
preso in s ogni sapere umano, vien perci, insieme con
l'etica ad essa subordinata, abbassata a un grado infe
riore, suo organo essendo la cppvTjocc; tanto nella legi
slazione quanto
in quella che in senso pi stretto si
dice politica. Etica e politica sono tanto lontane dal
coincidere con la scienza suprema quanto
1' uomo dal
l'essere la pi alta realt dell' universo 3). Si avverte
qui,
in modo evidente, la separazione della metafisica
dall'etica compiuta da Aristotele. Essanonimporta, certo,
alcuna svalutazione del fKog ftsuprjuxg, e anzi piut-
!) Elh. IVico.-n..
Z 7, 1141 b 2 lv.
813
x&v elppsvwv tv;Aov et'.
il crocia
iati xal irciaxijjii] xal
vo6
xtv xi|itu>xdx<i)V vg 8i
'AvaSayipav xal Qatojv xal toiii
xoioxouj oocpo? piv qjpovlpoue
8'o5 paaiv stvai,
Stay XSwoiv dDO'lvta? x oopcpipovxa auxots,
xal xepvtx |iv xal Oaopaox xal xa,n xal Saipvia stSsval
aSxog tpa.aiv,
fixP'i0'ca
SA, 6x1 06 x vOpiiuva
fa&
(ijxoSot.
ij i cppvr/Oi?
uspl x vfl-pitiva xal ftepl tbv loxt pou/.eaaoSaL. x&0
tap ypovipou fiioxa
xoOxo Ipyov etvai(papev, x su pooeEoOai.
1140 b 7 8t xoOxo IIspixAa xal xobg
xoioxooe
cfpovlpou; otpeOa
slvai. 8x1 x afjxot{ dLyaM xal x xot{ vt-pwxo'.g Svavxai Oem-
pttv" stvai 8
XO10T0O5 ij-fOiiEila xog olxovoptxoi){
xal xof; itoXi-
xixo;. evidente come qui Aristotele polemizzi contro ci cbe egli
stesso, da un punto di vista ancora affatto platonico, aveva soste
nuto nel Prolreptico e ncll'Eudernca.
2) Eth. Nicom., Z 7, 1141 a 9 segg. e 5, 1140 a 24 segg.
s) Elh.
Nicom., Z 7, 1141 a 21 xoxav ?p sX xi{ xr,v itoAmxv
9j xrjv cppvrjoiv oxoo8atoxxr(v otsxai slvat, e! p
x pioxov xfv v
x$>
xopcp SvOpMxj oxiv.
5S0 APPENDICE
tosto implica un innalzamento del suo livello spirituale :
ma
quanto pi alto il cielo sulla terra, tanto meno
esso la tocca, e perci non facile trovare nell'Etica
Nicomachea in che propriamente ancora consista la di
pendenza interna della virt morale dalla conoscenza
scientifica, quando si prescinda dalla preminenza spiri
tuale del fi-swpTjtixg a paragone del (3cn; Kpav.ziY.6r; 1).
Studiosi moderni hanno compiuto a
questo proposito
acute indagini, ma con risultato negativo :e gi il fatto
che in Aristotele manchi ogni asserzione positiva circa
questo problema un sintomo della debolezza del nesso
che collega la vera e propria dottrina della virt e del
l'ethos con la raffigurazione della beatitudine del
frewpTjitxs, incuitermina e culmina l'intero edificio del
l'Etica 2). Una frase come quella che si legge alla fine
dell'Etica Eudemea, in cui la conoscenza di Dio ele
vata a criterio di scelta di ogni valore morale, non s' in
contra intutta la Nicomaciea 3). assolutamente chiaro,
certo, come la posizione privilegiata della vita specula
tiva resti immutata anche in quest'ultima opera: fin
dalla sua giovinezza, quando egli, ancora scolaro di Pla-
*) Cfr. sopra, p. 322.
a) L. H. G. Greenwood (Aristotle, Nicomachean Ethics, Book Six,
Cambridge 1909, p. 82 segg.) mise giustamente in chiaro, in base
a una sottilissima analisi di tutte le espressioni della Nicomachca
concernenti questo problema, come a tale proposito non ci sia pos
sibile giungere ebe a soluzioni congetturali.
3)
Quando
il Greenwood dice (o. c., p. 82) che Actions are good,
according to Aristotle, inproportion as they lead to the a-etopi)Ttxp
pio? as the end, la sua osservazione quadra col rapporto che in
tercorre tra la virt morale e la 8-siooia ftso solo se si presuppone
il modo incui tale rapporto formulato, nelle sue proposizioni con
clusive, dall'Eudemea. Per la formulazione della Nicomaciea va bene
invece quel che egli dice a p. 83 : Heprobably
followed
to some extent
the feelings
of
the ordinary man inattributing to moral actions an inde
pendent goodness
of
their own and would allow the noXmxg ploj
to possess a certain rationality and value even though it should ignore
or contemn the
S-stopyjrtxds piog altogether.
l'ideale filosofico deli,a vita 5S1
tone, mand per il mondo il suo Protreptico, Aristotele
tenne sempre fermo a questo concetto, su cui s' imper
ni tutta la sua vita di filosofo. Ma l' idea platonica
della dipendenza che legava la dottrina dell'ethos e
della virt alla filosofia teoretica e alla teologia si venne
in lui sempre pi attenuando. L'evoluzione del suo
pensiero si attuava infatti proprio nella direzione op
posta, tendendo a una distinzione sempre pi rigorosa
della sfera pratica da quella teoretica ;e l'opera pi
propriamente originale da lui svolta in
questo campo
era accentrata soprattutto
sul geniale approfondimento
di quella parte dell'etica, alla cui preponderanza que
st' ultima doveva poi il suo stesso nome, cio la teoria
dell'ethos e il sistema delle virt etiche 1). Accanto a
queste
Aristotele ammette,s, anche le Stavorjxtxa psxai',
cio la cultura spirituale e intellettuale dell' uomo, quale
secondo fondamento del valore della personalit
: e nel
sesto libro della Nicomachea offre persino una penetrante
analisi di
queste
facolt e capacit puramente spirituali
dell' uomo 2). Ma tale analisi collegata proprio con
Cfr. sopra, p. 512 c passim.
2) Sembra non si sia ancora avvertito che la distinzione delle
ps-al inTjfi-tv.aC e BiavoijTixat quale appare nell'etica aristotelica
era stata compiuta gi da Platone, e che il suo scolaro si limila
quindi a ripetere ci che gi apparteneva alla tradizione dell'Acca
demia. lo stesso non l'avevo notato, fino al giorno in cui, leggendo
il Cratilo platonico inun'esercitazione di seminario del semestre in
vernale 1926-27, feci la scoperta che le etimologie dei termini tecnici,
seguenti ai $e&v vopaxa e ai concetti fisici (quali jjXtos, otJivjvi] .
Satpa, oTpanrj nOo, 'qp, all+rjp ecc.), sono ordinate secondo un
principio preciso. Anzitutto (Crai., 411Dsegg.) vengono latppvpnp,
la vtjatp, l'imaT'/jiit], la avsaig, la aoyia: poi seguono, dopo
la menzione dell'faS-v, la Sixmo-ivi;
e l'vSpsia. La menzione
della terza fra le virt che vengono per lo pi citate quali esempi
tipici di Spirai etiche. cio della ccoypoavr], inserita dopo
quelle della cppvqaLg e della -ltjai?
quasi in forma di annota
zione marginale: essa infatti interpretata come corniola eppovr)-
ostDg, c quindi tale da poter essere sbrigata cos di passaggio. Icon
cetti del tipo di ypvTjots, oocpia, ovsatg c simili sono
582 APPENDICE
l' indagine che
porta
Aristotele a separare il lato intel
lettuale della personalit da quello specificamente etico,
e, pi che aver lo scopo di preparare positivamente e
di connettere con la dottrina della virt quella teoria
del pio; fi-etoprjTtxo; che s' incontra alla fine della Nico-
machea, accentua il distacco che separa quella parte, ori
ginariamente centrale, dell'etica aristotelica dalla vera e
propria dottrina della virt. Essa viene quindi a con-
Btrett.Tmcnte collegati con quelli di Smaiosuvij, sajtppocvT] e vtpeCa,
rientrando con essi nell'estensione del comune concetto di psivj :
e mentre queste ultime sono le Sperai Sixal nel senso aristotelico
della denominazione, leprime corrispondono esattamente alle Stavo?]-
Ttxal perat del sesto libro della Nicomachea. Da ci consegue che
gi Platone scisse ilconcetto della virt nei due elementi fronetco
ed etico, e determin, col suo metodo della divisione logica, le
diverse specie della virt della tppvrjots e di quelle dell' 8-05. Ci
di grave momento per l'interpretazione slorica dell'evoluzione del
l'etica aristotelica, che anche altrimenti opera, ad ogni passo, con
teorie e concetti di stabile tradizione accademica. Caratteristico
d'altronde il fatto che Platone non considerasse ancora la ypvijoij,
come poi faceva invece Aristotele nel lihro Z della Nicomachea,
quale
semplice sottospecie dcll'psT?] dianoetica, ma bens quale concetto
generale di tutta questa classe di virt. Ci risulta dal passo del
Filebo (19 A) in cui detto che si deve concepire la cppvrjctj (e ia
t]8ovt}) non soltanto come Iv ma anche come rcoXX nei suoi diversi
stSv), e si vede inci la grande conquista del metodo, primadescritto,
della SiaEpecic. E poco dopo (19 D) vengono enumerate le stesse
sottospecie della vppvvjotj che compaiono in Cratyl., 411D segg. c
nel libro Z delia Nicomachea. Ci quadra esattamente con la termino
logia e coi modo di vedere propri delle opere giovanili di Aristotele,
il Protreptico e l'EticaEudemea (cfr. su ci sopra, pp. 106 segg., 231 s.).
Contro tutta questa terminologia platonica e protoaristotelica e con
tro la delimitazione della 9pvr(oi{ tra le 8tavov)tixa! psxat po
lemizza poi lo stesso Aristotele nel sesto libro della Nicomachea. La
tendenza odierna ad assegnare il Cratilo a un'et relativamente an
tica mi sembra del resto poco conciliabile conlasua molto specificata
teoria della virt. Questo non tuttavia che uno solo tra imolti in
dizi che sarebbero da prendere inesame a questo proposito :n qui
illuogo, naturalmente, di accingersi a tale impresa. Unnuovo stu
dio radicale di quel difficile dialogo dal punto di vista di quanto oggi
sappiamo di Platone risponde a un bisogno urgente : e vi chi si
gi accinto a soddisfarlo [v. Ora M. Warburg, Zwei Fragen gum
Kratylos , nelle Neuc Philolcgiscke Untersuchungen edite da
W. Jaeger, vol. V, Berlino,
1929J.
1,'ideale filosofico della vita 583
fermare in modo decisivo la nostra dimostrazione
de]
fatto che il nesso collegante il
ffos
{tetopTjTixj col nu
cleo dell'etica aristotelica si venne sempre piallentando.
Questa
ricostruzione della linea di sviluppo dell'etica
aristotelica d'altronde convalidata dalla storia ulteriore
che il problema ebbe in seno alla scuola peripatetica.
Purtroppo gli scritti etici dei principali scolari di Ari
stotele sono andati perduti, e per noi la fonte piimpor
tante la cosiddetta Grande etica ('H?kx p-eyaXa, Ma
gna moralia) tramandata sotto il nome di Aristotele :
essa infatti l'unica opera di morale di
questa
et che
ci sia pervenuta
in forma quasi completa, ed stata
composta
da un peripatetico vissuto non prima dello
scolarcato di Teofrasto 1). La maniera in cui l'autore ri-
i) Tale l'opinione corrente fin da quando Io Spengel pubblic
negli Atti dell'Accademia di Monaco il suo famoso studio sulle tre
Etiche. Recentemente, dopo che dal Kapp e da me stata dimostrata
l'autenticit dell'Eudemea, Hans von Arnim ha sostenuto, intutta
una serie di scritti, che autentica anche lacosiddetta Grande Elica
(la quale invece, com' noto, la pipiccola delle tre), vedendo anzi
in essa la pi antica ed originaria tra te redazioni dell'etica aristo
telica. Ma la sua dimostrazione non affatto persuasiva : e io debbo
pienamente aderire alla confutazione critica che ne hanno compiuta
due esperti conoscitori dell'etica aristotelica quali il prof. E, Kapp
(nei suoi due scritti inGnomon, 1927) e ilprof. J. L. Stocks di Man
chester (Bruiscile Literaturzeitung, 1927). Del resto non la prima
volta che conoscitori anche dottissimi di antichi maestri scambiano
la copia conl'originale. L'unico fautore dell'Arnim il(quale attribuir
molta importanza alla cosa) lo Schleiermacher, nel discorso da lui
tenuto all'Accademia di Berlino. Ecerto egli era persona di spiritua
litelevata e di sensibilit fine :ma noto che il suo contributo alla
conoscenza di Platone frutto di congenialit filosofica ed artistica
e non certo di senso storico, giacch la sua autorit serv anzi a ritar
dare di decenni quella nozione storica dell'evoluzione del pensiero
platonico per cui egli, lo scolaro dei razionalisti di Halle, non aveva
ancora la minima sensibilit. Lo stesso spirito egli dimostr di fronte
alla Grande elica,che stranamente ritenne lasola non spuria, negando
con ci autenticit alle altre due trattazioni, che erano invece le sole
a possederla. Solo la Grande elica rispondeva, infatti, all' ideale di
una scienza etica valido per la sua mentalit di kantiano : non fa
ceva (a suo modo di vedere) dipendere la morale dalla ragion teore
tica, come accadeva invece nei dne altri trattati, e lasciava da parte
5S4 APPENDICE
produce iconcetti dell'etica aristotelica, abbreviandoli e
chiarendoli e ricollegandosi per lo pi strettamente al-
YEudemea e in seconda linea anche alla Nicomachea,
coincide pienamente coi metodi di tradizione didattica
consueti nelle scuole filosofiche ellenistiche, chiuse cia
scuna in s stessa, anche per quel che concerne la carat
teristica mescolanza di ossequio e d libert nei riguardi
della dottrina del fondatore. Non c' dubbio che il
il pio; (HwpYjtiy.;. Ma proprio questo l'indizio fondamentale della
sua non autenticit. Oggi che vediamo chiara, nelle singole tappe.
lalinea evolutiva che da Platone porta ad Aristotele e ai suoi scolari.
e comprendiamo la rigorosa necessit interiore di tale processo spi
rituale, non dovrebbe esser difficile scorgere come ifl Grande etica
possa e debba trovar posto solo dopo la Nicumachea. Vero che
l'Arnim(come gi rilevava con ragione io Stocks, 1. c.) nonha affatto
acceduto al nuovo metodo d' indagine, basato sulla comparazione
dei testi dal punto di vista dello sviluppo dei problemi. Per la que
stione che qui c' interessa, quel che occorre c applicare tale metodo
anche alla Grande etica :e ci pu tenere illuogo di ogni ulteriore con
futazione degli argomenti dell'Arnim, icui procedimenti critici on
deggiano tra l'estremo della severit e l'estremo dell'indulgenza.
Per tutta la Grande dica questo metodo d' indagine sar seguito dal
mio scolaro Richard Walzer nel suo prossimo libro sull'argomento
(frattanto uscito col titolo Magna Moralia und arislolelische Elb.Ui,
in JYeuc philnhgische Untersuchungen edite da W. Jaeger, voi. VIE,
Berlino, 1929], con cui devo naturalmente venire a contatto per il
singolo punto qui preso in esame. Che la Grande etica contenga in
se stessa idati per la sua collocazione cronologica, inquanto adopera
erane esempio scolastico il nome di Ncleo, scolaro prediletto di Teofra-
sto ed erede della sua biblioteca, nella stessa maniera incui Aristo
tele si era valso allo stesso fine, nei suoi scritti, del nome del padre
di Ncleo, cio del suo condiscepolo ed amico Corisco, cosa sfuggita
all'Arnim, e avvertita per la prima volta 30I0 dal Wilamowilz (Her
mes, 1927), che a buon diritto ne infer non potersi ascrivere la
Grande elica a un'et anteriore a quella di Teofrasto. L'obiezione,
avanzata dall'Arnia! (Hermes, 1928), che Neleo ascolt anche Ari
stotele (vecchio, per !) c non entr nella scuola solo quando gi la
dirigeva Teofrasto, trascura la difficolt fondamentale : la consue
tudine aristotelica di citar come esempio Corisco risale eridentemente
(come ho dimostrato in Entstehungsgesehichle der Metaphysik, p. 31
e a p. 344 del presente volume) al tempo incui Corisco frequentava
ancora personalmente le lezioni, e ci accadde ad Asso e a Scepsi
subito dopo la morte di Platone, dove egli (secondo Plat., ep. VI)
era tornato gi parecchio tempo prima. Specialmente le allusioni
scherzoso dell'Eudemia a Corisco danno l' impressione dello pi viva
l'ideale filosofico della vita 585
metodo dei commentatori peripatetici dell'et pi tarda
risalga in ultima analisi alla tradizione didattica della
scuola, lecui forme si vennero costituendo fin dalle prime
generazioni
successive ad Aristotele. L'esempio del fram
mento metafisico di Teofrasto o quello della Fisica di
Eudemo permettono
ancora oggi di constatare chiara
mente simile stato di cose : e di recente ci divenuto
possibile
anche per un'et tanto oscura della scuola pe-
attualit e presuppongono
negli ascoltatori una conoscenza diretta
delia sua persona. Che Aristotele in un ancor precedente corso di
morale (che secondo l'Arnim sarebbe appunto la Grande elica) abbia
citato il figlio di Corisco, e solo pi tardi abbia adottato il nome di
Corisco stesso, suo vecchio amico di giovent, come soggetto costante
di esemplificazione, cosa che contraddice alla logica e alla cronolo
gia. La menzione isolata di Neleo bens spiegabile solo quando si
presupponga che l'uso esemplificativo del nome di suo padre Corisco
fosse stato, inaltri tempi, corrente nella scuola di Aristotele :e ci
importa che tale menzione pu esser stata compiuta solo ncll et
postaristotelica.
Che la Grande etica appartenga a questo periodo
inoltre provato da parecchi termini tecnici ignoti ad Aristotele, e
adottati per primo da Teofrasto (v. perci il libro del Walzer).
Come esempio parallelo si possono ricordare, a questo proposito,
ilibri spuri della Storia degli animali, che furono composti in et
postaristotelica
e la cui provenienza insingoli casi piesattamente
determinabile solo con l'ausilio di simili analisi terminologiche. E
anche quando si voglia prescindere da tutte queste prove, la pater
nit non aristotelica della Grande etica risulta anzitutto dimostrata,
ad ogni passo, dalla sua lingua. Naturalmente, come ogni altra prosa
peripatetica, essa manifesta 1* influsso dello stile aristotelico : ma
una gran quantit d' indizi tradisce la sua natura seriore, ellenistica.
[Nella redazione originale seguiva, a questo punto, un elenco di tali
indizi di lingua e di stile. Inquesta traduzione esso pu esser sosti
tuito da un rinvio al lavoro di Karl Oscar Brink, Siri und Form der
pseudaristotelischen Magna Moralia (dissertazione presentata a Ber
lino nel 1931 e pubblicata a Ohlau nel 1933). Le mie annotazioni,
pi che altro provvisorie e messe insieme a caso, Bono infatti ormai
superate, o invia di correzione o in via di approfondimento,
dalia
sua analisi, che si basa su estese indagini comparative condotte
sulla Grande etica e sui trattati aristotelici non solo dal punto di vista
della lingua e dello stile, ma anche da quello della forma del pen
siero scientifico. Lo studio del Brink rien cos pure a costituire una
necessaria ed efficace integrazione del libro del Walzer, icui esami
comparativi concernono soprattutto il contenuto teorico delle tre
opere di etica, N. d. Ai),
586
APPENDICE
I
I
ripatetica qual' l'ultima met del
secondo secolo
dopo
Cristo, essendosi conservati, attraverso gli estratti che ne
fece lo
Pseudo-Ocello, brani di un corso peripatetico
di
questo periodo, il quale in sostanza ima ripetizione
parafrasata dello scritto
aristotelico IIspl Yevsaecoj xal
tpfropg l). Al
contributo personale cbe egli reca nel
modo d' intendere
l'ormai stabile eredit dottrinale della
scuola l'autore della Grande erica d spesso la forma di
aporie : egli segue cio il metodo cbe gi aveva adot
tato Aristotele nei
riguardi della tradizione
didattica
dell'Accademia, spesso da lui
semplicemente seguita
nelle lezioni 2). Ma anche con le sue omissioni o accen
tuazioni l'autore della Grande etica manifesta spesso la
sua posizione personale rispetto ai problemi presi in
esame, per quanto, certo, egli sovente non intenda pi
) Iframmenti della Fisica di Eudemo sono raccolti nella silloge
complessiva dei suoi frammenti curata da Leonhard Spengel
D
frammento metafisico di Teofrasto stato ultimamente edito dal-
1Lsener. Sui fatto che lo Pseudo-Ocello si sia valso di esegesi peripa
tetiche dello scritto aristotelico De generatione et corruption compo
ste in et anteriore a Andronico cfr. R. Harder, Ocellus Lucanus,
(Neuc
PfcMeg- Vntersuchungen, I, Berlino,
pp. 97113.
!) Di ci basti qui un solo esempio. InEth. Nicom., Z 1, 1138b
20-34 Aristotele dice che ilgiusto
mezzo, di cui aveva parlato a
proposito della determinazione dell'essenza propria della virt etica,
e <Ii
S 6 X6fO{ iipS-ds Uyei, ma che questa
determinazione non
abbastanza chiara e ha bisogno di essere ulteriormente precisata.
InB 2, 1103 b 21 osserva ehe la definizione della gi; moralmente
buona come xaz zv p8-v
Xfoi
universalmente accettata (xsi-
vv) e pu esser senz'altro presupposta, ina deve in seguito
rice
vere una
determinazione pi precisa. Infine in Z 13, 1144 b 21
.
clle ora tutti, definendo I'apetfy aggiungevano la formula
xavee tov pS-v Xyoi : il che naturalmente si riferisce ai suoi sco
lari, spesso divergenti nella soluzione di tali problemi. H compito
ideale, e ormai insolubile nel particolare, dell' indagine storica
quello di scindere nettamente, in ogni concetto e dottrina di Aristo
tele, 1originano contenuto accademico e la modificazione che egli
vi apport. Analoga la situazione della Grande etica rispetto
ad
Aristotele : solo che in
questo caso sono
superstiti entrambi idocu
menti originali.
i,'ideale filosofico della vita 587
il senso che in origine essi avevano avuto per Aristo
tele. Ci accade soprattutto
in occasione delle caratte
ristiche difficolt cbe si presentano
ad Aristotele inforza
del continuo suo riferimento polemico
a Platone, spon
taneamente determinato dall'evoluzione
del suo pensiero.
Proprio la fondazione dell'etica
sul
fifos
&topy)Ttns era
una di tali eredit platoniche,
cbe procuravano difficolt
non piccole
all'autore della Grande etica.
Purtroppo
manca la fine di quest'opera,
la quale
s' interrompe a met di quella
trattazione della
tftXlce
a cui, com'
noto, segue nella Nicomachea, quale suo
libro decimo, la trattazione
del piacere (compiuta, cosi,
per
la seconda
volta) e la dottrina del (3o? frecopYjxixc.
Non si pu affermare cbe anche la Grande etica finisse
allo stesso modo : e certo non conclusione cbe possa
considerarsi
necessaria, dato anebe cbe proprio
nella
struttura tale opera
si ricollega piuttosto
al'Eudemea,
della quale riproduce
anche la conclusione. Quest'ultima,
costituita dai capitoli sulla relazione dell' s&Saipovfa
con
l'eutocia
e sulla vera xxXoxyaiHct, corrisponde in
certo modo alla dottrina dell'eudemonia svolta alla fine
della Nicomachea
, ma ci nonostante tipicamente
di
versa da essa. Per ci stesso inverosimile cbe la Grande
etica, la
quale
desume questa
conclusione
dil'Eudemea
(pur cambiandole posto e inserendola prima
della trat
tazione della <ptXa), avesse in origine riprodotto
anche
la conclusione della Nicomachea 1), cio la raffigurazione
i) Icapitoli ottavo (itepl sifrox!as) e not> (itepl a58a'.|iovtac;)
del libro B della Grande etica sono aggiunti in appendice alla teoria
della 8o>y| e della sua importanza per l'eudemonia (B 7) ; e corri
spondenti esattamente ai capitoli secondo e terzo del libro 8 del-
VEndcmea. La corrispondenza di questi due capitoli all'ultimo libro
della Nicomachea vien poi resa anche pi evidente se, come nella
Grande etica, si fanno seguite al capitolo sulla VjSov7) :infatti la trat
tazione della 8ovr) apre anche illibro decimo della Nicomachea. Dal-
5S8 APPENDICE
del
pio? IktDpvjTixg. Ci sarebbe anche in disaccordo
col fatto che il suo
atteggiamento di fronte alla &eupla
e alle Scavorjitxal pstal altrimenti piuttosto
negativo.
Riproducendo la conclusione dell'-Endewtea, cio
la dot
trina dell'exuxi caratteristico come
l'autore della
Grande etica accentui il momento metafisico, la fraia
sTU)da! tanto essenziale per ilpunto di vista
dell'Eudc-
mea, che si ricollega al platonismo tardo *). Parimenti,
nella trattazione della
xaXoxccfalh'a, che pure desunta
dalla conclusione del'Eudcmeo, egli omette il
riferimento
alla ffecopla 8-eo e al |31og S-ecopYjTix?. E
tralascia anche
quello che formava ilpunto di partenza dell'EWemea, cio
la questione dell'eudemonia e della scelta del plog, in cui
tra le forme eleggibili di vita
annoverato e definito
anche il |3fog ffswprj-uy.g, ed con ci orientata fin dal
l'inzio in tal senso la soluzione del problema stesso
dell'eudemonia. Dopo quel che abbiamo
potuto accer
tare circa il progressivo rilassamento dei
legami che
nella Ncomaehea stringevano il piog eiopTjxtxg alla
parte centrale
dell'etica non pu meravigliarci il fatto
che
questo processo evolutivo, di cui possiamo seguire
isuccessivi momenti inPlatone,nel Protreptico del gio
vane Aristotele, nell'Eudemea e nella
Nicomachea, ci si
manifesti nella Grande etica nel suo stadio pi avanzato.
il
processo di crescente eliminazione
dell'elemento me
tafisico-intellettualistico (cio, storicamente parlando,
platonico) dal seno dell'etica aristotelica.
Personalmente
troude non necessario supporre ohe un. tempo seguisse, nell'Eucfe-
mea, una speciale trattazione del fie; Oewpijtixof;, il quale costi
tuiva per essa un principio indiscusso. Nella Granile etica, trasferita
tutta questa parte B 79 dalla conclusione finale alle soglie della
trattazione delle virt dianoetiche, essa resta sostanzialmente esclusa.
La dottrinadella Ssia 1V/rj, propriadel vecchio Platone, ha
urgente bisogno di esser fatta oggetto di uno studio a s, senza il
quale non k dato inserirla al punto giusto della storia che il pro
blema della Tt] ha avuto nel mondo ellenico.
L'IDEALE FILOSOFICO DELLA VITA 5S9
Aristotele
non giunse mai a disfarsi del tutto di questa
eredit platonica, che aveva avuto influenza tanto de
cisiva nella formazione del suo spirito d' indagine e del
suo ideale di scienza. Ma gli scolari furono in parte
pi
aristotelici di Aristotele : cos il distacco da Platone si
manifesta nettissimo nella posizione
teorica della Grande
etica, dalla prima all'ultima pagina dell'opera.
Con ci
connesso il fatto che l'affrancamento dell'etica dalla
teoria delle idee, a cui dovevano ancora dedicare tanto
spazio
e fatica le due Etiche di Aristotele, presupposta
dalla Grande etica come dato indiscusso, fin dall'inizio
della breve rassegna storica con cui essa apre la tratta
zione. Inessa si rinfaccia a Pitagora e a Platone di non
aver saputo mantener l'etica indipendente da specula
zioni metafisiche : si accusa il primo di aver mischiato
il problema
della virt con la metafisica dei numeri e il
secondo di averlo confuso con la teoria delle idee e con
l'ontologia, e si loda Socrate per essersi tenuto lontano
da tale errore x).
L'assoluta
evidenza e naturalezza che per l'autore
della
Grande etica, come appare
fin dalle prime righe
dell'opera, propria
della tesi secondo cui l'etica va se
parata
dalla metafisica deve naturalmente manifestarsi
soprattutto
nella trattazione delle cosiddette virt dia
noetiche
e nella questione
del rapporto della
croata
con
la cppvqaig. Se nel primo Aristotele (Protreptico, Eude-
meo)
la
wfla
e la cppvrai; non erano ancora rigoro
samente distinte, perch
la discriminazione morale si
basava, affatto platonicamente,
sulla conoscenza del som
mo bene e quest'ultima
determinava
in modo diretto
e decisivo
l'azione morale, nel sesto libro della Nicoma
chea era invece segnata tra esse, come si mostrato,
) Afagn. Mor., A 1, 1182 a 10-30.
590 APrENEICE
unft
precisa distinzione. La Grande etica fa ancora un
passo avanti nella stessa direzione. Essa invero non si
pone affatto da un
punto di vista che diverga radical
mente da
quello
della scuola, e anche in
questo punto
riferisce in modo esteriormente fedele la ormai tradizio
nale impostazione aristotelica del problema ;ma ci no
nostante chiaro come essa proceda oltre i termini
raggiunti dalla Nicomachea. In quest'ultima presup
posta fin dall' inizio, e mantiene sempre il suo vigore,
la piena equiparazione delle SiavoTjxixai ipexal alle
ohxal pxeci: equiparazione che rende perci neces
saria una minuta giustificazione del fatto che esse ven
gano esplicitamente distinte. L'accuratezza con cui la
cppivrjac?, quale ragione specificamente morale e pra
tica, vi distinta dalla oocpCct puramente teoretica, quale
conoscenza dei principi pi alti e universali, si spiega col
fatto che questa divisione di domini non era affatto
per Aristotele, la cui eredit platonica si faceva in tal
modo Bentire ancora nell'ultimo periodo della sua evo
luzione mentale, una cosa che fosse ormai evidente di
per s. Tale distinzione doveva appunto esser compiuta
da lui, e l'indagine particolare che occorreva affinch
le ScavoTjtixa psxat e la oocpfsc fossero
separate dalla
dottrina dall'eiftos veniva indirettamente a fornire ad
esse stesse un nuovo titolo per essere comprese nella
trattazione dell'etica. Per Aristotele, in forza del pro
cesso evolutivo che aveva
percorso il suo pensiero, tale
loro posizione intermedia aveva una certa giustificazione
interiore. All'autore della Grande etica, nonostante la sua
fedelt alla tradizione, essa riesce invece sostanzialmente
inconcepibile e incomoda.
Quando
egli, nell' indagine
circa la eppvtjai? (A 34), che corrisponde al sesto libro
della Nicomachea, distingue a priori la
parte razionale
dell'anima (Xoytxv) nelle facolt della deliberazione pra-
l'idfale filosofico della vita 591
tica e della conoscenza scientifica (jJouXeutixv e Ttwnj-
(iovtxov) presuppone
come gi stabile e consolidata
la distinzione
della cppvtjat?
:dalla aotpta, che il corri
spondente capitolo
della Nicomachea considera invece
come un punto
d'arrivo, a cui riesce a giungere.
Inci
l'autore della Grande etica segue, come dimostrano gli
estratti dalla letteratura di argomento morale della
scuola peripatetica che si conservano in Stofeeo (H117,
14 W.), un peripatetico pi antico, che sosteneva la me
desima partizione.
Dallarigorosa distinzione della cppvtj-
oi?
dalla oocp
{
egli trae conseguenze assai pi estese
di quelle
arist oteliche : essa importa infatti per lui ad
dirittura
l'emancipazione della prima dalla seconda.
Tuttavia egli no n fa, in certo senso,
che procedere con
seguentemente
nella direzione presa da Aristotele quando
manifesta la sua sorpresa circa il motivo per cui non sia
stata totalmente esclusa dall'etica quella GG<p(o: che pur
si separata,
come conoscenza puramente
teoretica, dalla
tppvrjaig: inop-fjotts S'ctv
ti?
xal ftau paeie, St ti
7rp Tj&tv J.yovue?
TtoXitix)?
tivo?
Jtpaypatea?
rcp eoep(a? Xyopev J). Cosi parla
un uomo che si
trova di fronte a una tradizione gi divenuta stabile, e
che esteriormente
si sottomette ad essa per quanto
di
fatto non la capisca pi. Non si tratta qui,
davvero, di
quella meraviglia
filosofica, che per Platone il principio
d'ogni sapienza : si tratta di una stupefazione
scolastica
di fronte
a singolarit,
ormai non pi comprese, della
tradizione.
Il problema
della aotpLa ha perduto per
l'autore l'attualit che aveva avuta per il platonico Ari
stotele :per spiegare
il motivo della sua trattazione egli
perci
costretto ad escogitare ogni sorta di sottigliezze
scolastiche.
Si consola col pensiero che sia bene un segno
1) Man. Mar., A 34, 1197 b 28-30.
592
APPENDICE
di lungiujirinte
intelligenza filosofica il prendere in
esame anche tali
questioni collaterali, non riferentisi
a
rigore all'argomento : d'altra parte, pensa, l'etica
si
occupa pure dell'anima, e all'anima
appartiene anche
la scienza
teoretica, e via di seguito con simili chiac
chiere x).
Nell'epoca in cui nacque la Grande etica fu persino
prospettata, e da
qualcuno anche difesa, nel Peripato,
la tesi del primato della ragion pratica a paragone della
teoretica. Anche la Grande etica pone, alla fine del primo
libro, la questione se la
cppv-qais non sia nell'anima
la vera energia dominante,
(Sai
itp Saxsi xal ccTcopelTat.
Che con queste parole si alluda a un reale oppositore
della concezione aristotelica, e non soltanto a una diffi
colt escogitata per la discussione, dimostrato anche
dal
tprjat, con cui citato un
argomento del difensore
di
questa tesi. Certo, la Grande etica non si allontana
tanto da Aristotele da subordinare la aoybx alla 'fpvijccg
e da espellere del
tutto la prima dal dominio dell'etica.
caratteristicoper la posizione indecisadell'autore,rima
sto fermo a mezza strada, ilfatto che egli non
tragga tale
conseguenza, a cui tende effettivamente il suo pensiero,
ma si tenga stretto alla tradizione scolastica, pur non
potendola ormai professare senza restrizioni. Per difen
dere l'opinione ortodossa della scuola peripatetica contro
l'audacia eretica della tesi propugnante il primato della
ragion pratica egli ricorre a un'
immagine, e paragona
la cppvijatg alla funzione subordinata dell'amministra
tore, mentre la aocpfa corrisponde, nell'economia spiri
tuale dell'anima, al padron di
casa2). Quanto, anche
') Magn. Mor., A 34, 1197
1)
30-35.
a) Magn. Mor., A 34, 1198 b 9 segg. : per il tpvjai v. 1198 b 11.
A prima vista si potrebbe
pensare che l'aporia non significasse se
non quello che detto in Eth. Nicom., Z 7, 1141 a 21 : fitoirov
L'IDEALE FILOSOFICO
DELLA VITA
593
nella Grande
etica, il Xfo; perda
in realt d' interesse
e
d' importanza
in confronto
dell'ethos e degli affetti
dimostrato
da una frase come quella che segue,
in cui
l'autore riassume conclusivamente U suo modo
di ve
dere: 'o%,
&o7tsp oloreat ci tfj( ciperi)?
ipyj)
xal laxi Xyo?, dXi [tlJ.ov l icccS-t)
a)
Glialtri, contro cui egli si rivolge, sono naturalmente
in prima
linea icreatori dell'etica greca, Socrate e Pla-
fp et ttj ti)v Tco?.ixv/.r)v ij trjv
tppvrjoiv aJtouSaioxrijv cUtai
elvai, et ri ipiaxov vv 8v Tip xsp<p v9-p<eic ionv. Ma
qui espresso soltanto il rifiuto del concetto socratico plato
nico della tppvijoi? nella sua ambiguit di signiBcato. Riferendosi
il termine q?pvjjotj originariamente solo a t vSpcinctva, Aristo
tele non poteva
accoglierlo come designazione della suprema facolt
spirituale anche nel senso pi lato che gli aveva attribuito il vec
chio Platone, il quale comprendeva in esso anche laoocpta ; e do
veva bens rimettere inonore, quale forma somma della conoscenza
razionale, la cocpta, avendo essa ad oggetto t 3-sCa. Viceversa la
elevazione della cppivrjotj a istanza suprema, contro cui si volge la
Grande etica (A 34, 1198 b 9), rappresenta a sua volta un ritorno
polemico contro questa supremazia aristotelica della
aofla.
Che qui
non si alluda al concetto platonico
della qptfvpotg risalta gi dal
fatto che di Platone non si sarebbe mai potato dire che egli si fosse
opposto al principato della ooylu. e avesse attribuito invece che
ad essa alla tppvt]atj il supremo dominio dell'anima. A Platone
ri addice invece benissimo quei che la IVicomachea osserva nel luogo
citato : egli ritenne onooSaiotdt; la itohtttxyj, e rispettivamente la
<ppsi]9i, perch, pur non considerando (per riferire l'espressione
ivi nsata da Aristotele) 1' uomo come la realt che nel monda
avesse il massimo
valore, concepiva tuttavia come supremo ver
tice tanto del mondo umano quanto del cosmo qaella tsa to5
<"r&o3
che era insieme oggetto e della poltica e della (ppdvtjctj.
Tra quest' ultima e la ooepta, la lotta per il primato poteva nascere
solo quando esse fossero state, de Aristotele, nuovamente divise
l'una
dall'altra, e coltica e metafisica avessero cessato di esser
quell' unica realt che costituivano in Platone. Mentre Aristotele
si decide per la croquet, inquanto ilsuo oggetto sta pi inalto nella
gerarchia cosmica, il suo oppositore, contro cui poi polemizza la
Grande elica, prende posizione per la cpevt|<ji?, in quanto
essa Srtt-
pEXetxov
jcvtcov, cio ha il comando supremo nel campo pratico,
mentre la ooepta vuol restar tranquilla nel sno studio, il pi pos
sibile libera da noie. Ma in questo appunto sta, per l'autore della
Grande etica, il segno della maggior nobilt: egli vede quindi nella
cpQcvqcrt? solo l'amministratrice, non la signora dell'anima.
i) Afagn. Afor., B 7, 1206 b 17.
88.
V.'. jAtosa, AHptcltle.
594 PTENDICE
tone : ma anche Aristotele, in (juanto platonico, rientra
qui nel novero, risultando anch'egli colpito dal biasimo,
mosso dalla Grande etica, di aver attribuito all' intel
letto grande importanza per l'educazione morale. Dare
ai TtdS'Y) il posto che ad essi
compete nei confronti del
Xyoq non significa altro che assegnare all'etica il com
pito di occuparsi anzitutto dell'ethos, tanto dal
punto
di vista teoretico quanto da quello pratico. Iltono deciso
con cui l'autore insiste fin dalle prime righe su que
sta tesi contro Aristotele concorda con la sua restri
zione sistematica del regno del Xyo; e del Xoytxv
[ipos Tfjs *) Anche il principale argomento di
cui si vale la Nicomachea per dimostrare la preminenza
della ooyla e del j3(o? tktDpTjuxg a petto della vita
dedita all'attivit pratica, e cio l'illazione dall'attivit
x) La Grande etica (A 1, 1181 a 1) comincia col definire il pro
prio nome, dicendo come esso derivi da ethos,e come quindi la sua
stessa natura di scienza sia da intendere in funzione di tale con
cetto. Ora questo valersi del nome di etica come di quello di
una disciplina gi rigidamente definita nei suoi confini, e per di
pi il valersene subito nell'enunciazione iniziale del toma d' inda
gine, non conviene tanto alla maniera di Aristotele quanto a quella
dei commentatori d'et pi tarda, soliti anch'essi a prmdere le
mosse da una delucidazione circa il nome della disciplina trattata
volta per volta, secondo quanto corrisponde, del resto, alla stereo
tipa consuetudine scolastica. Certo, quel che l'autore della Grande
etica chiama con quest' ultimo nome era gi stato designato occa
sionalmente da Aristotele, quando egli aveva voluto distinguerlo
da altri campi d'indagine scientifica, col nome di ij&ixol Xyot; e
cos Aristotele aveva, riferendosi a tutto il complesso degli scritti
relativi a tale argomento, parlato gi senz'altro di ijJHx come di
TtoXmxd, tbaXuux ecc. Ma singolare che nelTEudcmea e nella
ZVicomachea, ben lungi dal delimitare il contenuto della scienza
etica comprendendone il concetto nel nome di f]fkxct, egli eviti
sempre di adoperare tale parola. Essa piuttosto
ima
semplice
designazione collettiva di un complesso di scritti, che trattano fra
l'altro anche dell'elle; e dell'ijAtx ipezs), ma non si limitano sol
tanto a tali argomenti. La Grande etica, invece, caratterizzata
proprio dal fatto che trova riflessa nella designazione di i){kxfi l'es
senza medesima della disciplina designata, che per essa infatti
scienza dell'froj: ed perci che questa spiegazione del termine
costituisce addirittura l' inizio dell'opera.
l'ideale filosofico della vita 595
pensante
dello spirito divino alla pi alta e preziosa
forma di esistenza umana, lasciato cadere dalla Grande
etica. G quadra gi con l' intento di tener lontano ogni
elemento metafisico ;ma evidentemente anche unmodo
di schivare l'obiezione che l'attivit del Dio aristotelico,
contemplatore soltanto di s stesso, non era affatto la
suprema pensabile, cos come una simile contemplazione
di s medesimo non sarebbe stata per l'uomo la condi
zione pi perfetta ed eccelsa. Che l'autore della Grande
etica non prenda alla leggera questa
obiezione dimo
strato dal fatto che egli stesso cambia posto a quell'ar
gomento,
trasferendolo al problema
dell'autarchia del-
l'sSapitv,
e anche col mette in guardia contro l'affret
tata illazione analogica dall'autarchia di Dio a ci che
merita di essere fatto oggetto
delle aspirazioni
dei mor
tali J).
Ma
questa
la domanda che ora dobbiamo porci
se l'autore della Grande etica limitava in modo cosi de-
!) Eth. Nic., K 8, 1178b 7-23. La comune opinione degli uomini
attribuisce a Dio lapiperfetta beatitudine : ma non concepibile
che la sua attivit si esplichi nell'azione, cio inuna qualsiasi forma
di azione morale, tale che egli vi si manifesti dotato della virt
del coraggio o della liberalit o della giustizia e dell'assennatezza.
Tutto ci infatti assolutamente indegno di Dio. Ma una vita
a cui venga in tal senso negata l'attivit pratica non resta altro
contenuto che il puro pensiero : l'opera e la beatitudine di Dio
quindi da concepire come stuprix] Svipysia, ed anebe per
l'uomo la pi beata forma di vita quella maggiormente affine
a questo divino modo di essere (cfr. Metaph., A 7, 1072 b 25). In
B 15, 1212 b 37, la Grande etica esamina le ragioni di un opposi
tore di tale argomento. Apparentemente essa non prende posizione
rispetto alla tesi obiettata dall'oppositore, in quanto essa concerne
l'attivit di Dio (cfr. 1213 a 7 ti psv ov 6
9-ss
Ososxai, Saio&co) ;
ma che il suo autore l'approvi per quel che riguarda l' illazione
da Dio all'uomo, risulta dal passo 1212 b 33 : |iv ov i tot;
Xofois
eluj-ota
jioitijs Xap|3ves-&m Ix toO -&eoS oSt' xst p&fi;
o&t' v vTaDft-a elrj XP'joipos. Egli respinge con ci la teoria de-
l'autpxsta dell'sOSatp-'uv, ma insieme anche la parificazione della
beatitudine umana alla fruizione temporanea di quell'attivit di
pensiero, di cui Dio gode eternamente.
596 APPENDICE
ciso ed esclusivo all'ambito dell'ethos il campo d'azione
dell'psxrj umana, poteva egli ancora parlare, in gene
rale, di una ScavorjxiXT] pex-q che stesse accanto alla
psxrj, onon doveva piuttosto ilconcetto di dpev
assumere per lui quel significato della nostra virt o
moralit, che in origine era estraneo allo spirito greco ?
Dovremmo aspettarcelo, ma in realt troviamo anche
qui, come a proposito della posizione della ootpta, piut
tosto un' incertezza e un'oscillazione
nell'atteggiamento
dell'autore che una decisa intenzione di andare in fondo
al problema, ed anzi possiamo constatare come
proprio
in questo punto le sue espressioni divengano addirittura
contraddittorie. La tradizione dell'etica aristotelica gl'in-
segnava che quale nota del concetto dell'psxrj doveva
essere considerato ilfatto che un'azione o una fosse
lodata. Ora, nel
punto in cui l'autore compie per la
prima volta la
bipartizione dell'anima in Xoyixv
|ipoj
e SXoyov pipo?, e vi ricollegala distinzione delle Y)(hxa
&pvc (p. es. valore, dominio di s) dalle
Siavorjxixxl
dpexa (senno, saggezza, memoria ecc.), egli mette decisa
mente da
parte, giusta la sua sopravalutazione delle virt
etiche, le
SiavoYjxtxal psxai, come se per l'etica avessero
importanza soltanto accessoria :la nostra azione viene in
fatti lodata solo quando si tratta di sue propriet eti
che, mentre nessun uomo vien lodato per le prero
gative del suo spirito, come per esempio perch
saggio o
perch assennato o perch ha un'altra qualit di
questo
genere 1). Ci proprio l'opposto di quel che Aristotele
Magna Mot.. A 5, 1185 b 5 v [lv St| zip Xyov
Ixovti
(scil. jiopiu) tv); <jn)XiC' i"|-vsxai cppvr,otj
if/i-iot.7. ootpia t[ie-
[ivfyiv) xal x& xoiaxa, v S
t<J>
SXy<P axat at clpExal
Xsf-
[itvat, 0UKpp036vY) Bixaiocvi) vSpela 83ai 5XXai toO S-oug Soxoaiv
naivsxal elvai. xxt fp xaxa; inalveici
XeYSfis8a. xax 6
x; xoO
Xfoi ix0VTS oOSel; irtaivsrxai- oxs fp
l'ideale filosofico della vita 597
sostiene nel passo parallelo
della Nicomachea e dell'Eude-
mea, dov' detto che 1' uomo vien lodato anche per le
propriet
del suo spirito,
al pari che per quelle del suo
carattere l). Cos, il concetto di pzzrj non si ancora
ristretto per Aristotele al significato di virt, come
invece gi accaduto nell' uso linguistico
e nello spontaneo
modo di pensare
dell'autore della Grande etica, che qui
polemizza
direttamente contro Aristotele 2). Singolare
soltanto il fatto che egli non tuttavia tanto conse
guente da negar senz'altro il carattere di psxf) a qua
litspirituali come la cppvvjat? e la aocpa, ed anzi, quanto
pi innanzi procede e maggiormente
s'immedesima col
pensiero della sua fonte, tanto pi torna a confondersi
nei riguardi di quel contrasto che aveva prima cos ener
gicamente enunciato. Non solo egli conserva tranquilla
mente la tradizionale denominazione per cui la <ppvr]ais,
Su oocpij, oSels
itaivEiidi, oCxs 8xi cppvipioe
oS' 8Xw; xax xl t&y xoiotmy o69-v.
!) Eth. Nicom., A 13, 1103 a 4 8iopleiai psxi) ax
xijv Siatpopv Ta6i7]v (scil. xo Xyot ixvxo;
xal xo XYOt) [i-
pou; ti}? ux)' Xy'v fp axiv xa; [lv Siavoijxix; xa; 8
fjSix. cotav [lv xal ovsoiv xal cppvrjaiv Siavcr/xtxiig, Xsofrs-
pi6xv]xa S
xal'owtfpccvrjv x&ix;. Xyovtes fp uspl xo
et)
Xyojibv 8xi 0098; i) covex; &XX' 8xi aoSos awcppiov, ittai-
v o 5 [ie v S xal xvaotpiv xax iijv IJiv tv igeaiv S
xg
naivsxs
pzzkc, XyoiAsv. Parimenti Eth. Eud. B 1, 1220 a 5
pexrjf; 8'elr| 8Od, V| [lv yi&ixtj i) Ss SiavoYjxixtj. iitaivoO|iev
fp o (lvov
-oS3ixatoug XX xal x oil ;auvsxog
xa x o ;00906;.
2) InMagna Mor., A 5, 1185 b 5 egli fa la seguente distinzione :
nella parte razionale dell'anima si trovano 9pv)oi; co-pia xal x
x 0 1a 0 x a (P indeterminatezza di quest' ultima espressione eviden
temente voluta), rella parte irrazionale, invece,
k le cosiddette virt (axai al pexal Xey3[isvoi). Che
egli torni subito dopo, inquel che segue, a valersi inavvertitamente
della terminologia aristotelica e parli quindi di pnal xo X8y0V
Sxoyto;, non pu ingannar circa il fatto che quest' ultima conce-
rione essenzialmente aliena dal suo pensiero. E perci egli cerca
almeno di distinguere tali psxai da quelle che per lui sono vere,
0 cio le etiche, col negare alle prime la nota dell'axivsxv.
593 APPENDICE
la ffotpfa, la oveatg
ecc. appaiono come psxctf, ma si
contraddice addirittura palesemente l dove, ricollegan
dosi al sesto libro della Nicomachea, tratta ampiamente
anche di esse (A 34). Ivi infatti egli afferma ripetuta
mente che si lodati anche per le doti intellettuali, e
cerca anzi di dimostrare esaurientemente la causa di que
sto fatto 1). Ancor pi che il concetto delle virt in
tellettuali
poi naturalmente aliena dal suo pensiero
l'idea aristotelica che non sussistono soltanto virt
della
parte razionale e irrazionale dell'anima, anche la
parte vegetativa (x
&pxxixv pepo?) possedendo la sua
petrj. Vero che la tradizione scolastica e la lettera
dell'etica aristotelica lo costringono a ricordare
questa
strana opinione :ma evidente che egli non
presuppone
nei suoi ascoltatori o lettori alcuna simpatia per essa,
e dichiara miglior partito tener lontana dall'etica la que
stione se debba ammettersi una simile specie di psxfj 2),
) Tale contraddizione non pu del recto spiegarsi in nessun
modo fincli si creda che entrambe le espressioni derivino dall'opi
nione personale dell'autore. In A 34 egli si attiene bens al sesto
libro della Nicomackea, mentre nel passo antitetico A 5, 1185 b 5segg.
egli trascrive evidentemente un altro peripatetico, che si opponeva
ali ammissione di pstai intellettuali,
o almeno negava loro il ca
rattere dell'iitaivatv. Dell' influsso di quest' ultimo autore si pensa
che sia rimasta traccia anche nel fatto che la Grande elca evita
di valersi del termine tecnico aristotelico di 8iavoT]xixat pstC
(v. por ci ilmoralista peripatetico conservato inStobeo, II137, 19 :
ma cfr. per 118, 1e 145, 17). Com' noto, la morale peripatetica
posteriore qualifica la virt dianoetica come quella che non pro
priamente tale e la virt etica come quella che propriamente
tale.
Questo allontanamento da Aristotele comincia nella Grande
etica, o per lo meno la Grande etica il documento pi antico in
cui noi possiamo segnalarlo.
a) Magna Mar., A 4, 1185 a 23 ti oOv, &/ tig eTnoi, nrspov
xal -coxeo to5 popioo xijg ({"-"Xtis So-ctv psn); e a 26 : si pv oOv
ionv pstrj totoo f, jitj lettv, SUog Xyoj. Cfr. invece Eth. Ni-
com., A 13, 1102 a 32 segg. : xafrjp jiiv o5v y.otvrj ipsxi) xat
o&x v3-pTtvr; cratvsrat (scil. yjtcy.ijp xal Opsitxixyj?
uviue'oc
"IS
4"X?S); Eth. Eud., B 1, 1219 b 38 8w o&8' al petal al to5
5-petmxo xal c" r.;-ivxoO
vOprtou (scil. pstal etoiv). Inentrambi
l'ideale filosofico della vita 599
E come ormai egli non capisce pi, quando chiede che
abbia a che fare la aocpia con la morale, in che senso
l'etica aristotelica culmini nella metafisica, cos, quando
non riesce pi a concepire 'ptvfj umana come grado
gerarchico
immediatamente
superiore
a quello costituito
dall'pexf) delle piante e degli animali, mostra di non
intendere pi
il modo in cui l'etica si fonda sul sistema
teleologico della natura.
Si ha la netta impressione che la Grande etica si de
streggi penosamente
tra ibruschi contrasti, che divisero
la scuola peripatetica nella prima generazione seguente
al maestro. Esse concernevano proprio il punto in cui
s' visto il suo autore oscillare tra l'esigenza dell'orto-
dossia scolastica e quella di una critica indipendente,
cio la valutazione del (Sto? fteiopijxtxdij
e delle virt
intellettuali per la costruzione
della vita umana e la
loro posizione
nell'etica. Conosciamo ancora il nome del
l'oppositore,
che attacc aspramente
Aristotele e respinse
la sua sopravalutazione
del pio? frswpTjxix? :fu Dicearco
di Messene. La tradizione fa di lui, sotto questo aspetto,
l'antitesi di Teofrasto, il quale, sia come successore di
Aristotele nella direzione della scuola e suo pi fedele
seguace,
sia, certamente, per sua interiore convinzione
di uomo dedito alla ricerca
scientifica, tenne fermo alla
teoria del primato
del jkg -eioprjxixs. La controversia
tra lui e Dicearco dovette essere famosa, perch
ancora
ai tempi di Cicerone la gara del [ilo? xktopYjXiXS
e del
pio? itpaxxixs per la supremazia
era legata a quei due
questi due ultimi passi Aristotele presuppone
come affatto ovvia
l' idea che il dpeitttxv possieda una sua peculiare pstij. Ilmera
vigliato interrogativo della Grande elica tradisce invece la stessa
tipica situazione dell'epigono ignaro, che si manifesta anche nella
sorpresa circa l' inserzione della ootpia nell'etica, espressa dall'autore
inA 34, 1197 b 28 ;e lamanieraincui egli mette dapartelaquestione
analoga a quella da lui seguita in B 15, 1213 a 6 a proposito del
problema se Dio pensi s stesso.
600
APPENDICE
nomi1). Fu Dicearco il
peripatetico il quale dichiar
che non la
oocpfa ma la cppvijais era l'energia domi
nante
nell'anima umana : come risulta necessariamente
dal fatto che egli vide la missione dell' uomo non nel
frsttpelv ma nel TtpartEtv 2). Egli dov spezzare inessi
che
Aristotele, sulle tracce di Platone, aveva ammesso
sussistessero tra l'azione morale e la
conoscenza dei pro
blemi
sommi, e giungere
coerentemente
all'opinione rie
cheggiata dall'autore della Grande etica :non si
capisce
che abbia a che fare la
ao'ficr, nell'etica, concernendo
quest' ultima solo l'rjffog e la izp%i<; 3). Dicearco dovette
svalutare il
XfO?
pei accrescere in
compenso l'impor
tanza
dell'ho?
: ed lecito credere che sia stato lui a
negare affatto ilcarattere di
pzift alle facolt intellet
tuali del
carattere e a restringere tale concetto all'am
bito
dell'attivit etica e politica. N si saprebbe chi, al
l' infuori di lui, fosse
potuto giungere all'argomentazione,
estremamente eretica per un
peripatetico, che l'autore
della Grande etica cita con molta considerazione : cio
quella
che dichiarava falsa la nota
deduzione aristote
lica per cui, nou esistendo nulla di pi perfetto di Dio
e Dio potendo
pensare solo la realt
pi perfetta, egli
non
poteva avere come oggetto del suo pensiero altro
che s
medesimo. In tale argomentazione si
osservava
infatti che un uomo il quale non facesse altro che im-
1) Gc., ep. ad Ait., II 16 unric prorsus hoc statu, ut, quoniam
tanto controersia est Dicaearcho,
familiari tuo, cunt Theophrasto,
amico meo,ut Ole tuus xv Jtpaxnxiv gCcv longe omnibus anteponat,
hic outetn tv
ftetoprjTixY, utrique a me mas gestus esse videatur.
Pitto enim me
Piicaearcko ajfatm satisfecisse, respicio nunc ad hanc
familiam, qua? miki nonmodo,ut requescam, permittit, sed reprehen-
iit. quia non semper quierim.
Quarc incumbamus,o nosier Tle, ad
illa praeclara
studia et co, unde discedere non oportuit, aliquanda
revertamur,
2) Cic. sopra, pp. 592 sgg.
*) Cft. sopra, p. 591.
l'ideale filosofico della vita 601
mergersi
nella contemplazione di s stesso verrebbe bia
simato come un essere insensibile, e che perci era as
surda l'intuizione
di una divinit contemplante B me
desima *). La dissoluzione del sistema aristotelico del
mondo e della sua teologia, che qui
si manifesta, muove
da un'argomentazione fondata inultima analisi su un'in
dimostrabile
equazione di valori : vivere significa agire.
L'autocontemplazione
del voO; aristotelico doveva ces
sare di essere l'ideale supremo
della vita umana e di
vina appena
il suo modello terreno, il jSto? B-Etup'rjttx?
del filosofo, non avesse pi saputo giustificare,
di fronte
al vivo sentimento dei contemporanei e a paragone delle
altre forme di vita, lapropria superba esigenza. Lo stesso
Aristotele aveva del resto gi insegnato che il ffrw-
pt]Tixs
aveva la preminenza
sul [Sfo; 7upirax; Bolo
per
ilfatto che ilfilosofo raggiungevanello stesso tempo
il grado supremo
dell'attivit creatrice: esso era l'ar
chitetto del mondo spirituale
e sociale 2).
Quanto
pi,
nel corso
dell'evoluzione, la scienza diventava teoretica
nel senso nostro della parola, quanto pi essa si ritraeva
l) Si potrebbe pensare a Teofrasto, ma sembra da escludere la
possibilit che si tratti di lui. Nel frammento metafisico egli si raf
figura infatti palesemente l'attivit di Dio, e la forma dell'azione
da esso esercitata sulla natura e in particolare sul moto astrale,
nella stessa maniera incui se la raffigura Aristotele in Metaph., A 7.
Vistanza suprema xCvvjTej xafl* a&Tijv, essendo causa del mo
vimento
degli altri esseri merc unaforma d'azione diversa dal mo
vimento
stesso, cio merc la8pei? di questi esseri verso l'fipicTov.
Per questo essi hanno bisogno della ijjuxrl e della Sietvoia, da cui
infatti muove la Spsfi?. Anche il itpeBtov quindi a
fortiori
da con
cepire come spirito e come pensamento o volizione del perfettissimo,
il quale d'altronde coincide col npSTov stesso nella sua perfezione.
Nella formula x6
f-P
3i| Tiptov xal S-siixa-ov rcvta -ti dpioxa
pouXpsvov
nonsembra ame sia nullaebe vada al di l dellateoria
di Aristotele.
Dio pensa s stesso come la cosa
migliore che esista,
e deve anche volere questo suo esser ottimo. Se invece si esclude il
pensamento
di s, si modifica nello stesso tempo l'oggetto della vo
lont divina e lesi d una direzione diversa.
->
Pol., H3, 1325 b23.
602 APPENDICE
dalla vita, tanto meno essa
poteva far
pienamente pro
prio 1* ideale aristotelico del (05 fttiopTjttx;, e con la
sua stessa unilateralit provocava la genesi dell'antitesi,
l' ideale del 0( npay.Tiy.6g. Dicearco mostrava agli epi
goni di Aristotele che essi non
rappresentavano affatto
il supremo fiore dell' umanit, e che anche nella storia
non si trovava mai ombra di una tale supremazia della
pura intelligenza sull'attivit creatrice.
Torniamo ora, con la nostra indagine, al
punto di
partenza, e cio alla tradizione classica circa il J3og dei
filosofi pi antichi. La profonda mutazione dell' ideale
filosofico della vita che si veniva producendo doveva a
un tratto farli apparire in una luce completamente
nuova. Lo stesso Dicearco compose BCoi cptXoacpwv, di
cui sono superstiti alcuni frammenti che parlano appunto
dei pensatori pi antichi e che lasciano chiaramente ve
dere come la concezione etica dell'autore si riflettesse
intutta la sua interpretazione del
passato. 1pi antichi
rappresentanti dellafilosofia erano anche per lui,evidente
mente,icampioni di unideale, e ad essi
egli commisurava
ifilosofi del proprio tempo. Chi, come Dicearco, vedeva
lo scopo della societ umana nella vita attiva, doveva
o giungere al dispregio generale di ogni scienza 0 con
trappone
all' unilaterale forma di vita della filosofia pre
sente l'immagine di un pi grande passato, in cui il
pensiero aveva ancora realmente posseduto la forza di
passare all'azione creatrice. Se si consideravano da que
sto punto di vista le rare notizie che si avevano circa
ipi antichi pensatori, si vedeva come accanto alla de
dizione al puro contemplare, messa in luce esclusiva da
Platone e da Aristotele, essi manifestassero anche una
familiarit con la vita pubblica, che era aliena dagli scien
ziati dell'et di Dicearco e su cui nessuno ancora aveva
richiamato l'attenzione.
Questi uomini avevano realmente
l'ideale filosofico della vita 603
adempiuto, nel loro (fos, all' ideale di Aristotele, secondo
cui iportatori
dei sommi pensieri
dovevano essere nello
stesso tempo gli py_izixzovsg della vita attiva.
Quando
Aristotele, nel dialogo Ilepl cpiXoaocpfa?, aveva dato, con
interpretazione
modernizzante, ai sette saggi la qualifica
di sofisti, era evidentemente incorso in un errore. Pro
prio questi venerandi personaggi,
la cui memoria era
fino allora sopravvissuta
nella coscienza del popolo greco,
avevano impersonato la pi compiuta
unit di pensiero
e di azione. Erano stati legislatori e uomini politici,
avvertiva Dicearco
1), il quale doveva trovar la con
ferma di questa
sua opinione
non soltanto nel caso di
Solone e di Pittaco, ma anche p.
es. in quello
di Ta-
lete, di cui Platone aveva fatto un puro rappresentante
del (3o? fi-ewpTjTtxs. In favore della sua tesi Dicearco
poteva
facilmente accumulare prove, traendole sia dalle
migliori
fonti storiche sia, anche, dal regno dell'aneddo
tica. La tradizione collegava Talete con le maggiori con
quiste tecniche della nautica e dell'astronomia.
Secondo
una notizia conservata
in Erodoto, egli era come inge
gnere al servizio del re Creso inoccasione della sua spe
dizione contro iMedi, e con una singolare trovata in
segn il modo di deviare il fiume Halys e di abbassare
il livello delle sue acque,
in modo che l'esercito lidio
pot guadarlo senza bisogno di ponti o di navi 2). An
che se la critica razionalistica di Erodoto dubitava della
credibilit della notizia, questa
comunque attesta che
la comune opinione popolare
vedeva in Talete piuttosto
!) Fragm. hislor. graec. II, 243 Mueller (framm, 28) ;Diog., I,40
4 5s Aixa'.apxog o&ts ao-poi>j o5ts iXoaepouj cpijclv abros YST"
vivai, ouvstobj 8i rivac *al
votioOsxixob?.
ej Per il passaggio del Haiys cfr. Herod. I,75 (Diels, Vorsokr.
*
1A 6). Cie nel Peripato si accettasse la tradizione (attestata gi in
Herod., I, 74) degli studi astronomici di Talete dimostrato da
Eudemo, r. 94 Spenge].
604 APPENDICE
un pratico che un astratto scienziato. Anche come uomo
di Stato egUeraintervenutonellavita delle cittioniche,
giacch era ancora noto ad Erodoto il consiglio da lui
dato ai loro abitanti: essi dovevano creare un parla
mento comune e trasferirlo nell'isola di Teo, che oc
cupava una situazione centrale fra le citt ioniche, e le
citt, fino allora indipendenti, dovevano essere sotto
poste a questo governo centrale, al pari di comuni di
un unico stato.
Questa
tradizione attribuisce a Talete
un prestigio politico che si estendeva largamente oltre
iconfini della sua citt natale ; ed certo che Dcearco
non si lasci sfuggire, anche se questo non ci esplici
tamente attestato, simili tratti della sua figura1). Nella
tradizione della tarda antichit concernente gli antichi
uensatori s' incontrano notizie di
questa specie, e insieme
altre di carattere del tutto
opposto, miranti ad attestare
come igrandi sapienti, immersi nelle loro ricerche scien
tifiche, dimenticassero ogni interesse pratico :notizie per
lo pi tranquillamente giustapposte, conforme al carat
tere compilatorio dell'opera di
Diogene Laerzio e delle
fonti affini s). Possiamo ammettere come estremamente
!)Herod., I, 170 { Vorsokr. 4, A 4). Diogene Laerzio, I,25 (For
go
fcr.4, 1A1) ascrive aTalete ancheilconsigliopolitico, dato ai Mi-
lesii, di rifiutare l'alleanza ad essi offerta da Creso :consiglio che li
salv, quando pi tardi Creso venne in guerra con Ciro.
2) Cos, subito dopo la menzione del consiglio politico ricordato
nella nota precedente Diogene riferisce come Eraclide Pontico (fr. 47
Voss) facesse dire a Talete, introdotto quale personaggio di un dia
logo (evidentemente con metodo simile a quello incui faceva raccon
tare a Pitagora le sue precedenti incarnazioni: v. Diog., Vili 4) di
essere unisolato e unsolitario (fiovijpijj xal ittoxijj).
Questo tratto
conviene naturalmente solo al .Sioj Jeoiprjxixj :e richiama alla memo
ria il motto di Aristotele, quand'egli si definisce aOrifrjj xal |iov)Tqj
(fr. 668 Rose). A questo motto Demetrio aggiunge, come chiari
mento, l'osservazione t [lv yetp povi-njg IStcmxurcipoo &ooj
ioti xt?.. ;e ci spiega ilnesso di con tSwwfq? in. Era
clide, potendo persino darsi che il motto di Aristotele si ricolleghi
direttamente al passo di quest'ultimo. Per Eraclide era naturale che
l'ideale filosofico della vita 605
verosimile, dato che nel caso dei sette saggi siamo ancora
in grado
di darne una dimostrazione diretta, che le no
tizie raffiguranti gli antichi filosofi come legislatori,uomini
di stato, inventori di espedienti pratici siano state im
messe per la prima volta da Dicearco nell'alveo della
tradizione. Di tal genere sono le notizie concernenti
Anassimandro, Parmenide, Zenone, Melisso e sopratutto
Empedocle,
le quali
mettono specialmente inrilievo l'at
tiva partecipazione
di questi
uomini alla vita politica 1).
Talete rappresentasse tipicamente il gtoc $su)pt)Ttx non meno di
Pitagora, di cui egli raccontava il colloquio col tiranno Leone di
Fliunte (cfr. sopra, p. 569).
. .
*) Anassimandro dedusse una colonia da Mileto ad Apollonia
sul Ponto (Vorsokr.4, 2 A 3). Parmenide diede un codice di leggi
ai suoi concittadini (Vorsokr. 4, 18 A 1=Diog. L., IX, 23). Zenone
fu amico fanatico della libert, prese parte alla congiura contro il
tiranno Nearco (altri lo chiamano Diomedonte o Demilo) e tem*e
fede al suo ideale politico anche in mezzo alle torture (Vorsokr. ,
19 A 1=Diog., IX, 26 ;19 A 6-7). Melisso fu uomo di stato e co
mand, col grado di navarco, iSami nella guerra contro Pericle
(Vorsokr. 4, 20 A 1-2). Particolarmente
ampia la tradizione concer
nente l'attivit politica di Empedocle (Vorsokr.4, 21 A 1). Essa ri
sale all'opera storica di Timeo, che vedremo come sia stato colui
che trasmise alla posterit la tradizione diccarchea circa l'attivit
politica di Pitagora. Le notizie ins sono certo, inparte, piantiche
di Dicearco : e cori, p. es., quella riferenteri
all'opera legislatrice
di Parmenide attinta al IIspl cpiXootptov di Speusippo, che eviden
temente era andato incerca di unmodello per gli analoghi tentativi
di Platone. Ma dev'essere pur stata una determinata personalit
di storico della filosofia a prospettare a un dato momento, inmodo
sistematico, le ligure degli antichi pensatori mettendo in luce il
lato pratico e politico della loro attivit, e a raccogliere perci le
notizie che facevano al caso. E un simile interesse per il rcpcocu
xg proprio dei filosofi verosimile solo nell'uomo che vedeva
la grandezza degli antichi pensatori soprattutto nella loro attivit
pratica e listudiava solo per tale motivo, cio inDicearco. Non un
caso che questo membro del pi antico Peripato non s' incontri tra
idossografi come Teofrasto, Eudemo e Menone, e dimostri di avere
interesse solo per igio 91X0069(0v. La cosiddetta biografia,
infatti, una forma letteraria che non nasce dal mero interessamento
per l'individualit in quanto tale, ma bens ricerca nella vita dei
singoli individui la manifestazione del tipo universale
ctiecssi
rappre
sentano, cio l'estrinsecazione di quell'entit
ideale che l'etica filoso
fica intende col nome di analizzandone
le diverse specie.
606 APPENDICE
Pensatori del tipo di Anassagora e di Democrito dove
vano naturalmente assumere per Dicearco una posizione
tanto pi secondaria, quanto pi erano invece venuti
in primo piano agli occhi dei seguaci dell' ideale della
vita contemplativa. II loro cosmopolitismo pratico su
scitava necessariamente la sua
antipatia. Quanto ad
Eraclito, non era difficile scoprire nel suo pensiero
l'aspetto politico e mostrare come egli non fosse stato
unpuro studioso della natura, dato che egli aveva sentito
disgusto per la vita politica della sua patria. A unimme
diato scopo politico mirava la filosofia di Socrate e si
Platone. Certo, sembra che Dicearco abbia visto realiz
zato non tanto in Platone
quanto in Pitagora il tipo
ideale del riformatore e legislatore filosofico. Per ilavori
dei Peripatetici e dell'Accademia Pitagora costituiva gi
da
tempo un tema centrale dell' interesse filosofico :e la
lotta delle
opposte interpretazioni della sua figura si
faceva, ora, tanto pi vivace, quanto piincerti ed oscil
lanti erano ilineamenti che ad essa attribuiva la tradi
zione orale.
Dalla met e fin verso la fine del
quarto secolo avanti
Cristo s' intendevano col nome di Pitagorici due gruppi
affatto diversi di persone.
Quando
Aristotele, come fa
ripetutamente, parla dei cosiddetti Pitagorici, allude
all'ambiente scientifico capeggiato da Archita di Taranto,
Non possibile decidere se, e in cbe misura, risalga direttamente
o indirettamente a Dicearco l'enumerazione di filosofi cbe svolsero
attivit politica, e delle loro azioni, compiuta da Plutarco, adv. Co
lot., c. 32. Questa enumerazione comprende ifilosofi fino ad Aristo
tele e a Teofrasto, ma mancano proprio isette saggi e Pitagora, che,
come possibile dimostrare, avevano particolare importanza per
Dicearco. D' altra parte inverosimile che egli abbia citato Teofrasto
proprio come rappresentante del itoXiiixj gio;, tanto pi in
quanto ilmotivo allegato da Plutarco, siainquesto caso sia inquello
di Aristotele, poco probante, entrambi ipensatori sembrando
aggiunti alla serie pi per amor di completezza cbe per altro.
l'ibeale filosofico della vita
07
con cui Platone aveva avuto ancora relazioni personali.
Sembra per altro che egli non abbia avuto a disposizione
alcun preciso punto
di riferimento per poter determinare
fino a cbe et risalisse nell' Italia meridionale quella
tra
dizione, e non c' bisogno di dire che egli non avrebbe
ritenuto lecito di riportare le origini alla persona
di Pita
gora, da cui quell'ambiente
traeva il nome. Ma la desi
gnazione di Pitagorici era condivisa anche da un altro
genere di persone, il cui singolare metodo di vita veniva
sovente messo in burla dalla commedia di mezzo, e che
quindi doveva essere ben noto inquell'et.
Era unordine
di persone pie, che si attenevano a ima regola di vita
strettamente ascetica e derivavano iloro simboli e le
loro intuizioni religiose da Pitagora, venerandolo come
fondatore di religione e taumaturgo 1). Gi inet antica,
al pi tardi nel quarto secolo, vediamo come queste
due
interpretazioni
di Pitagora fossero in lotta tra loro ;ed
ben naturale che idue gruppi, iquali in quel tempo
non avevano in ogni modo nulla di comune e avrebbero
quindi potuto
coesistere pacificamente
l'uno accanto al
l'altro, dovessero essere condotti dalla loro denomina
zione di pitagorei o pitagoristi
a combattersi, per
decidere chi di loro fosse il successore del Pitagora auten
tico e quale dei loro metodi di vita fosse quello veramente
pitagorico. La scuola matematico-astronomica
cbe si
raccoglieva intorno ad Archita sembra non abbia se
guito quel comandamento dell'astensione dalla carne e
l) Cfr. le fondamentali argomentazioni di E. Bolide nel suo
classico saggio Die
Quellen
des Iamblichus in seiner Biographic des
Pythagoras (in Kleine
Schriften.
ZI, p. 102 segg.). HRobde spiega
il parallelismo delle due tendenze facendolo dipendere da una scis
sione sussistente inseno alla scuola, e le considera quindi entrambe
unificate nella personalit di Pitagora. Parimenti Burnet, Die An-
fnge der griechiscken Philosopkie, ed. ted., p. 85. Le testimonianze
dei comici sono raccolte inDiels, Vorsokr. 4, 45 E, p. 373
603
APPENDICE
da altri cibi, che per il
giuppo opposto era invece sacro :
ed quindi ben probabile cbe sia stata essa ad intro
durre nella tradizione la
variante, secondo la quale Pi
tagora non
avrebbe predicata tale astinenza. Parimenti
sar stata
opera sua l'attribuzione alla
persona storica
di Pitagora di certi fondamentali concetti politici da
essa sostenuti, e di singole tesi matematiche e fisiche1).
Questi scienziati dovevano provare avversione a raffi
gurarsi il fondatore della loro scuola come un medico e
taumaturgo girovago. Col loro modo di pensare quadrava
soprattutto quella raffigurazione di Pitagora che si in
contrata per la prima volta in Eraclide Pontico e per
cui esso appariva come l'iniziatore del fiioq &etPftYj'cixq.
Ma come si
spiegava che uomini di tipo tanto diverso
facessero risalire iloro ideali di vita al medesimo mae
stro ?
Questo problema non era ancora affatto risolto
dalle due
opposte interpretazioni della
personalit di Pi
tagora, e appariva risolubile solo dal
punto di vista di
Dieeaico, incline a vedere nel pensatore arcaico non un
puro teorico di tipo moderno ma un fondatore di Btati
e unlegislatore,
che avesse
posto tanto lareligione
quanto
la conoscenza in servigio di un'attiva organizzazione
della vita.
Di fatto nella nostra tradizione, tarda e affatto leg
gendaria,
concernente la vita di
Pitagora, icui testi
moni
principali, cio ineoplatonici
Giamblico e Porfirio,
riferiscono d seconda e d terza mano fonti antiche
come
Aristosseno, Eraclide e Dieearco, troviamo accanto
al tipo dello scienziato e a quello del
taumaturgo ancora
i) 11 principale
rappresentante di questa interpretazione laica
della personalit di Pitagora Aristosseno, elle in ci, Btando ad
Aulo Gelilo (TV, 11, 7
= Fragni. Hist. Graec.,
11. 273 Mueller
s=
Aristox. fr. 7), seguiva l'opinione degli scienziati pitagorici suoi
amici.
l'ideale filosofico della vita 609
un terzo tipo, quello del fondatore di citt e del legisla
tore. Itratti che si riferiscono a quest'ultimo sono invero
sempre fusi e confusi, senza alcuna critica, con quelli ri-
ferentisi agli altri due :tuttavia alcuni dei
primi,
e pro
prio quelli pi
caratteristici, vengono esplicitamente fatti
risalire all'autorit di Dieearco, confermando cos la con
gettura
gi avanzata da Erwin Rohde, che sia stato
quest'ultimo
adelevare Pitagora a simbolo di quell' ideale
del npccxtttxbq jloq, a cui egli stesso mirava tanto in
teoria quanto in pratica1). A ci egli dovette essere
specialmente incoraggiato dall'esempio del pitagorico
Archita, che era nello stesso tempo capo di stato e inda
gatore
scientifico 2). A Dieearco risale la tradizione dei
discorsi politico-pedagogici
che Pitagora, arrivato nel
l'Italia
meridionale, avrebbe tenuti a Crotone, per in
carico del consiglio, agli uomini, alle donne e ai giovani
della citt ;e, anche se Dieearco stato preceduto da
Aristosseno nell'affermazione del grande influsso eser
citato da idee pitagoriche sulle condizioni politiche
della
Magna Grecia e della Sicilia, possibile tuttavia dimo
strare che egli riprese questa
tesi e cerc di convalidarla
anche meglio con argomenti particolari. L'interpreta
zione politica dell'attivit di Pitagora traeva assai vo
lentieri alimento dalla tradizione concernente la violenta
catastrofe dell'ordine a causa del crescente sfavore poli
tico e la fuga del maestro a Metaponto3). Ma, ora,
!) Cfr. Itohde, 1. c., p. 110. In et moderna questa opinione d .
Dieearco stata ripresa dal Xriscbe, De societalis a Pythagora con
ditile scopo politico, 1830.
s) Cfr. G. Orate,
Hist,
of
Greece, IV, p. 405.
s) Per le asserzioni di Dieearco circa idiversi discorsi di Pitagora
a Crotone v. l'orph.. Vita Pvth., 18, 19. H contenuto letterale di
questi
discorsi riferito da Giauibico (Vita Pyth., 37-57), il quale
lo attinge da un'altra fonte, ebe a sua volta aveva liberamente com
posto quei discorsi inbase alle indicazioni di Dieearco (cfr. E. Robde,
1. c., p. 132 : egli ne conclude cbe autore dei discorsi sia Timeo). An
no.
IV. .T,conn, Ar/.f.i/ilt'.
610 APFEND1CE
l' intervento di Pitagora nella vita politica di Platone in
occasione del suo arrivo nell' Italia meridionale avrebbe
seguito senza alcun trapasso alla favoleggiante narrazione
dei suoi viaggi di studio in Egitto e in Oriente, e non
avrebbe trovato alcun precedente logico nelle notizie
che Dicearco (fr. 88 Mueller) presuppone inPitagora intenti di rifor
mapolitica, quando descrive come iLocri, all'arrivo di Pitagorafug
giasco da Crotone, spedissero messi al confine per dirgli che essi
stimavano la sua sapienza, ma che non avevano niente a ridire sulle
loro leggi n pensavano affatto di modificare il loro regime politico,
e che quindi egli si compiacesse di volgere altrove iBuoi passi. Circa
l' influsso esercitato dai Pitagorici sulla legislazione delle citt della
Sicilia e dell' Italia meridionale riferiscono diversamente Porfirio
( 21) e Giamblico ( 130 :ripetuto abbastanza esattamente, con cam
biamenti non essenziali, nel 172). La notizia di Dicearco circa i
discorsi di Pitagora ai Crotoniati pass a Porfirio attraverso la me
diazione di Nicomaco ( 20) ;ed quindi evidente che egli desumesse
da quest'ultimo anche il capitolo sulle legislazioni dei Pitagorici
nelle citt della Sicilia e della Magna Grecia, che segue immediata
mente e che strettamente connesso a quel che precedo tanto dal
punto di vista logico quanto da quello linguistico. Nicomaco, a sua
volta, aveva desunto questo capitolo ( 21) non da Dicearco ma da
Aiistoeseno, ossia da una fonte antica di egual valore : ci detto
da Porfirio stesso ( 22) per quanto riguarda l'influsso politico del
pitagorismo sui Lucani, Messapi, Peucezi e Romani, cio sul barbari
dei paesi circostanti, ed quindi da ritener vero anche per quel che
couceme le citt greche, menzionate prima, della Magna Grecia
della Sicilia. Ora, mentre Aristosseuo-Porfirio racconta che iPitagorici
avrebbero datoleggi a Crotone, Sibari, Catania, Reggio, Imera, Agri
gento, Tauromenio e ad altre citt ancora, e ascrive tutte queste legi
slazioni ai due presuntipitagorici Caronda e Zaleuco, Giamblico (130)
dice che Caronda diede leggi a Catania, cita per Locri, accanto a Zaleu
co, anche un certo Timares (a 172 Timarato) e infine menziona per
Reggio, evidentemente basandosi su ampie tradizioni storichelocali e
cominciando
dall'otv.ioilis
Tucle (cfr. Thucyd., VI 3, 3), addirittura
unaserie di personaggi legati a mutazioni costituzionali (al 130 Fitio,
Elicaone e Aristocrate : al 172 c aggiunto a questi Teeteto, ma
manca Tucle). escluso che questi particolari si trovassero gi nel
l'esposizione originale di Aristosseno e che Porfirio (o l'intermedia
rio Nicomaco) abbia semplicemente trascurato di riferirli : evidente
mente Giamblico non segue qui Aristosseno-Porfirio ma un'altra
fonte. Che la versione delle cose data da Aristosseno sia antica e
inalterata provato dal catalogo aristotelico dei legislatori, il quale
(come gi feci vedere inEntstehungsgeschickte der Metaphysik, p. 45
e qui sopra, p. 385 n. 1) stato aggiunto inet posteriore al secondo
libro della Politica. Ivi (1274 a 22) detto che Zaleuco fu legisla-
l'ideale filosofico della vita 611
concernenti la sua giovinezza ed educazione, se Giam
blico e Pompeo Trogo non avessero inserito tra ilritorno
da cjuei lunghi viaggi e l'arrivo nell' Italia meridionale
un altro viaggio a Creta e a Sparta, compiuto allo scopo
di studiare le leggi di Minosse e di Licurgo 1). Evidente-
lore di Locri, Caronda di Cataniae delle altre citt calcidiche della
Sicilia e della Magna Grecia (Porfirio solo un po' meno preciso
nell'esprimersi, ma evidentemente vuol dire la stessa cosa, quando
menziona insieme Zaleuco e Caronda come autori di tutte le legi
slazioni della Sicilia e della Magna Grecia). Per la tradizione locale
circa ilegislatori di Reggio, superstite inGiamblico, dobbiamo perci
cercare una fonte diversa da Aristosseno : e data la situazione stessa
delle cose questo autore non pu essere se non Dicearco, che essendo
di Messina poteva esser bene informato dei fatti della vicina Reggio,
e a cui d'altronde attingevano spesso non solo Giamblico ma anche
(come sopra si visto) Porfirio. Ci che il catalogo aristotelico dei
legislatori sa di Zaleuco e di Caronda, quando estende la loro in
fluenza tanto pi largamente di quando faccia Dicearco-Giamblico,
certo gi desunto da Aristosseno, perch il catalogo Btesso fu ag
giunto al libro soltanto tardi, mentre Aristosseno scrisse assai pre
sto : presso Giamblico ( 233) egli infatti racconta che la storia
(ben nota attraverso Schiller) della fedele amicizia dei pitagorici
Damone e Pizia gli era stata raccontata dal tiranno Dionisio in
persona, Sxs Ixitsov xfj( povap/taj ypppat a 4v Koptvfhp 48I8b-
oxbv (la cacciata di Dionisio da Siracusa, per opera di Dione,
avvenne nel 354).
Questa
narrazione intutto degna di fede e con-
vien bene alla maniera di Aristosseno, che anche altrove si compiace
di simili reminiscenze personali (cfr. sopra, p. 574 n e il grazioso
ricordo di Archita che egli, in Giamblico, L c., 197, dice essergli
stato comunicato dal padre Spintaro). Del resto questo caso insegna
come in Dicearco 1* idea dell'attivit politica dei pensatori antichi
non fosse una mera escogitazione soggettiva, ma una convinzione
che egli, da buon erudito peripatetico, si era costruita attingendo
sempre a buone fonti. Cos, per quel che riguarda Pitagora, egli era
stato evidentemente preceduto da Aristosseno, a cui lo legavano
ripporti di amicizia e che certo influ su di lui auche intema di dot
trina politica. (Analogamente, circa l'attivit politica di Parmenide
era srato preceduto da Speusippo : cfr. sopra, p. 605, n. 1).
ti Dodo aver largamente narrato dei viaggi inOriente einEgitto,
Giamblico (!. c., 25) fa solo una breve menzione di quello a Creta
e a
Sparta. Ma che anch'esso avesse salda radice gi nella tradizione
pi antica dimostrato da Pompeo Trogo (Epitome di Giustino
XX 4) :inde regressus Cretam et Lacedaemona ad cognoscendas Minais
et Lycurgi inclitas ea tempestate leges contenderai. Quibus
omnibus
insiruclus Cratonam venit.... Seguono idiscorsi tenuti da Pitagora
ai Crotoniati secondo Dicearco (cfr. Porph., 18) ;ma Giustino evi-
612 APPENDICI!
mente questa
versione mira, pure arrivando in ritardo,
a far posto nella formazione spirituale di Pitagora anche
all'elemento politico, e deriva isuoi ideali di educazione
politica dall'esempio delle due classiche legislazioni do
riche. la premessa necessaria per l'intervento di Pila-
gora a Crotone, nella forma in cui risulta dal racconto
di Dicearco circa idiscorsi che egli vi tenne : e perci
non si pu fare a meno di ritenere che derivi da Dicearco
anche lanotizia del suo viaggio a Creta e a Sparta. L'ana
logia del modo in cui egli interpret Platonerende
questa
congettura anche pi verosimile.
In un passo di Plutarco, a mio parere per lo pi
frainteso, detto infatti che Platone, nella sua dottrina,
fuse evidentemente con Socrate non meno Licurgo che
Pitagora, secondo
quanto opinava Dicearco *).
Questa
interpretazione delle parole di Plutarco presuppone solo
dentemente conosce gi il loro contenuto e re riproduce punti
caratteristici :l'ampliamento esornativo del racconto dicearclieo e
la libera composizione dei discorsi erano perci gi un fatto compiuto
nellafonte diPompeo-Giustino. IlRohde (Kleine Schriflen, IX,p. 132)
dimostr che loro autore dovette essere Timeo, il quale si valse di
Dicearco. Ci persuade anche perch Timeo, come storico, era ad
dirittura tenuto dallo stile del suo l'va; alla libera invenzione dei
discorsi. Timeo stato molto sfruttato da Pompeo Trogo-Giustino :
che la notizia alla fine del capitolo su Pitagora (trasformazione delia
casa del filosofo inuntempio, inGiustino, XX 4, 18)risalga a Timeo,
dimostrato da Porfirio (1. c., 4), e costituisce il fondamento pi
solido per 1* ipotesi del Rohdc.
*) Plut., quaest. conv.. Vili 2, 2 (fr. 27 Mueller) AM' 5pa -.1
ooi xpooijxov 6 nUtwv xal otxstcv aiviT-jievo; ?.?.7)8-v, Stb 8
Tip 2xptxei tv Aoxopyov AvapiYvog
o/
)-tov tv Jluvia-
fpav, (<ig)
fijsxo
Aixaiapxo;. L'integrazione dell'(bg dell'Osami,
l'unico che abbia esattamente prospettato tale problema di critica
del testo collegandolo idealmente con tutto il complesso della con
cezione dicearchea, nella ricostruzione della quale egli si acquistato
meriti grandissimi. IlBernardakis ha accolto i'iiig nel testo, mentre
Ch. Mueller dichiara di non riuscire a scorgere la necessit dell'jg,
escludendo con ci, naturalmente, il riferimento di Dicearco a Li
curgo : e cos gi faceva M. Fuhr, Dlcucarchi Mess,
quae supersuat,
Darmstadt 1838, p. 58.
l'ideale filosofico della vita 613
una piccola modificazione del testo, senza la quale esso
significherebbe : Platone mescol con Socrate anche
Licurgo e non soltanto, come credeva Dicearco, Pita
gora .Intal caso l'opinione che ilpersonaggio del dialogo
plutarcheo esprimerebbe come sua propria sarebbe una
integrazione di quella di Dicearco. A sottilizzare sulla
costruzione della frase c' poca probabilit di giungere
all' interpretazione giusta, la quale invece mi sembra ri
sulti chiara se si tien conto del senso che qui logicamente
richiesto. Dicearco era proprio quell'espositore della
storia della filosofia, che aveva messo dappertutto in pri
ma linea il momento politico. Citarlo non era affatto
necessario quando si fosse voluto con ci appoggiare
soltanto l'opinione, comune a tutta l'antichit, che la
filosofa platonica fosse una mescolanza di socratismo e
di pitagorismo ; opinione che si trovava espressa gi in
Aristotele e che fin dall' inizio era stata convinzione ge
nerale delle scuole platonica e peripatetica1). La nota
particolare, che Dicearco aggiunge a questa opinione cor
rente, pu consistere solo nell'affermazione del rapporto
che lega in Platone (veduto naturalmente
soprattutto
*) Cito per ci, in luogo di testimonianze ulteriori, solo Ari
stotele, Metapk., A 6, 987 a 29 peti Si tig stpijpvag cpD-oootplag
nXdtoivog
iTcs-fsveto
npay\ia.xtia, x. piv itoiX Totoig xoXoo
Jfoaa, t 5i xal I8ia xap tvjv t&v TiaXixfiiv Soiiaa cpiAooocpiav,
Specialmente stretta fu la relazione che coi Pitagorici ebbero gli
altri platonici, e anzitutto Spcusippo, Senocrate, Eraclide, Filippo
d'Opunte : e infatti s' intende che Dicearco, ricollegando Platone a
Pitagora, poteva alludere solo a una relazione di tal genere con la
scuola epicurea, perch di Pitagora in persona non c'era nessuno
scritto. La sua affermazione non fa quindi altro che riprodurre
l'opinione dominante nell'Accademia e nel Peripato. Plutarco non
poteva pensare a citare, come testimone di essa, proprio lui, e per
giunta con la prudente formula (peto iixatapxog, come se si
trattasse di una congettura e non dei pi noti fatti storici. Le re
lazioni di Platone coi Pitagorici sono state di recente studiate, e
dimostrate assai intense, da E. Frank (Plato und die sozenonnten
Pythagoreer, Halle 1923).
614
APPENDICE
attraverso le Leggi) il teorico della filosofia col realiz
zatore nel campo politico e legislativo. Che il grande
pensatore politico trovi il suo modello nell'artificiosa
creazione dello stato di Licurgo per la mentalit di
Dicearco doppiamente
caratteristico. Sparta egli vede
infatti, da un lato, realizzata la costituzine mista, che
per lui l'ideale dello stato :mi sembra infatti evidente
che nella frase seguente Plutarco si riferisca ad essa, e
ci conferma l' interpretazione del passo che qui si
adottata1). Tipica di Dicearco , d'altro Iato, l'opinione
che in nessun luogo e tempo
la filosofia teoretica sia
stata la creatrice originaria delle leggi ed istituzioni della
vita umana, essendo queste
invece creazione degli stati
e dei loro legislatori, dalla cui opera storica tutti ifilosofi
avrebbero poi ricavato iloro concetti. Troviamo espresse
queste
idee nell' introduzione della maggiore opera de
dicata da Cicerone alla filosofia politica : opera nella
quale si manifesta di frequente l'influsso della conce
zione di Dicearco 2). questa
lapremessa da cui dobbiamo
J) Dicearco, framra. 21-23 Mueller. Cfr. Fuhr, 1. c., p. 29. In
sieme con ia teoria della costituzione mista Polibio (VI 3, 8 e VI 10)
desume da Dicearco la designazione dello stato di Licurgo quale
esemplare tipico di tale costituzione. Plutarco(Quaesl. conti.. Vili 2, 2,
p. 719 B) determina la caratteristiea dello stato di Licurgo ricol
legandosi inmodo evidentissimo alla concezione dicearchea di Sparta,
e cio definendola come costituzione mista di democrazia, aristo
crazia e monarchia : ed perci del tutto chiaro che, con questo
stesso argomento, Dicearco aveva sostenuto la tesi dell' influsso di
Licurgo su Platone. Essi volevano creare una costituzione che avesse
a fondamento non un'eguaglianza estrinseca e meccanica, ma
un'eguaglianza proporzionale degli uomini (suum euigue), quale sol
tanto poteva convenire a una oligarchia assennata e a unamo
narchia legata a leggi. Ma questi sono appunto itre elementi dello
stato ideale di Dicearco.
2) Cic., de rep., I2, 2 nihil enim dicitur a philosophic, quod qui
-
dem recle honesleque dicatur, quoi non ab iis partum confirmatumque .
sit, a quibuc civitalibus iura discripta sunt. Che questa frase e le
seguenti siano di origine dicearchea, una supposizione che per
il momento avanzo soltanto, sperando di darne presto altrove la
l'ideale filosofico della vita 615
partire se vogliamo comprendere l'intento che spingeva
Dicearco ad avvicinare Platone a Licurgo : e da questo
punto
di vista si pu esser quasi celtiche l'accostamento,
operato
dalla tradizione, di Pitagora alle leggi di Minosse
e di Licurgo, quale risulta da Giamblico e da Pompeo
Trogo, risale egualmente alla concezione di Dicearco.
Ma fermiamoci qui. Abbiamo visto come il singolare
fenomeno da cui ha preso le mosse la nostra indagine,
e cio l'opposta luce in cui la vita dei filosofi pi antichi,
prospettata ora come pio; frewpYj-cixo; e ora come pio;
icpaxttx;, messa dalla tradizione, non sia altro che
un riflesso del modo in cui, da Platone a Dicearco, si
evolve l'ideale filosofico della vita. Man mano che per
corre isuoi gradi, questa
evoluzione si rispecchia Del
l' interpretazione del passato. Non davvero una no
vit ilfatto che ogni vera storia, la quale non sia soltanto
una raccolta di materiali greggi ma si conformi in una
raffigurazione del
passato, tragga dall' intima vita del
l'osservatore imotivi determinanti della sua conforma
zione e della sua scelta dei fatti. Ogni epoca conferisce
quindi al quadro della storia una forma nuova. Ci
doppiamente vero pei Greci, che non considerarono mai
la storia come il semplice apprendimento di qualcosa
di ormai accaduto, ma la fecero sempre oggetto di una
costruzione intellettuale, o in forza dell' ideale ond'era
animato chi la tramandava al futuro o in nome della
grande ed universale saggezza che egli vi scorgeva mani
festata. La tradizione concernente la personalit e il
giustificazione. Ma la cosa gii di per s stessa abbastanza evi
dente. Per attestare che l'attivit politica superiore a quella filo
sofica Cicerone (1. e,, I7, 12) cita l'esempio dei maggiori filosofi,
che, come Platone, si dedicarono almeno allo studio del problema
dello stato ;ma meglio ancora ricorda quello dei sette sa-gi. occu
patisi tutti personalmente degli affari politici. Anche qui egli at
tinge a Dicearco (cfr. fr. 28 Mueller).
616 APPENDICE
sistema di vita dei pensatori pi antichi, in gran parte
aneddotica e leggendaria e spesso soltanto orale, offriva
un materiale estremamente plastico, che perci poteva
esser facilmente
piegato a raffigurare imutevoli ideali
dell'etica filosofica. Dovremmo adattarci alla rassegna
zione, se tutto il valore di questa tradizione si riducesse
a quel che essa contiene di dati cosiddetti storici, e che
la stessa nostra indagine circa la sue vicende dimostra
assai povero. Ma essa conserva bens importanza per
tutti itempi in forza del contenuto ideale, che eterna
rono in essa coloro che variamente la conformarono.
Hprocesso filosofico, di cui abbiamo seguito iriflessi
nella tradizione concernente ipensatori pi antichi, co
stituisce, nella sfera del pensiero, un ricorso ciclico di
singolare regolarit : ogni momento del processo segue
per intima necessit a quello che precede, e non si po
trebbe invertire la loro serie senza alterare la direzione
del moto e torcerla a serpeggiamento irregolare. Nella
storia della cultura greca questo processo di pensiero
costituisce un capitolo a s : e non si valuta in pieno
la sua importanza se lo considera soltanto appartenente
alla storia, pi o meno concludente, di alcune scuole
filosofiche.
Questo processo circolare conforme a una
legge non solo nel senso che isuoi singoli momenti si
susseguono per una necessit logica, ma anche in quello
che vi si manifestano in modo esauriente le possibilit
proprie dello spirito umano. Nel suo momento iniziale,
il binomio Socrate-Platone lega il mondo morale alla
conoscenza filosofica dell'essere : in quello finale, l'ideale
della vita pratica difeso da Dicearco sottrae di nuovo
del tutto la vita e la morale al dominio della grande
speculazione filosofica e le restituisce alla propria auto
nomia, tarpando le ali al pensiero speculativo. Anche
l' ideale della vita teoretica perde cos il suo vigore. Nei
l'ideale filosofico della vita 617
casi in cui d'allora in poi
lo s' incontra, esso si riferisce
sempre al mondo dellascienza pura, e si contrappone
come tale alla vita pratica
: quando non vengano
esco
gitati magri compromessi come il cosiddetto po ouv-
frsioe, che di fatto soltanto una contaminazione estrin
seca del pio? &wpTjTty.? e del irpaxxtx?. Il p(og
S-ccopTjxix? nasce a nuova vita solo quando, permeata
ormai dalla scepsi la filosofia e la metafisica
scientifica,
assume la forma religiosa
della vita contemplativa, nel
senso in cui essa, dal tempo
dell'omonimo scritto di Fi
lone,divenne Fideale del monachesimo. Particolarmente
da notare il fatto che iRomani, quando incorpora
rono la filosofia greca classica nella loro cultura, non ne
attinsero insieme anche l'ideale filosofico della vita.
Certo, ci furono sempre anche tra essi singole persone,
che nella loro professione
di fede convenivano con la
lode del poeta
felix
qui potuit rerum cognoscere causas.
Ma quando
Cicerone si accinse al compito di assegnare
alla filosofia greca un posto
stabile nel complesso della
cultura romana, pot, nei suoi libri Sullo stato, conci
liare lo spirito politico del suo popolo con la scienza
ellenica solo facendo proprio,
ad onta della sua venera
zione per
Platone e per
Aristotele, l'ideale dicearcbeo
dei 7toXrax?.
INDICE DELLE COSE PI NOTEVOLI
Accademia: sua fase tarda:
15 sgg.; mancanza di un'orga
nizzazione della ricerca scien
tifica: 21; dialettica; 22; co
munanza etica di vita : 28 ;
spirito dell'Accademia nel Pro-
treptico: 124 sgg.
Alcibiade: critica dell'ideale
alcibiadeo: 130.
Analitica, mentalit: 503
sgg-
Anamnesi: 65.
Anima: suo concetto: SI sgg.;
una sostanza: 52, 57; un
sKog: 57; evoluzione del suo
concetto inAristotele : 57 ;po
lemica di PJo ino controilcon
cetto aristotelico dell'anima
come entelechia: 57.
ps-rj: l'i. come simmetria
dell'anima: 55; le quattro &.
platoniche: 56, 96, 110, 374;
origine della teoria della pso-
n)i
: 56; definizione dell' d. :
325 ;inno all'i. : 140, 152;l'i.
ellenica: 154; 4. come forma
di uno dei tre pio:: 85, 102,
128, 315 sgg.; sua subordina
zione alla decupla: 128, 131,
322 sgg.; genesi della distin
zione dell'i,
dall'i. 8:a-
YOTj-EixV): 319; distinzione
gi platonica: 581 sgg.; . e
Ipyoi : 86; i.nei Magna Mo
rchia: 596 sgg,
Asso: sede dei Platonici Era-
sto e Corisco: 148; sede della
prima scuola di Aristotele:
149, 229 sgg., 252, 254, 343,
389 sgg.
Astri: ipotesi circa il moto de
gli astri: 186; loro natura ani
mata: 187 sgg,; loro libera
volont: 200 sgg.; influsso
delle teorie astronomiche: 204
sg. ; teoria dei motori delle
sfere: 470 sgg.; metafisica e
astronomia: 483 sgg.; numero
delle sfere: 471.
Astronomia: v. Astri.
Beni, teoria dei: 73, 94,
109, 130, 312, 373 sg.
pio:; 570 sgg. ;pio: cpioocpcov:
605 sg. ; plog evdsiog 617;
pio? 0-U)p7)t:x;: v. Vita
contemplativa;piog xpa-
xtocg: v. Vita attiva.
Delfi: decreto delfico di ono
ranze ad Aristotele: 442; ri
trattazione di tali onoranze :
434.
Dossografia: 559; sua di
pendenza dall'ideale della vita
contemplativa: 563 sgg.; da
quello della vita attiva: 602
sgg.
Educazione: ideale isocrateo
e ideale accademico dell'edu
cazione: 74; educazione alla
670 INDICE DELLE COSE 2>I NOTEVOLI
ricerca empirica minuta: 459 ;
concetto etico-pedagogico del
lo etato: 546.
Entelechia: 523 sgg,
E'itre: trattato con Ermia:
145.
Esattezza
matematica,
quile ideale dell'etica e poli
tica giovanile: 100, 113 sgg. ;
posteriorerifiutodiquestoidea-
le : 313 sgg. ;nella
Metafisica
:
462, 479 sgg.
Etere:primaformulazione pub
blica dell'ipotesi
dell'etere:
182; suo uso teologico: 189
sgg.; suoi motivi e sua evolu
zione inAristotele : 202
sgg. ;
nell'Accademia: 406; nett'Epi-
nomide;
189; se sia npjctov
o npt-cov
offifia:
190.
Etica: concezione giovanile di
Aristotele: HO; sua posizio
ne rispetto al Filebo: 113; po
sizione intermedia dell'Eude-
mta: 311 sgg.; suoi cambia
menti infattodimetodo: 315",
derivazione della sua struttura
dal Protreptico: 318 sgg.; ca
rattere teonoinico dell'etica
giovanile-. 323 sgg.; teologia e
etica della contemplazione:
576 sgg. ; sua critica nell'etica
pi tarda: 595, 600 6gg. ; in-
ttlUttuaSismoetico:542-,
amo
re di s: 330; problema
del
valore etico dello etato: 544
sgg.; come termine tec
nico: 594.
Fisica: suagenesi precoce: 400 ;
suo caratterespeculativo :405 ;
antichit delia cosmologia:
204, 406 sgg.; platonicit
dei
noi problemi: 415 ;tracce del
l'evoluzione : 186 sgg., 201;
importanza
per la teologia:
185 414 sgg. ; uso del IIspi,
rpiEooocpCco; nel Iltpi cvpavov:
408 sgg, ; causalit meccanica
e teleologiav 526 sg.; concetto
della natura: 97, 119 sg.
Forma: suo concetto: 463, 520
sgg., 551.
Fuoco: questione degli anlruali
viventi nel fuoco: 189 sgg.
Ideale della vita: 557 sgg.
E v. Vita attiva e Vita
contemplativa.
Idee:quando Aristotele ne con-
ditise la teoria: 67, 117 sgg.;
terminologia corrispondente:
118, 228; primapolemica con
tro le idee: 164 sgg.; teoria
delle idee ad Asso: 149, 229;
l'idea come ideale: 153; di
scussioni nell'Accademia sulla
teoria delle idee: 18,123 sg.;
teoria ormai nonpi attuale:
236 sg. ; nella Grande etica non
pi nemmeno discussa: 589.
Immortalit: 51 sgg., 215,
Intellettualismo: sua pro
gressiva accentuazione; 506
Sg-
Isole dei beati: 94 sgg., 126.
Logica: sua genesi precoce:
51 sgg. ; anche ladottrina del
le categorie 6 antica: 59 sg. ;
dialettica nei dialoghi: 60;
mentalit analitica: 503 sgg-;
logica inSocrate: 126; logica
del platonismo tardo: 16sgg. ;
metodo analogico: 189, 194;
astrazione: 504.
Montica: 215 sg., 323, 454;
(iivteia nel senso di intuizione
arcana: 211 sg.
Medicina: 457 sg., 551.
Metafisica: delimitazione pi
antica del suo mbito: 126 sg. ;
neli'EWemo: 61; nel Protrep
tico: 109; genesi del primo
motore; 186; carattere teo
logico della metafisica pi an
tica: 254, 261 sgg.; suo am
pliamento a dottrina della so
stanza: 271; contraddizioni:
287 sgg.; avversione dei Greci
pi antichi a indagare, mor-
JNDICE DELLE COSE Piti NOTEVOLI 621
tali, l'immortale: 94, 218; la
teoria dei motori delie sfere
tarda: 475 sgg.; critiche che
ad essa muovono Teofrasto e
Plotino:476 sgg. ;sue contrad
dizioni: 481; metafisica e ipo
lesi: 484 sgg.; carattere cri
tico della metafisica aristote
lica: 515 sgg.
Meto do: 16, 30, 94sg., 110 sgg.,
241 sg., 266, 350 sg., 357,
391 sgg., 417, 459 sgg.
p t
f
o v : inPlatone:55 ;pitpov
e psottjs: 56; il problema
della misura nell'etica:
113 sgg, V. anche Nor ma.
pEprjpa: 118 sgg.
Misteri: riecheggiament ari
stotelici del loro linguaggio:
131; religiosit mistico-senti
mentale: 212.
Mito: sua interpretazione ra
zionalistica: 180, 486; menta
lit mitologica inPlatone: 63,
66, 197, 206; in Aristotele:
66; miti nel dislogo: 60; g>;-
J.opi>SKe del filosofo : 436.
Mondo: intuizione del mondo:
56, 68, 129, 514 sgg.. 552;
quadrodeli' universo:529 sgg. ;
fuga dal mondo: 50, 130, 538 ;
senso cosmico: 217 sgg., 330
Sgg'
Neopitagorici: 41, S70 sgg.
Neoplatonici: 39, 78 sgg. (e
v.. nell'indicedei nomi, Giam-
blico, Plotino, Porfi
rio, Proclo).
Norma: concetto del valore
normativo: 100, III,121, 324
sgg., 387, 534 sgg.
Occulti, fenomeni: 213.
Organizzazione del la
voro scientifico: 21, 440
sgg-, 548 sgg.
Oriente: capperiifra la cul
tura orientale e l'Accademia:
172 sgg.
Ottimismo circa l'aldil: 61,
129 sgg., 538.
Parenesi: trasformazione del
l'antica parenesi ellenica:. 73
sg., 93 ; parenesi isocratea
71 sg.
Peripato: fondazione: 423;
sua posizione politica: 424 sg. ;
organizzazione e spirito della
scuola: 426 sgg.; opera di ri
cerca: 440 sgg.; programma
dell' indagineminuta: 460sgg. ;
discussione del problema delle
sfere: 468, 476, 489; evolu
zione della scuola dopo Ari
stotele: 553 sg,
Personalit: di Piatone: 25,
138, 141 sgg.; di Aristotele:
434 sgg. ;esperienza personale:
12, 50 sg., 125, 131, 153 (v,
anche Religione).
Pessimismo circa l'aldiqu:
61, 129 sgg., 538.
qpvTjot?: 85 sgg., 101 sg.;
evoluzioneterminologicae con
cettuale: 106 sgg., 321 sgg.,
578 sgg., 589 sgg.
Politica: concezione giovani
le: 350 sgg.; strati evolutivi:
362 sgg. ;fine etico dello stato:
371. 544 sgg, ; influssi della
realt politica: 389 sgg.; me
todo: 392.
Preesistenza: 64 sgg.
Preghiera; sua intimit spi
rituale: 212.
Psicologia: 451 sgg. (e v.
Anima).
Religione: come esperienza
inleriore'.211sgg.; genesi della
fede inDio; 213 ; conoscenza
di Dio; 218; filosofia della
religione: 206; dimostrazione
dell'esistenza di Dio: 209; re
ligione e metafisica: 515 sg.;
religione astrale : 181sgg. ; in
flusso della filosofia aristotelica
sull'evoluzione storica della re
ligione: 206.
622 IPTDICE DELLE COSE PI NOTEVOLI
Scienza: nuovo buo ideale: 88
sgg., 92, 115; progressi della
scieDza: 125; scienza e intui
zione del mondo : 462, 514
sgg., 552;storia della scienza :
455; filosofia scientifica: 508,
552.
Scolastica: 3, 502, 516.
Senso della vita, nel gio
vane Aristotele: 129 sgg.
Sistematica: 509 sgg.
Stoa: 198, 206, 216, 509 sgg.,
553.
tori a: come Aristotele inter
pret storicamente s stesso ;
1; storia della saggezza pi
antica: 168; eterno ritorno:
170, 179; storia delle scienze:
455 sgg.; interesse teorico che
ne determina la prima genesi :
549 sg-; astoricit dell' uni
verso aristotelico: 531.
" '!t
' come imitazione della
natura: 97; suo duplice signi
ficato: 353; la politica come
tvv] esatta : 100.
Teleologia: 86, 97, 522 sgg.
Teologia: genesi della teolo
gia ellenica: 181sgg., 183, 204,
206; problema della conoscen
za di Dio: 218; ateismo: 183;
universalismo: 220; etica teo-
nomica: v. Etica(e v. inoltre
Metafisica, Religione,
Astri).
Umanesimo: 5.
Universalismo: 220.
Vita attiva: suo ideale: 599
sgg. ; suo influsso sulla raffi
gurazione degli antichi filosofi:
602 sgg.
Vita contemplativa: 81
sgg., 104 sgg., 125 sgg., 537
sgg. ; genesi di questo ideale:
563 sgg. ;suo influsso sulla raf
figurazione degli antichi filo
sofi: 564 sgg.
INDICE DEGLI SCRITTI ARISTOTELICI
Categorie: 59.
Dialoghi: evoluzione formale:
30 sgg. ; influsso nel mondo
anticov 39;punto di vista pla
tonico: 39 sgg. ; posizione ri
spetto ai trattati: 40 sgg.;
polemica contro Platone: 45
sgg.; Xiyoi essoterici: 41 sgg.,
331 sgg.
Didascalie: 143.
iixatpata: 446.
Elegia dell'altare: 137 sgg.
Essoterici, s cri t ti:v. Dia
loghi .
Etica Eudemea:
titolo:309;
Eudemo non ne l'autore:
320; laprimaetica:320 sgg. ;
si vale del Protreptico
; 331
sgg. ; se ne vale laprima po
litica: 381 sgg.; data di com
posizione: 344.
Etica Nicomachea: opera
tarda; 107 sgg., 311 sgg., 320;
composizione : 318 sgg.
Eudemo: 49 sgg.
Fisica: genesi antica: 400; li
bro H: 402; rielaborazionc di
8 6: 488 sgg.; correzione di
Eudemo : 499 sg.
Inno ad Ermia: 152 sgg.
Mafix;: 177.
Magna Moralia: 583 sgg.
Irlet af isica: sua composizio
ne: 222 sgg.; il risultato di
un'intima evoluzione:226; la
prima metafisica: 227 sgg.;
sua data: 246 sgg.; inserzio
ne dei libri centrali: 265; an
tichit dei libri K e A: 279
sgg., 294 sgg. ; inserzione po
steriore di A 8: 469 sgg.
Meteorologia: 416.
Ntxat iiovooiaxcii: 444.
N6
fi
t pa:446,
Espi
<i>wv
xivrjaea)?: 484
sgg-
IIe p t tq'iov popiojv: 449.
[IIe p ! xop oo] : 98.
Ileel NsiXoo vagosoig:
450.
Espi opavo0:relativamen
te antico: 204, 405 sgg.; pre
suppone e utilizza ilHspl
f
i-
Xoaocpiaj: 410 sgg.
Depi epiXoootptas:
et e
struttura: 163 sgg.; utiliz
zalo nell'Eudemia: 344; nel
Espi opavo : 410 sgg.
ne pt u
xfi
: 451.
Pitionici, catalogo dei:
442 $g.
IIoXiTsta 'AS-r v a iv: 445,
noitctai: data: 445: sono
utilizzate nei libri IY-VI d.Ja
Pulizlca: 357.
624 INDICE DEGLI SCRUTI AHI3T0T1LI:i
Politica: struttura genera le c
trasposizione dei libri: 354;
suo programma formulato alla
fine della NUomaciea: 356;
rielaborazioneseriore: 357 sgg. ;
idue strati : 362;libro primo:
365 sgg.; citazioni: 367 sgg.;
data della prima politica: 370
sgg. ;vi sono utilizzati il Pro-
treptico
e l'Ei demca: 372 sgg.,
382 sgg.
ProDietili: 446 sgg,
Protreptico: l'orma c model
lo: 69 sgg.; estratti inGiarn-
blico : 78 sgg.
Storia degli animali:
448,
INDICE DEI NOMI DI PERSONA
Agostino: 39, 516.
Alessandro di Afrodisia:
40.
Alessandro di Fere: 49.
Alessandro Magno: 157,
432.
Anassagora: 98, 127, 340,
525, 556, 562 sgg., 606.
Anassimandro: 605.
Andronico: 4, 516 sg.
Apuleio: 191 sgg.
Archita: 60 sg., 609.
Aristocle di Messana: 136
sgg.
Arist osseno: 137, 219, 603sg.,
610 sg.
Aristotele: come egli stesso
interpret la propria filosofia:
1; come l'interpret la tradi
zione scolastica :3 sgg. ; forma
dei trattati :5sgg. ;periodo ac
cademico: 11 sgg.; sua po
sizione rispetto a Platone:
12 sgg., 136 sgg.; rispetto a
Eudosso: 19; dialoghi : 29,
34 sgg.; loro atteggiamento
platonico: 39 sgg.; dipenden
za e indipendenza da Platone
negli scritti giovanili : 56 sgg. ;
Eudemo: 49 sgg. ;Protreptico:
69 sgg.; ideale stilistico: 38;
etica giovanile: 113; senso
giovanile della vita filosofica
e religiosa: 125sgg. ;soggiorno
ad Asso: 135 sgg.; elegia del
l'altare:137sgg. ;amicizia con
Ermia: 114 sgg. ; scuola ad
Asso: 149; inno ad Ermia:
152 sgg. ;Aristotele a Mililene:
150; r. alla corte di Filippo,
e sua funzione politica a Pclla:
155 sgg.; Ar. e Alessandro:
156 sgg.; il Uspt jpUooocpiaf,
prima critica pubblica di Pla
tone: 161 sgg.; orientamento
teologico giovanile: 181 sgg.;
et dell'insegnamento ad Ate
ne: 421 sgg-; posizione poli
tica: 425; scuola e insegna
mento: 426 sgg.; ultima fase
dei rapporti con Alessandro :
431 sgg.; personalit ed am
biente: 434 sgg. ;ritralto: 437 ;
testamento: 437 sgg.; pro
gramma delle ricerche scienti
fiche: 460 sgg.; posizione sto
rica: 501 sgg.
Boezio: 39, 84.
Callippo (l'astronomo): 467
Bgg.
Callistene: 149, 153, 432 sgg.
Cefisodoro: 47 sgg.
Cicerone: 35, 37, 127, 181sgg.,
341 sgg., ecc. ;influsso di Di-
cearco su C. : 614 sgg.
Cleante: 188, 198, 216.
Clearco: 149.
Co rise o : 144 sgg., 341.
Cratete il cinico: 39.
Crisippo: 188.
40. W. Jasuer, ,4riitutei.
626 INDICE DEI POMI DI PERSONA
Demetrio di Falero: 425
S6S-
Democ are: 426.
Democrito: 98, 527, 556, 560,
606.
Demostene: 154, 422 sgg.,
546.
Dicearco: 599 sgg.
Didimo: 145, 148.
Diocle di Carisio: 20.
Diogene Laerzio: 42, 177.
Dione: SO.
Empedocle: 605.
Epicrate: 20, 23.
Epicuro: 98, 509. 553.
Eraclide Politico: 128, 569
sg., 608.
Eraclito: 98.
Evasto di Scepsi: 144 sgg.
Erraia: 144 sgg.
T.rmippo: 177 sg.
Ermodoro: 173 sg.
Kudezno di Cipro: 49.
Ludemo di Rodi: 307 sgg.,
499, 585.
Eudosso: 18 sgg., 172-79, 204,
467 sgg., 519.
Euripide: 564 sgg.
Filippo diMaccdonia: 155
sgg-
Filippo d'Opunte: 190, 200
sgg., 218 sgg., 572.
rilistione: 20.
Filone Ebreo: 183 sgg-, 187
sgg., 617.
Gimli lieo: 78 sgg., ecc.;
609 sgg.
Giustino: 611 sg.
Isocrate: 69 sgg.
Lucrezio: 98.
Melisso: 605.
Ne 1e o : 150.
Nicnore: 434 sgg,
Parmenide: 605.
ns pt xispoo. autore del : 98.
Pitagora: 127; creazione del
suo tipoidealenell'Accademia:
569 sgg. ;P. e pitagorismo nella
tradizione: 606 sgg. ;rapporti
fra platonici e pitagorici: 613.
Platone: dialoghi tardi: 16
sgg. ;personalit filosofica: 25
sgg. ; evoluzione formale ed
evoluzione filosofica: 30 sgg.;
relazione di Aristotele con P.:
12, 25, 34, 39 sgg., 136 sgg.,
.
179; successori: 143; autenti- .
cita della sesta lettera: 144; il
Rapi (piXosocpiag prima critica
pubblicadel sistema platonico:
164 sgg. ;equiparazione di P.
a Zaratustra quale fondatore
di religione: 178 sgg.; vita
attiva e vita contemplativa:
564 sgg. ; ecc.
Plinio il vecchio: 172 sgg.
Plotino: 57, 479 sgg.
Plutarco: 42 sgg., 67.
Pompeo Trogo: 611 sg.
Porfirio: 80, 610 sgg.
Posidonio: 99, 192 sg., 195,
215.
Proclo: 42 sgg., 67, 83.
Pseudo-Ocello: 586.
Seneca: 99.
Senocrate: 19, 144, 573.
Senofonte: 97, 188.
Sesto Empirico: 188, 511.
Sette savi: 571, 603 sgg.
Socrate: 15, 17, 126, 533 sgg..
566 sgg.
Speusippo: 19, 22.
StraV one: 151.
Talete: 560 sgg., 568, 603 eg.
Temisone di Cipro: 76.
Temistio: 63 sg.
Teofrasto: 150, 476, 483 ng.
488 sg., 559, 585, 599 sgg.
Teopompe: 145, 148, 175.
Timeo: 612.
Zaratustra: 172 sgg.
Zenone d'Elea: 65.
INDICE GENERALE
Prefazione dell'autore all'edizione originale . . . Pag.
ix
Prefazione dell'autore a questa traduzione ... x
It PROBLEMA 1
I. It PERIODO ACCADEMICO 9
1. L'Accademia quando vi entr Aristotele 11
2. Le opere giovanili 29
3. L'Eudemo ........ 49
4. Il Protreplico ..... ... 69
1. Forma ed intento, 69; 2. Sopravvivenza e rico
struzione del Protreptico, 78; 3. La filosofia del
Protreplico, 103.
II. Gli anni di maggio
...... 133
1. Aristotele ad Asso e in Macedonia ...135
2. Lo scritto pregrammatico lispt tpiXooorf ice; . . 161
3. La prima metafisica .....,221
1. II problema, 221; 2, Primitivo abbozzo della
critica delle idee e introduzione alla metafisica, 227 ;
3. Critica pi antica e critica pi recente della
teoria accademica dei numeri, 235.
4. L'evoluzione della metafisica ..... 259
5. La prima etica ..... 306
1. Relazione tra l'Eudemea c il Protreplico in or
dine allo sviluppo dei problemi, 311;2, UEudcmca e
il problema degli scritti essoterici, 331.
6. La prima'politica ........348
7. Genesi della fisica e cosmologia speculative . . 396
628 INDICE GENERALE
III. L'et
dell'insegnamento
.....
Pag. 419
1. Aristotele ad Atene ...... 421
2. L'organizzazione della ricerca scientifica . . 440
3. La trasformazione della teoria del primo motore . 466
La posizione storica di Aristotele .... 501
A) La mentalit analitica, 503; B) Speculazione e
scienza, 514; C) L'analisi dell'uomo, 533; D) La
filosofia come scienza universale, 548.
Appendice: genesi e ricorso dell'ideale filosofico
DELLA VITA 557
Indice delle cose pi notevoli . . 619
Indice degli scritti aristotelici ......623
Indice dei nomi di persona ...... 625
Finito di stampare nella Tipografa Luigi l'arma - Bologna
nel novembre 1961
Vous aimerez peut-être aussi
- Trombelli Filosofia Moderna ContemporaneaDocument375 pagesTrombelli Filosofia Moderna ContemporaneaNick AvramovPas encore d'évaluation
- Giovanni Casertano - La Nascita Della Filosofia Vista Dai GreciDocument72 pagesGiovanni Casertano - La Nascita Della Filosofia Vista Dai GreciDBW100% (1)
- Massimo FERRARI, Cassirer, Natorp e L'immagine Di PlatoneDocument29 pagesMassimo FERRARI, Cassirer, Natorp e L'immagine Di PlatoneargentazzuPas encore d'évaluation
- Verità, Dialettica e Persuasione in PlatoneDocument421 pagesVerità, Dialettica e Persuasione in PlatoneAlba MarínPas encore d'évaluation
- Aldo Stella Relazione in Severino e Hegel PDFDocument21 pagesAldo Stella Relazione in Severino e Hegel PDFCarla NatoliPas encore d'évaluation
- Enrico Berti Aristotele Dalla Dialettica Alla Filosofia PrimaDocument239 pagesEnrico Berti Aristotele Dalla Dialettica Alla Filosofia PrimaFederico Orsini100% (1)
- Berto Francesco - Severino E La Logica DialetticaDocument178 pagesBerto Francesco - Severino E La Logica DialetticaRenato Degli EspostiPas encore d'évaluation
- 8 - Taddio-Fenomenologia Eretica DefDocument402 pages8 - Taddio-Fenomenologia Eretica Defdaniele28Pas encore d'évaluation
- Bacchin - Originarietà e MediazioneDocument77 pagesBacchin - Originarietà e Mediazionekidmarco100% (4)
- Cassirer LowithDocument24 pagesCassirer LowithIulianButnaruPas encore d'évaluation
- Fichte e L'anarchia Del Commercio. Genesi e Sviluppo Del Concetto Di "Stato Commerciale Chiuso"Document254 pagesFichte e L'anarchia Del Commercio. Genesi e Sviluppo Del Concetto Di "Stato Commerciale Chiuso"Pablus HispaniumPas encore d'évaluation
- Nicola AbbagnanoDocument5 pagesNicola AbbagnanoOsiel HernandezPas encore d'évaluation
- Heidegger e Aristotele Il Primo Significato Della DymanisDocument29 pagesHeidegger e Aristotele Il Primo Significato Della DymanisGabriel de AlmeidaPas encore d'évaluation
- Pietro Abelardo, Scritti Di LogicaDocument369 pagesPietro Abelardo, Scritti Di Logicabentospinoza100% (1)
- Enrico Berti Contraddizione e Dialettica Negli Antichi e Nei ModerniDocument311 pagesEnrico Berti Contraddizione e Dialettica Negli Antichi e Nei ModernivalentinabalestracciPas encore d'évaluation
- AA. VV., Ricordo Di M. Dal PraDocument80 pagesAA. VV., Ricordo Di M. Dal Prabentospinoza100% (1)
- Masnovo - Ancora Alberto Magno e L'averroismo Latino PDFDocument10 pagesMasnovo - Ancora Alberto Magno e L'averroismo Latino PDFAlberti Magni Studiosus100% (1)
- Enrico Berti Le Idee Di PlatoneDocument2 pagesEnrico Berti Le Idee Di PlatoneraimpoPas encore d'évaluation
- Filosofia Politica Il MulinoDocument12 pagesFilosofia Politica Il MulinoLory PirasPas encore d'évaluation
- 5.3 Il Realismo Interno Di Hilary PutnamDocument9 pages5.3 Il Realismo Interno Di Hilary PutnamAndrea VolonninoPas encore d'évaluation
- 1051 MisticismoDocument11 pages1051 MisticismoVanessa MonteleonePas encore d'évaluation
- E' Possibile Negare Il Principio Di Non Contraddizione LabordaDocument12 pagesE' Possibile Negare Il Principio Di Non Contraddizione LabordaFederico VirgilioPas encore d'évaluation
- L. Mancini, Fere Femminote Sirene. Il Mito in Horcynus Orca Di Stefano D'ArrigoDocument15 pagesL. Mancini, Fere Femminote Sirene. Il Mito in Horcynus Orca Di Stefano D'ArrigoLoredana ManciniPas encore d'évaluation
- Salvatore Giammusso - Antropologia Filosofica e Natura UmanaDocument10 pagesSalvatore Giammusso - Antropologia Filosofica e Natura Umanaalfredo89Pas encore d'évaluation
- (Visentin, Messinese) Ripensando La Metafisica. Dal Trascendentale Moderno Alla Metafisica Originaria.Document13 pages(Visentin, Messinese) Ripensando La Metafisica. Dal Trascendentale Moderno Alla Metafisica Originaria.johannes borgenPas encore d'évaluation
- Dorato, Mauro - Istituzioni Di Filosofia Della ScienzaDocument70 pagesDorato, Mauro - Istituzioni Di Filosofia Della ScienzaRenato Degli EspostiPas encore d'évaluation
- Del Mar Più Che Del Ciel Amante . Bruno e CusanoDocument292 pagesDel Mar Più Che Del Ciel Amante . Bruno e CusanoJosé Manuel OsorioPas encore d'évaluation
- La Fenomenologia Della PercezioneDocument227 pagesLa Fenomenologia Della PercezioneJhonan JacobPas encore d'évaluation
- Heidegger - Identita e DifferenzaDocument28 pagesHeidegger - Identita e DifferenzaFabio Saccone100% (1)
- Parmenide - Pasqualotto PDFDocument30 pagesParmenide - Pasqualotto PDFAlessio Tovaglia100% (1)
- Ebraismo e antisemitismo nella società italiana: Una storia discontinuaD'EverandEbraismo e antisemitismo nella società italiana: Una storia discontinuaPas encore d'évaluation
- Bacchin HaploustatonDocument80 pagesBacchin HaploustatonEleutheros1100% (1)
- Nuzzo - Dialettica Negativa e Dialettica Speculativa. Adorno e HegelDocument12 pagesNuzzo - Dialettica Negativa e Dialettica Speculativa. Adorno e Hegelredolfiriva77Pas encore d'évaluation
- Spanio - Gentile e Il RealismoDocument18 pagesSpanio - Gentile e Il RealismoAnonymous 28AYvphsTfPas encore d'évaluation
- Aldo Masullo, Al Di Qua Del Linguaggio, Il PatireDocument13 pagesAldo Masullo, Al Di Qua Del Linguaggio, Il PatiresaffarooPas encore d'évaluation
- La Critica Antispeculativa Di Feuerbach - RambaldiDocument199 pagesLa Critica Antispeculativa Di Feuerbach - RambaldiLiliana BaldoPas encore d'évaluation
- Bacchin - L'Immediato e La Sua NegazioneDocument169 pagesBacchin - L'Immediato e La Sua Negazionekidmarco100% (2)
- L'emergere Del Negativo Nella Filosofia Giovanile Di HegelDocument22 pagesL'emergere Del Negativo Nella Filosofia Giovanile Di HegelbrenciofrancescaPas encore d'évaluation
- Bacchin - Lettura Metafisica Dei Todesgedanken Di FeuerbachDocument22 pagesBacchin - Lettura Metafisica Dei Todesgedanken Di FeuerbachkidmarcoPas encore d'évaluation
- Lycan - Filosofia Del Linguaggio RiassuntoDocument11 pagesLycan - Filosofia Del Linguaggio RiassuntoLorenzo PasqualePas encore d'évaluation
- Capizzi. La Repubblica Cosmica (Epub OCR)Document594 pagesCapizzi. La Repubblica Cosmica (Epub OCR)Riccardo Rouvigny Rimbaud100% (2)
- Il Nietzsche Di HeideggerDocument103 pagesIl Nietzsche Di Heideggertoninobello100% (1)
- Trabattoni Sui Caratteri Distintivi Della MetafisicaDocument11 pagesTrabattoni Sui Caratteri Distintivi Della Metafisicamontag2Pas encore d'évaluation
- 18 FirpoDocument38 pages18 FirposirfrogPas encore d'évaluation
- La quadratura del nulla. Nicola Cusano e la generazione del significatoD'EverandLa quadratura del nulla. Nicola Cusano e la generazione del significatoPas encore d'évaluation
- GOMPERZ Pensatori Greci Storia Della Filosofia Antica Vol 1 (Cap IV Anassagora PG 334) PDFDocument429 pagesGOMPERZ Pensatori Greci Storia Della Filosofia Antica Vol 1 (Cap IV Anassagora PG 334) PDFMarco Lombardi100% (1)
- E. Berti - Quale Metafisica Per Il Terzo MillenneioDocument13 pagesE. Berti - Quale Metafisica Per Il Terzo MillenneiodaPipernoPas encore d'évaluation
- Massimo Donà, La Resurrezione Di Piero Della FrancescaDocument59 pagesMassimo Donà, La Resurrezione Di Piero Della FrancescaFabrizio Antonilli MagroPas encore d'évaluation
- Berti Il Platone Di Krämer PDFDocument15 pagesBerti Il Platone Di Krämer PDFdrklenartPas encore d'évaluation
- Lettieri LezioniDocument54 pagesLettieri LezioniGiuseppe QuattrominiPas encore d'évaluation
- De Hominis Dignitate - Pico Della MirandolaDocument19 pagesDe Hominis Dignitate - Pico Della MirandolaSintesi85Pas encore d'évaluation
- Verso L'inclusive EducationDocument15 pagesVerso L'inclusive EducationGiuliaCoelliRigoPas encore d'évaluation
- G Sussidi III Tappa Gerusalemme Genitori PDFDocument92 pagesG Sussidi III Tappa Gerusalemme Genitori PDFapi-421393782Pas encore d'évaluation
- 893 DAmore Presentaz Duval in ItalianoDocument4 pages893 DAmore Presentaz Duval in ItalianotchixaPas encore d'évaluation
- Pharos Convegni 2005Document53 pagesPharos Convegni 2005Emanuele GiustiniPas encore d'évaluation
- ERASMUS - Punteggi Graduatoria Ingegneria PadovaDocument2 pagesERASMUS - Punteggi Graduatoria Ingegneria PadovaMauro PiazzaPas encore d'évaluation
- Concursodia 4Document34 pagesConcursodia 4Edin CallesPas encore d'évaluation
- Didattica InclusivaDocument130 pagesDidattica InclusivaMilena VenierPas encore d'évaluation