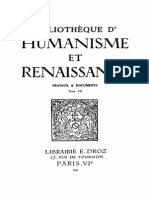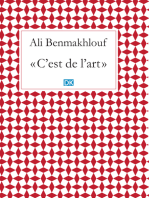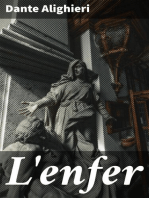Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Materni, Marta - Attività Scientifiche Di Gerberto D'aurillac
Materni, Marta - Attività Scientifiche Di Gerberto D'aurillac
Transféré par
Roberto SchiavolinTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Materni, Marta - Attività Scientifiche Di Gerberto D'aurillac
Materni, Marta - Attività Scientifiche Di Gerberto D'aurillac
Transféré par
Roberto SchiavolinDroits d'auteur :
Formats disponibles
Marta Materni
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
DI GERBERTO D’AURILLAC
Résumé
La figure de Gerbert d’Aurillac — le pape Sylvestre II s’est toujours distinguée,
dans l’imaginaire historique, par sa particulière inclination pour les disciplines
du quadrivium. En même temps que le contact avec des éléments d’origine arabe,
cette activité “scientifique” a donné lieu dans les siècles, autour du scolastique
de Reims, aussi bien à une légende noire que à des enthousiastes attributions
scientifiques tout à fait anachroniques. Pendant les derniers vingt ans, en
particulier à commencer par les congrès de Bobbio, on a constaté un renouveau
d’intérêt pour ce personnage, et une reconsidération de son oeuvre “scientifique”
qui a permis, en même temps, aussi bien de reconduire à de plus justes propor-
tions ses connaissances que d’avancer des nouvelles attributions, en particulier,
en ce qui concerne les éléments orientaux. Cette revue bibliographique veut
présenter un panorama d’ensemble sur la figure de Gerbert en tant qu’expert du
quadrivium, à commencer par l’époque de son séjour en Catalogne, qui se
configurera dans l’imaginaire comme un moment déterminant pour sa forma-
tion, en cherchant surtout de reconstituer le réseau de ses probables relations.
On continue puis en analysant ses compétences dans chaque discipline du
quadrivium, en suivant son enseignement près de l’école de la cathédrale de Reims.
Il en résulte une figure située plus correctement dans son contexte historique,
mais qui n’en est pas moins surprenante: l’intérêt pour Gerbert se déplace d’une
question de contenus à une question de méthode et d’esprit.
Abstract
In the common historical view the personality of Gerbert of Aurillac — pope
Silvestre II has been always characterized by his peculiar bent for the quadrivium’s
arts. This “scientific” activity, at the same time as the contact with some data
from the Arabic world, generated in the course of centuries, about the Reims’
school-master, both a dark legend and some enthusiastic scientific attributions
that were decidedly anachronistic. As from the latest twenty years, particularly
thanks to the Bobbio’s conferences, there has been an interest’s return in this
personage and a revaluation of his scientific work. This fact permitted some ex-
acter reappraisals and yet some new attributions, especially about the eastern
components of his knowledge. This bibliographic review wants to present a glo-
bal outline of Gerbert’s figure as quadrivium’s student as from the time of his
stay in Catalogne, that will seem as a crucial moment for his cultural education
in the mind of the contemporaries and of the posterity; it tried especially to re-
construct his probably acquaintances’ network. Then it analysed his competences
in the single disciplines in accordance with his teaching at the Reims’ cathedral’s
school. Consequently this figure is situated more correctly in her historical con-
text, but in spite of all this she isn’t less remarkable: the interest for Gerbert moves
from question of contents to a question of method and spirit.
ABob xxix - 1
Mate.Testo.PM 1 2008.02.13, 7:34
Scolastico di Reims, arcivescovo di Ravenna, abate di Bobbio,
precettore di Ottone II prima, di Ottone III poi, papa infine dal 999
al 1003, destinato quindi ad occupare la cattedra di Pietro allo
scoccare del fatidico anno Mille, Gerberto d’Aurillac appare senza
dubbio come uno dei protagonisti indiscussi sulla scena della fine
del primo millennio1.
Quale fedele segretario dell’arcivescovo Adalberone di Reims,
egli svolse un ruolo di primissimo piano nella complessa vicenda
che portò all’ascesa della dinastia capetingia. Fu il maturo, amato,
precettore che stette al fianco di un imperatore adolescente
nell’ultimo tentativo di restaurare la gloria di Roma fra le rovine
dell’Urbe, ricordando nel suo stesso nome di papa quello di chi,
secoli avanti, aveva battezzato il primo imperatore cristiano. Fu
sotto il suo pontificato che venne incoronato re Stefano I
d’Ungheria, contribuendo ad affermare la presenza della Chiesa
cattolica nell’est europeo. Forse nella sua lettera a Gerusalemme
balena l’idea di una crociata 2; forse in quell’anno Mille ci fu
1 Per una panoramica generale sulla situazione politica, sociale e culturale del decimo
secolo si vedano RICHÉ 1999 e HOMMES 2004, in particolare per gli aspetti culturali
OLDONI 2004 e ZIMMERMANN 2004.
2 GERBERT, Correspondance, Ep. 28, anno 984: «Ex persona Iherusalem devastatae, uni-
versali aecclesiae. Ea quae est Hierosolimis, universali ecclesiae sceptris regnorum
imperanti. Cum bene vigeas, immaculata sponsa Dei, cujus membrum esse me fateor,
spes michi maxima per te caput attolendi, jam pene attritum. An quoquam diffiderem
de te, rerum domina? Si me recognoscis tuam, quisquamne tuorum famosam cladem
illatam michi putare debebit ad se minime pertinere, utque rerum infimam abhorrere?
En quamvis nunc dejecta, tamen habet me orbis terrarum optimam partem sui. Penes
me, prophetarum oracula, patriarcharum insignia, hinc clara mundi lumina apostoli
prodierunt, hic Christi fidem repperit, apud me redemptorem suum inveni. Etenim
quamvis ubique sit divinitate, tamen hic humanitate natus, passus, sepultus, hinc ad
caelos elevatus. Sed cum propheta dixerit: “Erit sepulchrum ejus gloriosum”, paganis
sancta loca subvertentibus, temptat diabolus reddere inglorium. Enitere ergo, miles
Christi, esto signifer et conpugnator, et quod armis nequis, consilio et opum auxilio
subveni. Quid est quod das, aut cui das? Nempe ex multo modicum, et ei qui omne
quod habes gratis dedit, nec tamen ingratus recepit. Etenim hic multiplicat, et in fu-
2 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 2 2008.02.13, 7:34
qualcosa che si precisò solo secoli dopo con il primo giubileo
ufficiale indetto da Bonifacio VIII3.
Ma in tutta questa straordinaria carriera politica la costante che
emerge maggiormente nella raffigurazione di Gerberto d’Aurillac
– Silvestro II, sia durante la sua vita sia, e ancor più, dopo la sua
morte, è quella del grande sapiente. Gerberto è sempre, e innanzi
tutto, il più celebre maestro del X secolo.
Maestro di retorica, che compone il suo epistolario sul modello
ciceroniano, offrendolo al pubblico non solo come memoria del
suo agire ma anche come testimonianza di quel bene dicere che è
garanzia di bene facere:
«...Cumque ratio morum dicendique ratio a philosophia non
separentur, cum studio bene vivendi semper coniunxi
studium bene dicendi...»4
Maestro di filosofia, che nella prefazione al suo trattato filosofico
augura al giovane Ottone III di superare in ingegno ed eloquenza
gli antichi Greci e Latini:
«...Noster es Caesar, Romanorum imperator et Auguste, qui
summo Grecorum sanguine ortus Grecos imperio superas,
Romanis hereditario jure imperas, utrosque ingenio et
eloquentia praevenis...».5
Ma soprattutto egli è maestro di quadrivium6.
Uomo di scienza sullo scorcio del X secolo, educato in gioventù
in una terra di confine, nella Marca Hispanica, a diretto contatto
con il mondo dei mori di Spagna, portatori agli occhi dei latini di
turo remunerat, per me benedicit tibi, ut largiendo crescas, et peccata relaxat, ut secum
regnando vivas». Si veda al proposito MOR 1952 e LIGATO 2001.
3 Cf. MONTECCHIO 2000.
4 GERBERT, Correspondance, Ep. 44, a Evrardo abate di Tours, inizio del 985.
5 GERBERTUS, De rationale.
6 Si veda al proposito, sul valore dell’insegnamento del quadrivium, LEVET 1990 e 1997c.
ABob xxix - 3
Mate.Testo.PM 3 2008.02.13, 7:34
una sapienza occulta, Gerberto passerà alla storia tanto come il
papa-mago iniziato a un oscuro e diabolico sapere, quanto come
l’inventore di straordinari strumenti in anticipo di secoli sui tempi.
Una leggenda demoniaca, nata nel 1084 ad opera del cardinale
Bennone di Osnabrück7, che segnerà irrimediabilmente la fama
del papa dell’anno Mille, guadagnandosi l’ufficialità non solo del
Liber Pontificalis (DUCHESNE, Liber) ma anche quella di una lapide
diffamatoria posta sul suo sepolcro in S. Giovanni in Laterano.
Una leggenda assai dura a morire se ancora nel 1981 la biografia
scritta da Mario Bacchiega (BACCHIEGA 1981) si intitola Silvestro II
papa mago. Una prima analisi di questa leggenda, accompagnata
da una ricca antologia di testi, tutti con traduzione, è contenuta
nel testo di Arturo Graf del 1892-93, Miti, leggende e superstizioni
del Medioevo, recentemente ripubblicato (GRAF 2002). Estremamente
dettagliata l’analisi di Massimo Oldoni apparsa nell’arco di un
decennio sulle pagine di Studi medievali (OLDONI 1977), e poi ripresa
in OLDONI 1985 e OLDONI 2001. Qualche accenno è presente anche
nel testo di Michael Kieckhefer (KIECKHEFER 2004) dove la leggenda
gerbertiana, i cui caratteri sono condivisi peraltro anche da altri
intellettuali tacciati di magia, è descritta nel cap. VI dedicato alla
cultura araba e alle scienze occulte8.
7 Nella lotta fra Enrico IV e Gregorio VII, il cardinale Bennone di Osnabrück si schierò
dalla parte dell’antipapa nominato dall’imperatore. Si impegnò allora in un violento
attacco contro il papa, teso a dimostrare non solo l’eterodossia di Gregorio ma la
profonda corruzione della sede pontificia, da tempo covo di eretici e negromanti;
Bennone (BENNONE, Gesta Romanae) ricostruisce quindi una storia intellettuale della
Chiesa romana che vede avvicendarsi una serie di papi maghi, serie che, data la sua
biografia intellettuale, trovava il capostipite naturale in Gerberto d’Aurillac. La
singolare esperienza del viaggio in Catalogna, l’allusione, peraltro senza esplicito scopo
diffamatorio, di Ademaro di Chabannes a un soggiorno a Cordova (si veda NUVOLONE
2001b), lo spettro quindi del contatto diretto con questo sapere arabo ancora avvolto
dal sospetto, le oscure origini e la straordinaria carriera politica ed ecclesiastica, lo
studio delle scienze e in particolar modo dell’astronomia: la vita di Silvestro II
conteneva realmente tutti gli elementi per creare una leggenda. Per la biografia del
cardinale si veda ZAFARANA 1966.
8 Si segnala, come curiosità, che la figura di Gerberto, con la sua leggenda nera, non
ha ancora cessato di suscitare fantasie letterarie. È del 1996 la pièce teatrale La Cabeza
4 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 4 2008.02.13, 7:34
È a partire dal XVII secolo, con l’edizione (nel 1611), peraltro
piena di errori di trascrizione, della lettera a Costantino De
numerorum multiplicatione et divisione da parte di Jean Masson,
arcidiacono della cattedrale di Bayeux, che la figura di Gerberto
scienziato comincia lentamente a riemergere. Nel XVIII secolo si
scoprono la lettera a Costantino De sphaerae constructione,
pubblicata da Jean Mabillon negli anni ’40, e, grazie a Bernard
Pez, nel 1721 (PEZ 1721), gli scritti geometrici, la Geometria Gerberti
e la lettera a Adelboldo di Utrecht. Bisognerà però attendere il 1835
perché Jacques-Paul Migne, nel volume CCCXXXIX della sua
Patrologia Latina, dia alle stampe la prima raccolta di tutti i testi
scientifici di Gerberto; seguirà quindi, nel 1867, l’opera di A. Olléris,
Oeuvres de Gerbert (OLLÉRIS 1867), e infine, nel 1898, l’edizione per
eccellenza degli Opera Mathematica dello scolastico di Reims a cura
di N. Bubnov (BUBNOV 1899, ristampato).
Contemporaneamente, numerose sono state anche le edizioni
dell’epistolario gerbertiano, fonte principale, assieme agli
Historiarum libri quatuor del suo allievo remense Richero9 (RICHERUS,
Historiarum), per la ricostruzione della biografia e dell’opera
del Diablo, del drammaturgo spagnolo contemporaneo Jesús Campos García,
consultabile on-line all’indirizzo http://www.jesuscampos.com/pdf/30lacabeza.pdf
e pubblicata nel volume Jesús Campos, Es mentira, A ciegas. La Cabeza del Diablo, Sevilla,
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 2002. Questa, significativamente,
l’introduzione dell’opera: «Obra en la qual se representa la historia de Gerberto
d’Aurillac: arabista, matemático, mecánico, inventor y filósofo maestrescuela de Reims;
el cual ocupó el solio pontificio en las postrimerías del milenio con el nombre de
Silvestre II, y de quien se dija, sin mayor fondamento, que llegó poseer la Cabeza del
Diablo. La acción transcurre en Córdoba, Roma, Reims, Rávena, Paterno y Jerusalem
hace sólo 1000 años». E a Gerberto ha dedicato un romanzo, Gerbert, in progress dal
1999, il prof. Paolo Rossi ordinario di Fisica presso l’Università di Pisa, romanzo
consultabile all’indirizzo http://www.df.unipi.it/~rossi/ romanzi.html.
9 Le Historiae di Richero, composte su invito dello stesso Gerberto e redatte in due
momenti, nel 995-996 e nel 997-998, coprono un arco cronologico che va dalla morte
di Eudes (888) alla morte di Ugo Capeto (996) e sono geograficamente concentrate
nell’area della Francia dell’Ovest e della Lotaringia. Fondamentale per ricostruire la
ABob xxix - 5
Mate.Testo.PM 5 2008.02.13, 7:34
dell’aquitano: si segnalano, oltre l’edizione di Migne sempre nel
volume CCCXXXIX della Patrologia Latina, quella di Julien Havet,
Lettres de Gerbert (HAVET 1889); la traduzione inglese di Harriet Pratt
Latin del 1961, The Letters of Gerbert (LATTIN 1961); l’edizione di
Fritz Weigle del 1971, Die Briefsammlung Gerberts von Reims (WEIGLE
1971); la traduzione italiana L’epistolario di Gerberto in PAVINI 1980;
infine la recente edizione e traduzione francese condotta da Pierre
Riché e Jean Paul Callu nel 1993 per Les Belles Lettres (GERBERT,
Correspondance), edizione che presenta in appendice i testi scientifici
epistolari di Gerberto curati da A. Philippe Segonds (GERBERT,
Lettres scientifiques)10.
Numerose anche le biografie realizzate a partire dalla seconda
metà del XIX secolo: Hock, Silvestro II Papa e il suo secolo (HOCK
1846); Lauser, Gerbert : Etude historique sur le 10e siècle (LAUSER 1866);
Picavet, Gerbert, un pape philosophe (PICAVET 1897); La Salle de
Rochemaure, Gerbert, Silvestre Deux. Le savant, le “faiseur de rois”, le
pontife (LA SALLE 1914); Leflon, Gerbert : Humanisme et chrétienté au
Xe siècle (LEFLON 1940); Pratt Lattin, The Peasant Boy Who Became
Pope: Story of Gerbert (LATTIN 1951); Trystram, Le coq et la louve:
Gerbert et l’an Mille (TRYSTRAM 1984). La più completa biografia di
recente pubblicazione è quella di Riché, Gerbert d’Aurillac. Le pape
de l’An Mil (RICHÉ 1987, riveduta nel 2006 e tradotta in italiano nel
1988), alla quale si fa riferimento in questo lavoro; l’ultima, ma di
dimensioni ben più modeste, quella di Pladevall Font, Silvestre II
(Gerbert d’Orlhac) (PLADEVALL 1998).
biografia intellettuale di Gerberto è il libro III, dove l’autore dà notizia del viaggio
dell’aquitano nella Marca Hispanica e descrive l’insegnamento dello scolastico alla
scuola di Reims. Vedere al riguardo PALADINO 2007.
10 Nel presente lavoro le citazioni sono tratte da: l’edizione di Migne per la Geometria
Gerberti (GERBERTUS, Geometria); quella di Riché-Callu per l’epistolario (GERBERT,
Correspondance); di Ségonds per le lettere scientifiche (GERBERT, Lettres scientifiques);
per il trattatello De utilitatibus astrolabii, solo recentemente attribuito a Gerberto e non
senza lo scetticismo di alcuni studiosi, si è fatto riferimento all’edizione pubblicata
nel 2000 da Gemma Puigvert i Planagumá in appendice a PUIGVERT 2000b. Per una
storia delle edizioni dei testi di Gerberto si veda HUGLO 2000, p. 145-148.
6 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 6 2008.02.13, 7:34
Tuttavia è solo negli ultimi decenni che si è intrapreso uno stu-
dio dettagliato dell’opera scientifica di Gerberto d’Aurillac,
tentando di discernere con precisione quanto di reale vi fosse nella
sua leggenda di giovane educato a contatto con la cultura araba, e
cercando altresì di liberarsi di un’altra leggenda fiorita intorno
all’aquitano, quella cioè nata dalla glorificazione francese
ottocentesca che ne fece uno straordinario inventore: di telescopi,
di orologi meccanici e di congegni che sfruttavano la forza del
vapore, come illustrato in LINDGREN 2001.
A riportare in auge il nome di Gerberto hanno poi contribuito
notevolmente i Congressi Internazionali organizzati a Bobbio da
F. Nuvolone e da M. Tosi: il primo del 1983 (TOSI 1985), il secondo
del 2000 (NUVOLONE 2001a), il terzo dell’ottobre 2004 (NUVOLONE
2005a), accompagnati dalla regolare pubblicazione annuale della
rivista Archivum Bobiense, all’interno della quale lo scolastico di
Reims occupa un ruolo di primo piano. Sulla scia di queste
iniziative sono nati così anche altri congressi organizzati in luoghi
significativi della biografia gerbertiana: quelli di Aurillac del 1996
(CHARBONNEL 1997) e del 1999 (RICHÉ 2000), e quello di Vic-Ripoll
del 1999 (OLLICH 1999). Inoltre il nome di Gerberto compare sempre
più spesso nei contributi di congressi dedicati alla storia della
scienza medievale (si vedano ad es. FREGUGLIA 2000 e SCIENCE 2000).
Negli stessi anni si sono poi moltiplicati gli studi relativi alla
Catalogna del X secolo (si veda oltre), in particolare quelli condotti
da M. Zimmermann, ad esempio ZIMMERMANN 2003, i quali hanno
posto in evidenza precoci fenomeni di traduzione dall’arabo che
ridisegnano le origini del processo di trasmissione della cultura
araba all’Occidente latino. È da segnalare poi il lavoro ancora
inedito di M. Zuccato recensito in NUVOLONE 2005f, il quale offre
un quadro dettagliato degli scambi scientifici realizzatisi nel X sec.
tra mondo islamico e latino in area catalana, mettendo in evidenza
tracce di conoscenze di origine araba, finora non individuate,
presenti nell’opera di Gerberto. Si tratta della sua tesi di dottorato,
sostenuta presso l’Università di Melbourne, e intitolata The earli-
ABob xxix - 7
Mate.Testo.PM 7 2008.02.13, 7:34
est filtration of Arabic science in the Latin world: Gerbert d’Aurillac and
the case of “Gotmar’s circle”.
Gli ultimi anni hanno visto così, rispetto all’opera scientifica di
Gerberto d’Aurillac, mutamenti nelle attribuzioni dei testi, analisi
puntuali delle fonti utilizzate, un ridimensionamento della sua
fama di scienziato e al tempo stesso il riconoscimento della
presenza effettiva di elementi estranei alla tradizione antica.
Nella presente rassegna bibliografica si prenderà in
considerazione dapprima il momento decisivo del soggiorno di
Gerberto in Catalogna fra il 967 e il 970, quindi la sua attività
scientifica, analizzando singolarmente ciascuna disciplina del
quadrivium.
Cap. 1
L’educazione di Gerberto d’Aurillac
Le Storie di Richero ci indicano con chiarezza che la formazione
scolastica di Gerberto si è svolta in due momenti e in due luoghi
differenti. Dapprima nel suo monastero d’origine, Saint Géraud
d’Aurillac, ove riceve un’istruzione di base comprendente la
grammatica e — come si può arguire da quello che era il comune
cursus di studi di un giovane monaco — almeno nozioni elementari
di retorica e di computo: i maestri di Gerberto ad Aurillac sono
identificati in L ABANDE 1985; per un quadro generale
sull’insegnamento di base alto-medievale si faccia riferimento a
RICHÉ 1984, in particolare p. 230-244, e RICHÉ 2006, p. 37-68.
Successivamente — e sarà questa l’esperienza che
maggiormente segnerà l’attività e la fama di scienziato dello
scolastico di Reims — fra il 967 e il 970 il giovane monaco soggiorna
nella Marca Hispanica, la Catalogna del X secolo, scoprendo quel
quadrivium allora pressoché dimenticato nel resto dell’Occidente11.
11 L’episodio suggerisce almeno una riflessione: l’atteggiamento dell’abate, Géraud
de Saint-Céré, che prega il conte barcellonese Borrel di portare con sé il giovane perché
8 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 8 2008.02.13, 7:34
La Catalogna in cui Gerberto compie il suo viaggio,
politicamente dominata dalla dinastia dei conti di Barcellona (ZIM-
MERMANN 1991 e 1996), si presenta come un ambiente culturale
vivace e attivo, ma soprattutto direttamente legato a quella Spagna
islamica che appunto nel X secolo raggiunge l’acme della sua
potenza.
È proprio il legame con tale realtà culturale drasticamente
“altra” rispetto a quella occidentale latina che fa della Marca
Hispanica un unicum nell’Europa medievale, la sola area cristiana
in cui nel X secolo si possano studiare con profitto le scienze esatte
attingendo non solo al patrimonio della tradizione classica, ma
avendo anche la possibilità di entrare in contatto con la cultura
scientifica elaborata in seno alla civiltà islamica, dalla quale
pervennero all’Occidente molti elementi di novità, soprattutto nel
campo della matematica e dell’astronomia. È infatti attraverso la
via catalana (e in questo senso anche Gerberto darà, come vedremo,
un suo pionieristico contributo) che penetrano in Europa alcuni
elementi essenziali per lo sviluppo del pensiero scientifico, fra i
quali il sistema di numerazione decimale posizionale e l’astrolabio;
tutti elementi importanti non tanto in sé per sé, ma in quanto vanno
a costituire le basi di quel bagaglio tecnico di cui gli scienziati
europei potranno poi avvalersi per le loro successive speculazioni.
possa istruirsi, e anche dei confratelli di Gerberto dal momento che essi non esitano a
offrire il loro consenso, è testimonianza del rinnovato fervore intellettuale degli
ambienti monastici ed episcopali del X secolo, spesso in corrispondenza con
l’affermarsi delle riforme monastiche; al proposito si veda quanto ricordato dallo stesso
Richero riguardo all’attività di Adalberone, appena eletto vescovo di Reims: «... Quo
tempore, monachorum religio admodum floruit, cum eorum religionis peritissimus
metropolitanus huius rei hortatur esset et suasor. Et ut nobilitati suae in omnibus
responderet, aecclesiae suae filios studiis liberalibus instruere utiliter querebat…»
(RICHERUS, Historiarum, III, 42), o si consideri lo zelo di Arnulfo nell’arricchire la
biblioteca di S. Maria di Ripoll e nell’incentivare l’attività dello scriptorium all’indomani
della sua elezione ad abate (su Arnulfo e il monastero di Ripoll vedi oltre). Sugli
effetti culturali delle riforme monastiche del X secolo si veda RICHÉ 1984, p. 127-128;
CONSTABLE 1990.
ABob xxix - 9
Mate.Testo.PM 9 2008.02.13, 7:34
1.1. La Catalogna
Alla metà del X secolo l’ambiente culturale catalano, descritto
nel già citato ZIMMERMANN 2003, si presenta composto da tre diversi
elementi: la tradizione della cultura visigota, la cultura carolingia
e, fattore questo più caratterizzante, l’apertura verso il sapere arabo.
Il sostrato di tale complesso profilo è costituito dall’elemento
visigoto, una tradizione intellettuale di matrice latino-ecclesiastica
che, nei suoi termini generali, è una continuazione diretta della
cultura antica. La penisola iberica, in cui era stato istituito il regno
visigoto, aveva infatti rappresentato un’eccezione rispetto agli altri
regni romano-barbarici, costituendo un’isola felice di
sopravvivenza della cultura latina: il VII secolo, che vede il
definitivo estinguersi della tradizione scolastica dell’età classica,
produsse invece in Spagna un’opera come quella di Isidoro di
Siviglia, il quale, con le sue Etymologiae, diede vita all’enciclopedia
per eccellenza del mondo medievale. Né tale tradizione cedette di
fronte all’invasione araba, ma seguì senza estinguersi la ritirata
dei profughi cristiani negli stati del Nord della penisola,
penetrando anche al di là dei Pirenei. Non va tuttavia dimenticato
che si tratta di una cultura essenzialmente letteraria e oratoria:
benché infatti si registrino casi di interesse nei confronti delle disci-
pline scientifiche, nel campo dell’insegnamento però, rispetto al
canone antico delle arti liberali, è ormai caduto nell’oblio non solo
tutto il sistema del quadrivio ma anche l’ultima branca del trivio,
cioè la dialettica.
Su questa base, comune a tutto l’ambiente ibero-cristiano, si
innesta, all’indomani della costituzione della Catalogna come
Marca Hispanica, la cultura carolingia. Tale innesto fu
particolarmente fruttuoso e incisivo in quanto non fu il frutto di
un’imposizione di politica culturale diretta dall’alto e dall’esterno,
ma penetrò al seguito della riforma liturgica secondo il rito
occidentale, e della contemporanea e ancor più radicale riforma
monastica secondo la regola benedettina. Non da ultimo, la cultura
carolingia si affermò anche grazie all’adozione della nuova scrittura
10 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 10 2008.02.13, 7:34
carolina, in sostituzione della tradizionale minuscola visigotica.
In relazione a questi primi due elementi culturali risultano
interessanti i lavori di M. C. Diaz y Diaz (DIAZ Y DIAZ 1969 e 1964)
dedicati alla circolazione dei manoscritti e alla trasmissione dei
testi antichi nella penisola iberica fra VIII e IX sec. oltre che LACARRA
1963. Un parallelo con l’ambito francese è offerto da VERNET 1974.
Il terzo elemento che concorre a caratterizzare questo ambiente
intellettuale è quello arabo, assorbito dapprima attraverso l’azione
mediatrice dei mozarabi, e poi, proprio a partire dalla metà del X
secolo, attraverso il contatto diretto sia con i sapienti arabi sia con
i loro testi, di cui inizia una prima, non sistematica, opera di
traduzione in latino. Il X secolo vede allora realizzarsi episodi come
quello del viaggio alla corte cordovese di Gotmar IV, vescovo di
Gerona e ambasciatore del conte catalano Sunyer, il quale offre al
figlio del califfo Abd-ar-Rahman III, al-Hakam II12, la sua Cronica
regum Francorum (940 ca.)13; delle ambasciate inviate dal conte
Borrell a Cordova a partire dal 950 d.C., grazie alle quali si
stabiliscono rapporti amichevoli fra le due autorità14; o l’episodio,
nel 953, del viaggio di Giovanni di Gorze (per il quale si veda
PARISSE 1996 e MCCLUSKEY 1998, p. 166-170), monaco interessato a
12 Con il califfato di Abd-ar-Rahman III (922-961 d.C.) e del suo successore, il figlio al-
Hakam II (961-979 d.C.), il regno indipendente di Cordova raggiunge la massima
espansione territoriale, riuscendo anche a ottenere il riconoscimento ufficiale degli
stati cristiani; ma soprattutto i due califfi proseguono attivamente in quell’opera di
mecenatismo che nel secolo precedente, con Abd-ar-Rahman II (822-853 d.C.), aveva
dato avvio all’ascesa culturale di al-Andalus, attirando alla corte cordovese intellettuali
e artisti provenienti da Oriente e segnando così l’inizio della massiccia influenza della
tradizione araba orientale, sentita come espressione di nobiltà culturale, sull’arabismo
occidentale. Sui rapporti culturali fra il califfato ommayade e la parte orientale
dell’impero, e più in generale per una prima introduzione al mondo islamico iberico,
si veda ALBORNOZ 1965, GABRIELI 1974, WATT 1991, e per l’aspetto scientifico VERNET
1965.
13 Cf. RICHÉ 1984, p. 137; RICHÉ 1991, p. 375; ZIMMERMANN 1996, p. 91; PUIGVERT 2000b, p.
32.
14 Cf. ZIMMERMANN 1996, p. 92.
ABob xxix - 11
Mate.Testo.PM 11 2008.02.13, 7:34
problemi di computo astronomico, scelto da Ottone I come suo
rappresentante in un’ambasciata diretta a Cordova, dove Giovanni,
nell’arco di un triennio, risiederà più volte alla corte di Abd ar-
Rahman III. Per quel che riguarda poi l’argomento specifico della
cultura scientifica della Catalogna medievale rimangono
fondamentali, come base di partenza, i lavori di Millás Vallicrosa,
MILLÁS VALLICROSA 1931, 1949 e 1960.
La Marca Hispanica dell’epoca di Gerberto si presenta dunque
aperta a influssi culturali stranieri tanto a ovest, verso il mondo
islamico, quanto a est, verso il mondo franco meridionale. Ed est
significa non solo regno franco, ma anche Roma: nel X secolo,
infatti, si registrano numerosi viaggi di vescovi, conti e abati
catalani nella città papale per ottenere dal pontefice immunità e
privilegi e, nello spirito della riforma cluniacense, porre i centri
ecclesiastici sotto la protezione diretta della sede di Roma, ma
soprattutto per cercare di riunire le chiese catalane in una metropoli
indipendente da quella di Narbona (proprio questo scopo avrà
anche il viaggio del vescovo Attone di Vic e del conte Borrel, al
seguito dei quali Gerberto giungerà a Roma); e i protagonisti di
questi viaggi spesso riportavano nel loro paese codici dall’Urbe15.
Ci troviamo, dunque, di fronte a un ambiente in piena esplo-
sione culturale, dove la tendenza a costituirsi in entità politica
indipendente si accompagna alla volontà di costruirsi anche una
propria identità culturale, fatta di un costante richiamo al passato
ma anche di un’apertura agli stimoli esterni, con un atteggiamento
di vivacità intellettuale che, al di là delle precise conoscenze
scientifiche acquisite e delle quali si parlerà in seguito, può essere
considerato come il maggior contributo offerto da questa terra alla
formazione culturale di Gerberto.
15 Si ricordano, precedenti a quello di Attone e Borrell, i viaggi nel 951 del conte
Sunifredo di Cerdona accompagnato da Arnulfo di Ripoll, e nel 968 del conte Oliba
accompagnato dall’abate Garín di Cuxá, entrambi personaggi con il quale Gerberto
entrerà in contatto. Cf. D’ABADAL 1961, p. 8-9; LACARRA 1963, p. 268-269; DIAZ Y DIAZ
1969, p. 239.
12 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 12 2008.02.13, 7:34
1.2. Il viaggio di Gerberto
All’epoca in cui si compiva il viaggio di Gerberto le abbazie ca-
talane fondate nel IX secolo erano in pieno rigoglio rispetto a quelle
del resto del continente, avendo meno sofferto delle altre per l’ul-
tima ondata di invasioni. Come ben si evidenzia nei contributi di
M. Riu y Riu (RIU 1999) e G. Puigvert i Planagumá (PUIGVERT 2000a,
p. 171), emerge allora nella Marca Hispanica una sorta di triangolo
culturale particolarmente attivo, i cui vertici sono rappresentati
dai centri di Vic, Gerona e Barcellona, con i monasteri di San Feliu
di Gerona, Santa Maria e San Joan di Ripoll, San Cugat del Vallès
y Terrassa16, sullo sfondo del quale si può ragionevolmente collo-
care l’attività di studio di Gerberto, e la cui esperienza culturale
dal punto di vista della produzione scritta è illustrata in MUNDÒ
1991.
Benché infatti Richero menzioni come unico maestro di Gerberto
Attone di Vic, di cui si tenta una qualche ricostruzione biografica
in ORDEIG 1989 e 1999, la corrispondenza dello stesso monaco di
Aurillac ci lascia invece intravedere una rete di relazioni ben più
ampia (per una introduzione alle conoscenze catalane di Gerberto
si veda GÜMPEL 2003). D’altronde, se l’esperienza di Gerberto non
fosse andata oltre lo scriptorium di Vic, la cui attività è analizzata
in JUNYENT 1974 (si vedano anche IBARBURU 1986, ZIMMERMANN 1996,
p. 83-84, e PUIGVERT 2000b, p. 31-32), sarebbe difficile giustificare
pienamente l’eccezionalità della sua istruzione scientifica rispetto
agli standard dell’epoca. Fra i centri menzionati, infatti, quello di
Vic è in quegli anni il meno originale, e bisognerà aspettare ancora
un secolo perché la sua produzione raggiunga buoni livelli
qualitativi, in coincidenza con l’episcopato del grande abate di
Ripoll Oliba (vedi oltre). Inoltre, grazie a due inventari redatti nel
16 Tale area culturale si caratterizzava per essere molto ricettiva nei confronti delle
nuove correnti culturali franco-italiane, senza rinunciare comunque alla tradizione
visigota. Altri centri culturali di rilievo della Catalogna del X secolo, caratterizzati da
un maggiore conservatorismo, erano quello ruotante intorno alla cattedrale di Urgell
e quello legato ai monasteri di Elna e Cuixà.
ABob xxix - 13
Mate.Testo.PM 13 2008.02.13, 7:34
957 alla morte dell’abate Guadamir, e nel 971 alla morte dello stesso
Attone, possiamo dedurre quale fosse il contenuto della biblioteca
(descritto anche in JUNYIENT 1963) all’epoca del soggiorno di
Gerberto: ed essa, in realtà, non offriva nulla di più rispetto a una
qualsiasi biblioteca monastica franca. Per un tentativo di
ricostruzione di possibili studi scientifici a Vic si veda il contributo
di Molins e Pau (MOLINS 1993) in relazione proprio al soggiorno di
Gerberto. Considerando comunque che è ad Attone che il conte
Borrell affida il giovane per la sua istruzione nelle arti liberali,
bisognerà pensare alla figura di un singolo intellettuale
personalmente interessato alle discipline scientifiche, piuttosto che
a uno scriptorium che ne contempli programmaticamente lo stu-
dio, e in questo senso si muove A. Pladevalli Font (PLADEVALL 1999),
alludendo all’esistenza di biblioteche private a fianco di quelle
monastiche. Riguardo alla personalità scientifica di Attone si sa
però ben poco, e non è quindi possibile valutare con esattezza il
peso della sua influenza sulla formazione di Gerberto; è però da
segnalare l’ipotesi riscontrabile in PUIGVERT 2000b, p. 31-32, della
sua presenza, come arcidiacono di Gerona (su questo ruolo si veda
ORDEIG 1989), nel seguito di Gotmar IV in occasione della sua
ambasciata a Cordova, dalla quale avrebbe potuto perciò riportare
in patria testi scientifici.
All’altro polo di quest’area culturale, il centro vescovile di
Gerona, si collega la figura di uno dei corrispondenti di Gerberto,
Miró Bonfill, cugino del conte Borrell, il mecenate di Gerberto, conte
di Besalù e vescovo di Gerona dal 971 (lo stesso anno in cui compie
un viaggio a Cordova), celebre intellettuale dell’epoca e animatore
della fioritura culturale della scuola episcopale; personaggio,
inoltre, strettamente legato al monastero di Ripoll per il quale
redige, nel 977, il terzo atto della consacrazione della chiesa17. A
17 Cf. SALRACH I MARES 1984a. Bonfill risulta legato anche a Cuixá (SALRACH I MARES
1984b).
14 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 14 2008.02.13, 7:34
Miró Bonfill Gerberto, nell’ep. 12 e 25, richiede per ben due volte
un testo che dovette molto interessarlo, probabilmente per i suoi
studi sull’abaco, vale a dire il De multiplicatione et divisione
numerorum del sapiente Joseph Hispanus, identificato da G.
Puigvert i Planagumá (PUIGVERT 2000b, p. 34-35) e soprattutto M.
Zuccato (NUVOLONE 2005f, p. 494), con la traduzione del Maqala fi
l-darc wa-l-quisma («Sulla moltiplicazione e divisione»), composto
a Quayrawan (Tunisia), e considerato uno dei testi attraverso cui
fu veicolata la trasmissione delle cifre arabe in Occidente. Se poi è
esatta l’identificazione di Joseph Hispanus come intellettuale ebreo,
e più esattamente, secondo Zuccato, con Abu Yusuf Hasday ben
Ishaq ben Shaprut (che avrebbe realizzato la versione latina
all’epoca della sua attività diplomatica al fianco del vescovo
Gotmar di Gerona) la lettera di Gerberto pone in scena un’altra
componente distintiva del mondo culturale iberico, cioè la
componente giudaica (la cui presenza nella Catalogna dell’anno
Mille è analizzata in ROMANO 1991 e 1999) che, culturalmente di
lingua araba, svolgerà due secoli più tardi un ruolo di primo pi-
ano all’epoca delle traduzioni toledane18. Proprio questo indiretto
contatto fra Gerberto e il mondo ebraico è oggetto del contributo
di ZUCCATO 2005b.
Resta aperta la questione se Miró sia stato maestro di Gerberto:
la sua parentela con il conte Borrell, i suoi legami con il monastero
18 Il primo a intuire le enormi potenzialità culturali insite nella presenza di comunità
ebraiche bilingui, parlanti cioè l’arabo e il volgare, fu Raimundo, arcivescovo di To-
ledo dal 1126 al 1152. La città, riconquistata dai cristiani nel 1085, era stata infatti uno
dei principali centri di cultura araba di al-Andalus. Raimundo cercò pertanto di attrarre
studiosi da tutta Europa nella città spagnola e patrocinò l’attività di traduzione
dell’ebreo convertito Giovanni di Luno e dell’arcidiacono Domenico Gondiscalco.
Dopo la morte dell’arcivescovo il fenomeno delle traduzioni esplode, portando alla
costituzione di una vera e propria scuola di Toledo in cui spicca il nome di Gherardo
di Cremona. La maggior parte delle traduzioni del XII secolo fu il frutto della
collaborazione fra un ebreo, che traduceva dall’arabo al volgare, e di uno studioso,
generalmente cristiano, che effettuava poi la redazione del testo in latino. Cf. HASKINS
1926; BEAUJOUAN 1965, p. 593-595; GRANT 1983, p. 28-31; WATT 1991, p. 90.
ABob xxix - 15
Mate.Testo.PM 15 2008.02.13, 7:34
di Ripoll, in particolare con l’abate Arnulfo, al quale succedette
sulla cattedra vescovile di Gerona, sembrano comunque rendere
plausibile una risposta affermativa, tanto più che la lettera inviata
a Miró rivela una certa familiarità fra il vescovo catalano e Gerberto,
il quale gli indica due date possibili per potersi incontrare in Italia.
Ma è soprattutto il monastero di S. Maria di Ripoll a distinguersi
come centro culturale di primissimo piano, aperto alle maggiori
innovazioni, analizzato nei suoi rapporti con la città di Vic nel
contributo GROS 1999. Gli anni del viaggio di Gerberto coincidono
con quelli dell’abbaziato di Arnulfo (948-970), inauguratore della
stagione della fioritura culturale di Ripoll, che raggiungerà la sua
acme nel secolo successivo con la figura dell’abate Oliba il quale,
dall’elezione nel 1008 fino alla morte nel 1040, dedicherà gran parte
delle sue energie all’attività dello scriptorium della scuola
monastica. L’abate Oliba, inoltre, ottiene successivamente anche
l’abbaziato di Cuixá e l’episcopato di Vic, confermando così, come
si vedrà anche oltre, gli stretti legami esistenti fra i centri culturali
di quest’area della Catalogna; va sottolineato infine anche il fatto
che Oliba era nipote del conte Miró Bonfill19. Arnulfo dimostra
immediatamente uno spiccato interesse per l’educazione dei
monaci: si preoccupa in primo luogo di rafforzare i legami con la
Francia meridionale, in particolare con la cattedrale di Le Puy in
Alvernia, e, soprattutto, è a lui che si deve il sostanzioso
arricchimento della biblioteca, anche con codici provenienti da
Roma (nel 951 infatti si reca nell’Urbe per chiedere al papa Agapito
II di porre il monastero di Ripoll sotto la diretta protezione del
pontefice)20. Ma ciò che maggiormente caratterizza Ripoll è il fatto
che nel suo scriptorium si registrino alcuni fra i primi casi di
traduzione in latino di testi arabi, un fenomeno questo di
19 Cf. RICHÉ 1984, p. 165-166; PUIGVERT 2000a, p. 173; PUIGVERT 2000b, p. 27.
20 Cf. RICHÉ 1984, p. 164; UDINA 1985, p. 40-42; PUIGVERT 2000b, p. 29.
16 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 16 2008.02.13, 7:34
fondamentale importanza per lo sviluppo della cultura europea.
Per quel che riguarda in particolare il campo scientifico, è proprio
allo scriptorium di Ripoll che si deve ascrivere, ad esempio, un testo
fondamentale per l’astronomia come il ms. ACA Ripoll 225 (metà
XI sec.), cioè uno dei testi che fecero conoscere all’Occidente
europeo l’astrolabio (vedi oltre il cap. 2.3, L’Astronomia). Grazie ai
cataloghi della biblioteca è dunque possibile affermare che
all’epoca del viaggio di Gerberto il centro di S. Maria di Ripoll
possedeva codici tali da permettere l’apprendimento delle disci-
pline scientifiche facendo riferimento non solo alla tradizione
tardo-antica ma permettendo anche un primo approccio con le
novità provenienti da Oriente, come illustrato in UDINA 1985, SAMSÓ
1991 e PUIGVERT 2000b. Fra le miscellanee di argomento scientifico
giunte fino a noi è da ricordare il ms. ACA 106 Ripoll, da collocarsi
cronologicamente a cavallo fra il IX e il X secolo: la ricchezza
principale del manoscritto è la presenza di un corpus di gromatici
veteres, seguito da testi di aritmetica e astronomia applicata al
computo pasquale, rispettivamente di Boezio e di Beda; si tratta,
evidentemente, di un libro scolastico per l’insegnamento del
quadrivio, al quale Gerberto dovette molto probabilmente avere
accesso21. Va infine segnalato che gli abati di Ripoll erano spesso
anche vescovi di Gerona e Vic — ne è un esempio lo stesso Arnulfo,
abate di Ripoll dal 948 e vescovo di Gerona dal 954 — per cui fra i
tre centri si era venuto a creare uno stretto legame che rende ancora
più plausibile l’ipotesi di un soggiorno di Gerberto anche al di
fuori di Vic.
Seguendo ancora la corrispondenza dell’aquitano è possibile
segnalare altri due intellettuali dell’ambiente catalano. In primo
luogo Guarín (ep. 17 e 45), abate di San Miguel de Cuixá dal 962 e
uno dei personaggi di maggiore levatura culturale dell’epoca, la
21 Cf. DIAZ Y DIAZ 1969, p. 235; UDINA 1985, p. 40-42, 47-48; PUIGVERT 2000b, p. 39-41.
ABob xxix - 17
Mate.Testo.PM 17 2008.02.13, 7:34
cui figura in relazione all’attività ecclesiastica e alla partecipazione
al movimento di riforma cluniacense è analizzata in D’ABADAL 1961,
articolo nel quale si affacciano anche ipotesi riguardo le modalità
con cui si instaurarono i rapporti fra l’abate e Gerberto. Da
sottolineare che l’abbazia di Cuixá era strettamente legata all’area
Vic-Gerona-Ripoll22.
Il secondo personaggio è Lupito di Barcellona, identificato
generalmente con Sunifredo Llobet, arcidiacono di Barcellona (963-
977 d.C.), nonché probabile uomo di fiducia di Borrell:
un’identificazione non facile, così come illustrato in LATTIN 1932, e
in FELIU 1972. M. Zuccato, nella sua tesi di dottorato ancora inedita,
propone un’identificazione alternativa con Lupinus abate del
monastero di Arles di Vallespir.
Con la sua lettera a Lupito, al quale richiede la traduzione
dall’arabo di un testo di astronomia, Gerberto ci illumina su una
realtà culturale altrimenti quasi sconosciuta, cioè la scuola della
cattedrale di Barcellona nel X secolo. Inoltre il nome di Lupito si
intreccia ancora con la storia dei testi poi confluiti nella più tarda
compilazione del ms. ACA 225, se è giusta, come si legge ancora
in LATTIN 1932 ma anche più recentemente in PUIGVERT 2000b p. 34,
l’identificazione del testo a lui richiesto da Gerberto con una parte
di un trattato sull’astrolabio contenuta nel suddetto codice.
Secondo Zuccato invece il testo coinciderebbe con una parte degli
Alchandreana, un corpus costituitosi probabilmente su suolo
spagnolo (vedi oltre il cap. 2.3 L’Astronomia). Più cauto D. Juste
(JUSTE 2000, p. 277), per il quale l’espressione liber de astrologia è
troppo vaga per poter stabilire con certezza l’appartenenza del
testo al corpus astrologico del Liber Alchandraei o al corpus astrolabico
costituitosi anch’esso in Catalogna nel medesimo periodo.
È dunque da sottolineare come, con le sue richieste a Miró
Bonfill e a Lupito, Gerberto compia uno dei primi significativi
22 Cf. PUIGVERT 2000b, p. 30.
18 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 18 2008.02.13, 7:34
tentativi del mondo occidentale di aprirsi alla scoperta del sapere
arabo, anticipando quella che diventerà una prassi culturale
abituale solo un secolo e mezzo più tardi, con il fiorire della scuola
di traduttori di Toledo.
Il soggiorno di Gerberto in Catalogna pone un ulteriore
problema, quello cioè dell’ipotesi di un suo viaggio nel cuore della
Spagna islamica. Tale ipotesi si basa sulla sola testimonianza di
Ademaro di Chabannes (analizzata in NUVOLONE 2001b) il quale
afferma che il futuro papa si spinse fino a Cordova (ADEMARUS,
Chronicon).
Gli storici sono però unanimi nel negare la probabilità di una
simile esperienza. In primo luogo per motivi politici: sono questi,
infatti, gli anni del califfato di Hisham II, personaggio assai
intollerante nei confronti dei cristiani e il cui generale, al–Mansur,
guidò l’attacco a Barcellona, León e Santiago de Compostela del
985 d.C.; nonostante il persistere di contatti tra il califfato e la Marca
appare quindi poco probabile che un giovane monaco potesse
aggirarsi liberamente in territorio islamico senza la protezione
rappresentata da un’ambasciata diplomatica, e si è visto come le
date delle spedizioni ufficiali a cui parteciparono i personaggi
catalani legati a Gerberto siano tutte antecedenti o posteriori il
triennio 967-970. In secondo luogo Gerberto non sembra conoscere
l’arabo (si consideri la sua richiesta a Lupito), né, d’altronde, nella
sua corrispondenza ricorrono mai nomi di eventuali maestri
mozarabi. I nomi di personaggi cristiani dell’area catalana, invece,
non solo sono presenti nelle lettere, ma anche in alcune bolle papali
(al visconte di Barcellona, a Sallo vescovo di Urgell, a Oddo vescovo
di Gerona, all’abate di San Cugat) (S YLVESTER II, Epistolae),
testimoniando il forte legame stabilitosi fra Gerberto e questo
ambiente.
Senza bisogno, quindi, di ipotizzare un viaggio nella Spagna
islamica, la Marca offriva all’epoca la possibilità di istruirsi nelle
arti del quadrivium attraverso maestri cristiani, che parlavano
dunque in latino. Inoltre, da quanto detto in precedenza, risulta
evidente che Gerberto ebbe la fortuna non solo di poter risiedere
ABob xxix - 19
Mate.Testo.PM 19 2008.02.13, 7:34
per tre anni in un ambiente culturale dinamico, vivace e aperto,
ma di godere oltretutto della protezione dei maggiori
rappresentanti di questo stesso ambiente, personaggi di spicco,
fra l’altro, anche della vita politica del paese, entrati per questa
via in contatto diretto con la corte di Cordova23. Gli stretti legami
che li univano l’uno all’altro24 devono indubbiamente aver facilitato
e incoraggiato i movimenti del giovane monaco fra i vari centri
dell’area barcellonese. Con loro Gerberto riuscì a stabilire durature
amicizie che, protraendosi nel tempo per via epistolare,
continueranno a influenzare per anni la sua vita intellettuale,
configurandosi, probabilmente, come una costante fonte di novità.
Cap. 2
L’insegnamento scientifico di Gerberto d’Aurillac
Nel 970 il conte Borrell e il vescovo Attone di Vic si recano a
Roma per chiedere al papa Giovanni XIII l’indipendenza delle
diocesi catalane dalla metropoli di Narbona; al loro seguito c’è
Gerberto d’Aurillac. Interrogato dal papa, Gerberto stupisce tutti
per le sue conoscenze scientifiche, in particolare astronomiche e
musicali; il papa si affretta allora a segnalare la presenza del
giovane a Ottone I e, alla corte romana dell’imperatore, ha inizio
la carriera di scolastico di Gerberto. Desideroso di istruirsi nella
logica, l’unica materia che ancora mancava al suo cursus studiorum,
23 Si consideri l’ipotesi della presenza di Attone al seguito del vescovo di Gerona
Gotmar IV nell’ambasciata del 940; il viaggio di Mirò Bonfill nel 971; oltre che le
frequenti ambasciate promosse verso Cordova dal conte Borrell a partire dal 950 d.C.
24 Ricordo in sintesi che Miró Bonfill, vescovo di Gerona, era cugino del conte Borrell
ed era legato al monastero di Ripoll, in particolare all’abate Arnulfo, suo predecessore
sulla cattedra vescovile della città; che negli anni del viaggio di Gerberto Arnulfo era
sia abate di Ripoll sia vescovo di Gerona; che Lupito di Barcellona era un probabile
uomo di fiducia del conte Borrell; che, infine, Attone prima di diventare vescovo di
Vic era stato arcidiacono di Gerona.
20 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 20 2008.02.13, 7:34
l’aquitano si lega a Geranno, arcidiacono di Reims inviato in
missione diplomatica dal re Lotario (e del quale era nota la
profonda cultura logica) e, con l’autorizzazione dell’imperatore,
lo segue in terra di Francia (RICHERUS, Historiarum, III, 43-44-45).
Succeduto al suo maestro, dal 972 al 982 Gerberto guiderà la scuola
dell’arcivescovato di Reims, primo, dopo secoli, capace di
insegnare l’intero sistema del trivium e del quadrivium (RICHERUS,
Historiarum, III, 45).
Certamente esperto di filosofia e abile insegnante di retorica, la
sua corrispondenza verterà però soprattutto su problematiche
scientifiche, e saranno proprio gli strumenti astronomici da lui
realizzati a essere impiegati come oggetto di scambio per ottenere
manoscritti. Ed è alle quattro discipline della mathesis che Richero
dedica il maggior numero di capitoli nella descrizione
dell’insegnamento del suo maestro.
L’interesse di Gerberto per la scienza non si esaurirà
nell’esperienza remense ma si protrarrà per tutta la vita, trovando
nuovo alimento sia nella corrispondenza con i vecchi maestri
catalani sia nel contatto con la ricchissima biblioteca di Bobbio negli
anni del suo abbaziato (981-984).
Principale destinatario dei suoi scritti scientifici è Costantino,
monaco benedettino di Fleury e, dal 989 al 995, scolastico di St.
Mesmin vicino a Orléans, fidato amico oltre che fedele discepolo;
così lo descrive lo stesso Gerberto: «...nobilis scolasticus, adprime
eruditus, michique in amicitia conjunctissimus...» (G ERBERT,
Correspondance, ep. 92), «…vis amicitiae impossibilia redigit ad
possibilia...o mi dolce solamen laborum, Costantine...» (GERBERT,
Lettres scientifiques, ep. 1).
Per un’analisi generale della figura di Gerberto nel suo ruolo
di maestro si vedano FROVA 1974b, LINDGREN 1976, GASEC 1986,
LINDGREN 1991, POUPARD 2003, LINDGREN 2001b, POULLE 2005. Per
inserire l’insegnamento dell’aquitano nel contesto dell’ambiente
culturale a lui contemporaneo è utile consultare RICHÉ 1984, RICHÉ
1985, WOLFF 1987, RICHÉ 2000a, FRANCI 2000.
ABob xxix - 21
Mate.Testo.PM 21 2008.02.13, 7:34
In particolare poi per ciò che concerne la storia della scienza
medievale si faccia riferimento a G RANT 1983, ampliato e
parzialmente modificato in alcune sue conclusioni in GRANT 2001,
e a DIJKSTERIUS 1970. Date poi le allusioni a conoscenze di origine
araba si segnala anche NASR 1971.
2.1
La Matematica
È con l’aritmetica che Gerberto inizia l’insegnamento del
quadrivium, e questa priorità è da spiegarsi con il fatto che essa,
tanto nei suoi aspetti puramente speculativi quanto nelle sue
applicazioni pratiche, rappresenta l’indispensabile chiave di
accesso alle altre discipline: non si può infatti comprendere la teoria
musicale se non si conosce quella dei numeri e delle loro
proporzioni, né si potrà fare a meno di uno strumento di calcolo
nello studio della geometria pratica e dell’astronomia. Ma i due
aspetti della disciplina, quello teorico e quello pratico, erano
all’epoca, e lo saranno ancora per molto, fortemente distinti: con il
nome di aritmetica, perciò, si intendeva propriamente la scienza
dei numeri quale era tramandata dall’opera boeziana, mentre la
pratica matematica costituiva la scienza del computo, ampiamente
analizzato in BORST 1997.
E Boezio costituisce dunque, anche per Gerberto, la fonte
principale per lo studio dell’aritmetica: la sua opera sul quadrivium
è ampiamente illustrata in C HADWICK 1986 e, con particolare
riferimento alla matematica, in GUILLAUMIN 1995. Il filosofo romano
tardo-antico si trovò a vivere in un periodo particolarmente critico
per la scienza: da una parte essa aveva subito, rispetto al periodo
greco, una situazione di fondamentale disinteresse nella cultura
latina, che l’aveva emarginata relegandola quasi esclusivamente
nel campo della tecnica; dall’altra, a partire soprattutto dal periodo
del basso-impero, essa era stata sottoposta prevalentemente a
influenze di tipo neo-platonico, oltre che delle mistiche orientali e
delle sempre più diffuse pratiche magiche. Di fronte quindi allo
22 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 22 2008.02.13, 7:34
stato di abbandono in cui versavano gli studi scientifici dell’epoca,
Boezio si propone, impegnandosi in una sistematica opera di
traduzione, di consegnare al mondo latino un corpus di scritti
scientifici e filosofici che, attingendo agli originali greci, garantisse
la sopravvivenza del quadrivium, cristianamente inteso come
propedeutica allo studio teologico, nel mondo occidentale. Nel caso
dell’aritmetica, la sua Institutio arithmetica, sostanziale traduzione
dell’Introduzione all’aritmetica di Nicomaco di Gerasa (sulla cui
opera si veda BOYER 1976) — pitagorico del II secolo d.C. la cui
opera divenne il libro di testo corrente delle scuole neoplatoniche
di Atene ed Alessandria — trasmise al Medioevo, in armonia con
il clima culturale in cui Boezio viveva, gli aspetti più esoterici della
matematica greca, in particolar modo quelli legati alla scuola
pitagorica, rivisti alla luce della sua formazione cristiana. I numeri
erano allora concepiti come principi ordinatori dell’Universo,
elementi dotati ciascuno di una propria personalità; essi celavano
nell’armonia, nella coerenza e nell’eleganza delle loro proporzioni,
le regole poste dal Creatore a garanzia della perfezione del creato.
La conoscenza della teoria dei numeri e la meditazione sulle loro
proprietà aprivano perciò la mente umana all’intuizione della
perfezione del divino. Così intesa, l’aritmetica era quindi la
disciplina scientifica più adatta a fondersi con la teologia cristiana
dando vita a un complesso simbolismo mistico che sfruttava il
linguaggio dei numeri.
Gerberto mostra di condividere questa visione: non a caso, nel
Prologus della Geometria (vedi oltre) egli cita il versetto biblico della
Sapienza (XI, 21) che tante volta ritorna negli scritti medievali,
versetto nel quale si esalta un Creatore il quale ha posto «… om-
nia in numero et mensura et pondere…». Il versetto era già stato
citato, fra gli altri, da s. Agostino, il quale aveva ammesso che le
speculazioni matematiche non sono inutili per comprendere alcuni
passaggi oscuri delle sacre scritture25.
25 Cf. BEAUJOUAN 1991a, p. 161.
ABob xxix - 23
Mate.Testo.PM 23 2008.02.13, 7:34
Tuttavia, al di là di un evidente misticismo, il porre i rapporti
fra numeri a base del creato può significare anche, dismesso il
simbolismo, riconoscere che il mondo delle cose è regolato da
rapporti di tipo quantitativo, e che la scienza dei numeri permette
quindi di comprendere anche il funzionamento della natura, intesa
in senso fisico e non solo come teatro della manifestazione del di-
vino. Se precedentemente, a proposito di Gerberto, si è citato il
versetto biblico della Sapienza, si deve ora sottolineare che l’elogio
della scienza dei numeri, principi di ogni realtà, contenuta
nell’epistola 187 a Ottone III, appare scevra da misticismi cristiani
e più vicina all’esaltazione pitagorica, a una visione dei numeri
come uniche e reali scaturigini dell’universo, piuttosto che alla
tendenza cristiana, spesso scadente in una semplice, seppur
complessa nei modi di espressione, associazione fra numeri e
simboli o concetti religiosi. Inoltre la comprensione delle leggi che
regolano i rapporti fra i numeri è per Gerberto anche una sfida
all’intelligenza, un modo per esercitarla e raffinarla: nel
Fragmentum de norma abacis (vedi oltre), Gerberto dice infatti a
Costantino che gli assiomi proposti nel suo trattato sono destinati
ad acuirne la prontezza di spirito.
Il suo scritto propriamente aritmetico è una lettera a Costantino
(ep. 6, GERBERT, Lettres scientifiques) contenente il commento a un
passo piuttosto oscuro dell’Institutio arithmetica boeziana (II,10),
per la cui tradizione manoscritta si vedano MOSTERT 1997 e SILVESTRE
1949, mentre per la sua analisi si considerino FROVA 1974a, p. 344-
345 e HUGLO 2000, p. 154-155. Egli riesce a dimostrare con chiarezza
come una proporzione numerica di tre elementi diseguali sia
riconducibile, tramite un’operazione costante ripetuta in più
passaggi, a tre termini uguali, un interesse questo per le
proporzioni fra i numeri che ritorna anche nell’ep. 134 a Remigio
(GERBERT, Correspondance). Gerberto non evita qui di far trapelare il
proprio orgoglio introducendo la sua soluzione, laddove molti si
erano cimentati ma non con risultati altrettanto validi: fra i tanti
anche l’altro grande maestro del secolo, Abbone di Fleury. A riprova
del successo che effettivamente ottenne il commento proposto da
24 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 24 2008.02.13, 7:34
Gerberto si tenga presente che in molti manoscritti dell’XI secolo
dell’Institutio arithmetica, provenienti dalla Lotaringia, la lettera a
Costantino viene riportata come glossa al passo preso in esame.
Ciò che affascina maggiormente Gerberto, il Leitmotiv di NAVARJ
1975, è dunque l’idea della disuguaglianza che, attraverso un
processo ordinato, per gradi successivi si riduce a uguaglianza,
l’idea del molteplice riconducibile all’unità. E lo incanta il motivo
dell’ordine perfetto che regola i rapporti fra numeri, un motivo
che ritorna più volte nello scolio boeziano al termine del quale lo
scolastico afferma che proprio in esso risiede la vera natura dei
numeri.
Si segnala infine la possibilità di un’attribuzione a Gerberto, o
al suo entourage, delle glosse al commento di Calcidio al Timeo del
ms. Brussels, Bibliothèque Royale 9625-26 (X sec.), avanzata da
Anna Somfai in SOMFAI 2005. L’autore di tali glosse potrebbe essere
considerato l’iniziatore della lettura matematica di alcuni passaggi
del dialogo platonico, un profondo conoscitore del testo in grado
di creare dal nulla dei diagrammi esplicativi. Lo stile delle glosse,
il contesto scolastico, le caratteristiche paleografiche portano
l’autrice a ricollegare questi testi ai due maestri per eccellenza del
X secolo, cioè Gerberto e Abbone di Fleury, con una netta preferenza
però per il primo.
2.1.a. L’abaco e le cifre decimali
L’interesse matematico di Gerberto non è tuttavia limitato solo
a questo aspetto speculativo; in lui si evidenzia infatti anche la
volontà di elaborare un sistema di calcolo più efficace rispetto a
quello dell’antichità, attirandosi così il disprezzo di quanti,
philosophi li definisce, ma philosophi sine litteris (GERBERT, Lettres
scientifiques, ep. 1) guardano con disdegno a simili problematiche.
La tendenza a cercare di ricomporre la frattura esistente fra i
due aspetti della disciplina si fa sentire, in verità, anche nell’opera
dell’altro grande maestro, nonché rivale politico di Gerberto:
ABob xxix - 25
Mate.Testo.PM 25 2008.02.13, 7:34
Abbone di Fleury,, autore di un Commentarium in calculum Victorii
e di un Computus. Per un primo approccio con l’opera di Abbone
si vedano EVANS 1985 e FROVA 2000 per l’aritmetica, e THOMSON 1985,
THOMSON 1998 e MCCLUSKEY 1998, p. 152-157, per l’astronomia, oltre
a RICHÉ 1984, p. 148-155, e 2004 per una valutazione globale del
suo insegnamento. Per un più specifico confronto fra l’opera di
Abbone e quella di Gerberto si considerino invece BISSON 1999 e
MOSTERT 2001. L’opera di Abbone risulta tuttavia decisamente
inferiore a quella di Gerberto, sia dal punto di vista teorico che da
quello della risoluzione dei problemi del calcolo; soprattutto in
questo secondo campo lo scolastico di Reims poteva d’altronde
vantare conoscenze pressoché uniche nell’ambiente occidentale
latino dell’epoca.
È dunque all’abaco che Gerberto deve principalmente la sua
fama nel campo della matematica, tanto che, nell’XI secolo, quando
si registrerà il fiorire di questo genere di studi, gli abacisti saranno
spesso chiamati con il nome di «Gerbertisti»; ed effettivamente la
riforma dello strumento calcolatorio fu, come si legge in
DIJKSTHERIUS 1971, p. 141, il maggiore contributo dello studioso di
Reims alla storia dell’aritmetica.
Questi i testi gerbertiani legati all’abaco, la cui tradizione
manoscritta è analizzata in MOSTERT 1997:
1) la prima lettera indirizzata a Costantino di Fleury, datata
verso il 980: essa contiene una sorta di breve trattatello, più che
altro un compendio di norme d’uso per effettuare la
moltiplicazione e la divisione, intitolato spesso anche Libellus de
numerorum divisione. Esso è edito in BUBNOV 1899 come Regulae de
numerorum abaci rationibus, e, con traduzione francese, in GERBERT,
Lettres scientifiques, ep. 1, e in LEVET 1997a.
2) una seconda lettera a Costantino, scoperta da Bubnov e
testimoniata da un solo manoscritto, il Vat. lat. 3123, è stata
identificata dallo studioso russo con l’introduzione al trattato
sull’abaco perduto di cui ci dà testimonianza solo un’allusione di
Richero, e intitolata Fragmentum de norma rationis abacis; edita in
BUBNOV 1899 e in GERBERT, Lettres scientifiques, ep. 2.
26 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 26 2008.02.13, 7:34
3) nella sezione relativa al teorema di Pitagora della Geometria
Gerberti abbiamo poi l’esemplificazione di numerosi casi di calcolo
con le frazioni, dei quali si dice «… quod abacistae facillimum est
...» (GERBERTUS, Geometria, caput XII).
4) un’ultima citazione dell’abaco è infine contenuta nell’epistola
183 (GERBERT, Correspondance) a Ottone III dove, nella chiusa,
Gerberto augura al giovane sovrano di poter vivere tanti anni
quanto il numero più grande rappresentabile sull’abaco.
L’abaco utilizzato da Gerberto pone innanzi tutto un problema
di origine, rispetto al quale si vedano i contributi di FROVA 1974a,
LINDGREN 1976, VOGEL 1985, BEAUJOUAN 1996: esso è obiettivamente
diverso dall’abaco usato nell’antichità ma, a fronte di quanti ne
affermano come sicura l’origine islamica, non è neanche presente
in alcuna fonte araba; tuttavia è indiscutibile il fatto che il suo uso
presupponga necessariamente il ricorso al sistema di numerazione
arabo, cioè il sistema decimale posizionale, importato dall’Oriente
nella Spagna islamica. In esso bisognerà allora vedere il prodotto
di una contaminazione culturale, la sintesi fra uno strumento
tradizionale per il mondo latino, l’abaco, e un importante elemento
di novità, a esso estraneo, i numeri decimali. Il problema rispetto
a Gerberto, peraltro irrisolto, è quello di stabilire se egli sia stato il
creatore dell’abaco a colonne oppure se la sua elaborazione vada
ricondotta all’ambiente dei matematici spagnoli cristiani e Gerberto
si sia limitato allora a svolgere una funzione di mediatore,
esportando materialmente l’abaco al ritorno dal suo viaggio in
Catalogna; di sicuro lo si potrà però considerare come il maggior
divulgatore di questo strumento, tenendo presente che, prima di
lui, non v’è traccia del suo utilizzo, e che gli abacisti dell’XI secolo
si ricollegano tutti, più o meno direttamente, alla scuola di Reims.
Gli scritti di Gerberto ci forniscono indicazioni solo sul modo
di eseguire le operazioni ma non contengono nessuna informazione
sull’aspetto dello strumento. Per quest’ultimo problema bisognerà
allora ricorrere alle descrizioni contenute nelle Storie di Richero
(RICHERUS, Historiarum, III, 54) e nei trattati sull’abaco dell’XI secolo,
ABob xxix - 27
Mate.Testo.PM 27 2008.02.13, 7:34
in particolare quelli di Bernelino ed Erigero di Lobbes26, entrambi
dipendenti nei loro studi dall’insegnamento di Gerberto,
integrando tali descrizioni con le illustrazioni presenti nei
manoscritti della Seconda Geometria apocrifa di Boezio, che utilizza
le regole esposte nel Libellus di Gerberto27.
Si arriva così a determinare con esattezza l’aspetto dell’abaco,
costituito da una tavola divisa verticalmente in 27 colonne, riunite
in gruppi da tre, nelle quali si collocavano gli apices, cioè quadratini
mobili di avorio od osso per mezzo dei quali si componevano i
numeri e si eseguivano le operazioni.
Sono proprio gli apices l’elemento di maggiore interesse, in
quanto essi testimoniano l’utilizzo del nuovo sistema di
numerazione arabo: Richero afferma infatti che, attraverso la
combinazione di nove segni incisi sugli apices, sull’abaco si poteva
comporre qualsiasi numero. La testimonianza di Richero è
confermata poi dalle illustrazioni della Seconda Geometria dove sono
26 Bernelino è autore di un Liber abaci scritto fra il 999 e il 1003, il più antico trattato
sull’abaco che contenga una descrizione della tavola calcolatoria. Erigero, scolastico e
abate di Lobbes dal 970 al 1007, istruito a Liegi da Notkero, fu corrispondente di
Gerberto; è autore di due trattati sull’abaco: Regulae numerorum super abacum Gerberti
(perduto) e Regulae de numerorum abaci rationibus (a lungo attribuito a Gerberto e
pubblicato ancora come tale da Olleris, in OLLERIS 1867, con il titolo di Regula de abaci
computo). In riferimento a questi successivi trattati sull’abaco si veda FROVA 1974a e
FOLKERTS 2001.
27 La Seconda Geometria apocrifa di Boezio è un falso dell’XI secolo composto in
Lotaringia e strettamente legato alla figura di Gerberto: non solo infatti l’autore utilizza
le regole di calcolo con l’abaco esposte nel Libellus, ma la parte propriamente geometrica
attinge molto probabilmente a quel manoscritto, oggi Napoli V.A.13, contenente
numerosi estratti di gromatici e testi geometrici sotto il nome di Boezio, che Gerberto
scoprì a Bobbio e del quale fece dono al suo corrispondente Adelboldo di Liegi. Lo
stesso Gerberto è citato dall’autore ma, coerentemente con la falsificazione, sotto il
nome di Archytas di Taranto, matematico greco pitagorico del IV secolo a.C., e l’abaco
è detto tabula Pythagorae (sul manoscritto Napoli V.A.13 si veda cap. 2.4, La Geometria).
Sulla sua storia e sui suoi legami con Gerberto si veda FOLKERTS 1970, 2003a, 2003c.
Sulla problematica della tradizione degli scritti geometrici in epoca medievale si veda
il lavoro di TONEATTO 1994.
28 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 28 2008.02.13, 7:34
appunto rappresentati i nove segni della numerazione araba nella
forma occidentale detta ghubar28. Era proprio l’assenza di una cifra
rappresentante il concetto di zero che rendeva indispensabile l’uso
dell’abaco dove, in luogo dello zero, si lasciava una colonna vuota29.
La contemporanea testimonianza di Richero è poi tanto più
importante in quanto, a dispetto della sua fama di introduttore
della scienza araba, nessuna menzione dei numeri decimali è
contenuta negli scritti autentici di Gerberto. L’unico passo
suscettibile di essere interpretato come un’allusione al sistema
decimale è contenuto nel Fragmentum, in cui Gerberto afferma che
tutti i numeri sono dati dall’alternanza di digiti e articuli, il che
potrebbe essere spiegato facendo riferimento al valore posizionale
28 Il che, data la fedele aderenza dello pseudo-Boezio all’insegnamento di Gerberto,
permette di escludere l’uso di altri sistemi di numerazione alternativi a quello latino,
come il sistema greco che utilizzava le lettere dell’alfabeto minuscolo. Il sistema di
numerazione introdotto dagli arabi, e di origine indiana, si presenta con una notevole
varietà di forme; la sua caratteristica, e importanza, fondamentale, non risiede infatti
nell’aspetto dei segni utilizzati per rappresentare le cifre ma nel concetto di valore
posizionale. La forma conosciuta nella Spagna cristiana è quella ghubar, la cui
attestazione più antica, escluso però lo zero, in un manoscritto di datazione certa è
contenuta nel codex Vigilanus (Escorialensis D.I.2) originario del monastero di Albelda
in Asturia, copiato in un arco di tempo che va dal 974 al 976, al foglio 12v. Più complessa
è la testimonianza del miscellaneo Ovetense di El Escorial (R.II.18), giunto a Oviedo
nell’ 884, e nel quale i numeri indiani, compreso lo zero, figurano in una nota marginale:
è difficile però stabilire se si tratti di una mano mozarabica cordovese, anteriore all’884,
oppure di quella di un rifugiato a Oviedo, e posteriore quindi a tale data. Per un’analisi
paleografica e codicologica, e una parziale edizione del codex Vigilanus, si veda GOMEZ
1989. Per il codex Ovietensis si veda DIAZ Y DIAZ 1969, p. 226-227. Per una storia della
diffusione delle cifre indiane nel bacino del Mediterraneo si consideri BURNETT 2002,
mentre sull’argomento particolare della numerazione decimale nella forma ghubar si
faccia tiferimento a FOLKERTS 2001. Riguardo al problema dell’uso delle cifre in Gerberto
si veda POULLE 2005, p. 99-100 e NUVOLONE 2005e; sulle forme numeriche incise sugli
apici, e sul loro nome, FOLKERTS 2003, BEAUJOUAN 1991b, NUVOLONE 2003, fig. 7, 14-19;
2004, p. 293-297.
29 Nell’XI secolo l’abacista Raoul di Laon introdusse l’uso di un gettone bianco
designato con il nome greco sipos (gettone). L’attuale nome di zero deriva appunto
dalla convergenza fra questo termine e quello arabo imparentato di al-sifr (cifra). Cf.
BEAUJOUAN 1965, p. 588-589; FOLKERTS 2001, p. 256-262.
ABob xxix - 29
Mate.Testo.PM 29 2008.02.13, 7:34
delle cifre; si può però osservare che questa terminologia si collega
in realtà a quella tradizionale del computo digitale.
L’ipotesi della presenza delle cifre arabe in uno scritto di
Gerberto è stata formulata nel 1995 dal musicologo americano
Clyde Brockett, in BROCKETT 1995, lavoro successivamente ripreso
e ampliato da Nuvolone in NUVOLONE 2003, 2004, 2005b e 2005e,
articolo quest’ultimo in cui si ripercorre la storia delle polemiche
nate intorno alla scoperta delle figurae nascoste. Brockett ha
riconosciuto la paternità gerbertiana di un poema figurato al f. 1v
del ms. Paris, BNF, Lat. 776, un codice liturgico realizzato nel
monastero benedettino della diocesi di Albi e contenente un cor-
pus di graduali, tropi e officii secondo lo stile “aquitano”. Il poema
è inserito in una figura composta da un’orbita circolare a otto raggi,
convergenti verso un centro racchiuso da due quadrati iscritti a
45° l’uno nell’altro; l’evidenziazione delle lettere maiuscole O e T
fornisce la chiave di lettura del poema, permettendo di individuare
sugli assi centrali la scritta OTO e lungo i raggi il nome OTTO,
riconnettendo così il testo alla dinastia ottoniana. L’occasione per
la composizione del poema sarebbe stata il dono di un organo a
Ottone II per il suo matrimonio con la principessa bizantina
Teofano nell’aprile 972.
Sul modello delle pagine a tappeto di Rabano Mauro (per le
quali si veda SCHIPPER 2004), probabile modello del poema attribuito
a Gerberto, che vedevano l’associazione del poema figurato con
una pagina in cui i versi erano riscritti in forma di testo normale in
modo da evidenziarne tutti i significati nascosti, Brockett procede
a una ridistribuzione dei versi associandoli in modo tale che le
prime e le ultime lettere costituiscano l’acrostico OTTO. All’interno
del testo così ottenuto l’autore rintraccia, inscritta fra i versi,
un’ulteriore strofa (in cui si esplicitano l’autore e i destinatari della
composizione: «Reum a qua aequa dedoce meta, / vere libri apta
piatur./ Ararum ala ducta minor, ecce,/ a tumore vertas una
novem. Dos/ a Gerberto Ottoni Theophano»), le cui lettere
sembrano essere disposte a formare figurae equivalenti alle cifre
arabiche secondo le forme presenti nel Codex Vigilanus. Assai
30 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 30 2008.02.13, 7:34
scettico nei confronti della tesi di Brockett si rivela Emmanuel
Poulle, il quale, pur accettando l’autorità gerbertiana dello scritto
e la sua composizione in occasione del matrimonio di Ottone II,
rimprovera al musicologo americano di non aver minimamente
esplicitato il metodo di lavoro che lo ha condotto all’individuazione
del testo nascosto (POULLE 2005, p. 103-108). Severo il suo giudizio
finale (ivi, p. 113): «… Je ne puis tenir une telle riconstitution pour
un travail d’historien; nous sommes même ici plus près de la sci-
ence-fiction que du roman historique… ».
Ma le tesi di Brockett sono ampiamente confermate dagli
approfondimenti del prof. Nuvolone, il quale ha apportato anche
alcune modifiche alle conclusioni del collega, sia per quel che
riguarda l’edizione del testo e la traduzione, sia soprattutto la sua
datazione, spostata a dieci anni dopo, nel giugno 983. Nuvolone
infatti individua, dopo OTO e OTTO, anche la parola OTTTO,
leggibile sui perimetri dei quadrati iscritti a partire dalla O posta
al centro della composizione. Il numero otto è così il leit-motiv della
composizione, non solo per il riferimento agli Ottoni, ma anche
per il richiamo a un complesso simbolismo numerico: otto sono i
toni della salmodia che formano l’octoechos o modalità
“gregoriana”, otto sono le “stazioni” dell’orbita solare
corrispondenti a quelle della liturgia quotidiana delle ore nei
monasteri. A tutto questo si aggiungono poi le considerazioni sulle
valenze simboliche delle due figure che compongono la struttura,
cioè il quadrato e il cerchio, simboli di perfezione e completezza, e
delle ultime due figurae, il triplice zero o triqueta e l’omega. Il testo
quindi riecheggia l’ordine della creazione e della provvidenza,
connettendovi il ruolo della famiglia imperiale; esso è dunque
destinato alla coppia imperiale Ottone II – Teofano, ma con un
occhio da una parte al ricordo di Ottone I e dall’altro, e soprattutto,
visto il ruolo grafico centrale, al bambino futuro Ottone III.
L’importanza dell’abaco di Gerberto è stata sottolineata in
particolar modo dallo storico della scienza medievale Guy
Beaujouan in BEAUJOUAN 1971, 1985, 1991a e 1991b: lo studioso
ABob xxix - 31
Mate.Testo.PM 31 2008.02.13, 7:34
stabilisce un legame fra l’uso degli apici dell’abaco e le modalità
con cui vengono rappresentate le cifre arabe nelle più antiche
testimonianze manoscritte, evidenziando la priorità dell’uso dello
strumento rispetto allo scritto, coerentemente d’altronde con quella
che Beaujouan identifica come una delle caratteristiche
fondamentali dello studio del quadrivium nell’Alto Medioevo, il
suo vivere cioè della trasmissione, nell’ambito dell’insegnamento,
di tecniche integrate dalle conoscenze del maestro piuttosto che
della pratica con i soli testi. A questo proposito è interessante notare
che spesso i trattati sull’abaco non si presentavano come trattati
dogmatici contenuti in codices, bensì erano copiati su rotuli o
schedulae intitolate, negli antichi cataloghi, Tabula abaci o Regula
abaci, a riprova del fatto che l’uso dell’abaco si insegnava molto
più attraverso la pratica che attraverso testi canonici.
Le rappresentazioni delle cifre presentano il fenomeno definito
da Beaujouan come «rotazione paleografica delle cifre»: la stessa
cifra compare cioè, nei vari testi, in forme apparentemente diverse,
che sono in realtà il frutto di una o più rotazioni di novanta gradi
rispetto alla forma ghubar originale; tale fenomeno è spiegabile
supponendo appunto che la prima conoscenza delle cifre arabe
nel mondo occidentale sia derivata dalla consuetudine con lo
strumento dell’abaco e in particolare con gli apices che, essendo
quadratini mobili e non fissi sull’abaco, potevano essere ruotati,
generando così confusioni ed errori che talvolta finivano per essere
assunti come la norma, guadagnandosi la dignità del testo scritto.
L’abaco di Gerberto svolse quindi, secondo Beaujouan, un ruolo
fondamentale nella fase iniziale di diffusione del nuovo sistema
di numerazione.
L’esperienza degli abacisti sarà rapidamente superata
dall’affermarsi, a partire dal XII secolo, di un nuovo sistema di
calcolo, l’algoritmo, che sarà quello destinato a trasmettersi al
mondo moderno: introdotto ormai anche lo zero l’abaco a colonne
risulterà del tutto obsoleto, e il nuovo sistema consisterà nel
tracciare i vari passaggi delle operazioni su una superficie coperta
di polvere o sabbia (e in seguito su carta), secondo un metodo
32 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 32 2008.02.13, 7:34
assai più agile rispetto a quello degli abacisti (sulla difficoltà dei
trattati sull’abaco si veda EVANS 1972).
Tuttavia il loro contributo alla storia della scienza resta, e
consiste nell’aver effettuato il primo tentativo organico di superare
il farraginoso sistema di calcolo ereditato dall’antichità.
2.2
La Musica
La musica è, fra le discipline insegnate da Gerberto, quella per
la quale disponiamo del minor numero di testimonianze
significative, ed è quindi piuttosto difficile definire con precisione
i limiti delle conoscenze dello scolastico. Per uno sguardo d’insieme
sui più recenti contributi allo studio della musica in Gerberto si
veda NUVOLONE 2005b; per una prima introduzione a Gerberto-
musico si legga la voce Gerbert nel New Grove Dictionary, HUGLO
1980; per una panoramica più approfondita si veda LIÉBERT 2001 e,
con particolare riferimento al contesto catalano, GÜMPEL 2003.
Nelle Storie Richero afferma che il giovane monaco aquitano,
interrogato dal papa Giovanni XIII, si dimostrò assai esperto di
musica e astronomia. Ancora attraverso Richero sappiamo poi che
il logico di Reims Geranno chiese al giovane allievo di essere
istruito nelle arti del quadrivium, ma dovette arrendersi di fronte
alle difficoltà incontrate nell’ambito della musica.
Certamente quindi Gerberto dovette avere una formazione
piuttosto solida in campo musicale (e si ricorda anche che nel Liber
pontificalis l’aquitano è definito Gerbertus cognomento musicus), e
l’episodio di Geranno dimostra come anche tale tipo di conoscenze
non fosse facilmente acquisibile; tuttavia, in questo caso, Richero
esagera nella lode del suo maestro quando afferma che, allora, la
musica era totalmente ignorata sia in Italia sia in Gallia. Già presso
i maestri carolingi si era infatti registrato un crescente interesse
per tale disciplina, in coincidenza anche con la riscoperta del IX
libro del De nuptiis di Martiano Capella (per un’introduzione
ABob xxix - 33
Mate.Testo.PM 33 2008.02.13, 7:34
all’opera del quale si vedano MCCLUSKEY 1998, p. 120-128 e CONTE
2000, p. 586), interesse che spinse alla riesamina delle teorie antiche,
alla loro attualizzazione, e alla creazione di ottimi manuali che
resteranno a lungo, anche nei secoli successivi, la base
dell’insegnamento musicale, così come illustrato in FARMER 1970,
p. 181-182, MEYER 1997, p. 186-187, MEYER 2001, BOWER 2002 e SANTI
2003.
Per comprendere il perché dell’inserimento della musica fra le
discipline del quadrivium, come ben illustrato in BELLISSIMA 2000, si
deve tener presente che la teoria musicale si fonda su presupposti
numerici, noti fin dall’Antichità e la cui scoperta era attribuita per
tradizione a Pitagora: i suoni sono cioè rappresentabili attraverso
numeri, e gli intervalli attraverso rapporti numerici. Su questi
principi matematici si basava poi l’interpretazione metafisica della
musica che trovava una completa formulazione nel Timeo di
Platone, noto agli studiosi altomedievali attraverso la traduzione
di Calcidio30: nel Timeo si afferma infatti che l’anima del mondo è
strutturata secondo le proporzioni che si possono stabilire fra le
serie dei quadrati e dei cubi di 2 e 3 (cioè fra le due serie 1,2,4,8 e
1,3,9,27), proporzioni che conducono a una scala musicale
(precisamente la scala di Mi) considerata come il sistema acustico
perfetto; il movimento delle sfere celesti produce così un’armonia,
la musica cosmica, non percepibile dall’orecchio umano.
A partire proprio dalle formulazioni platoniche si era venuta
però a costituire una profonda frattura fra quella che era la teoria
della musica e la pratica strumentale, relegata in una posizione
decisamente inferiore. Questa distinzione, consolidatasi nella Tarda
Antichità nelle due figure distinte del musicus e del cantor, si
trasmise anche all’Alto Medioevo, in particolare attraverso l’opera
latina per eccellenza di musica speculativa (e riferimento principale
dello stesso Gerberto) vale a dire l’Institutio musica di Boezio, per
30 Sulla trasmissione di Calcidio in epoca medievale si veda HUGLO 1990.
34 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 34 2008.02.13, 7:34
la cui analisi si vedano FARMER 1970, p. 190-196, CHADWICK 1986, p.
113-139, GUILLAUMIN 1995, p. XXIX-XXXIX e MEYER 2001, p. 19-21.
I testi a noi pervenuti di mano dello scolastico di Reims sono:
1) due lettere indirizzate a Costantino di Fleury e contenenti
scolii all’Institutio musica di Boezio, 10,II-2,IV-21,II (in realtà essi
concernono problemi solo aritmetici analoghi a quelli dello scolio
all’Institutio arithmetica), edite in BUBNOV 1899 e in GERBERT, Lettres
scientifiques, con traduzione francese. Per la tradizione manoscritta
si veda MOSTERT 1997. Vi si affrontano questioni legate ai rapporti
fra numeri: nella prima lettera Gerberto intende chiarire
l’affermazione di Boezio per cui un rapporto superparticolare
moltiplicato per due dà un risultato che non è né superparticolare
né multiplo; nella seconda lettera viene invece commentata la
proposizione boeziana per cui, se si sottrae a un rapporto
superparticolare un altro rapporto superparticolare più piccolo, il
resto è minore della metà del rapporto che è stato sottratto.
2) Un trattato sulle canne d’organo, De mensura fistularum,
composto a Reims intorno al 980, la cui paternità gerbertiana è
stata riconosciuta solo nel 1976 dal musicologo tedesco Klaus-
Jürghen Sachs, e pubblicato in GERBERTUS, De mensura. Il testo era
già stato edito nel 1779 dall’abate di Saint-Blaise (Foresta Nera)
Martin Gerbert, nella sua opera Scriptores de musica sacra, ma era
stato attribuito a Bernelino. La posizione di Sachs si giustifica, fra
l’altro, con l’esplicita attribuzione dell’opera a Gerberto contenuta
nel ms. Madrid, Biblioteca Nacional, 9088, dove l’inizio dell’opera
è il seguente: «Gerbertus de commensurabilitate fistularum et
monochordi, cur non conveniant...». Inoltre Sachs sottolinea che
si tratta di un testo scritto su richiesta (esso è infatti identificato
anche con l’incipit «Rogatus a pluribus»), caratteristica questa delle
opere di Gerberto; e che le autorità citate sono le stesse presenti
nella Geometria Gerberti, testo con il quale si possono rilevare anche
delle affinità lessicali. Sull’argomento si vedano anche SACHS 1972,
p. 257-274 e NUVOLONE 2005b.
3) Si segnala che M. Huglo e C. Meyer, in HUGLO 2000, p. 158,
avanzano l’ipotesi della possibilità di attribuire a Gerberto anche
ABob xxix - 35
Mate.Testo.PM 35 2008.02.13, 7:34
un secondo trattatello intitolato De ratione, proportione et divisione
semitonii, il cui testimone più antico è un manoscritto della fine
del X secolo proveniente dalla Lotaringia; il problema del calcolo
del semitono qui esposto è infatti al centro anche del De mensura
fistularum.
2.2.a. Il monocordo
Secondo quanto affermato da Richero l’insegnamento musicale
di Gerberto a Reims prevedeva l’utilizzo del monocordo, e al
proposito M. Huglo, in HUGLO 2000, fa notare come Richero utilizzi
un appropriatissimo vocabolario tecnico.
Si tratta, come è noto, di uno strumento dimostrativo assai
antico, la cui invenzione è attribuita dalla tradizione addirittura a
Pitagora. Esso è costituito da una cassa di risonanza sopra la quale
è tesa una corda: l’applicazione di piccoli pesi di piombo a diverse
altezze prestabilite, variando la lunghezza della corda rispetto alla
cassa di risonanza, permette di produrre i sette suoni naturali e di
verificare quindi praticamente l’esattezza delle proporzioni
numeriche che li generano, corrispondenti alle misure dei due tratti
in cui la corda è divisa dal suddetto peso; esso è ampiamente
descritto dal punto di vista tecnico in BEAUJOUAN 1971 e BELLISSIMA
2000, mentre i trattati sulla divisione del monocordo prodotti in
epoca medievale sono analizzati in MEYER 1996.
L’affermazione di Richero ci dimostra che il monocordo era
concretamente presente nella “classe” di Gerberto a Reims, e che
lo scolastico non si limitava quindi a illustrare le proporzioni
numeriche che generano i suoni ma ne mostrava fattivamente,
udibilmente, la corrispondenza reale31.
Teoria della musica e sua dimostrazione pratica sembrano
dunque ricongiungersi nell’insegnamento di Gerberto; resta il
31 Cf. FARMER 1970, p. 181-182; MEYER 2001, p. 60-69.
36 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 36 2008.02.13, 7:34
problema se questo possa significare anche introduzione dell’uso
del monocordo nelle scuole cantorie, come suggerito in MEYER 1997.
L’utilizzo pratico del monocordo, tanto come strumento-guida
per l’insegnamento del canto quanto come strumento dimostrativo
per la comprensione della musica speculativa, era pratica comune
fra i musici arabi; in particolare si sottolinea, vista l’esperienza di
Gerberto, che la musica era ampiamente diffusa in Andalusia, dove
il suo insegnamento, sulla scia del fiorire della trattatistica orientale
al riguardo, si era affermato a partire dal IX secolo, come illustrato
in FARMER 1970, p. 26-28 e SANTI 2003. Nell’Occidente latino, invece,
il canto gregoriano, canto senza accompagnamento sviluppatosi a
partire dall’età carolingia, era insegnato quasi esclusivamente
senza alcun ausilio strumentale, ma avendo come guida a cui
conformarsi solo la voce del maestro; talvolta poteva essere
utilizzato come riferimento per l’intonazione un organo, strumento
che però non garantiva la stessa precisione e ampiezza di possibilità
del monocordo, rispetto al quale nel Dialogus de musica si afferma
che, grazie ad esso, l’allievo può imparare il canto anche senza un
maestro32.
Il fatto che proprio intorno all’anno Mille, in corrispondenza
con gli anni del pontificato di Silvestro II, il monocordo si sia diffuso
improvvisamente nei monasteri d’Europa e sia entrato nelle scuole
cantorie per imporsi come strumento fondamentale per
l’insegnamento del canto gregoriano, e che tutti i trattati di musica
successivi a questo periodo (a partire dal Dialogus de musica,
risalente proprio agli anni del pontificato di Silvestro II, e composto
in Italia settentrionale) si aprano invariabilmente con l’illustrazione
del metodo di divisione, fa sospettare che nell’affermazione di
Richero, secondo il quale attraverso questo strumento Gerberto
metteva in corrispondenza toni e suoni, possa celarsi l’allusione
al suo utilizzo non solo per la verifica dei principi della teoria
32 RICHÉ 1984, p. 249-250; HUGLO 2000, p. 156; MEYER 2001, p. 40-44.
ABob xxix - 37
Mate.Testo.PM 37 2008.02.13, 7:34
musicale, ma anche come strumento guida nell’apprendimento
del canto33.
2.2.b. Gerberto costruttore di organa?
Un primo problema, recentemente sollevato, rispetto alla
questione degli organa, è quello della identificazione, data finora
per scontata, con l’anonimo strumento musicale, problema
illustrato in H ENTSCHEL 2003. In generale poi sull’argomento
Gerberto-costruttore di organi si segnala il volume FLUSCHE 1994.
Per quel che concerne i testi, benché le Storie di Richere facciano
menzione del solo monocordo come strumento utilizzato da
Gerberto, ben quattro epistole dello stesso scolastico parlano degli
organa (ep. 70-91-92-160, GERBERT, Correspondance) rimasti a Bobbio
dopo il precipitoso ritorno a Reims34, organa che l’aquitano avrebbe
voluto recuperare per farne dono al monastero di Aurillac.
A questa testimonianza va aggiunta poi quella dell’operetta De
mensura fistularum (vedi sopra), con la quale Gerberto si inserisce
in una tradizione di trattatistica tecnico-speculativa, quella appunto
sulle proporzioni delle canne d’organo, in cui gli autori alto
medievali avevano mostrato una notevole originalità, oltre che
buone conoscenze e abilità d’analisi del sistema acustico. Il trattato
di Gerberto si propone di dimostrare come le proporzioni
33 Cf. FARMER 1970, p.181-182; SACHS 1972, p. 259-260; MEYER 1997, p. 185, 191; SANTI
2003, p. 84.
34 Come abate di Bobbio Gerberto aveva cercato, inutilmente, di contrastare l’ingerenza
delle grandi famiglie aristocratiche della regione nelle questioni riguardanti l’abbazia.
La morte improvvisa del suo protettore Ottone II il 7 dicembre 983, e il conseguente
rafforzarsi del partito di corte a lui avverso, lo spinsero ad abbandonare Bobbio e,
dopo alcune soste in città italiane, a ritornare a Reims.
38 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 38 2008.02.13, 7:34
numeriche valide per il monocordo, e corrispondenti alla scala del
sistema acustico perfetto di Platone-Calcidio, non siano
automaticamente applicabili alle canne dell’organo, in quanto, in
questo secondo caso, il suono non è prodotto dalla vibrazione di
una corda bensì di un corpo cilindrico ed è quindi necessario tener
conto del volume della canna oltre che della sua lunghezza. Il
problema della non corrispondenza fra le due serie di proporzioni
numeriche, quella del monocordo e quella delle canne d’organo,
non era solo un problema di natura tecnica, ma aveva pesanti
implicazioni teoriche data l’equivalenza dei valori numerici validi
per il monocordo con quelli alla base della struttura dell’anima
del mondo secondo il Timeo platonico. Gerberto, costantemente
alla ricerca di quell’ordine universale che ha ampiamente lodato
nei suoi scritti geometrici e matematici, riesce a dimostrare,
attraverso una complessa serie di operazioni aritmetiche, come le
proporzioni valide per le canne dell’organo siano in realtà
riconducibili, in base a una serie di semplificazioni, a quelle del
sistema perfetto pitagorico, e così equivalenti a quelle del
monocordo, rivelando in tal modo l’esistenza di un unico ordine
razionale a fondamento dell’universo. Per un’analisi del trattato e
del procedimento matematico usato da Gerberto per la sua
dimostrazione si vedano SACHS 1972, p. 266-274 e MEYER 1997, p.
187-190. Michel Huglo, in HUGLO 2000, sottolinea la probabilità
che, fra le fonti di Gerberto, vi sia anche la Musica Isidorii, cioè il III
libro delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia interpolato, in
manoscritti in scrittura visigotica, con la scala dei suoni tratta dal
Commento di Porfirio al Timeo (HUGLO 1994), manoscritti che in
Catalogna lo scolastico avrebbe potuto facilmente consultare.
Ultima testimonianza della capacità di Gerberto di costruire
organa è il già citato carmen figurato analizzato da Clyde Brockett,
poema che accompagnava proprio il dono di un organo.
Come si è già visto nel caso del monocordo, in Gerberto si
vedono dunque convergere le conoscenze del teorico musicale e
quelle del musicista strumentale, unite in questo caso anche a
notevoli abilità artigianali.
ABob xxix - 39
Mate.Testo.PM 39 2008.02.13, 7:34
A Bobbio dunque Gerberto dovette essersi dedicato con
particolare attenzione all’insegnamento della musica 35 ,
impegnandosi soprattutto nella realizzazione di strumenti, gli
organa, che potevano essere utilizzati non solo come ausilio per la
comprensione dei principi della teoria musicale, al pari del
monocordo, ma anche, a differenza di quest’ultimo, come veri e
propri strumenti musicali di accompagnamento alla liturgia.
In relazione all’insegnamento musicale di Gerberto a Bobbio è
stata evidenziata da M. Tosi (T OSI 1985) l’esistenza di un
manoscritto, l’Ambr. C.128 Inf., databile alla seconda metà del X
secolo e contenente scritti musicali e aritmetici legati a Boezio,
manoscritto che, secondo l’autore, con molta probabilità è
riconducibile alla scuola gerbertiana. Il f. 1 di questo codice contiene
infatti una decorazione a piena pagina costruita sull’espressione
«pone superparticolares», l’espressione cioè che apre lo scolio
gerbertiano all’Institutio arithmetica di Boezio, e che ci fornisce così
un prezioso indizio per individuare l’ambiente in cui il manoscritto
è stato prodotto. Al f. 46v è poi presente un disegno rappresentante
un organo: si tratta di una struttura verticale a 10 canne alla base
delle quali è posta la tastiera, alla destra è collocato il suonatore e
alla sinistra un inserviente che manovra i mantici; in base all’ipotesi
formulata da Tosi, che lega quindi questo manoscritto alla scuola
musicale bobbiense organizzata dal nuovo abate, questo potrebbe
essere proprio l’aspetto degli organa realizzati da Gerberto.
Più difficile è stabilire di quale tipologia di organo si trattasse.
Per una storia di questo strumento si vedano ROBBINS 1929, APEL
1948, WILLIAMS 1993 e MORENO 2000: la prima forma, realizzata
dall’ingegnere alessandrino Ctesibio nel III secolo a.C., era
35 Il fatto che a Bobbio Gerberto avesse organizzato una scuola, a prescindere dalle
materie insegnate, è confermato dall’epistola 13 (GERBERT, Correspondance) (Bobbio o
Pavia, prima del 7 dicembre 983) a Egberto, arcivescovo di Trevi, nella quale l’abate
promette al suo corrispondente di accogliere studenti in Italia. Inoltre proprio all’epoca
dell’abbaziato bobiense, giugno del 983, è datato il carmen figurato secondo Nuvolone.
40 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 40 2008.02.13, 7:34
l’hydraulis, nel quale, per equilibrare la pressione dell’aria
all’interno delle canne, veniva utilizzata l’acqua; successivamente
si passò all’impiego di mantici e, a partire dal III secolo d.C., si
introdusse il termine organum, a indicare soprattutto il nuovo
modello dell’organo pneumatico. La storia dello strumento in
Occidente subisce un arresto all’epoca delle invasioni barbariche:
intorno al VI secolo, infatti, si perde del tutto la capacità di
realizzare l’hydraulis, mentre permane qualche sporadica
realizzazione del tipo pneumatico. L’uso dell’organo, riservato
come già nell’Antichità alle cerimonie civili, rimane invece sempre
vivo a Bisanzio, e riceve un nuovo impulso dal contatto con il
mondo arabo, dove la sua tecnica di costruzione, in primo luogo
del tipo idraulico, era stata appresa direttamente dai testi greci. A
partire dall’VIII secolo l’hydraulis, grazie a Bisanzio, fa la sua
ricomparsa nell’Occidente latino, suscitando un immenso stupore
e guadagnandosi menzioni nelle cronache dell’epoca: nel 757
l’imperatore Costantino Copronimo ne fa dono a Pipino il Breve,
nell’812 un secondo organo viene inviato a Carlo Magno, nell’826,
alla corte di Ludovico il Pio, un hydraulis è realizzato da un prete
veneziano edotto in quest’arte a Bisanzio.
Benché il tipo pneumatico resti comunque quello più diffuso
nell’Occidente latino, un passaggio del carmen figurato analizzato
da Brockett — nel quale si afferma che «... omnia que nato rogite
cum pneumate sacro/ occupat atque suo mare quod tam gurgite
vasto...», «...Richieda con insistenza tutto ciò che necessita al figlio
col Soffio sacro,/ pressato inoltre dal mare con le sue onde
profonde...», versi questi che giocano sul doppio senso
dell’espressione «pneuma sacer», interpretabile sia come Spirito
santo sia come soffio dell’organo utilizzato nelle celebrazioni
liturgiche e sospinto dall’acqua36 — fa propendere piuttosto verso
36 Cf. NUVOLONE 2003, p. 140-141, 199-205 e 2004, p. 315-322.
ABob xxix - 41
Mate.Testo.PM 41 2008.02.13, 7:34
la tipologia idraulica, di più complessa fattura, il che spiegherebbe
anche le difficoltà di trasporto dall’Italia al monastero di Aurillac.
Al proposito si segnala che, benché la testimonianza di
Guglielmo di Malmesbury vada considerata con cautela dato il
suo legame con il filone letterario della leggenda di Gerberto papa-
mago, egli fa comunque riferimento a un organo idraulico lasciato
dallo scolastico a Reims (di cui tuttavia non fa menzione Richero)
(WILLELMUS, Gesta).
2.3
L’Astronomia
Una storia dell’astronomia alto-medievale è offerta dal lavoro
MCCLUSKEY 1998, dal quale risulta che, persi i contatti con la
tradizione antica di osservazione e di studio secondo modelli
geometrici di rappresentazione, tale disciplina si era
sostanzialmente ridotta al rango di ausiliaria della liturgia: ad
essere praticata era infatti quasi esclusivamente l’arte del computo
(per il quale si veda il già citato B ORST 1997), sia per la
determinazione del calendario liturgico, in particolar modo della
data della Pasqua, sia per il calcolo del tempo giornaliero,
fondamentale per la vita monastica rigorosamente scandita dalle
ore della preghiera. L’astronomia pratica dunque, limitata a tali
ambiti esclusivamente monastici, finiva per diventare in realtà un
semplice caso particolare della pratica aritmetica.
Un’altra forma di interesse per l’astronomia, tendenzialmente
più teorica, registra la sua fioritura a partire dall’epoca carolingia
e si concretizza nella produzione dei cosiddetti “cataloghi di stelle”:
si tratta di descrizioni dell’aspetto visivo delle costellazioni, delle
quali vengono messe in evidenza il numero di stelle che le
compongono e la localizzazione di quelle principali; vi si
affrontavano, inoltre, anche problemi di cosmologia, fornendo
schematiche rappresentazioni pittoriche del sistema delle sfere
42 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 42 2008.02.13, 7:34
celesti. Si tratta tuttavia di testi più letterari che scientifici, che
attingono alla tradizione enciclopedica latina, dalla Naturalis
Historia di Plinio alle Etymologiae di Isidoro di Siviglia fino ad
arrivare al De natura rerum di Beda il Venerabile, e che non sono
scevri da fascinazioni mitologiche: spesso, infatti, le illustrazioni
che accompagnano il testo rappresentano in realtà la figura
mitologica che dà il nome alla costellazione piuttosto che lo schema
reale secondo cui sono disposte le stelle; né manca, talvolta, un
certo simbolismo religioso riscontrabile ad esempio in Alcuino di
York. Sempre costante era il rischio che lo studio dell’astronomia
degenerasse in astrologia, a tutto discapito della scientificità. È
ancora alla corte carolingia, in particolar modo a partire da Luigi
il Pio, che si registra un revival di quella contaminazione fra
astronomia e astrologia che era fiorita alla corte imperiale romana,
e aveva poi lasciato scarse tracce di sé nei primi tempi dell’Alto
Medioevo. Si tenga presente tuttavia che questa astrologia di corte
non va confusa con la semplice predizione astrologica,
unanimamente deprecata, e godeva di una considerazione pari a
quella della scienza astronomica vera e propria; almeno
teoricamente, infatti, astronomia e astrologia costituivano due
discipline distinte e di pari dignità, secondo la definizione
isidoriana che assegnava all’una lo studio dei movimenti dei corpi
celesti, e all’altra le ragioni che presiedono a tali movimenti, cioè
rispettivamente il nomos e il logos. La latente ambiguità perlomeno
nella pratica, se non nella definizione ufficiale della materia, risulta
però chiara dal fatto che i due termini astronomia/astrologia nel
linguaggio comune spesso si sovrapponevano e si confondevano.
Ma nessuna ambiguità emerge nell’attività di Gerberto, il quale
si mostra a tutti gli effetti un astronomo, osservatore del cielo non
già per scorgervi segni e determinare influssi astrali ma per
individuare pianeti e stelle in esso presenti: l’invito da lui rivolto
ai suoi studenti di Reims è infatti quello di scrutare, nelle notti
serene, i corpi celesti per riconoscerli e determinarne le altezze
sull’orizzonte al momento del sorgere e del tramontare:
ABob xxix - 43
Mate.Testo.PM 43 2008.02.13, 7:34
«… Nam tempore nocturno ardentibus stellis operam
dabat; agebatque ut eas in mundi regionibus diversis
obliquatas, tam in ortu quam in occasu notarent…» (RICHERUS,
Historiarum, III, 50)
Per quel che riguarda i testi sicuramente autentici di Gerberto
ricordiamo:
1) la lettera a Costantino di Fleury sulla costruzione della
semisfera (ep. 3, GERBERT, Lettres scientifiques), di data sconosciuta
ma collocabile entro il 982 (della quale si parlerà nel paragrafo
seguente).
2) la lettera 153 (GERBERT, Correspondance) a Adamo sul metodo
di determinazione degli archi diurni e notturni alle diverse
latitudini, datata al 989, analizzata in POULLE 1985, p. 600-602, 612;
MCCLUSKEY 1998, p. 65-70; SIGISMONDI 2003, p. 70-75. La lettera si
fonda su una conoscenza astronomica esclusivamente latina, in
particolare Gerberto commenta qui una regola esposta nel De
nuptiis di Marciano Capella. Con questo scritto inoltre l’aquitano
si inserisce nella tradizione altomedievale dei computi, tipica
dell’ambiente monastico, e che soprattutto aveva avuto a Reims
un illustre rappresentante in Remigio d’Auxerre, scolastico dall’883
al 900. Remigio fu autore, fra l’altro, di un commentario In
Marcianum Capellam, nel quale si dimostra a tal punto versato
nell’arte del computo da riuscire a chiarire, e talvolta perfino
correggere, alcune affermazioni dell’autore. In realtà l’interesse di
Gerberto per tale tradizione era probabilmente debole,
avvicinandosi maggiormente, in questa branca del sapere, allo
spirito antico di osservazione: nonostante la tradizione della scuola,
nonostante la possibilità di accedere all’opera di Remigio, la lettera
di Gerberto presenta infatti un grossolano fraintendimento della
regola di Capella commentata. Sull’aspetto delle conoscenze
geografiche di Gerberto, in particolare gli aspetti tolemaici di esse,
si vedano LINDGREN 1985 e SIGISMONDI 2003a.
Di notevole aiuto sono poi le Storie di Richero, il quale si diffonde
dettagliatamente nella descrizione degli strumenti usati dallo
scolastico per l’insegnamento dell’astronomia alla scuola di Reims.
44 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 44 2008.02.13, 7:34
Come spia dell’interesse sempre vivo di Gerberto in questo
campo si consideri poi anche la richiesta del trattato di astronomia
tradotto dall’arabo fatta a Lupito di Barcellona nel 984 (ep. 24,
GERBERT, Correspondance).
2.3.a. Gli strumenti astronomici di Gerberto
Furono essenzialmente gli strumenti usati da Gerberto, in
particolare le sfere, a destare la grande ammirazione dei suoi
contemporanei, tanto che lo scolastico di Reims poté utilizzarli
come prezioso oggetto di scambio per ottenere un bene altrettanto
prezioso per lui: manoscritti (ep. 134, GERBERT, Correspondance).
L’estrema cura con cui tali sfere sono descritte da Richero, il
quale sottolinea come esse rendessero facilmente comprensibile a
chiunque una disciplina tanto ardua, e dedica proprio
all’insegnamento dell’astronomia il numero maggiore di capitoli
delle sue Storie, rivela quale dovette essere l’entusiasmo suscitato
fra i contemporanei.
Si tratta dunque di ottimi strumenti pedagogici, di cui non c’è
traccia in precedenza nelle scuole alto-medievali né in quelle
contemporanee37, e che paiono scaturire dall’inventiva dello
scolastico, l’ars di Gerberto sottolineata da Richero, dalla sua stessa
passione per l’insegnamento38, dalla capacità di rileggere le fonti
tradizionali del sapere operando un’intelligente contaminazione
fra di esse, non limitandosi come i suoi predecessori a semplici
rielaborazioni letterarie ma riproducendo fattivamente quelle
descrizioni in modelli tangibili, il tutto corroborato probabilmente
37 Cf. FROVA 1974b, p. 79.
38 Gerberto rivela una spiccata propensione per l’elaborazione di efficaci strumenti
pedagogici: oltre alle sfere astronomiche si consideri infatti la tavola-manuale da lui
creata per aiutare nella memorizzazione delle regole retoriche, citata nell’epistola 92
al monaco Bernardo (inizio del 987) (GERBERT, Correspondance).
ABob xxix - 45
Mate.Testo.PM 45 2008.02.13, 7:34
dal ricordo di strumenti utilizzati in ambiente culturale arabo, visti
durante il suo soggiorno in Catalogna. È da sottolineare,
comunque, che si tratta solo di strumenti pedagogici e non di veri
e propri strumenti di osservazione, in quanto essi permettono
esclusivamente l’individuazione dei corpi celesti ma non offrono
la possibilità di effettuare la misurazione delle coordinate stellari.
Si individuano quattro tipi di sfere, per la cui descrizione tecnica
si vedano FROVA 1974b, LINDGREN 1976, POULLE 1985, ZUCCATO 2005a.
Per una panoramica generale sugli strumenti astronomici in uso
nel Medioevo si consulti poi DESTOMBES 1966.
1) una sfera delle stelle, piena e in legno, rivestita di cuoio,
recante sulla superficie il disegno delle costellazioni, testimoniata
da Richero (RICHERUS, Historiarum, III, 50) e da Gerberto nell’ep.
148 e 152 (GERBERT, Correspondance). Si tratta cioè di una sfera ce-
leste, strumento di rappresentazione astronomico di origine
ellenistica utilizzato anche dagli arabi. La rappresentazione della
sfera celeste si basa sull’impressione che si ricava dall’osservazione
del cielo in una notte serena, per cui le stelle appaiono come punti
fissi luminosi incastonati sulla superficie di una volta centrata verso
l’osservatore: lo strumento non fa altro che riprodurre questa volta
immaginaria. Per quel che riguarda l’origine araba di queste sfere,
ampiamente descritte in SAVAGE 1985, si consideri che il ms. ACA
225 Ripoll, di cui si parlerà più oltre, contiene il De orologio secun-
dum alkoram, id est, speram rotundam, che è appunto la testimonianza
di una sfera celeste ed utilizza una fonte araba; e di origine araba
è il più antico globo celeste esistente al mondo, fabbricato a Valen-
cia da Ibrahim ‘Ibn Said nel 1085 e conservato all’Istituto e Museo
della Storia della Scienza di Firenze. Una descrizione letteraria
latina di un globo celeste è quella contenuta nel libro VIII del De
nuptiis di Marciano Capella: nella rappresentazione allegorica
l’Astronomia compare sulla scena accompagnata dalla sorella
Geometria, la quale indossa un mantello sul quale sono
rappresentati il sistema dei cieli, le orbite del sole e della luna e
varie costellazioni, e reca in mano un globo celeste.
46 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 46 2008.02.13, 7:34
2) la semi-sfera, oggetto oltre che della descrizione di Richero
(RICHERUS, Historiarum, III, 51) anche di quella dello stesso Gerberto
nella ep. 3 a Costantino (GERBERT, Lettres scientifiques), per la cui
tradizione manoscritta si veda MOSTERT 1997. Essa era, fra tutte, lo
strumento più complesso e quello più specificatamente legato
all’osservazione diretta dei corpi celesti. Si trattava di una semi-
sfera in legno di grandi dimensioni sulla cui superficie erano
segnati i circoli polari, i tropici e l’equatore, intersecati da un
meridiano. Nei punti di intersezione fra i paralleli e il meridiano
erano praticati dei fori e inserite delle fistulae, in tutto sette,
convergenti verso il centro, dove si collocava l’osservatore. Siamo
qui di fronte ad una anbuba, cioè un tubo rettilineo per
l’individuazione dei corpi celesti, di origine araba, descritto
ampiamente insieme ad altre tipologie dello stesso strumento in
MICHEL 1954. Guardando attraverso le fistulae, una volta orientata
la sfera secondo l’inclinazione del globo terrestre, era possibile
individuare le stelle presenti di volta in volta alle principali
latitudini. Secondo Ute Lindgren invece, in LINDGREN 1976, le fistu-
lae comprese fra le due polari non sarebbero state convergenti verso
il centro ma parallele fra loro. Come si sottolinea in ZUCCATO 2005a
l’intento di Gerberto era quindi quello di familiarizzare gli studenti
con i cinque cerchi della tradizione aratea, essenziale per
comprendere i principi base dell’astronomia classica. Tale
strumento non ebbe però seguito nel Medioevo in quanto
soppiantato dall’affermarsi di un nuovo, autentico e ben più
maneggevole strumento di osservazione: l’astrolabio.
3) la terza è una sfera armillare, cioè un antico strumento di
rappresentazione dei grandi cerchi celesti (equatore, meridiani,
eclittica, tropici), in pratica corrispondente a una sorta di scheletro
della sfera celeste. La più antica armilla completa conosciuta è
quella utilizzata dai Greci di Alessandria nel 140 d.C. ca., ma
modelli più semplici erano di uso generale anche prima di questa
epoca. La prima versione dell’astrolabio, il cosiddetto astrolabio
sferico illustrato da Tolomeo, non era altro in realtà che una
rielaborazione dell’armilla in modo tale da trasformarla da modello
ABob xxix - 47
Mate.Testo.PM 47 2008.02.13, 7:34
astronomico a strumento d’osservazione. Le sfere armillari
conobbero una grandissima diffusione nel mondo islamico e le
armille utilizzate nel XII secolo dagli arabi di Spagna costituirono
i prototipi di tutte le successive sfere europee. Quella di Gerberto,
testimoniata da Richero (RICHERUS, Historiarum, III, 52), è costituita
dai cerchi rappresentanti i circoli polari, l’equatore e i tropici, il
tutto tenuto insieme dai due coluri (cioè dai meridiani celesti
passanti per il punto equinoziale e solstiziale), ed esternamente
dall’eclittica, all’interno della quale erano sospese le sfere delle
orbite dei pianeti, così da permettere la localizzazione dei singoli
pianeti nello Zodiaco e l’individuazione dei principali rapporti di
ciascuno con gli altri. Come illustrato da Zuccato (NUVOLONE 2005f,
p. 495) i pianeti sono collocati nello loro sedi d’origine all’inizio
dell’anno cosmico, secondo il metodo illustrato dal Liber Alchandrei.
4) infine una sfera, descritta in RICHERUS, Historiarum, III, 53,
che rappresenta una commistione fra la sfera armillare e la sfera
delle stelle: essa presentava infatti la struttura di un’armilla sulla
quale però erano rappresentate le costellazioni per mezzo di fili
metallici. La sfera era munita di una fistula passante per i poli che
permetteva, individuando attraverso di essa l’Orsa maggiore, di
orientare la sfera in modo analogo all’inclinazione reale del globo
terrestre: era quindi soprattutto quest’ultimo particolare a
distinguerla dal primo globo celeste.
Zuccato, nel già citato ZUCCATO 2005a, ha messo in evidenza
che l’aspetto più interessante di questa sfera è la presenza
dell’anello dell’orizzonte, un particolare tecnico che la ricollega
senza possibilità di equivoco al mondo islamico. Si tratta di un
anello esterno, regolabile, utile per mostrare la posizione delle stelle
a differenti latitudini geografiche, la cui prima attestazione risale
alla descrizione di un globo solido nell’opera di Tolomeo. Tale
espediente tecnico, da non confondersi con il concetto teorico di
linea dell’orizzone, nozione questa del tutto comune, era
totalmente sconosciuto alla tradizione latina antecedente a
Gerberto, mentre è sistematicamente utilizzato nei globi celesti
islamici.
48 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 48 2008.02.13, 7:34
Se le sfere erano la base dell’insegnamento astronomico di
Gerberto a Reims, non manca tuttavia nelle fonti la menzione di
altri strumenti.
Abbiamo due testimonianze della costruzione da parte di
Gerberto di quello che viene definito come un horologium: Tietmaro
di Magdeburgo, nel suo Chronicon, riferisce della costruzione di
un horologium a Magdeburgo, come dono all’imperatore Ottone
III (THIETMARUS, Chronicon, 61); Guglielmo di Malmesbury parla di
un horologium arte mecanica compositum lasciato a Reims (WILLELMUS,
Gesta, II, 168).
Le due testimonianza sono analizzate da E. Poulle in POULLE
1985, 1996a e 2000. L’autore conclude che per quanto riguarda il
primo testo, lo strumento andrà sicuramente identificato con un
notturlabio, cioè uno strumento per determinare l’ora notturna
avvalendosi dell’osservazione della posizione dell’Orsa Maggiore;
quanto invece alla testimonianza di Guglielmo di Malmesbury,
escludendo che si tratti di un orologio meccanico, nato alla fine
del XIII secolo e sconosciuto quindi allo stesso autore, si potrà
pensare o ancora a un notturlabio, oppure, considerando le valenze
della parola horologium nel Medioevo, a una meridiana o a una
clessidra.
Infine, nella lettera a Adamo, Gerberto nomina una clepsydra,
della quale avvalersi per la determinazione degli archi temporali:
si tratta di un orologio ad acqua, strumento del quale si è conservata
la tradizione dall’Antichità fino al XIII-XIV secolo, ma di cui, per
l’epoca in questione, non si conoscono esattamente i dettagli tecnici.
Nel X secolo una clessidra ad acqua era presente nel monastero di
Fleury, e il problema di come calcolare il tempo in base alla quantità
d’acqua che scorre nei vasi di una clessidra è affrontato in uno
scritto di Abbone di Fleury sulla base di Macrobio.
ABob xxix - 49
Mate.Testo.PM 49 2008.02.13, 7:34
2.3.b. Gerberto e l’astrolabio: un problema irrisolto
Il nome di Gerberto di Aurillac si inserisce in modo molto
problematico nella discussione riguardo alle modalità di
trasmissione dell’astrolabio dal mondo islamico a quello
dell’Europa occidentale latina.
Benché si trattasse di uno strumento molto antico è però con
gli arabi che esso viene portato alla perfezione e conosce un’ampia
diffusione. La sua storia nel mondo latino è ampiamente descritta
in BORST 1989, ma si veda anche MCCLUSKEY 1998, p. 171-175.
L’astrolabio penetra nel mondo occidentale latino attraverso la
via spagnola, dall’Andalusia alla Catalogna, in due fasi temporali
successive. La prima, corrispondente agli ultimi decenni del X
secolo (quella dunque in cui si colloca anche la figura di Gerberto)
vede in atto i primi tentativi di traduzione di opere arabe
sull’argomento: il risultato sarà la produzione di un corpus
astrolabico in lingua latina, rappresentato da testi molto complessi
e spesso oscuri, data la difficoltà di adattare in latino la nuova
terminologia araba e di comprendere appieno la materia stessa,
totalmente estranea per un Occidente che ignorava l’opera di
Tolomeo. Tali testi, proprio per la loro difficile accessibilità, saranno
destinati per la maggior parte a cadere nell’oblio, mentre, per la
reale diffusione del nuovo strumento e la generalizzazione del suo
utilizzo, bisognerà aspettare la seconda fase, quella cioè dell’ondata
di traduzioni sistematiche del XII secolo — in particolare quelle di
Johannes Hispalensis — quando si renderanno disponibili in latino
non solo i trattati sull’astrolabio ma anche l’opera che ne espone i
principi teorici: vale a dire il Planispherium di Tolomeo.
Tornando alla prima fase di trasmissione, una delle più
importanti testimonianze al riguardo è il ms. ACA Ripoll 225,
descritto dal punto di vista paleografico e codicologico in MARTINEZ
2000, contenente un’ampia raccolta di testi appartenenti all’antico
corpus (fra i quali anche il De utilitatibus e alcuni passi della
Geometria Incerti Auctoris, vedi oltre) e copiato nello scriptorium di
50 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 50 2008.02.13, 7:34
S. Maria de Ripoll prima della metà dell’XI secolo, confermando
così il ruolo svolto dal monastero catalano in questo processo di
trasmissione culturale. In particolare il ms. 225 contiene le Astrolabii
Sententiae, cioè il più completo dei primi testi sull’astrolabio, con
il quale è stato identificato dai più (si vedano ad es. MCCLUSKEY
1998, p. 175; MARTINEZ 2000, p. 243-246; KUNITZSCH 2000, p. 392) il
Liber de astrologia tradotto da Lupito e conosciuto da Gerberto. Una
proposta alternativa è quella (THORNDIKE 1923, p. 697-701) di
identificare il testo di Lupito con lo stesso De utilitatibus attribuito
a Gerberto, chiudendo quindi in negativo la spinosa questione sulla
paternità gerbertiana dello scritto con l’ipotesi che l’aquitano si
sia limitato a una semplice “ripulitura” dell’ostico testo latino
inviatogli dal suo corrispondente catalano, senza peraltro
intervenire in modo sostanziale sul contenuto. Dubbi sulla
identificazione delle Sententiae con l’opera di Lupito avanza invece
E. Poulle in POULLE 2005.
Paul Kunitzsch, in KUNITZSCH 1997 e 2000, ha messo in evidenza
che tale testo si avvale, come fonte principale, di un trattato
sull’utilizzo dell’astrolabio di al-Kwarizmi (Baghdad, IX sec.), oltre
che dell’osservazione diretta di uno strumento originale arabo,
testimoniando così che i primi approcci latini alla nuova
astronomia si avvalsero contemporaneamente sia di materiale
testuale che di oggetti, entrambi originali. Kunitzsch ha anche
messo in rilievo che, sebbene per le traduzioni sistematiche delle
grandi opere di Tolomeo bisognerà aspettare l’attività organizzata
delle scuole di traduzione toledane, primi tentativi di adattamento
parziale di tali testi poterono essere realizzati già nel X secolo: ne è
testimonianza il manoscritto Paris, BNF, lat. 7412, che contiene,
frammisti proprio al testo delle Astrolabii Sententiae, alcune righe
identificate dallo studioso come gli inizi della traduzione dei primi
due capitoli del Planispherium nella versione araba, una traduzione
cioè precedente di un secolo e mezzo quella di Ermanno di Carinzia
(1143 d.C.). Sul problema della esistenza di traduzioni dall’arabo
in latino già prima del XII sec. si veda anche l’articolo JUSTE 2000.
L’autore individua, sul finire del X sec. in Catalogna, la
ABob xxix - 51
Mate.Testo.PM 51 2008.02.13, 7:34
composizione di due corpora destinati a contendersi il primato per
quel che riguarda l’elaborazione dei primi testi scientifici latini
con elementi arabi: il corpus dei testi astrologici conosciuto sotto il
nome di Alchandreus e il corpus astrolabico.
Il testo del Planispherium è d’altronde, proprio nel X secolo,
oggetto dei commenti dell’astronomo andaluso Maslama, il
maggior propugnatore degli studi sull’astrolabio nell’ambiente
islamico d’Occidente. Come si evidenzia in KUNITZSCH 1997, SAMSÓ
1999, PUIGVERT 2000b, p. 51 e MARTINEZ 2000, p. 248-249, proprio il
nome di Maslama si collega indirettamente con le Astrolabii
sententiae: questo testo infatti contiene una tavola delle coordinate
stellari ricalcata sul modello di quella elaborata da Maslama o dalla
sua scuola nel 978 d.C.; il che ci permette non solo di stabilire un
sicuro termine post quem per la redazione delle Astrolabii Sententiae,
ma anche di collocare il pieno sviluppo degli studi arabo-andalusi
sull’astrolabio, e la loro diffusione in ambito catalano, a partire
dal terzo quarto circa del X secolo. A conferma di tale datazione si
consideri che il più antico astrolabio latino conosciuto, l’astrolabio
“carolingio” o astrolabio Destombes, è un oggetto di fabbricazione
catalana risalente al terzo o ultimo quarto del X secolo39.
Questo dunque il quadro cronologico-culturale sul cui sfondo
si colloca l’attività di Gerberto. Il problema, riguardo allo scolastico
di Reims, è non solo quello di capire se egli abbia conosciuto tale
strumento, ma soprattutto se, eventualmente, la sua conoscenza
possa essere stata tale da permettere di attribuirgli la paternità di
un trattato sull’argomento, il De utilitatibus astrolabii o Quicumque
astronomice peritiam discipline, la cui tradizione manoscritta è
analizzata in MOSTERT 1997. È soprattutto quest’ultimo punto a
dividere gli storici della scienza medievale fra chi, come Emmanuel
Poulle, nega la possibilità di una tale attribuzione e chi, come Ute
Lindgren, la sostiene invece con fermezza. Lo stesso Bubnov pone
39 Cf. PUIGVERT 2000b, p. 54; MARTINEZ 2000, p. 247-248.
52 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 52 2008.02.13, 7:34
il trattato fra gli opera dubia, non sapendo fondamentalmente
esprimersi né a favore né a sfavore della presunta autenticità
gerbertiana.
Che Gerberto abbia potuto perlomeno vedere un astrolabio du-
rante il suo soggiorno in Catalogna è possibile: l’allusione a un
oscuro radium geometricum contenuta in una lettera a Costantino
(ep. 1, GERBERT, Lettres scientifiques) può essere chiarita se la si
interpreta come ricordo dell’alidade, cioè di quella parte
dell’astrolabio costituita da un’asticella munita di mirino, utilizzata
per calcolare l’altezza di un astro sull’orizzonte40. Resta da chiarire
tuttavia il punto fondamentale: se Gerberto abbia potuto cioè anche
assimilare le conoscenze teoriche sottintese alla possibilità di
utilizzo di tale strumento.
Poulle, in POULLE 1985, 1996b e 2005, nega l’attribuzione del
trattato a Gerberto e pone l’eventuale conoscenza dell’astrolabio
in un’epoca molto avanzata. A conferma della sua tesi lo studioso
sottolinea come la semi-sfera descritta da Richero e dallo stesso
Gerberto non avrebbe avuto senso se lo scolastico avesse avuto
conoscenza e pratica dell’astrolabio: la semi-sfera infatti non avrà
seguito proprio perché del tutto inutile in conseguenza della
diffusione del nuovo strumento, che assolveva le medesime, e ben
altre, funzioni in modo assai più pratico. Inoltre Richero, che scrive
alla fine del X sec., non fa menzione dell’astrolabio, pur dedicando
un’esauriente sezione delle sue Historiae all’insegnamento
astronomico del maestro. (È però da sottolineare che Richero non
fa nemmeno menzione, in campo musicale, degli organa, di cui ci
dà invece testimonianza certa la corrispondenza dello stesso
scolastico). Se si considera poi l’unico scritto di teoria astronomica
senza alcun dubbio di Gerberto, cioè la lettera a Adamo, bisogna
ammettere che essa poggia, ancora nel 989, su conoscenze
astronomiche esclusivamente latine.
40 Cf. BEAUJOUAN 1985, p. 646, 651; BEAUJOUAN 1991, p. 309; MCCLUSKEY 1998, p. 171.
ABob xxix - 53
Mate.Testo.PM 53 2008.02.13, 7:34
Se l’aquitano conobbe l’astrolabio, tale conoscenza è dunque,
secondo lo storico francese, da collocarsi sicuramente dopo il 984,
l’anno in cui Gerberto richiede a Lupito di Barcellona la sua
traduzione di un Liber de astrologia, e, considerato il tempo di avere
il manoscritto e di assimilarne il contenuto, lo scolastico di Reims
fu eventualmente in grado di comprendere correttamente il
funzionamento dello strumento solo dopo il 989, l’epoca cioè della
lettera a Adamo. Ammessa la conoscenza dello strumento, Poulle
nega però la possibilità che Gerberto sia stato l’autore di un testo
complesso come il De utilitatibus astrolabii, il quale presenta inoltre
uno stile alquanto differente da quello abituale dello scolastico,
una prosa infarcita di termini arabi per la cui conoscenza si
dovrebbe postulare anche un’altra fonte rispetto alle Astrolabii
sententiae, non identificabile peraltro con nessuno dei testi del
primo corpus astrolabico. Secondo lo storico francese Gerberto si
sarebbe allora limitato allo studio del testo inviatogli, divulgando
progressivamente ai propri discepoli le conoscenze che andava
acquisendo. Quanto all’origine del De utilitatibus astrolabii, esso
andrà allora ricondotto, attraverso i discepoli di Gerberto,
all’ambiente degli studiosi di Lorena dell’inizio dell’XI secolo, fra
i quali dette notevoli risultati la diffusione dello spirito
dell’insegnamento dello scolastico di Reims, l’ambiente cioè al
quale va attribuita anche la Geometria Incerti Auctoris (vedi oltre), e
in cui operò l’altro divulgatore latino dell’astrolabio, Ermanno
Contratto, autore del De mensura astrolabii.
Recentemente Poulle, in POULLE 2005, ha ripreso le sue posizioni,
sempre decisamente contrarie alla paternità gerbertiana dello
scritto, illustrando un lavoro ancora inedito di Jacquemard che
sembra confermare le sue teorie. Jacquemard individua il momento
in cui si registra una presa di coscienza delle possibilità
pedagogiche dell’astrolabio intorno al 1020, e lo situa a Chartres
in relazione con l’insegnamento di Fulberto, di cui sono noti i
rapporti con la Catalogna. La dispersione dei suoi allievi fra la
Valle della Loira (Micy, Fleury), la Lotaringia (Liegi) e la Germania
54 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 54 2008.02.13, 7:34
(Ratisbona, Augsburg e Reichenau), assicurò la diffusione della
collezione catalana primitiva, e la redazione di una nuova
generazione di testi, di cui farebbe parte Quicumque astronomice o
De utilitatibus. Il ruolo di questa area geografica nel processo di
trasmissione delle nuove conoscenze scientifiche influenzate da
elementi arabi è oggetto in particolare dello studio di Charles
Burnett, BURNETT 1998.
Oltre a Poulle, contro la paternità gerbertiana dello scritto si
sono espressi anche Dalché, in DALCHÉ 1996, il quale, tracciando
una linea di diffusione dell’astrolabio che passa attraverso la
Catalogna e poi la regione della Loira, ritiene probabile che in
questo processo siano stati tuttavia coinvolti discepoli di Gerberto;
e Samsò (citato in PUIGVERT 2000b, p. 51 e MARTINEZ 2000, p. 246),
che colloca lo scritto in area barcellonese insieme agli atri testi
contenuti nel ms. 225 (Astrolabii Sententiae, De mensura astrolapsus,
De orologio secundum alkoram) in quanto tutti sembrano far
riferimento alla latitudine di 42°, cioè quella dell’area Barcellona,
Gerona, Vic e Ripoll.
Su una posizione diametralmente opposta si pone invece Ute
Lindgren. In LINDGREN 1976, 1985 e 2001, la studiosa si esprime a
favore della paternità gerbertiana dello scritto, considerando
innanzitutto che l’attribuzione a Gerberto presente nella tradizione
manoscritta risale a epoca molto precoce, ad es. nel ms. Oxford,
Bodleian Library, Digby 174 (XII sec.). (A differenza della Lindgren,
Poulle non dà peso alla nota in questione, pur non negando
anch’egli l’esistenza di alcuni casi molto antichi di attribuzione
del trattato a Gerberto: ne è un esempio un catalogo di Saint-Evre
de Toul, anteriore al 1084, che cita un Gerbertus de astrolapsu). Inoltre
la comparazione con la lettera a Adamo è considerata dalla
studiosa, a differenza di Poulle, come un indizio a favore della
paternità gerbertiana del De utilitatibus astrolabii. Infatti, anche se
nella lettera la questione dei climata è affrontato secondo una
prospettiva esclusivamente latina, l’argomento stesso è di una tale
rarità per l’epoca che il ritrovarlo nella corrispondenza di Gerberto
ABob xxix - 55
Mate.Testo.PM 55 2008.02.13, 7:34
e come cap. 18 e 19 del trattato, pur se, in quest’ultimo caso, secondo
una prospettiva di conoscenze ben più ampia41, depone a favore
dell’autenticità gerbertiana dello scritto. La differenza di stile
rispetto agli altri scritti di Gerberto è poi spiegabile come il risultato
di una fedele aderenza dell’autore alla fonte originale. Gerberto
dunque sarebbe stato in grado di produrre un testo che spiegasse
le modalità d’impiego del nuovo strumento astronomico,
realizzando un ulteriore volgarizzamento in latino, in una forma
più comprensibile, della prima traduzione da lui conosciuta al
riguardo, cioè le Astrolabii Sententiae, il Liber de astrologia richiesto
al suo corrispondente barcellonese.
In questo dibattito si è inserito anche Guy Beaujouan, in
BEAUJOUAN 1965, 1971 e 1985. Sostanzialmente lo storico francese
afferma che se anche Gerberto non fosse l’autore del trattato,
sarebbe comunque legato ad esso in modo molto stretto attraverso
uno dei suoi allievi diretti (mentre Poulle, come si è visto, sposta
la composizione in area lorenese, in un ambiente piuttosto di “eredi
spirituali” dell’insegnamento di Gerberto). Beaujouan fa notare
41 L’argomento dei climata come esposto nel De utilitatibus testimonia la conoscenza
di alcuni dati presenti esclusivamente nell’Almagesto di Tolomeo, il che, al di là della
questione della paternità gerbertiana, pone il problema delle fonti da cui può aver
tratto questi dati un autore latino del X secolo (il problema si porrebbe anche se la
data di composizione del trattato fosse spostata all’XI secolo). Kunitzsch, in KUNITZSCH
2000, p. 394-396, propone come soluzione che l’autore abbia tratto i dati relativi alle
zone climatiche dall’osservazione di un astrolabio originale arabo: sappiamo infatti
che i primi esempi dello strumento erano degli astrolabi universali, non adattati cioè
alla latitudine di utilizzo, e che presentavano perciò la rappresentazione dell’intero
mondo: di questo tipo è l’astrolabio riprodotto nel Paris, BNF, 7142, un astrolabio
andaluso che presenta le sette fasce climatiche secondo le latitudini individuate da
Tolomeo, e corrispondenti a quelle del De utilitatibus. (Quanto detto sopra sui
frammenti del Planispherium, traendo i dati dallo stesso Kunitzsch, dovrebbe tuttavia
far riflettere sulla sorprendente vivacità dell’ambiente culturale catalano). È stato
rilevato anche, in DALCHÉ 1996, che la tavola dei climi del De utilitatibus presenta una
caratteristica distorsione delle fasce climatiche da spiegarsi con la conoscenza di
rappresentazioni cartografiche comprendenti i soli toponimi, senza la divisione dei
climata, tipica di manoscritti siriani derivanti da modelli arabi.
56 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 56 2008.02.13, 7:34
che nel De utilitatibus è presente l’utilizzo del termine radium nel
senso di alidada così come un radium geometricum, spiegabile solo
come allusione all’alidada, è presente nella lettera a Costantino.
Ora, l’utilizzo del termine radium come equivalente di alidada non
ha riscontro in nessun altro testo del corpus astrolabico, e permette
perciò di stabilire uno stretto legame fra il trattato e l’entourage di
Gerberto. Anche per Beaujouan tuttavia, come per Poulle, la stesura
del trattato — che sarebbe quindi opera, probabilmente, di un
allievo di Gerberto, da lui stesso erudito dopo aver fatto pervenire
la documentazione da Barcellona — è da collocarsi dopo il 989,
cioè dopo la lettera a Adamo.
La discussione si è arricchita nel 1989 di un ulteriore dato messo
in evidenza da Arno Borst, e ampiamente analizzato in BORST 1989
(citato anche in MCCLUSKEY 1998, p. 176-177): la scoperta cioè, da
parte dello studioso, dei “frammenti di Costanza” (Konstanz,
Stadtarchiv, Fragmentensammlung Mape 2, Umschlag 8, Stck 7),
editi e analizzati paleograficamente e codicologicamente nell’opera
citata. Si tratta di due frammenti pergamenacei contenenti testi
del corpus astrolabico testimoniato dal ms. Ripoll 225, ma
soprattutto alcuni passi del De utilitatibus astrolabii. In base alle
caratteristiche paleografiche è possibile datare i frammenti con
precisione agli anni intorno al 1008, fatto questo che lega la
produzione del codice a cui appartenevano i testi alla figura di
Bern, abate dal 1008 al 1048, proveniente dal monastero di Fleury,
da quel monastero cioè in cui risiedeva il principale corrispondente
scientifico di Gerberto, Costantino. Né il testo modello in base al
quale fu realizzata la copia di Reichenau poteva essere stato portato
dal predecessore di Bern, l’abate Immo (1006-1008), il quale era
stato educato nel monastero di Gorze, centro di meditazione
ascetica fornito di una ricca biblioteca i cui codici non andavano
però oltre il IX secolo, e fra i quali non era dunque compreso nessun
testo sull’abaco e sull’astrolabio. Il ruolo svolto in questa vicenda
dal monastero di Fleury, dati i rapporti che con esso intratteneva
Gerberto, potrebbe quindi permettere di porre lo scolastico di
Reims in relazione con i testi contenuti nel detto codice. Come già
ABob xxix - 57
Mate.Testo.PM 57 2008.02.13, 7:34
Beaujouan, anche Borst sostiene l’idea che l’autore probabile del
De utilitatibus sia un allievo piuttosto che Gerberto stesso,
considerando che gli anni dopo il 989 sono anni di un’intensa
attività politica, che avrebbe probabilmente reso assai difficoltoso
per l’aquitano il cimentarsi in prima persona nella stesura di un
trattato scientifico.
La recettività dell’area lorenese, e in particolare di Fleury,
rispetto ai testi di natura scientifica, e in particolare astronomica
(in linea con quanto affermato da Emmanuel Poulle, soprattutto
in POULLE 2005), è stata poi ulteriormente messa in evidenza da
David Juste (JUSTE 2000), il quale colloca proprio in quest’area
l’elaborazione del Liber Alchandraei nella versione oggi conosciuta,
a partire da un corpus tradotto in latino, in Catalogna, nella seconda
metà del X sec. (in nota, a p. 286 del suo articolo, Juste cita la tesi di
REICHEL 1991 per il quale Gerberto sarebbe stato il traduttore del
Liber Alchandrei e il responsabile della sua diffusione in Europa).
2.4
La Geometria
L’ultima materia di insegnamento nel corso scolastico proposto
da Gerberto è la Geometria. Per comprendere il modesto livello
delle conoscenze dello scolastico di Reims in questo campo è
necessario far riferimento a quella che era stata la sorte di tale
disciplina nel mondo latino, del tutto impermeabile allo spirito
speculativo greco.
Della tradizione ellenica degli studi di geometria, confluita nella
grande opera di sistemazione realizzata da Euclide con i suoi
Elementi, i Romani ritennero in prevalenza solo quanto necessario
a effettuare misurazioni sul terreno e calcoli in ambito
architettonico: formule, quindi, di determinazione di aree e volumi,
applicate in modo meccanico senza alcun interesse per le
dimostrazioni. Questo minimo bagaglio di conoscenze fu perciò
58 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 58 2008.02.13, 7:34
appannaggio quasi esclusivo di figure professionali: quella
dell’agrimensore nel mondo latino e, successivamente, quella
dell’architetto nel mondo medievale. L’insegnamento fu invece
scarsamente praticato, e sempre esclusivamente in una prospettiva
di utilità pratica: la geometria era cioè considerata solo come l’arte
di prender misure. D’altronde, è anche vero che il concetto di
geometria teorica non potrà di nuovo assumere pieno significato
se non al momento della riscoperta dei testi originali di Euclide
grazie alle traduzioni arabe del XII secolo.
L’entità della tradizione di sapere che si offriva a Gerberto nel
campo geometrico era dunque modestissima, tanto più se si
considera che in quest’ambito lo scolastico di Reims non aveva
neanche il supporto dell’opera di Boezio: sicuramente il filosofo
tardo-antico, nel suo progetto di dotare il mondo latino di un
bagaglio di testi utili allo studio delle scienze, dovette aver
composto un’opera geometrica42, ma di essa si perse ben presto la
memoria. Si possono però considerare come indizi della sua
esistenza gli excerpta di Euclide in latino sopravvissuti nella
tradizione manoscritta, e confluiti poi nella redazione della
medievale Prima Geometria apocrifa di Boezio, conosciuta anche
come Geometria Euclidis a Boethio in latinum lucidius translata e
composta a Corbie probabilmente nell’VIII secolo, la cui tradizione
manoscritta fino al X sec. è analizzata in STEVENS 2005.
Ciò non implica, tuttavia, che a Gerberto non fosse chiaro
perlomeno l’alto valore formativo attribuito dal suo auctor a tale
disciplina.
Per i platonici e i pitagorici, della cui cultura Boezio è erede e
divulgatore, lo studio delle forme geometriche permette di guidare
il pensiero fino alla contemplazione dell’essere immutabile:
42 Ne dà testimonianza Cassiodoro il quale, nelle Institutiones, afferma che Boezio
aveva adattato Euclide in latino; inoltre alcuni manoscritti della medesima opera
contengono passi di una traduzione latina di Euclide che potrebbe essere quella
boeziana. Cf. CHADWICK 1986, p. 141; GUILLAUMIN 1995, p. XXVI.
ABob xxix - 59
Mate.Testo.PM 59 2008.02.13, 7:34
partendo infatti dalla materia, dall’attività pratica di misurazione
della terra, si arriva a ricondurre le forme naturali alle forme
geometriche, immutabili, a esse sottese, delle quali si riconosce
l’astrattezza. La riflessione sulle figure geometriche è perciò
addestramento della mente alla riflessione sull’essere supremo,
attraverso il distacco dal mondo del divenire che costituisce la realtà
contingente. Tale posizione era stata condivisa anche da S.
Agostino, per il quale la geometria, distraendo dal mondo delle
realtà materiali, predispone alla comprensione delle verità
spirituali: non a caso Gerberto cita proprio un passo del De
quantitate animae nel cap. I della sua opera. Il metodo geometrico,
consistente nel porre definizioni, assiomi e postulati, e nel discutere
poi quali conseguenze ne derivino necessariamente, è considerato
come una delle più ferree forme di ragionamento e, in quanto tale,
massima espressione di razionalità.
Sul piano però delle effettive conoscenze, Gerberto mancava
totalmente del rapporto con quella tradizione greca ancora
accessibile a Boezio, e la sua geometria si colloca dunque,
inevitabilmente, nella scia dell’agrimensura romana, con tutti i suoi
limiti e soprattutto con il suo disinteresse per la dimostrazione.
Per un’ampia trattazione dei testi di agrimensura si faccia
riferimento al lavoro di Lucio Toneatto, TONEATTO 1994. Vi si troverà
in particolare l’analisi dei manoscritti citati di seguito.
I testi a noi pervenuti sono due:
1) la Geometria Gerberti, composta in una data imprecisata fra il
980 e il 983 (per le varie ipotesi sulla datazione dell’opera si vedano
FROVA 1974a, p. 327 e VOGEL 1985, p. 592-593), l’unica sua opera
scientifica di un certo respiro sopravvissuta (vedi oltre).
2) la lettera a Adelboldo, monaco di Liegi divenuto nel 1010
vescovo di Utrecht, composta fra il 997 e il 999; pubblicata in BUBNOV
1899 e GERBERT, Lettres scientifiques (con traduzione francese), e per
la cui tradizione manoscritta si veda MOSTERT 1997.
Nell’epistola, l’aquitano chiarisce al suo corrispondente il
perché della differenza fra i risultati ottenuti con i due metodi,
geometrico e aritmetico, per la determinazione dell’area del
60 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 60 2008.02.13, 7:34
triangolo equilatero. La lettera a Adelboldo ci informa anche che
Gerberto aveva fatto dono al monaco di Liegi di un testo contenente
figure geometriche, vale a dire il ms. Napoli, V.A.13, del quale si
parlerà più avanti; e dell’esistenza di una precedente discussione
dello scolastico di Reims sul metodo di determinazione dell’area
del triangolo, una figura quindi che suscita in lui un notevole in-
teresse, da riconnettersi al particolare simbolismo pitagorico che
associava il triangolo al numero 10, numero significativo in quanto
prodotto dalla somma dei primi quattro numeri naturali, e quindi
assommante in sé le loro virtù.
Adelboldo scriverà anche una seconda lettera, di cui non
possediamo la risposta, a Gerberto ormai papa, interrogandolo
sul problema della determinazione del volume della sfera
(problema assai arduo per gli studiosi dell’epoca che non
conoscevano il valore del pi greco), testimoniando così come
l’aquitano fosse considerato un’autorità in materia. La lettera è
pubblicata in Migne come De ratione inveniendi crassitudinem spherae
(ADELBOLDUS, De ratione), e in BUBNOV 1899 come Epistola Adelboldi
ad Silvestrum II papam. Di essa ci dà testimonianza anche Guglielmo
di Malmesbury in WILLELMUS, Gesta, II, 168.
Scarsissime informazioni ci fornisce invece Richero, il quale si
limita ad affermare che lo studio della geometria era preceduto
dallo studio dell’abaco (RICHERUS, Historiarum, III, 54). Il fatto che
lo strumento calcolatorio fosse associato agli studi di geometria
dimostra come la componente pratica fosse senz’altro ben presente
nella mentalità di Gerberto, erede in questo della tradizione
occidentale.
2.4.a. La Geometria Gerberti
La Geometria Gerberti venne edita nel XVIII e XIX secolo in 94
capitoli (PEZ 1772; Gerbertus, Geometria; OLLERIS 1867) ma nel 1889
Bubnov ne considerò autentici solo i primi tredici, raccogliendo il
resto sotto il nome di Geometria Incerti Auctoris. Recentemente, LEVET
ABob xxix - 61
Mate.Testo.PM 61 2008.02.13, 7:34
1997b, è stata proposta una traduzione francese; per la tradizione
manoscritta dell’opera si veda MOSTERT 1997; per un’analisi del testo
consultare FRIEDRICK 1973, FROVA 1974b, LINDGREN 1976, VOGEL 1985,
BEAUJOUAN 1985.
Essa consiste in un’esposizione delle definizioni delle
fondamentali entità geometriche che Gerberto, con un metodo
caratteristico e del tutto personale, inverso rispetto a quello
abituale, propone in un ordine che va dal generale al particolare,
cioè dalla definizione di figura solida a quella di punto, alludendo
così a quel processo di progressiva astrazione che è alla base dello
studio geometrico; segue una dissertazione di geometria piana
limitata però solo alla prima figura, il triangolo. Si segnala che, a
proposito del triangolo, Gerberto dimostra di saper padroneggiare
il teorema di Pitagora, del quale vengono forniti numerosi esempi
numerici, non esitando nemmeno di fronte al calcolo con le frazioni.
Si consideri che nella corrispondenza fra i due scolastici dell’XI
secolo, Ragimboldo di Colonia e Rodolfo di Liegi, non si evidenzia
la conoscenza del teorema; non solo, ma i due hanno anche notevoli
difficoltà nella comprensione della Prima Geometria apocrifa: ad
esempio risultano per loro tremendamente oscure le espressioni
“angolo interno” e “angolo esterno” di un triangolo43 .
La datazione incerta della Geometria, fra il 980 e il 983, pone il
problema di determinare se, nella sua composizione, Gerberto
abbia utilizzato come fonte quanto ritrovato nella biblioteca di
Bobbio. Già in precedenza lo scolastico doveva esser venuto in
contatto con manoscritti di gromatici (organizzati in un corpus a
partire dal VI secolo d.C.): sicuramente ne conobbe a Ripoll, come
ci testimonia il ms. Ripoll, ACA, 106. Possedeva perciò una
conoscenza di base della geometria secondo la metodologia usata
dagli agrimensores (che è poi quella su cui è impostato gran parte
del linguaggio della Geometria). Ma a Bobbio Gerberto scopre
43 Cf. DIJKSTHERIUS 1971, p. 142; GRANT 1983, p. 26-27.
62 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 62 2008.02.13, 7:34
qualcosa di molto interessante (sull’inventario della biblioteca
all’epoca si veda GENEST 1996) e ce ne dà notizia nell’ep. 8 (GERBERT,
Correspondance) a Adalberone di Reims, datata all’estate del 983,
nella quale comunica al suo arcivescovo di aver trovato
«…VIII volumina Boetii de astrologia, praeclarissima
quoque figurarum geometriae, aliaque non minus
admiranda…»
Su questo passo si è appuntata l’attenzione degli storici: in
particolar modo è sorto il problema di chiarire se i materiali che
Gerberto definisce preclarissima figurarum geometriae fossero da
legare all’opera di Boezio o fossero invece presenti in un
manoscritto a parte. In questo secondo caso sorge allora il problema
di identificare l’eventuale opera astronomica boeziana, di cui quella
di Gerberto sarebbe l’unica testimonianza esistente.
La prima proposta avanzata (Havet e Bubnov in un primo
momento) è stata quella di considerare le due opere come facenti
parte di due manoscritti diversi, e di identificare l’opera geometrica
con il contenuto del Codex Arcerianus di Wolfenbüttel (Aug. 2°
36.23), una collezione cioè di trattati gromatici. Come illustrato in
TOSI 1985, il codice era sicuramente presente a Bobbio nel X secolo
quando le illustrazioni vennero colorate dal pittore Adalberto, la
cui firma compare in testa al foglio 41v in lettere greche del X secolo;
certamente, quindi, Gerberto dovette averlo fra le mani.
Ma il manoscritto che catturò il suo interesse è stato
successivamente identificato con il ms. Napoli, V.A.13 (lo stesso
Bubnov modificò la sua posizione al momento della scoperta di
questo secondo codice), contenente la Prima Geometria dello
pseudo-Boezio — e quindi excerpta euclidei – e alcuni testi
astronomici e di computo. L’identificazione del ms. Napoli, V.A.13
con il manoscritto conosciuto da Gerberto è stata poi confermata
dagli studi di Menso Folkerts sulle Geometrie apocrife boeziane
(FOLKERTS 2003a e 2003b). Anche se questa è la tesi generalmente
accettata dagli storici della scienza non mancano riserve: Riché
(GERBERT, Correspondance, p. 17) continua a considerare valida
l’identificazione con il Codex arcerianus, e Genest, GENEST 1996,
ABob xxix - 63
Mate.Testo.PM 63 2008.02.13, 7:34
sottolinea come nel Napoli, V.A.13 i trattati di astronomia siano
esplicitamente attribuiti a Isidoro e Cassiodoro e quelli di computo
a Isidoro e Beda, mentre il nome di Boezio si lega solo alla Geometria,
rendendo così problematica l’espressione di Gerberto il quale parla
invece esplicitamente di un Boetii de astrologia. Considerando
corretta l’identificazione con il codice napoletano, è questa la
collezione di testi che sarebbe stata oggetto della richiesta di copia
fatta da Gerberto al monaco Rainardo (ep. 130, G ERBERT ,
Correspondance), ed è il codice ricevuto (cioè il Napoli, V.A.13, forse
effettivamente una copia, forse lo stesso originale) che Gerberto
avrebbe poi donato a Adelboldo di Liegi, fornendo così
all’ambiente delle scuole di Lotaringia dell’XI secolo la fonte
principale per la redazione della Seconda Geometria apocrifa
boeziana.
Se il manoscritto scoperto da Gerberto era il Napoli V.A.13,
effettivamente esso non poté costituire la fonte della Geometria,
nella quale non esistono tracce del metodo euclideo. Inoltre le
citazioni boeziane presenti nella Geometria sono tratte dall’Institutio
arithmetica, mentre non si fa menzione alcuna di un eventuale
lavoro geometrico del maestro. La conoscenza di tale opera fu
invece certamente alla base del progresso matematico riscontrabile
nella lettera a Adelboldo, dove non ci si limita a enunciare una
definizione ma si tenta anche, attraverso un disegno, una
dimostrazione.
Ma nella Geometria è rintracciabile un’altra fonte, messa in
evidenza in GUILLAUMIN 2000, totalmente estranea alla tradizione
latina, e rispetto alla quale non è al momento possibile chiarire il
modo in cui Gerberto ne sia venuto a conoscenza. Per individuare
tale fonte è necessario porre attenzione alle due definizioni che
Gerberto dà dell’angolo piano al cap. IV (GERBERTUS, Geometria):
«… Est autem planus angulus duarum linearum in
planitie e diverso ductarum ad unum punctum coadunatio.
Sive aliter: angulus est spatium quod sub duabus lineis se
invicem tangentibus continetur…»
64 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 64 2008.02.13, 7:34
Nella conclusione essa presenta un’espressione, «ad unum
punctum coadunatio», che è non euclidea e quindi del tutto
sconosciuta alla tradizione latina; lo stesso termine coadunatio è
estremamente raro e, nel latino classico, mai attestato in campo
scientifico. Le origini di tale espressione andranno ricondotte a
una tradizione di scuola geometrica assai meno conosciuta, la
tradizione cioè di Apollonio di Pergamo (III sec.a.C.)44, illustrata
accanto a quella di Euclide (nello stesso spirito quindi da cui deriva
la sintesi di Gerberto) da Proclo45 nel suo Commento al Primo libro
degli Elementi; l’espressione di Gerberto «coadunatio ad unum
punctum» si spiega allora come calco latino dell’espressione greca
«sunagwgh\ pro/j e0n shmei~on», parte cioè della definizione di
Apollonio riportata da Proclo. Il riferimento a Proclo si fa più
evidente nella seconda definizione, per la quale l’angolo è uno
«spatium», un concetto questo non solo non euclideo ma
apertamente contrastante con l’assioma 946 per il quale due linee
non delimitano uno spazio, assioma conosciuto dallo scolastico in
quanto contenuto nell’Institutio arithmetica di Boezio; ma appunto
come spazio, «e0 p ifa/ n eia», definiva l’angolo Apollonio.
44 Apollonio di Pergamo (262 ca.-190 ca. a.C.). Matematico dedito soprattutto agli
studi di geometria e alla matematica astronomica. Si formò ad Alessandria sotto la
guida dei discepoli di Euclide. La sua opera principale sono i Conici. Cf. BOYER 1976,
p. 166-184.
45 Proclo (411-485 d.C.) Filosofo e matematico formatosi alla scuola di Alessandria;
successivamente continuò i suoi studi all’Accademia platonica ateniese, della quale,
dopo la morte dei suoi insegnanti, divenne il maestro, guadagnandosi così il
soprannome di Diadochus (successore). Il suo Commento al primo libro degli Elementi di
Euclide rappresenta la principale fonte per la più antica storia della geometria greca.
Cf. BOYER 1976, p. 223-224.
46 L’assioma 9 era in realtà apocrifo, ma saldamente radicato nella tradizione latina.
Boezio lo riporta in Institutio arithmetica II,6,2: «…duae enim lineae rectae spatium
non continent...». Cf. GUILLAUMIN 1995, p. XLII.
ABob xxix - 65
Mate.Testo.PM 65 2008.02.13, 7:34
L’opposizione concettuale con la scuola euclidea, e quindi con la
tradizione latina, è qui totale. È dunque all’opera di Proclo che
Gerberto sembra coscientemente far riferimento, mutuandone non
solo le espressioni ma lo stesso spirito informatore del testo, il
tentativo cioè, per quanto possibile, di operare una sintesi fra le
due scuole: se Proclo aveva infine formulato una sola definizione,
Gerberto ne presenta due che, unite dal sive aliter, risultano però
fra loro complementari.
2.4.b. La Geometria Incerti Auctoris
Si è visto in precedenza come, a partire dall’edizione
ottocentesca di Bubnov, si sia parlato di una Geometria Incerti
Auctoris respinta in blocco come non appartenente all’insieme delle
opere autentiche dello scolastico di Reims. Un recente lavoro di
ricerca sulla Geometria Incerti, JAQUEMARD 2000, ha però messo in
evidenza come essa non sia in realtà un’opera unitaria, e come i
due libri che la compongono abbiano un’origine indipendente
l’uno dall’altro. Ma soprattutto molti dati di questo studio
permettono forse di ricollegare l’opera al nome di Gerberto.
Il primo libro della Geometria Incerti presenta due nuclei
fondamentali: il primo, quello originale dell’opera, è rappresentato
dai capitoli 20-25 che, unitariamente concepiti, espongono con
rigorosa coerenza una serie di problemi di geometria pratica risolti
attraverso l’astrolabio, presentando una strettissima affinità con i
testi del più antico corpus astrolabico, e presupponendo quindi
l’utilizzo di fonti arabe; l’altro nucleo è invece costituito
dall’intervento, ben individuabile, di un secondo redattore — che
può essere considerato come colui che ha impresso una svolta
decisiva alla geometria pratica nel mondo latino — il quale ha
utilizzato come fonte un trattato completo sugli usi geometrici
dell’astrolabio (testimoniando così un livello più avanzato rispetto
alle nozioni del corpus antico), ed è stato in grado di reperire nella
tradizione carolingia quelle pratiche geometriche che riposavano
66 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 66 2008.02.13, 7:34
sui medesimi principi di utilizzo di questo strumento. Il secondo
libro si presenta invece come una semplice compilazione,
essenzialmente tributaria della tradizione degli agrimensores.
Dell’opera, nel suo complesso, sono state evidenziate le seguenti
caratteristiche, fondamentali per l’identificazione del secondo
redattore e del luogo in cui i due testi sono stati associati: va
innanzitutto sottolineato che molti manoscritti della Geometria
Incerti contengono frammenti riguardanti l’opera di Gerberto
(come evidenziato in LINDGREN 2001), fra cui la corrispondenza con
Costantino di Fleury e quella con Adelboldo di Liegi; che la
tradizione manoscritta dell’opera non risale oltre l’XI secolo; che
infine è nell’ambiente delle scuole della Lotaringia dell’XI e dei
secoli precedenti che si registra la tendenza a creare collezioni di
testi geometrici, fra i quali si ricordano la Prima e soprattutto la
Seconda Geometria apocrifa di Boezio, che è all’incirca contempora-
nea alla redazione definitiva della Geometria Incerti.
Tenuto conto di questi dati, il secondo redattore del primo libro
è stato individuato in uno degli allievi mosani di Fulberto di Char-
tres. La situazione della scuola di Fulberto, che muore nel 1026,
permette infatti di giustificare tutte le caratteristiche, sopra enun-
ciate, della Geometria Incerti: Chartres aveva, all’epoca, rapporti
privilegiati con l’abbazia di St. Mesmin de Micy, e la possibilità
quindi di raccogliere l’eredità di Gerberto attraverso la figura di
uno dei suoi migliori allievi, Costantino; aveva ricevuto nel 991 la
visita di Richero, per la quale si veda OLDONI 1998, recatosi là per
approfondire i suoi studi di medicina, costituendo così una via
ancor più diretta per la conoscenza dei lavori dello scolastico di
Reims; aveva particolari legami intellettuali con la regione della
Mosa, tanto che Fulberto educa un’intera generazione di monaci
mosani fra i quali i già citati Ragimboldo di Colonia e Rodolfo di
Liegi, la cui corrispondenza rappresenta una delle prime
testimonianze certe di conoscenza dell’astrolabio da parte di
monaci latini (e l’interesse dell’ambiente mosano per la geometria
trova conferma anche nello scambio epistolare tra Gerberto e
Adelboldo); un poema di Fulberto che ha come oggetto le stelle
ABob xxix - 67
Mate.Testo.PM 67 2008.02.13, 7:34
rappresentate sul disco dell’astrolabio, conferma infine la
conoscenza dello strumento a Chartres a una determinata altezza
cronologica. È poi ancora nell’ambiente di Lotaringia che, a breve
distanza dall’intervento del secondo redattore, si sarà realizzato
anche l’accorpamento fra il primo e il secondo libro. Risulta quindi
evidente come il nome di Gerberto emerga nella storia della
Geometria Incerti.
Un “intellettuale”?
La figura di Gerberto d’Aurillac “scienziato” offre innanzitutto
almeno due aspetti di particolare interesse, che riguardano la
natura delle sue conoscenze: la tendenza al recupero e alla rilettura
della tradizione antica da un lato, l’apertura costante verso quella
nuova fonte di sapere che il mondo arabo rappresentava per
l’Occidente di lingua latina dall’altro.
La prima definizione possibile dello scolastico di Reims,
destinata nel tempo al maggiore successo, appare così quella del
“precursore”: precursore, in pieno X secolo, di pratiche e
atteggiamenti culturali che si affermeranno con decisione solo due
secoli dopo.
Gerberto è in primo luogo, e soprattutto, profondo conoscitore
di quanto, dell’eredità antica, era sopravvissuto in Occidente: egli
non scopre nuovi testi ma riprende in mano quelli che, da secoli
ormai, erano sì copiati e conservati nelle biblioteche ma spesso
erano conosciuti solo in modo superficiale. È un ricercatore
instancabile di manoscritti, e questi manoscritti contengono opere
dell’antichità.
«... bibliothecam assidue comparo et sicut Romae dudum
ac in aliis partibus Italiae, in Germania quoque et Belgica,
scriptores auctorumque exemplaria multitudine
mummorum redemi, adjutus benivolentia, ac studio
68 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 68 2008.02.13, 7:34
amicorum comprovincialium, sic identidem, apud vos fieri
ac per vos, sinite ut exorem…» (Ep. 44, GERBERT, Correspon-
dance, a Evrardo abate di Tours, inizio del 985).
«... Nosti quanto studio librorum exemplaria undique
conquiram. Nosti quot scriptores in urbibus ac in agris Italiae
passim habeantur…» (Ep. 130, GERBERT, Correspondance, al
monaco Rainardo, settembre 988)47.
L’elezione di Boezio a suo maestro e punto di riferimento, tanto
nelle discipline scientifiche quanto in quelle del trivium (in
particolar modo la logica), e la ricerca incessante di testi originali,
significa, da parte dello scolastico, riallacciare rapporti diretti con
la tradizione antica; e la capacità di rielaborare il sapere delle sue
fonti al fine di creare una personale sintesi lo porta a superare
decisamente la ripetitiva tendenza all’enciclopedismo dei suoi
predecessori, tendenza che, affondando le sue radici nella Naturalis
Historia di Plinio e poi, all’alba dell’epoca altomedievale, nelle
Institutiones di Cassiodoro, andava progressivamente, dopo la
grande sintesi isidoriana, estinguendosi in mera ripetizione,
sempre più frammentaria, sempre più eterogenea.
Restringendo il campo di interesse all’ambito scientifico, che è
quello qui analizzato ma è peraltro anche quello a cui
maggiormente si lega la fama di Gerberto, si riportano i significativi
giudizi di tre storici della scienza:
47 Altre richieste di manoscritti sono le seguenti: (GERBERT, Correspondance) Ep. 7, a
Ayrardo, Bobbio primavera o estate del 983: «...Petitionibus tuis annuimus, nostra ut
exequaris negotia velut propria monemus. Plinius emendetur, Eugraphius recipiatur,
qui Orbacis et apud sanctum Basolum sunt prescribantur...»; Ep. 8, a Adalberone
arcivescovo di Reims, Bobbio o Mantova estate del 983: «...Istoriam Julii Caesaris a
domno Azone abbate Dervensi ad rescribendum nobis adquirite...»; Ep. 9, all’abate
Gisalberto, Bobbio estate 983: «...De morbis ac remediis oculorum, Demostenes
philosophus librum edidit, qui inscribitur Ophtalmicus. Ejus principium si habetis
habeamus, simulque finem Ciceronis pro rege Dejotaro...»; Ep. 40, a Stefano diacono
della Chiesa romana, settembre-ottobre 984: «...Michi quidem ac nostro Adalberoni
archepiscopo Suetonios Tranquillos, Quintosque Aurelios, cum caeteris quos nosti...
remittes...».
ABob xxix - 69
Mate.Testo.PM 69 2008.02.13, 7:34
«... Dagli autori discussi nelle pagine precedenti
[Cassiodoro, Isidoro, Beda, Rabano Mauro ecc...] la cui ope-
ra era principalmente di natura ricettiva e preservativa, si
stacca la notevole figura di Gerberto d’Aurillac... a motivo
della grande indipendenza della sua attività scientifica... Nel
corso dell’XI secolo il seme gettato da Gerberto d’Aurillac
produsse un frutto evidente nella forma di un accresciuto
interesse per la matematica...» (DIJKSTHERIUS 1971, p. 140).
«... Questa [l’epoca di Isidoro di Siviglia] fu veramente
l’“Età buia” della scienza... Per altri due secoli la cultura
europea continuò ad essere avvolta da un buio profondo, al
punto che... in Europa si poteva sentire soltanto il graffiare
della penna del Venerabile Beda (637 circa-735) che in
Inghilterra scriveva intorno alla matematica necessaria al
calendario ecclesiastico o alla rappresentazione per mezzo
delle dita... Rabano Mauro (784-856) continuò i deboli sforzi
matematici e astronomici di Beda... Ma per un altro secolo e
mezzo non si verificò alcun cambiamento degno di nota
nell’ambito della matematica dell’Europa occidentale: alla
fine però qualcosa di diverso si ebbe con la comparsa di un
uomo che doveva diventare papa Silvestro II...» ( BOYER 1976,
p. 291).
«… Dal 500 d.C. la conoscenza del greco cominciò a
diventare rara e ancor più raro divenne il possesso di una
scienza specialistica... La tradizione enciclopedica [era] ora
dominante. Perché gli europei occidentali acquistassero un
serio incentivo a trovare nuove conoscenze nelle civiltà e cul-
ture vicine, dovevano prima essere destati e stimolati ad un
nuovo interesse per la scienza e la natura. E come spesso
accade nella storia della scienza, un singolo individuo
avrebbe giocato un ruolo assai importante nello svolgimento
di questo compito essenziale... Gerberto di Aurillac...» (GRANT
1983, p. 25).
70 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 70 2008.02.13, 7:34
Tornare all’opera boeziana come fonte principale significa, a
prescindere dal livello delle conoscenze del filosofo tardo-antico,
tornare a opere che offrono al loro lettore e studioso una chiave di
interpretazione della realtà e, soprattutto nel campo scientifico,
non solo una massa di curiosità sul mondo fisico. È proprio
partendo da queste basi che Gerberto sarà in grado di costituire
un organico programma di insegnamento, tanto nel trivium quanto,
e soprattutto, nel quadrivium, fino a questo momento relegato in
una posizione decisamente di secondaria importanza: sarà cioè il
primo, dai tempi di Boezio, a saper padroneggiare l’intero sistema
delle sette arti liberali, dimostrando una conoscenza sicura di tutte
le fonti allora disponibili; il primo, fra l’altro, a ricostituire l’intero
corpus dei testi aristotelici disponibili in latino, quella logica vetus
che resterà la base del programma di insegnamento filosofico fino
alla riscoperta della restante opera aristotelica, la logica nova,
all’epoca delle grandi traduzioni dall’arabo.
In campo scientifico Gerberto offre perciò ai suoi allievi un pro-
gramma completo, che, a testimonianza dell’eterogeneità della sua
formazione unisce antiche ascendenze filosofiche di matrice
pitagorica, derivate da Boezio, a uno spiccato spirito pratico
ereditato dagli scolastici altomedievali, avvezzi a insegnare
attraverso giochi linguistici e manuali, a un personale acume
pedagogico da vero maestro, nonché a elementi che a tutta questa
tradizione erano estranei e che provengono invece da quel vivace
mondo catalano conosciuto in gioventù.
Ed è quest’ultimo elemento quello che maggiormente
caratterizza la figura di Gerberto d’Aurillac. Si è visto come
effettivamente, nella realtà e non solo nell’immaginario, nell’opera
dello scolastico di Reims siano rintracciabili elementi arabi: essi si
evidenziano non nell’impianto teorico delle conoscenze, che è un
impianto classico, o meglio fondato su quanto dell’erudizione
classica era sopravvissuto, bensì in tutta quella serie di strumenti
pedagogici che accompagnano il suo insegnamento. Ed è la
combinazione di questi due fattori che rende la scuola di Reims
un unicum per l’epoca.
ABob xxix - 71
Mate.Testo.PM 71 2008.02.13, 7:34
Così, in campo matematico, Gerberto insegna che il mondo è
retto, nel più perfetto ordine, dalle affascinanti leggi dei numeri,
ma sa anche che quegli stessi numeri, riportati al livello di “cifre”
(nel senso di simboli grafici), sono semplici strumenti di calcolo, e
insegna allora come eseguire quei calcoli nel modo più semplice e
rapido, in quanto essi non sono fini a sé stessi, quasi giochi di
prestigio, bensì utili nello studio della terra e del cielo, della
geometria e dell’astronomia. E con Gerberto vediamo comparire,
per la prima volta nell’Occidente latino, le cifre arabo-indiane.
La sua geometria è sì scienza della misurazione della terra ma,
contro la tendenza generale che ne faceva materia di architetti e
carpentieri, è anche aspirazione a una speculazione astratta che
affini l’intelletto.
Nell’insegnare l’astronomia non si accontenta di proporre ai
suoi studenti elenchi più o meno letterari di costellazioni, né di
mostrar loro fantasiose immagini cariche di reminescenze
mitologiche, ma si impegna a tradurre quei dati in modelli reali,
visibili e tangibili, che aiutino la memoria al momento della reale
osservazione, in quelle sfere delle quali ha probabilmente visto
modelli di origine araba. È per l’osservazione diretta degli astri
che ingegnosamente crea, a quanto pare dal nulla, la sua semi-
sfera, munendola di arabe fistulae; ed è lui, in prima persona, ad
accompagnare all’aperto i suoi studenti per approfittare delle notti
serene. Sembra, infine, che il suo nome possa anche legarsi alla
prima diffusione dell’astrolabio nell’Occidente latino.
Il suo insegnamento della musica è conoscenza e
approfondimento della teoria musicale in un modo che supera
quello dei suoi predecessori, ma è anche capacità di coniugare, e
adattare, teoria musicale e principi tecnici nella realizzazione di
uno strumento complesso come l’organo, in un’esperienza che
costringe ad una strettissima collaborazione lo scienziato e
l’artigiano, e tentativo forse di superare anche, attraverso un
utilizzo pratico del monocordo, secondo il metodo arabo, la
dicotomia venutasi a creare fra musica e cantus.
72 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 72 2008.02.13, 7:34
Certamente non siamo ancora nel XII secolo, non è ancora
l’epoca delle traduzioni toledane, certamente gli Elementi di
Euclide, l’opera di Tolomeo e quella di Al-Kwarizmi sono ancora
lontani; non si può perciò attribuire a Gerberto quello che la
situazione culturale dell’epoca non rendeva obbiettivamente
possibile: lo scolastico conosce le cifre arabo-indiane ma non ancora
l’algorismo moderno ed è così costretto a creare (o adottare) uno
strumento di compromesso come l’abaco; la sua Geometria, date le
fonti disponibili, non può spingersi oltre le conoscenze di un
trattato di agrimensura; la sua semi-sfera, semplice strumento di
individuazione dei corpi celesti, non avrà futuro di fronte
all’affermarsi dell’astrolabio; riguardo allo stesso astrolabio
Gerberto può forse scrivere o ispirare, e non è indubbiamente poco,
un trattato sui modi di utilizzo ma non ancora sul metodo di
costruzione, il che presupporebbe conoscenze teoriche ancora non
accessibili.
Eppure, nonostante tutti i limiti sopra elencati, il contatto fra i
due mondi culturali, quello arabo e quello latino, esiste, anzi
potremmo dire che con Gerberto esso prende le mosse, ed è un
contatto fatto essenzialmente di percezioni di elementi sparsi
ingegnosamente reinterpretati, ma alimentato anche da quei testi
ricercati per tutta la vita.
Così in DIJKSTHERIUS 1971, p. 143-144:
«... Lo spirito che Gerberto aveva infuso al suo
insegnamento a Reims... può venir definito come studio della
cultura antica con una forte inclinazione verso la matematica
e la scienza...».
LINDGREN 2001, p. 118:
«... On pourra résumer que Gerbert a repris le fil de
l’érudition classique — sans pour autant être représentant
de l’âge obscur qui avait négligé les arts libéraux — et en
même temps il est allé au-delà...».
ABob xxix - 73
Mate.Testo.PM 73 2008.02.13, 7:34
POULLE 2005, p. 122:
«... Si, ramenée à une plus juste appréciation de la liste de
ses oeuvres, la réputation de Gerbert en matière scientifique
est sans doute moins prestigieuse que de passer pour le
fondateur de la science médiévale, elle reste du moins celle
d’un pédagogue averti tel que nous le décrit son élève Richer...
De telles méthodes d’enseignement ont d’ailleurs fait leur
preuves, puisque ce sont les élèves du maitre ainsi formés
qui furent ensuite en mesure d’accueillir les prémices de la
nouvelle science: n’est-ce pas là en définitive, pour un
enseignant, le plus solide des mérites?».
Una più profonda conoscenza dei circostanti ambienti culturali
a lui contemporanei, e della tradizione testuale, ci permettono
dunque, come visto, di avallare la definizione del “precursore”.
Essa necessita però di un corollario, al fine di non isolare la figura
di Gerberto dal suo contesto, illuminandola di uno sfavillio che a
posteriori appare senza ombre. Il problema che si pone
considerando quella che è stata la reale eredità di Gerberto, è
definire esattamente il peso avuto dalle sue opere all’epoca. Si deve
infatti constatare al riguardo che, nello spazio di nemmeno due
secoli, l’opera di Gerberto cade nell’oblio. Ed è ulteriormente da
precisare che, negli anni che seguono la sua morte, nel corso di
quel X secolo denso di cambiamenti, i suoi testi sono sì copiati,
nella Lotaringia, patria della maggior parte dei discepoli di
Gerberto48, nei centri della Germania del sud-ovest, a Saint-
Emmeran, Reichenau, Ratisbona, nell’Inghilterra del sud attraverso
48 Fra gli allievi di Gerberto si ricordano Remi, monaco di Mettlach presso Treviri,
autore di un trattato sull’abaco così come Erigero di Lobbes; l’abate Sigefroid I, zio di
Adalberone di Reims, che per riformare la scuola di Echternach fa adottare un pro-
gramma di studi analogo a quello di Reims; Herbert, futuro abate di Chagny, che
prosegue i suoi studi a Chartres; infine Costantino di Fleury (sugli allievi di Gerberto
si veda RICHÉ 1984, p. 65-66). Si ricorda infine che è nelle scuole di Lotaringia che
74 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 74 2008.02.13, 7:34
il canale rappresentato da Fleury e Abbone. saranno conosciute a
Chartres, dove la scuola di Fulberto si affermerà come il nuovo
polo culturale e prevederà un programma di insegnamento assai
simile a quello di Reims49, ma quegli elementi di novità così
caratterizzanti, in primis e soprattutto l’uso delle cifre arabe,
potenzialmente carico di effetti rivoluzionari, non riusciranno a
uscir fuori dalle pagine dei manoscritti prodotti in ambito
monastico, con un utilizzo peraltro assai marginale, limitato a una
ristretta circolazione fra “addetti ai lavori”. Non si può dunque
disconoscere che il ruolo di Leonardo Fibonacci sia stato carico di
ben più significative conseguenze: egli a tutti gli effetti è colui che
ha introdotto le cifre arabe nell’uso comune del mondo latino. Né
d’altronde l’esperimento gerbertiano era più ricordato all’epoca,
se non forse nella memoria di qualche erudito monastico che
poteva aver visto quei segni in codici già antichi. E oggi esso è un
fatto conosciuto solo in ambito strettamente specialistico. Se lo si
identifica essenzialmente come “precursore” in alcuni specifici
ambiti, visti gli esiti della sua azione, la storia di Gerberto ha
dunque validità soprattutto come storia di un’individualità, avente
in sé la propria giustificazione senza proiezioni sul futuro.
Ancora un altro corollario è poi necessario aggiungere:
sottolineare cioè la rapidità con cui prese piede la leggenda nera
di Gerberto. Solo ottant’anni dopo la sua morte essa può già
cominciare ad affermarsi, e non trova invero alcuno che la contrasti
viene prodotta la Seconda Geometria apocrifa di Boezio e parte della Geometria incerti
auctoris. Per i manoscritti delle opere di Gerberto provenienti dalla Germania e
dall’Inghilterra si veda MOSTERT 1997, p. 312-318.
49 La conoscenza di Gerberto a Chartres è confermata, oltre che dalla provenienza
dallo scriptorium della cattedrale di alcuni manoscritti contenenti i testi scientifici di
Gerberto (cf. MOSTERT 1997, p. 312-318), dal fatto che il trattato gerbertiano De rationa-
le et ratione uti fosse presente, accanto al corpus aristotelico, nel ms. 100 di Chartres
(distrutto durante la guerra), vale a dire il testo utilizzato da Fulberto per
l’insegnamento della filosofia (cf. RICHÉ 1984, p. 64). Sulla scuola di Chartres si veda
DIJKSTHERIUS 1971, p. 143-146; GRANT 1983, p. 26-28.
ABob xxix - 75
Mate.Testo.PM 75 2008.02.13, 7:34
efficacemente. Il suo essere “precursore” per l’epoca non gli
garantisce allora una degna eredità, bensì un’aura di eccezionalità
agli occhi dei contemporanei che trascina la sua figura storica verso
l’ambiguità di una leggenda, oscillante fra il demoniaco e il
meraviglioso, ma che in entrambi i casi rivela un dato di fondo,
cioè una sostanziale incomprensione, sia che essa sia stata generata
dalla diffidenza che da un’ingenua ammirazione.
Diffidenza o ammirazione che evidentemente non riguardano
solo le sue competenze culturali ma anche la sua carriera politica,
proceduta decisamente a “tappe forzate”, non senza carattere anche
qui di eccezionalità: dal nulla al papato nel giro di un quarto di
secolo.
Ma al discorso sulla carriera politica di Gerberto si intreccia un
altro tema che vorrei qui affrontare. È possibile cioè, vista anche la
strana sorte subita, superare la definizione di Gerberto
semplicemente come maestro particolarmente avveduto e
precursore nel campo di determinati dati dottrinali, per cercare di
riconnettere la sua vicenda a categorie più ampie di storia della
cultura, tali da giustificare in modo più significativo lo stesso in-
teresse per la sua persona? In altri termini, con le dovute cautele, è
possibile definire Gerberto un “intellettuale” del suo tempo?
Per una riflessione in questo senso è d’obbligo avere come punto
di partenza la definizione data da Le Goff nel testo che ha ormai
permesso anche agli storici del Medioevo di appropriarsi di questo
termine, vale a dire Gli intellettuali nel Medioevo:
«… questa [la funzione dell’intellettuale] designa per me
un gruppo dai contorni ben definiti: quello dei maestri delle
scuole, che appare nell’Alto Medioevo, si sviluppa nelle
scuole urbane dell’ XI secolo, e si afferma a partire dal XIII
nelle università. Questo nome designa coloro che fanno il
mestiere di pensatore e di trasmettere il proprio pensiero
mediante l’insegnamento…».
76 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 76 2008.02.13, 7:34
Il suo collocarsi nell’ultimo quarto del X secolo fa sì che Gerberto
si trovi esattamente a metà fra l’epoca delle prime attestazioni di
questa categoria e quella del vero sviluppo nel XII sec.; ma la sua
eccezionalità per l’epoca può essere interpretata come sintomo di
una decisa proiezione in avanti, in questo un vero “precursore”.
La congiuntura della sua vita lo porta anche, singolarmente, a
svolgere la sua attività di scolastico in una scuola cattedrale e non
già monastica, conformandosi per ciò a un tratto determinante nel
profilo dell’intellettuale definito da Le Goff, che è l’appartenenza
a un contesto urbano.
La dimensione di maestro, al di là delle sue caratteristiche quali-
tative, è forse proprio quella che meglio caratterizza Gerberto:
maestro lo è ufficialmente per dieci anni a Reims, ma maestro con-
tinua ad esserlo anche dopo, in quanto figura di riferimento a cui
porre quesiti di natura intellettuale. Abbiamo poi visto quanto la
comunicazione nel senso di attenzione per la didattica, la
preoccupazione di garantire la corretta comprensione e
memorizzazione delle nozioni sia constantemente presente nella
sua attività scolastica. Le sue opere sono scritte spesso su richiesta
e in quanto tali contengono già implicitamente in sé la spinta alla
diffusione. Conoscenze da comunicare, questa la cifra dello stile
intellettuale di Gerberto.
Ma la sua attività di uomo di cultura non si esaurisce nella
dimensione dell’aula scolastica: c’è tutta un’attività intellettuale
per così dire privata che permane, con più o meno difficoltà, anche
quando si esaurisce l’esperienza di scolastico, c’è la ricerca di
manoscritti, gli scribi pagati in tutta Europa, ci sono quegli studia,
dai quali con rammarico l’avanzare degli anni e della carriera lo
tengono lontano per tempi sempre più lunghi.
E qui è il punto che determina una mancanza di aderenza
perfetta alla definizione di Le Goff; Gerberto è «pensatore,
trasmette il proprio pensiero mediante l’insegnamento», ma questo
non è propriamente il mestiere della sua vita.
A questo proposito si può introdurre un altro aggettivo che
rischia l’anacronismo se non trattato con cautela: dal momento
ABob xxix - 77
Mate.Testo.PM 77 2008.02.13, 7:34
che in Gerberto convivono strettamente due istanze, quella
dell’uomo di cultura e quella dell’uomo politico, lo si potrà definire
come una sorta di “intellettuale engagé”? Forse, visto quanto detto
sul suo rapporto con l’intellettualità in quanto mestiere, la realtà
della sua figura si potrà cogliere meglio invertendo i termini, “un
engagé intellettuale”. Nel momento in cui il coinvolgimento po-
litico, sia esso di politica laica o ecclesiastica, raggiunge determinati
livelli, a cominciare dall’intricata vicenda che lo vede coinvolto
nell’ascesa della dinastia capetingia, la dimensione intellettuale
diviene affaire del tutto privato, che cede quando necessario di
fronte alle priorità imposte dalle circostanze pubbliche. E tuttavia
il discorso non può giungere a nette separazioni, perché le due
situazioni di “intellettuale engagé” e di “engagé intellettuale” sono
costantemente in uno stato di mescolanza. La capacità intellettuale
di Gerberto ha infatti avuto un peso nella eccezionalità della sua
carriera politica? Pur tenendo conto della dimensione celebrativa
della testimonianza di Richero, è comunque innegabile che la
relazione fra il giovanissimo Gerberto e la dinastia ottoniana sia
passato attraverso il dato culturale, e il rapporto con Ottone III
nasce comunque come rapporto fra un maestro e un discepolo.
C’era certamente una progettualità politica in questa coppia
imperatore-papa, in cui il papa assume un nome altamente
significativo, ma è azzardato pensare che dietro il rapporto ma-
estro-discepolo, dove il discepolo è un uomo di potere, ci fosse
anche, più o meno cosciente, la fascinazione di un sogno antico,
un sogno tutto da intellettuali, quello che, per citare un modello
sicuramente ben noto a Gerberto, aveva cercato di riproporsi,
invano, in Boezio e Teodorico, ma aveva il suo precedente mitico e
illustre in Aristotele e Alessandro, per non parlare di quello
sfortunatissimo di Seneca e Nerone?
Il suo essere “precursore” nel campo delle singole conoscenze
dottrinali appare allora, a questo punto, in una luce diversa: le
novità rispetto alla sua epoca sono spia dell’attività di un
personaggio che non fa ancora il “pensatore per mestiere”, ma
78 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 78 2008.02.13, 7:34
dedica all’attività del pensare una parte notevole della sua vita, e
ad essa è in parte debitore della propria fama.
Resta, infine, la testimonianza di un grande maestro per il quale
«… discipuli victoria, magistri est gloria…» (GERBERT,
Correspondance, Ep. 194);
di un personaggio dotato di una curiosità intellettuale fuori del
comune, capace di affermare che
«… proinde in otio, in negotio, et docemus quod scimus,
et addiscimus quod nescimus…» (GERBERT, Correspondance,
Ep. 44).
Bibliografia
ADELBOLDUS, De rationi: ADELBOLDUS, De rationi inveniendi crassitudinem
spherae, J. P. MIGNE (éd.), Patrologia Latina, vol. CCCXXXIX, 1853.
ADEMARUS, Chronicon: P. BOURGAIN – R. LANDES – G. PON (ed.) - ADEMARUS
CABANENSIS, Chronicon (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis 129),
Paris 1999.
ALBORNOZ 1965: C. S. ALBORNOZ, «El Islam de España y el Occidente», in:
L’Occidente e l’Islam nell’Alto Medioevo, Spoleto, CISAM, 1965, p. 149-308.
APEL 1948: W. APEL, «Early History of the Organ», Speculum 23, 1948, p.
191-216.
BACCHIEGA 1981: M. BACCHIEGA, Silvestro II papa mago, Foggia 1981.
BEAUJOUAN 1965: G. BEAUJOUAN, «La science antique et médiévale (des
origines à 1450)», in: R. TATON (a cura di), Histoire générale des sciences,
tome I, Paris 1965.
BEAUJOUAN 1971: G. BEAUJOUAN, «L’enseignement du quadrivium», in: La
scuola nell’Occidente latino dell’Alto Medioevo, Spoleto, CISAM 1971, p. 639-
667.
BEAUJOUAN 1985: G. BEAUJOUAN, «Les apochryphes mathématiques de
Gerbert», in: TOSI (ed.) 1985a, p. 645-655.
BEAUJOUAN 1991a: G. BEAUJOUAN, «The transformation of the Quadrivium»,
in: G. BEAUJOUAN, Par raison des nombres: l’art du calcul et les savoirs
scientifiques médiévaux (Variorum reprints), Aldershot 1991, cap. III.
BEAUJOUAN 1991b: G. BEAUJOUAN, «Étude paléographique sur la rotation
ABob xxix - 79
Mate.Testo.PM 79 2008.02.13, 7:34
des chiffres et l’emploi des apices du X au XII siècle», in: G. BEAUJOUAN,
Par raison des nombres: l’art du calcul et les savoirs scientifiques médiévaux
(Variorum reprints), Aldershot 1991, cap. IX.
B EAUJOUAN 1996: G. B EAUJOUAN , «L’abaque du Pseudo-Boèce», in:
GUYOTJEANNIN 1996, p. 323-328.
BELLISSIMA 2000: F. BELLISSIMA, «La musica nel quadrivio: un’introduzione
al problema dell’accordatura della scala», in: FREGUGLIA 2000, p. 256-284.
BENNONE, Gesta Romanae: K. FRANCKE (ed.) - BENNONE DI OSNABRÜCK, Gesta
Romanae Ecclesiae contra Hildebrandum, (Monumenta Germaniae Historica,
Libelli de lite 2), Hannover 1892.
BISSON 1999: TH. N. BISSON, «L’aprenentatge dels savis a Europa perls volts
de l’any mil: les lliçons de Gerbert, Abbo i Fulbert», in: OLLICH 1999, p.
593-620.
BORST 1989: A. BORST, Astrolab und Klosterreform an der Jahrtausendwende,
Heidelberg 1989.
BORST 1997: A. BORST, Computus. Tempo e numero nella storia d’Europa,
Genova 1997.
BOYER 1976: C. B. BOYER, Storia della matematica, Milano 1976.
BOWER 2002: C. M. BOWER, «The transmission of ancient music theory into
the Middle Ages», in: T. CHRISTENSEN (ed.), The Cambridge History of West-
ern Music Theory, Cambridge 2002, p. 136-167.
BROCKETT 1995: C. W. BROCKETT, «The frontespice of Paris, Bibliothèque
Nationale, Ms.Lat.776: Gerbert’s acrostic patern poems», Manuscripta 39,
1995, p. 3-25.
BURNETT 1998: CH. BURNETT, «Ptolomey and Alchandreus the Philosopher:
the Earliest Texts on the Astrolabe and Arabic Astrology at Fleury, Micy
and Chartres», Annals of Science 55, 1998, p. 329-368.
BURNETT 2002: CH. BURNETT, «Indian Numerals in the Mediterranean Ba-
sin in the Twelfth Century», in: DOLD – SAMPLONIUS – DAUBEN – FOLKERTS -
VANDALEN (ed.), From China to Paris: 2000 Years Transmission of Mathemati-
cal Ideas, Stuttgart 2002, p. 237-288.
BUBNOV 1899: N. BUBNOV (ed.), Gerberti postea Silvestri II Opera Mathematica
(972-1003), Berlin 1899 (rist. Hildesheim 1963).
CASSINET 1999: J. CASSINET, «Gerbert et l’introduction de la numeration
decimal arabo-indienne en Occident chrétien: le Liber Abaci», in: OLLICH
1999, p. 725-726.
CHADWICK 1986: H. CHADWICK, Boezio, Bologna 1986.
CHARBONNEL 1997: N. CHARBONNEL – J. E. IUNG (ed.), Gerbert l’européen, Actes
du colloque d’Aurillac (Aurillac, 4-7 juin 1996) (Société des lettres, sci-
ences et arts “La Haute Auvergne”, Mémoires 3), Aurillac 1997.
80 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 80 2008.02.13, 7:34
CONSTABLE 1990: G. CONSTABLE, «Cluny in the monastic world of the tenth
century», in: Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X, Spoleto, CISAM
1990, p. 391-437.
CONTE 2000: G. B. CONTE, Letteratura latina, Le Monnier 2000.
D’ABADAL 1961: R. D’ABADAL I DE VINYALS, «L’esperit de Cluny i les
relaciones de Catalunya amb Roma i la Italia en el segle X», Studi medievali
II, 1961, IIIa s., p. 3-41.
DALCHÉ 1996: P. G. DALCHÉ, «La table des climats du De utilitatibus astrolabii
du Pseudo-Gerbert», in: GUYOTJEANNIN 1996, p. 331-334.
DESTOMBES 1966: M. DESTOMBES, «La diffusion des instruments scientifiques
du Haut Moyen Âge au XVe siècle», Cahiers d’Histoire Mondiale 10, 1966,
p. 31-51.
DIAZ Y DIAZ 1969: M. C. DIAZ Y DIAZ, «La circulation des manuscrits dans
la pénisule ibérique du VIII au XI siècle», Cahiers de civilisation médiévale
XII, 1969, n° 3, p. 219-241, n° 4, p. 383-392.
DIAZ Y DIAZ 1974: M. C. DIAZ Y DIAZ, «La transmision de los textos antiguos
en la penisola iberica en los siglos VII-XI», in: La cultura antica nell’Occidente
latino dal VII all’XI secolo, Spoleto, CISAM 1974, p. 133-175.
DIJKSTHERIUS 1971: E. J. DIJKSTHERIUS, Il meccanicismo e l’immagine del mondo
dai presocratici a Newton, Milano 1971.
DUCHESNE, Liber: L. DUCHESNE (ed.), Liber pontificalis, CXLIII - Silvester II,
Paris 1892, t.II.
EVANS 1977: G. R. EVANS, «Difficillima et Ardua: theory and practice in trea-
tise on the abacus, 950-1150», Journal of Medieval History 3, 1977, p. 21-38.
EVANS 1985: G. R. EVANS – A. M. PEDEN, «Natural Science and the Liberal
Arts in Abbo Fleury’s Commentary on the Calculus of Victorius of Aqui-
taine», Viator 16, 1985, p. 109-127.
FARMER 1970: H. G. FARMER, Historical Facts for the Arabian Musical Influ-
ence, Hildesheim-New York 1970.
FELIU 1972: G. FELIU I MONTFORT, «Sunifred, anomenat Llobet, ardiaca de
Barcelona (finals del segle X)», in: II Col.loqui d’història del marraguisme
català: Sant Joan de les Abadesses 1970, Abadià de Poblet 1972, p. 51-63.
FLUSCHE 1994: A. M. FLUSCHE , Organa doctorum: Gerbert of Aurillac,
Organbuilder?, Ann Arbor 1994.
FLUSCHE 2005: A. M. FLUSCHE, The Life and Legend of Gerbert of Aurillac: the
Organbuilder Who Became Pope Sylvester II, New York 2005.
FOLKERTS 1970: M. FOLKERTS, Boethius Geometrie II, ein mathematisches
Lehrbuch des Mittelalters (Boethius 9), Wiesbaden 1970.
ABob xxix - 81
Mate.Testo.PM 81 2008.02.13, 7:34
FOLKERTS 2001: M. FOLKERTS, «The Names and Forms of the Numerals on
the Abacus in Gerbert Tradition», in: NUVOLONE 2001, p. 245-265.
FOLKERTS 2003a: M. FOLKERTS, «The importance of the pseudo-Boethian
“Geometria” during the Middle Ages», in: M. FOLKERTS, Essays on early
medieval mathematics, Aldershot 2003, VII, p. 187-209.
FOLKERTS 2003b: M. FOLKERTS, «The Geometry II ascribed to Boethius», in:
M. FOLKERTS, Essays on early medieval mathematics, Aldershot 2003, IX, p. 1-
9.
FOLKERTS 2003c: M. FOLKERTS, «The Names and Forms of the Numerals on
the Abacus in the Gerbert Tradition», in: M. FOLKERTS, Essays on Early
Medieval Mathematics, Aldershot 2003, VI, p. 1-17.
FRANCI 2000: R. FRANCI, «L’insegnamento dell’aritmetica nel Medioevo»,
in: FREGUGLIA 2000, p. 111-132.
FREGUGLIA 2000: P. FREGUGLIA – L. PELLEGRINI – R. PACIOCCO (ed.), Scienze
matematiche e insegnamento in epoca medievale. Atti del convegno
internazionale di studio (Chieti, 2-4 maggio 1996), Napoli-Roma 2000.
FRIEDRICK 1973: H. V. FRIEDRICK, «Zur Textgestaltung der Geometrie des
Gerbert von Aurillac», Archivum latinitatis medii aevi 39, 1973, p. 113-120.
FROVA 1974a: C. FROVA, «Le opere aritmetiche di Gerberto d’Aurillac», in:
Studi sul Medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen, Roma 1974, p. 323-
353.
FROVA 1974b: C. FROVA, «Trivio e Quadrivio a Reims: l’insegnamento di
Gerberto d’Aurillac», Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo
n. 85, 1974-1975, p. 53-87.
FROVA 2000: C. FROVA, «Cultura aritmetica nel X secolo: Abbone di Fleury»,
in: FREGUGLIA 2000, p. 36-57.
GABRIELI 1974: F. GABRIELI, «Gli Omayyadi di Spagna e l’Oriente», Bullettino
dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo 85, 1974-1975, p. 1-16.
GASEC 1986: H. GASEC, «Gerbert et la pédagogie des arts libéraux à la fin
du dixième siècle», Journal of Medieval History 82, 1986, p. 111-121.
GENEST 1996: J. F. GENEST, «Inventaire de la bibliothèque de Bobbio», in:
GUYOTJEANNIN 1996, p. 251-260.
GERBERTUS, Geometria: J. P. MIGNE (ed.) - GERBERTUS, Geometria Gerberti, in:
Patrologia Latina CCCXXXIX, Paris 1853.
GERBERTUS, De rationale: J. P. MIGNE (ed.) - GERBERTUS, De rationale et ratione
uti, in: Patrologia Latina CCCXXXIX, Paris 1853.
GERBERTUS, De mensura: GERBERTUS, De mensura fistularum, in: Kl. J. SACHS,
Mensura fistularum. Die Mensuriering der Orgelpfeifen in Mittelalter, tomo
I, Stuggart-Murrhardt 1970-1980, p. 59-72.
82 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 82 2008.02.13, 7:34
G ERBERT , Correspondance: P. R ICHÉ – J. P. C ALLU (ed.) - G ERBERT ,
Correspondance (Les Classiques de l’Histoire de France au Moyen Age 35-36),
Paris 1993.
GERBERT, Lettres scientifiques: A. P H. SEGONDS (ed.) - GERBERT, Lettres
scientifiques, in: GERBERT, Correspondance, II, p. 662-708.
GIBERT 1974: R. GIBERT, «Antigüedad clásica en la Hispania Visigótica»,
in: La cultura antica nell’Occidente latino dal VII al XI secolo, Spoleto, CISAM,
1974, p. 603-652 .
GOMEZ 1989: J. GOMEZ-PALLARES, «Textos latinos de computo eclesiastico
en los codices Albeldense y Emilianense de la Biblioteca del Escorial»,
Hispania Sacra 41, 1989, p. 11-34.
GRAF 2002: A. GRAF, Miti, leggende e superstizioni del medio evo, Milano 2002.
GRANT 1983: E. GRANT, La scienza nel Medioevo, Bologna 1983.
GRANT 2001: E. GRANT, Le origini medievali della scienza moderna. Il contesto
religioso, istituzionale e intellettuale, Torino 2001.
GROS 1999: M. S. GROS, «La vila de Vic i el monestir de Ripoll en els anys
967-970», in: OLLICH 1999, p. 747-761.
GUILLAUMIN 1995: J. Y. GUILLAUMIN, Boèce. Institution arithmétique, Les Belles
Lettres, Paris 1995.
GUILLAUMIN 2000: J. Y. GUILLAUMIN, «Le deux définitions de l’angle plan
par Gerbert (Géométrie, Ch.4,3)», in: SCIENCE 2000, p. 359-369.
GÜMPEL 2002: K.-W. GÜMPEL, «Gerbert von Aurillac und Spanien», in:
NUVOLONE 2003a, p. 79-100.
GUYOTJEANNIN 1996: O. GUYOTJEANNIN – E. POULLE (ed.), Autour de Gerbert
d’Aurillac le Pape de l’an Mil, Album de documents commentés (Matériaux
pour l’histoire publiés par l’ École des Chartes 1), Paris-Genève 1996.
HASKINS 1926: CH. H. HASKINS, «Translators from the Arabic in Spain», in:
CH. H. HASKINS, Studies in the History of Mediaeval Science, London-New
York 1926, p. 3-19.
HAVET 1889: J. HAVET, Lettres de Gerbert (983-997) (Collection de textes pour
servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire 6), Paris 1889.
HENTSCHEL 2003: F. HENTSCHEL, «Gerbert, organa, and historical thinking»,
in: F. G. NUVOLONE (ed.), Gerbertus qui et Silvester: minima gerbertiana da
Piacenza a Lovanio e altri studi (Archivum Bobiense 24, 2002), Bobbio 2003,
p. 53-77.
HOCK 1846: K. F. HOCK, Silvestro II Papa ed il suo secolo, Milano 1846.
HOMMES 2004: Hommes et sociétés dans l’Europe de l’an Mil, Toulouse 2004.
HUGLO 1980: M. HUGLO, «Gerbert d’Aurillac», in: New Grove Dictionary of
Music and Musicians 7 (London, 1980), p. 688.
HUGLO 1990: M. HUGLO, «La réception de Calcidius et des commentaires
ABob xxix - 83
Mate.Testo.PM 83 2008.02.13, 7:34
de Macrobe à l’époque carolingienne», Scriptorium 44, 1990/91, p. 3-20.
HUGLO 1994: M. HUGLO, «Les diagrammes d’harmonique interpolés dans
les manuscrits de la “Musica Isidori”», Scriptorium 48, 1994, p. 171-186.
HUGLO 2000: M. HUGLO, «Gerbert, théoricien de la musique, vu de l’an
2000», Cahiers de civilisation médiévale 43, 2000, p. 143-160.
JAQUEMARD 2000: D. JAQUEMARD, «Recherches sur la composition et la trans-
mission de la Geometria Incerti Auctoris», in: SCIENCE 2000, p. 80-119.
JUNIYENT 1963: E. JUNIYENT, «La Biblioteca de la Canónica de Vich en los
siglos X-XI», in: Gesamnelte Aufsätze fur Kulturgeschichte Spaniens 21,
Münster Westf. 1963, p. 136-145.
JUNIYENT 1974: E. JUNIYENT, «Le scriptorium de la cathédrale de Vich», Les
Cahiers de Saint-Michel de Cuxa 5, 1974, p. 65-69.
JUSTE 2000: D. JUSTE, «Les doctrines astrologiques du Liber Alchandrei», in:
I. DRAELANTS – A. TIHON – B. VAN DEN ABEELE (ed.), Occident et Proche Ori-
ent: contacts scientifiques au temps des croisades, Turnhout 2000, p. 277-311.
KIECKHEFER 2004: R. KIECKHEFER, La magia nel Medioevo, Roma-Bari 2004.
KUNITZSCH 1997: P. KUNITZSCH, «Les relations scientifiques entre l’Occident
et le monde arabe à l’époque de Gerbert», in: CHARBONNEL 1997, p. 193-
203.
KUNITZSCH 2000: P. KUNITZSCH, «La table des climats dans le corpus des
plus anciens textes latins sur l’astrolabe», in: SCIENCE 2000, p. 392-399.
LABANDE 1985: E. R. LABANDE, «La formation de Gerbert à St-Géraud
d’Aurillac», in: TOSI 1985a, p. 21-34.
LACARRA 1963: J. M. LACARRA, «La penisula iberica del siglo VII al X: centros
y vias de irradiación de la civilización», in: Centri e vie di irradiazione della
civiltà nell’Alto Medioevo, Spoleto, CISAM 1963, p. 233-278.
LA SALLE 1914: F. De LA SALLE DE RAUCHEMAURE, Gerbert, Silvestre Deux. Le
savant, le “faiseur de rois”, le pontife, Paris 1914.
LATTIN 1932: H. PR. LATTIN, «Lupitus Barchinonensis», Speculum 39, 1932,
p. 58-64.
LATTIN 1951: H. PR. LATTIN, The Peasant Boy Who Became Pope: Story of
Gerbert, New York 1951.
LATTIN 1961: H. PR. LATTIN, The Letters of Gerbert with his papal privileges as
Sylvester II, New York 1961.
LAUSER 1866: P. F. LAUSER, Gerbert. Étude historique sur le 10e siècle, Paris
1866.
LEFLON 1940: J. LEFLON, Gerbert. Humanisme et chrétienté au Xe siècle, Abbaye
Saint Wandrille 1940.
LEVET 1990: J.-P. LEVET, «Gerbert d’Aurillac. Le savant, le maître, le
84 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 84 2008.02.13, 7:34
mathématicien», in: Actes de l’Université d’Été sur l’Histoire des
mathématiques (La Rochelle 1988), Poitiers 1990, p. 257-287.
LEVET 1997a: J.-P. LEVET , Gerbert. Liber Abaci I (Cahiers d’histoire des
mathématiques et d’épistémologie), Poitiers 1997.
LEVET 1997b: J.-P. LEVET, Gerbert. Traité de géometrie (Cahiers d’histoire des
mathématiques et d’épistémologie), Poitiers 1997.
LEVET 1997c: J.-P. LEVET , «La vérité de Gerbert et de la sagesse et
l’humanisme des quatres voies», Tôzai 2, 1997, p. 19-45.
LIÉBERT 2001: Y. LIÉBERT, «Gerbert d’Aurillac et la musique», Tôzai 4, 2001,
p. 69-74.
LIGATO 2001: G. LIGATO, «L’appello di Silvestro II per Gerusalemme (Ep.
28)», in: NUVOLONE 2001, p. 127-172.
LINDGREN 1976: U. LINDGREN, Gerbert von Aurillac und das Quadrivium.
Untersuchungen zur Bildung im Zeitalter der Ottonen, Wiesbanden 1976.
LINDGREN 1985: U. LINDGREN, «Ptolémée chez Gerbert d’Aurillac», in: TOSI
1985a, p. 619-644.
LINDGREN 1991: U. LINDGREN, «Gerbert von Reims und die Lehre des
Quadriviums», in: Kunst in Zeitalter der Kaiserin Theophanu, Akten des
Internationalen Colloquiums veranstaltet vom Schnutgen-Museum, Köln,
13.-15. Juni 1991, Locker 1991, p. 291-302.
LINDGREN 2001: U. LINDGREN, «Représentant d’un âge obscur ou à l’aube
d’un essor? Gerbert et les arts libéraux», in: NUVOLONE 2001, p. 107-126.
MARTINEZ 2000: J. MARTINEZ-GASQUEZ, «Le monastère de Ripoll dans le
Nord-Est péninsulaire: point de rencontre des cultures arabe et
chrétienne», in: SCIENCE 2000, p. 239-253.
MCCLUSKEY 1998: S. MCCLUSKEY, Astronomies and cultures in Early Medieval
Europe, Cambridge 1998.
MEYER 1996: C. MEYER, Mensura Monochordi. La division du monocorde (IX-
XV siècles) (Publications de la Société Française de Musicologie II, 15), Paris
1996.
MEYER 1997: C. MEYER, «Gerbertus musicus. Gerbert et les fondements du
sistème acoustique», in: CHARBONNEL 1997, p. 183-192.
MEYER 2001: C. MEYER, Les traités de Musique, Turnhout 2001.
MICHEL 1954: H. MICHEL, «Les tubes optiques avant le telescope», Ciel et
terre, Bulletin de la société belge d’astronomie, de météorologie et de physique
du globe 70, 1954, p. 175-184.
MILLÁS VALLICROSA 1931: J. MILLÀS VALLICROSA, Assaig d’história de les idees
físiques i matemátiques a la Catalunya Medieval (Estudis Universitaris Catalans,
Série Monográfica 1), Barcelona 1931.
ABob xxix - 85
Mate.Testo.PM 85 2008.02.13, 7:34
MILLÁS VALLICROSA 1949: J. MILLÁS VALLICROSA, Estudios Sobre Historia de la
Ciencia Española, Barcelona 1949.
MILLÁS VALLICROSA 1960: J. MILLÁS VALLICROSA, Nuevos Estudios Sobre Historia
de la Ciencia Española, Barcelona 1960.
MOLINS 1993: G. MOLINS – M. PAU, «Arrels medieval de la revolució
scientifica: Gerbert d’Orlhac i la ciència vigatana del segle X», in Ausa:
Publicación Trimestral del Patronato de Estudios Ausonenses vol. 15, 1993, p.
269-282.
MONTECCHIO 2000: L. MONTECCHIO, «I precedenti del Giubileo nell’anno
Mille?», in: Dante e il Giubileo. Atti del Convegno (Roma, 29-30 novembre
1999), Firenze 2000, p. 43-54.
MOR 1952: C. G. MOR, Silvestro II e Gerusalemme, Milano 1952.
MORENO 2000: J. L. MORENO, «L’orgue dans Avranches 235 et la tradition
musicologique antique et médiévale», in: SCIENCE 2000, p. 121-143.
MOSTERT 1997: M. MOSTERT, «Les traditions manuscrites des oeuvres de
Gerbert», in: CHARBONNEL 1997, p. 307-324.
MOSTERT 2001: M. MOSTERT, «Gerbert d’Aurillac, Abbon de Fleury et la
culture de l’An Mille: étude comparative des leurs oeuvres et de leur
influence», in: NUVOLONE 2001, p. 397-431.
MUNDÓ 1991: A. M. MUNDÓ – M. ANSCARI, «Producció i conservació del
material escrit a Catalunya: escriptoris i biblioteques pels volts de l’any
Mil», in: Catalunya y França meridional a l’entorn de l’any mil. Actes del
col·loqui internacional Hug Capet (Barcelona, 2-5 juliol 1987), Barcelona
1991, p. 378-381.
MUNDÓ 1999: A. M. MUNDÓ, «Entorn de l’astrolabi de Gerbert», in: OLLICH
1999, p. 665-677.
NASR 1977: SEYYED HOSSEIN NASR, Scienza e civiltà nell’Islam, Milano, 1977.
NAVARJ 1975: J. V. NAVARJ, «The leitmotiv in the mathemathical thought of
Gerbert of Aurillac», Journal of Medieval History 1, 1975, p. 139-150.
NUVOLONE 2001a: F. G. NUVOLONE, Gerberto d’Aurillac da abate di Bobbio a
papa dell’anno 1000, Atti del Congresso Internazionale (Bobbio, Audito-
rium di S. Chiara, 28-30 settembre 2000) (Archivum Bobiense - Studia 4),
Bobbio 2001.
NUVOLONE 2001b: F. G. NUVOLONE, «Gerberto-Silvestro II visto da Ademaro
di Chabannes», in: NUVOLONE 2001a, p. 65-103.
NUVOLONE 2003: F. G. NUVOLONE, «Il Carmen figurato attribuito a Gerberto
nel Ms Paris, BNF, lat.776, f.1v: una composizione redatta nell’Abbazia
di San Colombano a Bobbio?», in: F. G. NUVOLONE (ed.), Gerbertus qui et
Silvester: minima gerbertiana da Piacenza a Lovanio e altri studi (Archivum
Bobiense 24, 2002), Bobbio 2003, p. 123-260.
86 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 86 2008.02.13, 7:34
NUVOLONE 2004: F. G. NUVOLONE, «Appunti sul Carmen figurato di Gerberto
d’Aurillac e la sua attività a Bobbio», in: F. G. NUVOLONE (ed.), Liber de
arca domni Athalani: a trent’anni dalla fondazione degli Archivi Storici Bobiensi,
1973-2003 (Archivum Bobiense 25, 2003), Bobbio 2004, p. 227-345.
NUVOLONE 2005a: F. G. NUVOLONE (ed.), Gerberto d’Aurillac-Silvestro II: linee
per una sintesi. Atti del Convegno Internazionale (Bobbio, Auditorium di
Santa Chiara, 11 settembre 2004) (Archivum Bobiense Studia V), Bobbio
2005.
NUVOLONE 2005b: F. G. NUVOLONE, «Gerberto e la musica», in: NUVOLONE
2005a, p. 145-164.
NUVOLONE 2005c: F. G. NUVOLONE, «L’abate Gerberto e la cultura: un
cristiano?», in: NUVOLONE 2005a, p. 189-213.
NUVOLONE 2005d: F. G. NUVOLONE (ed.), “Vidi et gavisus sum”, visione politica
e pratica scientifica in Gerberto, e altri studi (Archivum Bobiense 26, 2004),
Bobbio 2005.
NUVOLONE 2005e: F. G. NUVOLONE, «La presenza delle cifre indo-arabe nel
Carmen figurato di Gerberto: una discussione», in: NUVOLONE 2005d, p.
321-372.
NUVOLONE 2005f: F. G. NUVOLONE, «Influenze “islamiche” nell’astronomia
di Gerberto?», in: NUVOLONE 2005d, p. 490-498.
NUVOLONE 2007a: F. G. NUVOLONE (ed.), “Romanorum Christus”, La Croce di
luce palestinese, Nome e numeri sulla Tau di Gerberto, e altri studi fino alla
Liberazione di Milano (Archivum Bobiense 27-28, 2005-06), Bobbio 2007.
NUVOLONE 2007b: F. G. N UVOLONE, «Gerberto lascia delle impronte:
iscrizione e monogramma - Ipotesi di lettura», in: NUVOLONE 2007a, p.
257-319.
NUVOLONE 2007c: F. G. NUVOLONE, «Gerbert d’Aurillac et la politique
impériale ottonienne en 983: une affaire de chiffres censurée par le
moines?», in: C. CAROZZI - H. TAVIANI-CAROZZI (ed.), Faire l’événement au
Moyen Age: de l’événement au fait historique (Le temps de l’histoire), Aix-en-
Provence 2007, p. 234-273.
NUVOLONE 2007d: F. G. NUVOLONE, «Tau e numeri sulla Croce di Gerberto
a Elna. Riflessioni e ipotesi risolutiva», Quaderni della Valtolla 9, 2007, p.
6-26.
NUVOLONE 2008a: F. G. NUVOLONE, «Zh/ s ej», «che tu viva!». Dall’eredità
scientifica pluriculturale della Catalogna, ai risvolti contemporanei (Archivum
Bobiense 29), Bobbio 2008.
OLDONI 1977: M. OLDONI, «Gerberto e la sua storia», Studi medievali ser. 3a
18, 1977, p. 629-704; «A fantasia dicitur fantasma», 21, 1980, p. 493-622;
24, 1987, p. 167-245.
ABob xxix - 87
Mate.Testo.PM 87 2008.02.13, 7:34
OLDONI 1985: M. OLDONI, «Imago e fantasma: l’incantesimo storiografico
di Gerberto», in: TOSI 1985a, p. 747-768.
OLDONI 1987: M. OLDONI, Fantasmi e fantasia nel Medioevo, Gerberto e il suo
doppio, Napoli 1987.
OLDONI 1998: M. OLDONI, «Il viaggio a Chartres di Richero: un nuovo X
secolo», in: L’autobiografia nel Medioevo, Atti del XXXIV Convegno Storico
Internazionale (Todi, 12-15 ottobre 1997), Spoleto 1998, p. 103-129.
OLDONI 2001: M. OLDONI, «Gerberto e la sua leggenda, ovvero la sua
“Nachleben”», in: NUVOLONE 2001, p. 823-838.
OLDONI 2004: M. OLDONI, «L’anno mille: approcci culturali», in: HOMMES
2004, p. 317-332.
OLLERIS 1867: A. OLLERIS, Œuvres de Gerbert, pape sous le nom de Sylvestre II,
collationées sur les manuscrits, Clermont-Ferrand – Paris 1867.
OLLICH 1999: I. OLLICH I CASTANYER (ed.), Actes del Congrés Internacional
Gerbert d’Orlhac i el seu temps: Catalunya i Europa a la fi del 1r mil.lenni,
(Vic-Ripoll, 10-13 de novembre de 1999) (Documents 31), Vic 1999.
ORDEIG 1989: R. ORDEIG I MATA, «Ató, bisbe i arquibisbe de Vic (957-971),
antic arxiprest-ardiaca de Girona», Studia vicensia 1, 1989, p. 61-97.
ORDEIG 1999: R. ORDEIG I MATA, «Ato de Vic, mestre de Gerbert d’Orlhac»,
in: OLLICH 1999, p. 593-620.
PALADINO 2007: L. C. PALADINO, «La biografia di Gerberto nella Historia
Francorum di Richero di Reims. Con commento e traduzione criticamente
riveduta», in: NUVOLONE 2007a, p. 167-256.
PARISSE 1996: M. PARISSE, «La Vita di Jean abbé de Gorze vers 578», in:
GUYOTJEANNIN 1996, p. 37-42.
PAVINI 1980: M. G. PAVINI CARCIOTTO, «L’epistolario di Gerberto d’Aurillac
(trad. e note)», Quaderni di Filologia Medievale 1, 1980.
PICAVET 1897: F. PICAVET, Gerbert, un pape philosophe. D’après l’histoire et
d’après la légende, Paris 1897.
PEZ 1721: PEZ (ed.), GERBERTUS, Geometria Gerberti, in: Thesaurus, III/2, 1721.
PLADEVALL 1998: A. PLADEVALL I FONT, Sylvestre II (Gerbert d’Orlhac), Barce-
lona 1998.
PLADEVALL 1999: A. PLADEVALL I FONT, «Entorn a l’estada de Gerbert a
Catalunya (967-970). L’existència de biblioteques privades perdudes»,
in: OLLICH 1999, p. 651-663.
POULLE 1985: E. POULLE, «L’Astronomie de Gerbert», in: TOSI 1985a, p. 597-
617.
POULLE 1996a: E. POULLE, «Gerbert horloger!», in: GUYOTJEANNIN 1996, p.
365-366.
POULLE 1996b: E. POULLE, «Note sur l’autorité des traités de l’astrolabe»,
in: GUYOTJEANNIN 1996, p. 343-345.
88 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 88 2008.02.13, 7:34
POULLE 2000: E. POULLE, «Astrolabium, astrolapsus, horologium: enquête sur
un vocabulaire», in: SCIENCE 2000, p. 437-448.
POULLE 2005: E. POULLE, «Gerbert homme de science», in: NUVOLONE 2005a,
p. 95-123.
POUPARD 2003: P. POUPARD – C. SIGISMONDI, «Gerberto, scienziato e papa»,
Geografia, Trimestrale di ricerca scientifica e di programmazione regionale 26
n. 3-4, 2003, p. 58-65.
PUIGVERT 2000a: G. PUIGVERT I PLANAGUMÁ, «Textes communs au Manuscrit
ACA Ripoll 225 et au Manuscrit Avranches 235», in: SCIENCE 2000, p. 171-
175.
PUIGVERT 2000b: G. PUIGVERT I PLANAGUMÁ, Astronomia i astrologia al monestir
de Ripoll. Edició i estudi dels manuscrits científics astronomico-astrologics del
monestir de Santa Maria de Ripoll, Bellaterra 2000.
RICHÉ 1984: P. RICHÉ, Le scuole e l’insegnamento nell’Occidente cristiano dalla
fine del V secolo alla metà dell’XI secolo, Roma 1984.
RICHÉ 1985: P. RICHÉ, «L’enseignement de Gerbert à Reims dans le contexte
européen», in: TOSI 1985a, p. 51-69.
RICHÉ 1987: P. RICHÉ, Gerbert d’Aurillac. Le pape de l’an Mil, Paris 1987 (ul-
tima ristampa parzialmente riveduta, Paris 2006) (trad. italiana P. RICHÉ,
Gerberto d’Aurillac. Il papa dell’anno Mille, Cinisello Balsamo 1988).
RICHÉ 1991: P. RICHÉ, «Gerbert d’Aurillac en Catalogne», in: Catalunya y
França meridional a l’entorn de l’any mil. Actes del col.loqui internacional
Hug Capet (Barcelona, 2-5 juliol 1987), Barcelona 1991, p. 374-377.
RICHÉ 1999: P. RICHÉ, Les Grandeurs de l’an Mille, Paris 1999.
RICHÉ 2000a: P. RICHÉ, «Le Quadrivium dans le haut moyen âge», in:
FREGUGLIA 2000, p. 14-33.
RICHÉ 2000b: P. RICHÉ (ed.), Gerbert, Moine, Evêque et Pape. Actes des
journées d’étude d’Aurillac, Aurillac 2000.
RICHÉ 2004: P. RICHÉ, Abbon de Fleury (950-1004). Un moine combatif et sa-
vant, Turnhout 2004.
RICHÉ 2006: P. RICHÉ – J. VERGER, Des nains sur des épaules de géants. Maîtres
et élèves au Moyen Age, Paris 2006.
RICHERUS, Historiarum: H. HOFFMANN (ed.) - RICHER VON SAINT-REMI, Historiae,
(Monumenta Germaniae Historica, Scriptores 38), Hannover 2000.
RIU 1999: M. RIU Y RIU, «Els monestirs catalans entorn de l’any mil», in:
OLLICH 1999, p. 729-745.
ROBBINS 1929: H. ROBBINS BITTERMANN, «The organ in the Early Middle
Ages», Speculum 4, 1929, p. 390-410.
ROMANO 1991: D. ROMANO VENTURA, «Les juifs de Catalogne aux alentours
de l’an Mil», in: Catalunya i França meridional a l’entorn de l’any mil, Actes
ABob xxix - 89
Mate.Testo.PM 89 2008.02.13, 7:34
del col.loqui internacional Hug Capet (Barcelona, 2-5 juliol 1987), Barce-
lona 1991, p. 317-331.
ROMANO 1999: D. ROMANO VENTURA, «Notes sobre l’activitat dels jueus a
Catalunya l’any mil», in: OLLICH 1999, p. 697-700.
S ACHS 1972: K L .-J. S ACHS , «Gerbertus cognomento musicus. Zur
musikgeschichtlichen Stellung des Gerbert von Reims (nachmaligen
Papstes Silvester II.)», Archiv für Musikwissenschaft, 1972, p. 257-274.
SALRACH I MARES 1984a: J. M. SALRACH I MARES, «El conte-bisbe Miró Bonfill
i l’acte de consagració de Ripoll de l’any 977», in: Estudis Universitaris
Catalans, Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en
el seu selantè anniversari 4, 1984, p. 303-318.
SALRACH I MARES 1984b: J. M. SALRACH I MARES, «El conte-bisbe Miró Bonfill
i l’acta de consagració de Cuixa de l’any 974», Acta historica et archaeologica
Mediaevalia 10, 1989, p. 107-124.
SAMSÓ 1991: J. SAMSÓ, «Cultura científica àrab i cultura científica llatina a
la Catalunya altmedieval: el monestir de Ripoll i el naixement de la ciència
catalana», in: Symposium internacional sobre els origins de Catalunya (segles
VIII-XI), Barcelona 1991, p. 253-269.
SAMSÓ 1999: J. SAMSÓ, «Maslama al-Majriti y la tabla de estrellas en el
tratado De Mensura Astrolabii», in: OLLICH 1999, p. 679-695.
SANTI 2003: E. SANTI, «Gerberto e la musica», Geografia, Trimestrale di ricerca
scientifica di programmazione regionale 26, n. 3-4, 2003, p. 81-85.
SAVAGE 1985: E. SAVAGE-SMITH, Islamicate Celestial Globes: Their History, Con-
struction, and Use, Washington D.C. 1984.
SCHIPPER 2004: W. SCHIPPER, «Rabanus Maurus and his sources», in: A.A.
MCDONALD – M.W. TWOMEY (ed.), Schooling and Society. The Ordering and
Reordering of Knowledge in the Western Middle Ages, Leuven-Paris-Dudley
(MA) 2004, p. 1-21.
SCIENCE 2000: Science antique. Science médiévale, Actes du colloque interna-
tional (Mont-Saint-Michel, 4-7 septembre 1998), Olms Weidmann 2000.
SIGISMONDI 2003a: C. SIGISMONDI, «Gerberto e l’astronomia», Geografia,
Trimestrale di ricerca scientifica e di programmazione regionale 26, n. 3-4, 2003,
p. 66-69.
SIGISMONDI 2003b: C. SIGISMONDI, «Gerberto e la geografia tolemaica»,
Geografia, Trimestrale di ricerca scientifica e di programmazione regionale 26,
n. 3-4, 2003, p. 70-75.
S ILVESTRE 1949: H. SILVESTRE , «Une copie de la Scolie de Gerbert à
l’Arithmetique de Boèce (L.II, c.I)», Scriptorium 3, 1949, p. 131-134.
SOMFAI 2005: A. SOMFAI, «The Brussels gloss: a tenth-century reading of
the geometrical and arithmetical passages of Calcidius’s Commentary
90 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 90 2008.02.13, 7:34
(ca. 400 AD) to Plato’s Timaeus», in: D. JACQUART – Ch. BURNETT (ed.),
Scientia in margine. Études sur les marginalia dans les manuscrits scientifiques
du Moyen Âge à la Renaissance, Droz 2005, p. 139-169.
STEVENS 2005: W. M. STEVENS, «Marginalia in the Latin Euclid», in: D.
JACQUART – Ch. BURNETT (ed.), Scientia in margine. Études sur les marginalia
dans les manuscrits scientifiques du Moyen Âge à la Renaissance, Droz 2005,
p. 117-137.
SYLVESTER II, Epistolae: J. P. MIGNE (ed.) - SYLVESTER II, Epistolae et decreta
pontificia, in: Patrologia Latina CCCXXXIX, Paris 1853.
THIETMARUS, Chronicon: R. HOLTZMANN (ed.) - THIETMARUS MERSEBURGENSIS
EPISCOPUS, Chronicon (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum
Germanicarum, Nova Series 9), 1935.
THOMSON 1985: R. B. THOMSON, «Two astronomical tractates of Abbo of
Fleury», in: J. D. NORTH – J. J. ROCHE (ed.), The light of Nature. Essays in the
history and philosophy of Science, presented to A. C. Crombie, Dordrecht-Bos-
ton-Lancaster 1985, p. 113-133.
THOMSON 1998: R. B. THOMSON, «Further astronomical material of Abbo of
Fleury», Mediaeval Studies 50, 1998, p. 671-673.
THORNDIKE 1923: THORNDIKE, History of magic and experimental science. I.The
first thirteen centuries, Columbia University Press 1923.
TONEATTO 1994: L. TONEATTO, Codices artis mensoriae: i manoscritti degli antichi
opuscoli latini d’agrimensura, 5.-19. sec., Spoleto, CISAM 1994.
TOSI 1985a: M. TOSI (ed.), Gerberto. Scienza, Storia e mito. Atti del “Gerberti
Symposium” (Bobbio, 25-27 luglio 1983) (Archivum Bobiense - Studia 2),
Bobbio 1985.
TOSI 1985b: M. TOSI, «Il governo abbaziale di Gerberto a Bobbio», in: TOSI
1985a, p. 71-223.
TRYSTRAM 1984: F. TRYSTRAM, L’anno mille. Impero e Chiesa nell’Europa
medievale, Milano 1984.
UDINA 1985: F. UDINA MARTORELL, «Gerberto y la cultura ispanica: los
Manuscritos de Ripoll», in: TOSI 1985a, p. 35-50.
VERNET 1965: J. VERNET, «La ciencia en el Islam y Occidente», in: L’Occidente
e l’Islam nell’Alto Medioevo, Spoleto, CISAM 1965, p. 537-572.
VERNET 1974: J. VERNET, «La transmission des textes en France», in: La
cultura antica nell’Occidente latino dal VII all’XI secolo, Spoleto, CISAM 1974,
p. 89-123.
VOGEL 1985: K. VOGEL, «L’aritmetica e la geometria di Gerberto», in: TOSI
1985a, p. 577-596.
ABob xxix - 91
Mate.Testo.PM 91 2008.02.13, 7:34
WATT 1991: W. M. WATT, L’Islam e l’Europa medievale, Milano 1991.
WEIGLE 1971: F. WEIGLE (ed.) - GERBERTUS, Die Briefsammlung Gerberts von
Reims (Monumenta Germaniae Historica, Die Briefe der deutschen Kaiserzeit
2), Weimar 1971.
WILLELMUS, Gesta: G. WAITZ (ed.) - WILLELMUS MALMESBURENSIS, Gesta regum
anglorum (Monumenta Germaniae Historica, Scriptores 10), Hannover 1852.
WILLIAMS 1993: P. WILLIAMS, The Organ in western culture: 750-1250, Cam-
bridge 1993.
WOLFF 1987: PH. WOLFF, Storia e cultura nel Medioevo dal secolo IX al XII,
Roma-Bari 1987.
ZAFARANA 1966: Z. ZAFARANA, «Bennone», in: Dizionario Biografico degli
Italiani 8 (Roma, 1966).
ZIMMERMANN 1996: M. ZIMMERMANN , «Naissance d’une principauté:
Barcelone et les autres comtés catalans aux alentours de l’an Mil», in:
Catalunya i França meridional a l’entorn de l’any Mil, Actes del col.loqui
internacional Hug Capet (Barcelona, 2-5 juliol 1987), Barcelona 1991, p.
111-135.
ZIMMERMANN 1997: M. ZIMMERMANN, «La Catalogne de Gerbert», in:
CHARBONNEL 1997, p. 79-101.
ZIMMERMANN 2003: M. ZIMMERMANN, Écrire et lire en Catalogne (IXe-XIIe
siècle), Madrid 2003.
ZIMMERMANN 2004: M. ZIMMERMANN, «Écrire en l’An Mil», in: HOMMES 2004,
p. 351-378.
ZUCCATO 2005a: M. ZUCCATO, «Gerbert’s Islamicate Celestial Globe», in:
NUVOLONE 2005a, p. 167-186.
ZUCCATO 2005b: M. ZUCCATO, «Gerbert of Aurillac and a Tenth-Century
Jewish Channel for the Transmission of Arabic Science to the West», Specu-
lum 80, 2005, p. 742-763.
Weblografia
Si segnala il sito personale del prof. Costantino Sigismondi, del
Dipartimento di Fisica dell’Università “La Sapienza” di Roma: http://
www.icra.it/solar/sigismondi. Dalla pagina iniziale, per quel che
riguarda Gerberto d’Aurillac, si accede a due sezioni: Gerbert d’Aurillac
Opera Omnia, nella quale sono disponibili, in formato .pdf, i testi
dell’aquitano secondo l’edizione della Patrologia Latina, l’introduzione e
l’edizione delle lettere scientifiche dal volume di Harriet Pratt Lattin,
92 - ABob xxix
Mate.Testo.PM 92 2008.02.13, 7:34
The Letters of Gerbert; gli atti del convegno Gerberto, scienziato e papa tenutosi
il 12 maggio 2003 presso la Pontificia Università Lateranense: Sigismondi
– Poupard, Proemio; Sigismondi, Gerberto e l’astronomia; Sigismondi,
Gerberto e la geografia tolemaica; Palagiano, Gerberto e la medicina; Santi,
Gerberto e la musica (interventi pubblicati a stampa in Geografia, Trimestrale
di ricerca scientifica e di programmazione regionale, 26 n. 3-4, 2003, vedi
Bibliografia); materiali relativi alle celebrazioni in onore di Gerberto del
2006: Scienza in Cattedrale. La meridiana del Duomo e la figura e l’opera di
Silvestro II – Gerberto d’Aurillac papa e scienziato (Milano, 12 maggio 2006)
e Gerberto e il De Mensura Fistularum (Giornata gerbertiana a Roma, 16
maggio 2006).
All’indirizzo http://www.casanatense.it/HTML/archivio-eventi/
gerbertus/index.htm sono disponibili i testi che hanno accompagnato la
mostra bibliografica organizzata dalla Biblioteca Casanatense nel 2004,
Quadratus siderales: Silvestro II e la scienza dell’anno Mille: Sigismondi –
Berardini – Martone, Storiografia su Gerberto; Calia, Rinascenze culturali
altomedievali; Prosperi, Le fonti del Trivio; Sigismondi – Santi, La musica;
Mariani, Le fonti del Quadrivio; Ciliberto – Giustizi, L’Astronomia;
Nuvolone, Il carme figurato di Gerberto d’Aurillac.
ABob xxix - 93
Mate.Testo.PM 93 2008.02.13, 7:34
Vous aimerez peut-être aussi
- Exposé StrategieDocument16 pagesExposé StrategieAnge Tato60% (5)
- Kit Petite Souris Carnet de DentsDocument6 pagesKit Petite Souris Carnet de DentsVincent BrelPas encore d'évaluation
- Nolhac (Pierre De), La Bibliothèque de Fulvio Orsini. Contribution À L'histoire Des Collections D'italie Et À L'étude de La Renaissance, 1887.Document524 pagesNolhac (Pierre De), La Bibliothèque de Fulvio Orsini. Contribution À L'histoire Des Collections D'italie Et À L'étude de La Renaissance, 1887.Francophilus VerusPas encore d'évaluation
- Mélanges Georges OstrogorskyDocument3 pagesMélanges Georges OstrogorskyAndrei OrobanPas encore d'évaluation
- Recherches Augustiniennes Volume VIII - 1972 PDFDocument414 pagesRecherches Augustiniennes Volume VIII - 1972 PDFApocryphorum Lector100% (1)
- Bouhot La Tradition Manuscrite Du de Fide de Bachiarius (1979)Document12 pagesBouhot La Tradition Manuscrite Du de Fide de Bachiarius (1979)crespomanoloPas encore d'évaluation
- H. Delehaye Les Saints Stylite PDFDocument488 pagesH. Delehaye Les Saints Stylite PDFConstantin Alexandru Bulai0% (1)
- Le Commissariat Au CompteDocument80 pagesLe Commissariat Au CompteOverDoc100% (2)
- Bibliotheque D'humanisme Et Renaissance Tome Vii - 1945Document299 pagesBibliotheque D'humanisme Et Renaissance Tome Vii - 1945Vetusta MaiestasPas encore d'évaluation
- La Poesia MacarronicaDocument27 pagesLa Poesia MacarronicaSofia IvanoffPas encore d'évaluation
- F. Dolbeau, La Passion Des Saints Lucius Et MontanusDocument44 pagesF. Dolbeau, La Passion Des Saints Lucius Et MontanusdiadassPas encore d'évaluation
- Classica Et Christiana 7-1 2012Document326 pagesClassica Et Christiana 7-1 2012meteorPas encore d'évaluation
- Analecta Bollandiana, Vol. 23, 1904Document536 pagesAnalecta Bollandiana, Vol. 23, 1904diadassPas encore d'évaluation
- Portuguese Studies On Medieval Illuminated Manuscripts by Maria Adelaide Miranda Alicia Miguélez CaveroDocument218 pagesPortuguese Studies On Medieval Illuminated Manuscripts by Maria Adelaide Miranda Alicia Miguélez CaveroLorena CanoPas encore d'évaluation
- BORDIER - GREGOIRE de TOURS Les Livres Des Miracles Et Autres Opuscules - Tome III 1862Document485 pagesBORDIER - GREGOIRE de TOURS Les Livres Des Miracles Et Autres Opuscules - Tome III 1862ninkasi1Pas encore d'évaluation
- Hagiographie, Idéologie Et Politique Au Moyen Âge en OccidentDocument578 pagesHagiographie, Idéologie Et Politique Au Moyen Âge en OccidentAmanalachioaie SilviaPas encore d'évaluation
- Oeuvres de Sulpice SévèreDocument541 pagesOeuvres de Sulpice SévèreGloria ChristiPas encore d'évaluation
- Homélie Sur Lâ à Vangile, Livre I (1-20), Tome I (PDFDrive)Document500 pagesHomélie Sur Lâ à Vangile, Livre I (1-20), Tome I (PDFDrive)Rakotomalala RazoNandrianinaPas encore d'évaluation
- Le Songe de Poliphile Ou (... ) Colonna Francesco Bpt6k1073366tDocument651 pagesLe Songe de Poliphile Ou (... ) Colonna Francesco Bpt6k1073366tBailey Fensom100% (1)
- Jacques Elfassi - Connaître La Bibliothèque Pour Connaître Les Sources - Isidore de Séville PDFDocument8 pagesJacques Elfassi - Connaître La Bibliothèque Pour Connaître Les Sources - Isidore de Séville PDFApocryphorum LectorPas encore d'évaluation
- Actes de S.S. Pie XI - (Tome 1)Document399 pagesActes de S.S. Pie XI - (Tome 1)IHS_MAPas encore d'évaluation
- Hincmar, Adalard, Prou. de Ordine Palatii. 1884.Document168 pagesHincmar, Adalard, Prou. de Ordine Palatii. 1884.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Olivier Delouis. Le Stoudite, Le Bénédictin Et Les Grandes Catéchèses. Autour de La Traduction Française D'un Texte Grec Inédit. Revue Des Études Byzantines, Tome 61, 2003. Pp. 215-228.Document15 pagesOlivier Delouis. Le Stoudite, Le Bénédictin Et Les Grandes Catéchèses. Autour de La Traduction Française D'un Texte Grec Inédit. Revue Des Études Byzantines, Tome 61, 2003. Pp. 215-228.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Duval-La Littrature Syriaque-1900 PDFDocument474 pagesDuval-La Littrature Syriaque-1900 PDFphilologusPas encore d'évaluation
- Graffin, Nau. Patrologia Orientalis. 1913. Tomus Nonus.Document698 pagesGraffin, Nau. Patrologia Orientalis. 1913. Tomus Nonus.Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (1)
- Testard Reflexions Et Signification de La Façade ToulouseDocument18 pagesTestard Reflexions Et Signification de La Façade ToulouseGiovanni FoisPas encore d'évaluation
- Scaliger - Alain Michel Ed - Acta SCALIGERIANADocument139 pagesScaliger - Alain Michel Ed - Acta SCALIGERIANAcohenmaPas encore d'évaluation
- Graffin, Nau. Patrologia Orientalis. 1915. Tomus Decimus.Document698 pagesGraffin, Nau. Patrologia Orientalis. 1915. Tomus Decimus.Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (3)
- Migne. Patrologiae Cursus Completus: Series Latina. 1800. Volume 102.Document578 pagesMigne. Patrologiae Cursus Completus: Series Latina. 1800. Volume 102.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Renaissance and ReformationDocument246 pagesRenaissance and ReformationoctavianuliciPas encore d'évaluation
- Dufourcq. Étude Sur Les Gesta Martyrum Romains. 1900. Volume 3.Document350 pagesDufourcq. Étude Sur Les Gesta Martyrum Romains. 1900. Volume 3.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Severyns, A. 1963. Recherches Sur La Chrestomathie de Proclos. Vol. 4. La Vita Homeri Et Les Sommaires Du Cycle. Texte Et Traduction (Paris: Les Belles Lettres)Document53 pagesSeveryns, A. 1963. Recherches Sur La Chrestomathie de Proclos. Vol. 4. La Vita Homeri Et Les Sommaires Du Cycle. Texte Et Traduction (Paris: Les Belles Lettres)AlanWatermanPas encore d'évaluation
- La Tradidion Des Œuvres de Saint Jean Chrysostome. Catéchèses Inconnues Et Homélies Peu ConnuesDocument44 pagesLa Tradidion Des Œuvres de Saint Jean Chrysostome. Catéchèses Inconnues Et Homélies Peu ConnuesPatrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Le Monachisme Italo Grec Et Basilien D PDFDocument4 pagesLe Monachisme Italo Grec Et Basilien D PDFAndrei DumitrescuPas encore d'évaluation
- Bibliothquedel 122 EcolDocument360 pagesBibliothquedel 122 EcolFrancophilus VerusPas encore d'évaluation
- Jean Darrouzès. Trois Documents de La Controverse Gréco-Arménienne. Revue Des Études Byzantines, Tome 48, 1990. Pp. 89-153.Document66 pagesJean Darrouzès. Trois Documents de La Controverse Gréco-Arménienne. Revue Des Études Byzantines, Tome 48, 1990. Pp. 89-153.Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (1)
- Byzantion 8 PDFDocument384 pagesByzantion 8 PDFstefan elenaPas encore d'évaluation
- Ops Et La Conception Divine de L'abondance Dans La Religion Romaine Jusqu'à La Mort D'augusteDocument348 pagesOps Et La Conception Divine de L'abondance Dans La Religion Romaine Jusqu'à La Mort D'augustemangiacarrubePas encore d'évaluation
- André-Marie Dubarle. L'homélie de Grégoire Le Référendaire Pour La Réception de L'image D'édesse. Revue Des Études Byzantines, Tome 55, 1997. Pp. 5-51.Document48 pagesAndré-Marie Dubarle. L'homélie de Grégoire Le Référendaire Pour La Réception de L'image D'édesse. Revue Des Études Byzantines, Tome 55, 1997. Pp. 5-51.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Palanque Byzantion 10Document11 pagesPalanque Byzantion 10Alexandru MadgearuPas encore d'évaluation
- Humanistica Lovaniensia Vol. 5, 1936 - Une Gloire de L'humanisme Belge PETRVS NANNIVS 1500-1557 PDFDocument373 pagesHumanistica Lovaniensia Vol. 5, 1936 - Une Gloire de L'humanisme Belge PETRVS NANNIVS 1500-1557 PDFVetusta MaiestasPas encore d'évaluation
- Brigiite Mondrain: Le Cardinal Bessarion Et La Constitution de Sa Collection de Manuscrits GrecsDocument16 pagesBrigiite Mondrain: Le Cardinal Bessarion Et La Constitution de Sa Collection de Manuscrits GrecsHistorica VariaPas encore d'évaluation
- Doulcet. Essai sur les rapports de l'Église chrétienne avec l'État romain pendant les trois premiers siècles; suivi d'un memoire relatif à la date du martyre de Sainte Félicité et ses sept fils et d'un appendic épigraphique. 1882.Document282 pagesDoulcet. Essai sur les rapports de l'Église chrétienne avec l'État romain pendant les trois premiers siècles; suivi d'un memoire relatif à la date du martyre de Sainte Félicité et ses sept fils et d'un appendic épigraphique. 1882.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- 40 REAug 1994 Nr. 1-2Document580 pages40 REAug 1994 Nr. 1-2novitestamentistudiosus100% (1)
- Baronio, Raynaldus, Laderchii. Annales Ecclesiastici. 1864. Volume 32.Document588 pagesBaronio, Raynaldus, Laderchii. Annales Ecclesiastici. 1864. Volume 32.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Bouché-Leclercq, A - Histoire de La Divination Dans L'antiquité IV (1879) PDFDocument422 pagesBouché-Leclercq, A - Histoire de La Divination Dans L'antiquité IV (1879) PDFdodge666100% (1)
- Classic Acc 32008Document327 pagesClassic Acc 32008roscasilviuiulian100% (1)
- Peintures Antiques Romaines Et FaussairesDocument9 pagesPeintures Antiques Romaines Et Faussairesmerouane maamar bassataPas encore d'évaluation
- Ceillier, Rondet. Histoire Générale Des Auteurs Sacrés Et Ecclésiastiques. 1729. Volume 10.Document762 pagesCeillier, Rondet. Histoire Générale Des Auteurs Sacrés Et Ecclésiastiques. 1729. Volume 10.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Beek - Passio Sanctarum Perpetuae Et Felicitatis (1936)Document357 pagesBeek - Passio Sanctarum Perpetuae Et Felicitatis (1936)mquintaos5674Pas encore d'évaluation
- Anglade, Joseph - Poésies Du Troubadour Peire Raimon de Toulouse (Gutenberg)Document81 pagesAnglade, Joseph - Poésies Du Troubadour Peire Raimon de Toulouse (Gutenberg)SugarplantationPas encore d'évaluation
- Léopold Delisle, Cartulaire de La Sainte-Trinité Du Mont de Rouen (1030-1091)Document87 pagesLéopold Delisle, Cartulaire de La Sainte-Trinité Du Mont de Rouen (1030-1091)Anonymous NDQSmdKt51Pas encore d'évaluation
- Cassingen-Treverdy Function Symbolique Dans La Mystagogie PDFDocument11 pagesCassingen-Treverdy Function Symbolique Dans La Mystagogie PDFTeo FifiPas encore d'évaluation
- Essai D'une Définition de La Notion de Baroque LittéraireDocument25 pagesEssai D'une Définition de La Notion de Baroque LittéraireabelPas encore d'évaluation
- Havet - Manuel de Critique VerbaleDocument512 pagesHavet - Manuel de Critique VerbaleDominique PoirelPas encore d'évaluation
- Grammaire Latine Madvig PDFDocument218 pagesGrammaire Latine Madvig PDFAnca Crivat100% (1)
- Antiquité Tardive - Tome 23 - 2015 - Isidore de Séville Et Son Temps PDFDocument468 pagesAntiquité Tardive - Tome 23 - 2015 - Isidore de Séville Et Son Temps PDFApocryphorum Lector100% (1)
- Hellénisme Et Christianisme Aux Premiers Siècles de Notre ÈreDocument19 pagesHellénisme Et Christianisme Aux Premiers Siècles de Notre ÈreNawel BentaïebPas encore d'évaluation
- Archives D'histoire Doctrinale Et Littéraire Du Moyen-Âge. 1935-1936. N0018009 - PDF - 1 - 1DMDocument423 pagesArchives D'histoire Doctrinale Et Littéraire Du Moyen-Âge. 1935-1936. N0018009 - PDF - 1 - 1DMPatrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Alcide, le petit moine: Maximes et conseils de vie spirituelleD'EverandAlcide, le petit moine: Maximes et conseils de vie spirituellePas encore d'évaluation
- Le Prince de la Concorde: La vie lumineuse de Jean Pic de la MirandoleD'EverandLe Prince de la Concorde: La vie lumineuse de Jean Pic de la MirandolePas encore d'évaluation
- Chapitre - 1 Les Acides Et Les BasesDocument14 pagesChapitre - 1 Les Acides Et Les Baseseduardo3000Pas encore d'évaluation
- Brick HistoryDocument112 pagesBrick HistorypasmangiuPas encore d'évaluation
- TMDDocument10 pagesTMDBANIPas encore d'évaluation
- Cyborg LyricsDocument45 pagesCyborg LyricsKpakitoPas encore d'évaluation
- Les Dernières Années de Symphorien ChampierDocument27 pagesLes Dernières Années de Symphorien ChampierSvetlana HautalaPas encore d'évaluation
- 1-Epidemiologie Prevention Et Depistage - Des CancersDocument37 pages1-Epidemiologie Prevention Et Depistage - Des CancersFarah B. BtoushPas encore d'évaluation
- S6-Econometrie RACHIDI 2020Document65 pagesS6-Econometrie RACHIDI 2020Malika Hart100% (1)
- Les Couleurs Du TempsDocument1 pageLes Couleurs Du TempsAdeline MaaPas encore d'évaluation
- Fonctions Usuelles PDFDocument8 pagesFonctions Usuelles PDFfbhkePas encore d'évaluation
- 2005vermande PDFDocument252 pages2005vermande PDFSans Snoq100% (1)
- Mine Orga 07 08 WebDocument31 pagesMine Orga 07 08 WebMohamed Bakri100% (1)
- Support de Cours Physiologie Et Physiopathologie de La Cellule Musculaire ABED NousseibaDocument33 pagesSupport de Cours Physiologie Et Physiopathologie de La Cellule Musculaire ABED NousseibaSamwil SUANONPas encore d'évaluation
- Martine La Nuit de NoelDocument21 pagesMartine La Nuit de Noelh238979Pas encore d'évaluation
- Bac S Sujets de Philosophie PDFDocument4 pagesBac S Sujets de Philosophie PDFFamara DiedhiouPas encore d'évaluation
- Le GEMMADocument8 pagesLe GEMMAYousef ZoubairiPas encore d'évaluation
- PFE Evaluation Des Risques en CéramiqueDocument39 pagesPFE Evaluation Des Risques en CéramiqueAhmed Moujane75% (4)
- Génération Et Validation D'idée 21Document62 pagesGénération Et Validation D'idée 21senhajiPas encore d'évaluation
- La Reeducation de Pitesti - Le Documentaire DemascareaDocument5 pagesLa Reeducation de Pitesti - Le Documentaire DemascareaDenisa Elena FocaruPas encore d'évaluation
- Calcul Numérique D'une IntégraleDocument25 pagesCalcul Numérique D'une IntégraleFatinePas encore d'évaluation
- Faut Il Donner Des Devoirs À La Maison Aux ÉlèvesDocument2 pagesFaut Il Donner Des Devoirs À La Maison Aux Élèvesdoquochung8aPas encore d'évaluation
- Fiche Poésie 5èmeDocument3 pagesFiche Poésie 5èmeNiniFramboisePas encore d'évaluation
- Hav 2024 Programme Mail 9avril CompressedDocument45 pagesHav 2024 Programme Mail 9avril CompressedRaynald BPas encore d'évaluation